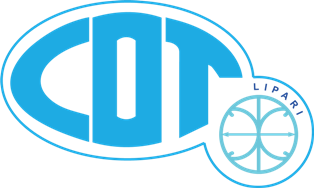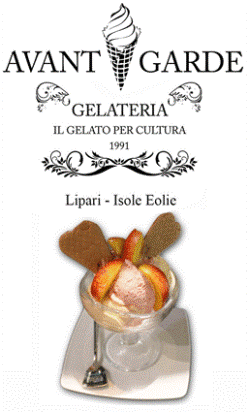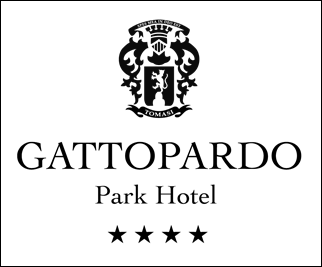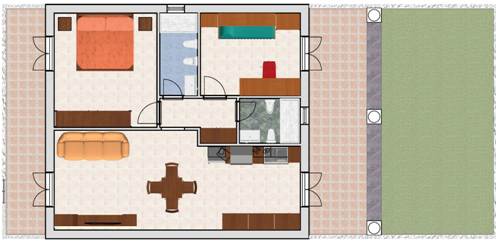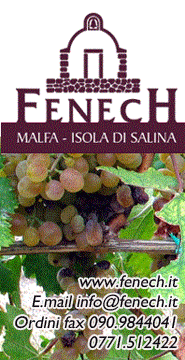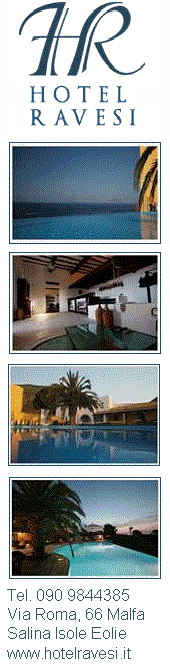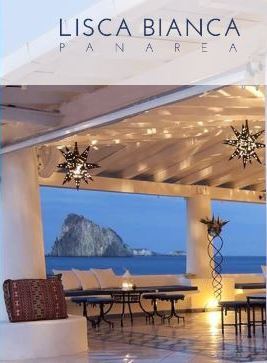27-5-64 finale Coppa dei Campioni fra Inter- Real Madrid: la doppietta prevista da Gianni Brera, le lacrime a Lisbona, le 3 “M” Mazzola-Moratti-Marotta, Lukaku, Angellilo-Icardi, il tentativo di portare Berlusconi all’Inter, non mollare San Siro, il mondo arabo nel calcio, Jair il compagno di squadra ideale, “Cuore Nerazzurro” di Sandro Mazzola ed. Piemme un gran libro bello come un grande goal, il messaggio e…
PER LA VISIONE CLICCARE NEL LINK CHE SEGUE
L’intervista del Notiziario al campione Sandro Mazzola. “Cuore Nerazzurro”, una bandiera per sempre
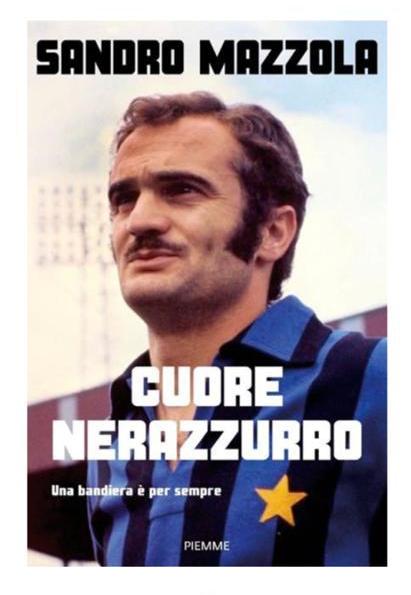
NOTIZIARIOEOLIE.IT
10 AGOSTO 2023
8 SETTEMBRE 2023
di Michele Giacomantonio
Salina conquista l’autonomia amministrativa
La specificità di Salina
Santa Marina Salina
Diversa ancora era la situazione di Salina[1] che merita una analisi specifica. Alla fine degli anni 50 del XIX secolo – osservano Saija e Cervellera -, la comunità salinara è economicamente ben strutturata ed in forte espansione. Si annotano più di 4,500 abitanti e in notevole incremento appaino matrimoni e battesimi. La costruzione di nuove case procura occasioni di lavoro, ma l’attività che più di ogni altra assorbe manodopera è la cura dei vigneti, attirando operai agricoli specializzati e braccianti dalla Sicilia e dalla Calbria, molti dei quali trovano, poi, stabile dimora sull’isola, ed “impiego nelle marine attività”[2]. Agricoltura, produzione di vino e malvasia, costruzione di navigli, e commerci questi sono gli ingredienti dello sviluppo di quest’isola. Così le case sparse, che erano ancora la sua caratteristica all’inizio del secolo già nel 1854, in conseguenza proprio dell’incremento degli scambi e dei commerci e della rivalutazione del prezzo del vino, lasciarono il posto, come annota Luigi Salvatore, ad una forte espansione edilizia segno di una nuova agiatezza della popolazione[3].Continuano ad essere carenti le strade di comunicazione interne ed i collegamenti fra le frazioni dell’isola sono esclusivamente marittime.
Molti terreni di Salina, la maggior parte degli incolti produttivi appartavano alla mensa vescovile ed erano concessi in enfiteusi o comunque in affitto. Ma all’inizio dell’800 sembra che questa pratica cada in disuso ed i discendenti degli originari concessionari espandono – soprattutto sotto la spinta dei guadagni provenienti dalle culture vinicole – i propri possedimenti e cominciano a disboscare i terreni incolti senza chiedere autorizzazioni. Il vescovo Tasca, pur nel breve periodo in cui governò la diocesi, protestò presso il governo borbonico e questo nel 1827 ordinò il sequestro dei prodotti dei terreni illegittimamente disboscati, il divieto di ulteriori coltivazioni e il rimboschimento dei terreni usurpati. Ma l’applicazione del provvedimento incontra forti ostacoli per cui si instaura un braccio di ferro fra civica amministrazione e vescovato. Sembra che si arrivi ad una composizione nel 1838 col vescovo Portelli ma le tensioni si riaprono con i vescovi Proto e Attanasio.
Nella seconda metà dell'80 si avvia un disboscamento per fare spazio all'agricoltura.
L'obiettivo dell'autonomia
Ora i borghesi di Salina non rivendicano più solo il possesso delle terre ma anche l’autonomia amministrativa da Lipari. Viene sottoscritta una petizione, discussa nel decurionato liparese nella primavera del 1855, con cui, sottolineando la sordità dei pubblici amministratori dinnanzi alle cresciute esigenze di Lipari per via dell’impetuoso sviluppo, chiedono all’Intendenza provinciale di promuovere l’erezione in un unico Comune autonomo delle isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. Il parere è sfavorevole e continuò ad esserlo anche nel 1858 e nel 1859 alle ripetetute reiterazioni della petizioni. Nel 1860 il giudizio negativo viene motivato “per le misere condizioni in cui in atto trovansi le diverse isole che vorrebbero riunirsi in Comune, mancando affatto di personale, di mezzi, di quella esistenza morale che desiderano”[4].
Le cose cambiano con l’unificazione del Regno a cominciare dalla legittimazione dei terreni usurpati e circa il rifiuto di pagare le decime gravanti sui territori di Salina per via delle vecchie concessioni, alla luce dei decreti del prodittatore Modini dell’ottobre 1860 che abolisce le decime sacramentali e converte in canone quelle dominicali[5]. Comunque il decreto non sana il conflitto perché il rifiuto non può essere unilaterale ma, il suo fondamento, va accertato giudizialmente. Il vescovo Ideo avanza opposizione richiedendo alla commissione provinciale la conversione in canone dei censi sulla base dei titoli che presenta. Ma l’accertamento giudiziale è difficile e la questione va avanti stancamente mentre gli eoliani decidono di chiudere le porte dei magazzini agli agenti vescovili.
Il notaio Domenico Giuffré primo sindaco del Comune di Salina.
A questo punto, su iniziativa di alcuni giovani salinari capeggiati da Domenico Giuffré che studiava a Napoli giurisprudenza, ripropongono la richiesta di autonomia amministrativa ma questa volta la avanzano per la sola isola di Salina innestandola sulla base della polemica relativa alla spese per opere pubbliche in relazione ai carichi fiscali. I salinari reclamano che l’amministrazione di Lipari non ha alcuna sensibilità per il problema delle scuole e per le opere di difesa dell’abitato della loro isola. Comunque il 4 luglio 1863 il consiglio comunale respinge la richiesta di autonomia . I salinari però non si arrendono e malgrado il voto contrario, inoltrano ugualmente la richiesta al Prefetto e quindi al Consiglio provinciale di Messina che la esamina nella seduta del 17 novembre.
Contro la richiesta parla il liparese Natoli che sostiene l’assoluta incapacità degli isolani di amministrarsi convenientemente proponendo una mediazione. Salina continui a dipendere la Lipari ma il Sindaco nomini un assessore delegato che risieda a Salina[6].
Il prefetto si schiera per l'autonomia
A favore dell’autonomia di Salina parlò invece il prefetto Vittorio Zoppi che rimproverò Lipari di non avere mai fatto nulla per le isole ma di non curare nemmeno adeguatamente le esigenze dell’isola maggiore. Infatti si è finora disinteressata dell’istruzione pubblica e non ha aggiornato le liste elettorali dimenticandosi addirittura di rinnovare il Consiglio Comunale. Quanto alla incapacità dei salinari di amministrarsi, se è problema di censo perché sarebbero pochi quelli che pagano le 15 lire richieste si può osservare che essendo gli abitanti del comune di circa 4 mila il censo richiesto è inferiore, inoltre la nuova legge stabilisce che in casi particolari si può far parte del collegio elettorale anche con un censo più basso. Infine non si può dire che uno non è capace di amministrarsi se non è messo alla prova e potrebbe anche darsi che inizialmente si commettano degli errori ma bisogna puntare sulla capacità di autocorreggersi e nel giudizio della pubblica opinione[7].
L’intervento del prefetto è determinante e il consiglio vota favorevolmente col solo voto contrario di Natoli. La delibera viene trasmessa al governo e questo il 3 febbraio del 1867 firma il decreto di fondazione del comune delegando la borgata di Santa Marina Salina a svolgere le funzioni capoluogo[8].
Il nuovo comune nasce nel pieno dell’espansione economica e demografica . Ed anche se ci sono contrasti fra Santa Marina e Malfa sulla nomina del sindaco e la localizzazione del municipio i passi in avanti si vedono immediatamente. I progressi si riscontrano soprattutto nel campo delle scuole, quindi arrivano due uffici postali, il telegrafo, la stazione dei reali carabinieri, il magazzino vendita tabacchi con rivendite in tutte le frazioni, la delegazione di porto viene elevata al grado di ufficio dipendente e comincia ad assolvere i compiti di controllo e di regolamentazione delle attività della locale gente di mare.
Se si vuole valutare comparativamente lo sviluppo della marineria commerciale nelle tre isole maggiori – Lipari, Salina e Stromboli – si può notare che nel rapporto stazza-numero dei velieri, la flotta di Salina appare complessivamente equivalente a quella di Lipari[9].
Malfa aspira ad essere il capoluogo dell'isola e del Comune
Una volta ottenuta l’autonomia amministrativa alla conflittualità tra Salina e Lipari si sostituisce quella fra S. Marina da un lato che è il capoluogo designato dal decreto e Malfa e Leni dall’altra che vorrebbero spostare a Malfa la sede municipale. Ed approfittando del fatto che in Consiglio comunale le due frazioni hanno 12 consiglieri contro gli otto di Salina dopo qualche anno che si era raggiunta l’autonomia viene votata una delibera che formalizza questa scelta. Ma il Consiglio provinciale, come organo tutorio, cassa la deliberazione[10].
Comunque le tensioni non spariranno e nel 1909, come vedremo, Santa Marina, Malfa e Leni diventeranno tre comuni autonomi.
[1] Quando non diversamente specificato nella stesura di questo capitolo abbiamo fatto riferimento continuo al lavoro di M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit., ed in particolare al II capitolo.
[2] M. Saija e A. Cervellera, op.cit., pag. 89.
[3] Le isole Lipari, vol.VIII, a cura di Pino Paino, Lipari 1986, pag. 42.
[4] Atti del Consiglio provinciale di Messina, sessione ordinaria del 1863, Messina 1864,pp.95-96 ed allegati, in M.Saija, A.Cervellera, op. cit., pp 89-91.
[5] La decima dominicale è il canone per la cessione di immobili ecclesiastici (ancora esiste). Invece le decime sacramentali erano oneri reali, cioè tributi obbligatori nei confronti degli enti ecclesiastici, proporzionali ai frutti di un fondo (di solito la decima parte).
[6] Verbale della seduta del Consiglio Provinciale di Messina del 17 novembre 1863 in Atti del consiglio provinciale di Messina…, op.cit., pp 97-99.
[7] Idem.
[8] Regio Decreto n.3533 del 7 febbraio 1867. L’art. 1 parla dell’erezione di Salina a comune con capoluogo Santa Marina, l’art 2 recita “Fino alla Costituzione del Consiglio Comunale di Salina, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia a norma di legge, l’amministrazione dell’isola predetta continuerà ad essere affidata all’attuale Consiglio Comunale di Lipari che ne curerà gli interessi, senza però vincolare in alcun modo l’azione della futura rappresentanza del novello Comune”:
[9] M.Saija e A. Cervellera, op. cit., pag. 96.
[10] M.Saija e A. Cervellera, op. cit. n. 22 pag. 160.

HOTEL VILLA ENRICA…un modo nuovo per vivere i colori e i profumi tipici della campagna delle Eolie, a due passi dal mare e dal centro abitato di Lipari.
L’hotel Villa Enrica è il primo hotel alle Isole Eolie ad essere immerso nel verde e si caratterizza sia per l’incantevole veduta sulla baia di Marina Lunga di Lipari, sia per la tranquillità del luogo.Le Eolie dell'800
La polarizzazione sociale di Lipari
A metà dell'800 l'agricoltura è ancora una delle principali riosrse per l'economia.
La situazione sociale, culturale e morale nelle Eolie nella seconda metà dell’800 continuava ad essere decisamente deprimente. L’indigenza e l’analfabetismo colpivano la maggioranza della popolazione, servizi collettivi ed igiene pubblica lasciano fortemente a desiderare e questo anche se, confrontata con il resto della Sicilia, l’economia eoliana appariva abbastanza prospera. I capisaldi dell’economia erano rappresentati ancora dall’agricoltura, e questa sopra tutti gli altri, malgrado i danni che aveva provocato il male della crittogama della vite; dall’attività di cava e ancora dai traffici marittimi, anche se già nella prima metà del secolo, per via dell’avvento della navigazione a vapore, aveva inizio la crisi della marineria eoliana[1]. Comunque il livello qualitativo e quantitativo di questa si mantenne elevato almeno sino alla metà dell’800 quando i “padroni di barca” ed i “capitani marittimi” risultavano circa 300. Poi andò calando e nel 1892 erano solo 102.[2]
Anche i traffici marittimi rimangono importanti.
Assai noti fra i padroni, i capitani di barche e gli armatori furono – in questo scorcio di secolo – a Lipari don Giuseppe Spanò, don Bartolo Picone, don Giuseppe Liello, don Nunzio Liello, don Rosario Rodriquez, don Felice Paino, don Francesco Di Stefano col figlio don Giuseppe,, don Giuseppe Bonica, don Francesco La Cava, don Antonino Arena, don Antonio e don Emanuele Saltalamacchia, don Giuseppe Virgona, don Giuseppe Iacono. A Salina don Domenico Giuffré col figlio Domenico, don Gaetano Barca, don Giuseppe Giuffré, don Domenico Re, i fratelli Felice e Giovanni Lauricella, don Onofrio Virgona, don Onofrio Paino. A Stromboli don Giuseppe Di Mattina, don Giuseppe Cincotta, don Vincenzo Criscillo. Fra tanti uomini c’era anche una donna, Marianna Manfré detta Chiaropa, moglie di don Bartolomeo Famularo e madre di cinque figli. Era una ricca e coraggiosa commerciante che spesso guidò personalmente le imbarcazioni con cui andava a fare approvvigionamenti in paesi anche lontani.[3]. Nelle chiese delle Eolie esistono ancora molti ex voto che raccontano delle bufere e delle tempeste incontrati nei viaggi ed ai quali erano scampati “per grazia ricevuta”.[4]
Uno degli ex voto per ringraziare la Madonna per lo scampato pericolo della tempesta in mare.
Questo trend positivo dell’economia – pur accompagnato da gravi squilibri sociali – aveva cominciato ad entrare in crisi a metà dell’800. Eppure, proprio in questi anni, si andava sempre più affermando nelle Eolie una classe borghese di buon livello: possidenti, coltivatori diretti, piccoli e medi imprenditori nel settore della pomice, padroni di velieri e manticane, uomini di commercio e professionisti. Comunque la situazione è differenziata da isola ad isola.
Intono al 1880 le Eolie contavano 18.400 abitanti di cui 12 mila residenti nella sola isola di Lipari e 7 nella città. A conclusione di una sua visita pastorale in tutte le isole - svoltasi negli ultimi mesi del 1880 - mons. Natoli così parla degli insediamenti abitativi dell’arcipelago: “Solo Lipari può essere considerata città, sebbene sia piccola e poco popolosa. In tutta la Diocesi si contano venti villaggi, tra ai quali i più importanti sono Santa Marina, nell’isola di Salina, e San Vincenzo, a Stromboli. Degli altri villaggi pochi hanno più di mille abitanti, e questo numero va di tempo in tempo
assottigliandosi a causa della continua emigrazione”[
Due padroni di barche di Salina. A sinistra Antonino Lo Schiavo e a destra Domenico Giuffré.
Dal punto di vista sociale la realtà di Lipari appariva fortemente polarizzata : un buon numero di ricchi e benestanti da una parte compreso un ceto emergente di impiegati pubblici statali e parastatali e una considerevole massa di modesti lavoratori e di indigenti dall’altra compreso i coatti o gli ex coatti che ultimato il loro periodo di relegazione decidevano di rimanere nell’isola.
Se questa, in estrema sintesi era la realtà di Lipari,, la situazione di Alicudi doveva essere al limite della sopravvivenza. “La sua popolazione è di 599 abitanti in case sparse – scriveva Francesco Salino che la visitò verso il 1870- ; produce poco grano; pochi legumi e poco vino, e somministra al capoluogo la legna da ardere…per cui quella popolazione mena vita stentata, e per poco che il raccolto scarseggiasse andrebbe a pericolo di morire di fame, se non fosse del Consiglio Provinciale e altri che vengono in suo soccorso”[6].
Un piccolo "trappitu" di Alicudi per fare l'olio.
La condizione nelle isole minori
“Nelle isole minori, dove a parte i pochi benestanti, regnava un più basso tono di vita – commenta Ugo Losacco -, i pasti consistevano generalmente in legumi, pesce conservato sotto sale e soprattutto verdura; la pasta compariva più di rado in tavola e così pure, in cesti posti, il pane di grano…D’estate gli abitanti di Alicudi e Filicudi vivevano in gran parte di frutta, di fichi, carrube e ancora più di fichi d’India…Di frutta e fichi d’India si nutrivano ovunque, quasi esclusivamente, vecchi, donne e bambini…D’inverno quando il vento e il mare si scatenavano, le barche rimanevano…in secco sulle spiaggette, e il nutrimento si riduceva allora a poche verdure ed erbe, consumate speso senza sale e nemmeno condite. Si poteva sussistere mangiando finocchio selvatico insieme a pane d’orzo, ma era anche possibile rimanere privi di tutto… e nelle sperdute casette delle isole più piccole e distanti si soffriva la fame. E di fame si poteva anche morire nelle Eolie, in questo scorcio del secolo passato: sette persone, infatti, erano morte di inedia in un solo inverno, pochi anni prima che l’arciduca Luigi Salvatore vi si recasse[7]”.
Ancora più miseranda la situazione di Vulcano e dei suoi abitanti. Tra il 1860 e il 1872 il ritmo produttivo delle officine Nunziante s’era andato sempre più allentando una volta morto il marchese. Vi erano i figli assistiti dal procuratore don Ambrogio Picone ma la spinta propulsiva degli inizi era venuta meno. Il geografo francese Elisée Réclus che la visitò nel 1872 approdò dalla parte di Gelso e subito vide “qua e là variopinti lembi di verzura, vigneti e oliveti, e come punti bianchi vi si distinguono tre o quattro casupole abitate da coloni che provengono da Lipari”[8]. Lo scenario cambia quando tocca il Porto di Levante e si incammina, guidato forse dal Picone, verso il cratere. Qui “alcuni isolani, ormai assuefatti come le salamandre della favola a vivere tra le fiamme, vanno qua e là raccogliendo le stalattiti di aureo solfo ancora fumante, e le fini punte dell’acido borico candide come piume del cigno…Quantunque la superficie di Vulcano si estenda per cinquanta chilometri quadrati, non è stabilmente abitata che da sei o sette operai intenti a farvi raccolta di zolfo e di acido borico e a fabbricarvi l’allume. L’officina è un meschino tugurio che per colore si confonde colle roccie circostanti; gli operai veri trogloditi, succinti in sordide vesti alle quali la polvere della lava dona una tinta di ruggine, dimorano negli antri della montagna di Vulcanello. Tentarono di coltivare legumi nella convalle delle ceneri e delle scorie, ma invano; ogni fil d’erba vi si spegne, e fra i molti frutteti colà piantati non restano che due o tre ceppaie di fichi rattrappiti e morenti. Ogni settimane deesi aspettare da Lipari una scorta di vitto; se per malavventura il battello delle provvisioni mancasse ad un solo dei suoi viaggi, la piccola popolazione di Vulcano sarebbe condannata a perire di fame”.
Gli operai dell’officina erano, lo ricordiamo, coatti della colonia di Lipari. Il primo luglio del 1873 gli eredi di Nunziante vendettero tenute e strutture allo scozzese James Stevenson, proprietario di fabbriche chimiche, che decide di raccogliere e lavorare acido borico, sale ammonico e zolfo; abbonda l’allume che non rende. Si lavora dentro il cratere, nel fabbricato che è stato ristrutturato e si sono impiantati due mulini per macinare il minerale. Il prodotto viene spedito in Inghilterra.[9] Ma il tentativo di rilancio non ebbe successo.
Indubbiamente migliore doveva essere la situazione di Stromboli. Gli abitanti di Stromboli – osservava Elpis Melena nel 1860 – “coltivano con successo le loro piccole pianure sulle quali cresce cotone e una quantità veramente eccellente di vite il cui ricavato è sufficiente ai loro bisogni”. La popolazione che allora contava 400-450 persone era laboriosissima. “Sulla spiaggia infuocata dal sole gli uomini erano occupati a scaricare i prodotti stranieri e a caricare quelli locali, a riparare le loro imbarcazioni e le reti, mentre le donne della contrada si dedicavano alla pulitura del grano, alla cottura del pane, all’essiccatura dei fichi e dell’uva e ad altre occupazioni domestiche”[10].
E questo anche se gli abitanti delle isole minori, ancora nel 1860, come osserva appunto la Melena “dovevano versare al vescovo di Lipari non soltanto la decima dei loro raccolti, ma anche dei cereali e degli altri generi alimentari che essi ritiravano dalla Calabria per il loro fabbisogno”[11].
[1] Angelo Raffa – Pirati, corsari, schiavi, marinai, mercanti - in Atlante .
[2] Rocco Sisci – Marineria di pesca e da traffico nella tradizione eoliana, in Atlante.
[3] Era nata il 7 aprile 1798 e morì il 29 dicembre 1879.
[4] AA.VV, La religiosità popolare e le devozioni domestiche, in I sentieri di Didime, a cura di Sergio Todesco e Riccardo Gullo, Messina 1999.
[5] Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B f. 259.
[6] F .Salino, Le isole di Lipari, in “Bollettino del Club Alpino Italiano”, anno 1874, p.147.
[7] U.Losacco, Nelle Isole Eolie alla fine dell’Ottocento, in “L’Universo”, anno LII, n.5 Sett-Ott. 1972, pag. 986.
[8] F. Bourquelot e R.Réclus, La Sicilia, Milano, 1873, pp 99-73.
[9] F.Salino Le isole Lipari, in Bollettino del Club Alpino, anno 1874, Torino, pp.178- 180.
[10] E. Melena, op.cit., pag. 86.
[11] Idem
James Stevenson
Lipari nella rivoluzione fra prudenza e patriottismo
Una comunità attonita e incerta

Garibaldi durante la spedizione verso Roma viene ferito ad Aspromonte. A quella missione sono presenti anche alcuni liparesi.
Il Consiglio comunale dell’11 ottobre oltre a non commemorare Policastro non parlò nemmeno – stando a quello che emerge dai verbali – dell’impresa di Garibaldi. Né nei consigli del 17 , 31 ottobre e 8 novembre si parla del plebiscito per l’annessione della Sicilia malgrado il 4 novembre fossero stati proclamati i risultati[1]. Le prime manifestazioni di “entusiasmo patriottico” si hanno il 13 novembre quando il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per eleggere tre persone che dovranno andare a Palermo a rendere omaggio a Vittorio Emanuele in visita ufficiale e l’ordine del giorno di qualche settimana dopo quando il consiglio si unisce a quello di Messina perché “ il nostro Dittatore Generale Garibaldi si benigni acconsentire alla demolizione delle fortezze” della Cittadella di Messina e dei Porti Salvatore, Lanterna, Don Blasco, “allorché saranno abbandonate dalle truppe borboniche”, oltre a quelle di Gonzaga e Castellaccio.
L’impressione che si ha è che Lipari è un po’ attonita ed incerta di fronte ai nuovi eventi. I Borboni d’altronde sono ancora dentro la cittadella di Messina ( che abbandonerà il 13 marzo del 1861) ed il re Francesco non ha abdicato ( andrà in esilio il 13 febbraio 1861 dopo la caduta di Gaeta). Inoltre la cittadinanza era sempre assillata dalla penuria dei beni di prima necessità e dal caro vita anche per via del contrabbando e della speculazione che in quel periodo oltre ad avere riflessi sulla qualità e quantità dei consumi della gente produceva anche, soprattutto a Salina, guasti gravi all’ambiente.[2].
Ma non erano solo le condizioni di vita a preoccupare la gente ed a renderla scettica nei confronti del nuovo governo ma anche provvedimenti nuovi che la gente non capiva e viveva come delle vere e proprie angherie. Uno di questi era la leva obbligatoria dove spesso avvenivano delle vere e proprie discriminazione a carico dei più deboli e favoritismi nei confronti di chi era pronto a pagare il proprio esonero. Da qui le numerosi diserzioni che avvennero in Sicilia e che alimentarono il brigantaggio che cominciò a chiamarsi anche “mafia”.
Il tributo di sangue degli eoliani a Lissa

Nella battaglia navale di Lissa durante la terza guerra di indipendenza muoiono 17 eoliani
Questo non voleva dire che non si era pronti a rispondere alle mobilitazioni che facevano appello agli ideali di patria e libertà. Come fu quando Garibaldi nel 1862 organizzò la sua spedizione per liberare Roma dal governo del papa, bloccata il 29 agosto ad Aspromonte dall’esercito regio. Dei liparesi a quell’impresa parteciparono almeno in due: Giovanni Di Mattina e Giuseppe Natoli figlio di Antonino Natoli che aveva combattuto con i garibaldini nella battaglia di Milazzo. Giuseppe Natoli, che aveva ventidue anni, nello scontro fu ferito e morì il giorno dopo.
Così nel corso della terza guerra di indipendenza – contro l’impero austriaco – le isole Eolie pagarono un pesante tributo di sangue il 20 luglio 1866 a Lissa quando nello scontro due corazzate italiane vennero affondate. Furono centinaia i morti fra i marinai italiani ma forse, in proporzione, il tributo più grande lo pagarono le Eolie con ben 17 . Altri tre morirono, sempre in quella guerra, per cause diverse[3].
Un forte disagio nel partecipare alle cerimonie patriottiche che si svolgevano in occasione delle feste nazionali e si volevano abbinate ad un rito sacro lo visse anche il vescovo mons. Ideo. Da una parte vi era la posizione della S.Sede che 12 maggio 1863 per mano del card. Cangiano della S. Penitenzeria esprimeva una posizione rigida “Non esiste legge la quale costringa a celebrare la suddetta festa [dell’Unità d’Italia il 5 giugno] con canto dell’inno del Te Deum o con altri atti religiosi” e questo se ci fosse anche “timore di qualche male per abuso di forza[4]”.Dall’altra vi erano i pressanti inviti che il vescovo riceveva da parte di organi governativi, dal sindaco[5], dalle autorità militari di stanza a Lipari. E il povero mons. Ideo cercava di destreggiarsi anche per evitare l’isolamento . Così il 5 giugno del 1864 non avendo celebrato alcuna funzione religiosa in occasione della festa nazionale, al comandante del distaccamento del XIX Reggimento di Fanteria che gli chiedeva dove potesse sentire messa il vescovo indicò la cattedrale. E lì, qualche giorno dopo, il comandante con la sua truppa potè assistere ad una “Messa bassa”[6]. La situazione dovette stabilizzarsi dopo il 1866 ed il vescovo partecipò, senza più remore, alle manifestazioni patriottiche.
Comunque dopo la presa di Roma la situazione si deve chiarire definitivamente. Ormai il Regno dell’Italia unita era una realtà stabile e così si cominciò a pensare alla nuova toponomastica. A fine degli anni 70 si ha a Lipari una vera rivoluzione nei nomi delle strade: la strada del Pozzo si chiamerà via Vittorio Emanuele II, la strada del Fosso via Umberto I, la strada del Timparozzo o del Municipio via Garibaldi, la strada dei Bottàri via Roma, ecc.
[1] I risultati per la Sicilia furono 432.053 favorevoli e 667 contrari. In questi consigli comunali niente si dice sul ritiro del Governatore e Presidente del Consiglio Comunale don Giuseppe La Rosa che dovette avvenire verso il 22 ottobre e della successione di don Mariano Pisano che rimarrà in carica sino al 27 marzo 1861.
[2] Sono problemi che emergono chiaramente dalle lettere e dalla documentazione della famiglia Aricò che il prof. Giuseppe Iacolino cita nel suo dattiloscritto inedito, quaderno VIII, pp. 354 a- f, 355, 357 a,b .” Per riguardo a ciò che scrivi voler conoscere per li prezzi di carne in Lipari ti posso assicurare che qui siamo nel vero Caos, e molto più per li prezzi dei generi… La carne vaccina sono più di venti giorni che non se ne vede…insomma tutto con scarsezza e caro; che perciò la condizione di cotesta Isola [Salina] è migliore di quella di Lipari”( Lettera del 24 novembre 1860 di don Giuseppe Aricò al figlio Giovanni capitano della milizia nazionale in Salina). Il 5 luglio 1861 il Sindaco di Lipari A. Natoli scrive al capitano Giovanni Aricò. “E’ venuta alla mia conoscenza che in cotesta Isola [Salina] sono enormi le contravvenzioni che si commettono contro le leggi forestali tagliandosi una gran quantità di legna non per il consumo ordinario della povera gente, ma per farne speculazione ad uso delli forni di calce, che continuamente si bruciano in cotesta:ed inoltre si trasmoda tanto nell’uso di legname in cotesto bosco che ne emerge fortissimo pericolo di riversamento d’acque e di ogni gravi sconvolgimenti per li fondi e le case sottomesse alle montagne di costesta Isola”. Il 21 novembre dello stesso anno è l’Assessore delegato Salvadore Amendola che denuncia il contrabbando di animali: “Essendo pervenuta a nostra notizia che una barchetta costì approdata proveniente da Palermo procura estrarsi da cotesta Isola degli animali porcini, caprini e bovini senzacché assoggettito si fosse alle formalità di legge, io credo indispensabile pregar lei affinché con ogni possibile modo procuri inibire siffatta estrazione, essendo ciò di pregiudizio al consumo e bisogno della nostra comune intera”.
[3] A Raffa, Venti eoliani morirono nella prima grande guerra navale del regno, in Notiziario delle Isole Eolie, giugno 1878, pag. 3.Archivio Comune di Lipari, Registro dei morti, anno 1886, dal n. 111 al n. 141. Unico superstite dei liparesi nella battaglia di Lissa fu il marinaio Giovanni Paternò che tornò con una gamba in meno. Intascò le 300 lire del premio che era stato stabilito dal Consiglio Comunale e qualche anno dopo fu assunto come “accensore” al fanale di Pignataro. Del Paternò si parlò nel Consiglio comunale del 24 maggio 1867.
[4] Archivio Vescovile, Corrispondenza Carp. E.
[5] Vi è una nota del Sindaco Salvatore Favaloro del 13 maggio 1865 molto perentoria “Ricorrendo domenica quattro Giugno la festa nazionale dell’Italia nostra prego Lei a ciò mi dia conoscenza se intende intervenire con il Municipio in chiesa a cantare l’inno Ambrosiano ( cioè il Te Deum)”.
[6] Archivio vescovile. Corrispondenza, Carp. G, fascicolo “Lutti e Gale”.
La tragedia del 2 ottobre 1860
La paura di don Piddu il farmacista
Via Garibaldi oggi col avanti sulla destra il palazzo allora del Municipio
Ma c’era chi non era soddisfatto della piega che stavano prendendo le cose. Che cosa avevano risolto? Valeva la pena aver portato centinaia di persone d’avanti al municipio per ascoltare quello che si sapeva già? Era possibile che a Lipari i signori l’avessero sempre vinta e non dovevano pagare mai? Fra i più loquaci c’era Nicola Cappadona che raccontava come in altre parti della Sicilia la rivoluzione era stata più coraggiosa e ai signori ed ai borghesi avevano messo addosso la paura. Intorno a lui si era formato un gruppetto dei più giovani che lo ascoltava come se fosse un oracolo. Intanto più in la Vanni Mario Cannistrà e Antonio Cappadona avevano formato un crocchio in un vicolo e parlavano fitto fitto.
Dopo un pò le voci si alzarono di tono e fu chiaro che si era cambiato registro. Non era più solo il problema del caro prezzi e del funzionamento del calmiere. Ora si parlava dei borbonici che volevano passarla liscia. Che volevano continuare a comandare ed a profittare come se niente fosse successo. Era loro la colpa se la gente pativa la fame, se le merci erano care, se non si trovava il pane e la carne. Ed ecco il giovane Cappadona gridare forte “Viva l’Italia e viva la Libertà! Abbasso ai borboniani e morte ai regressisti” che aveva sentito ed imparato per le strade di Milazzo. E con lui, a cominciare dai più giovani, il grido fu ripreso e divenne assordante fra la mura di via del Timaparozzo, filtrò fra le persiane delle finestre, raggiunse le case e i vicoli. E poi subito dopo:”Andiamo alle case dei padroni! Prendiamoci quello che ci spetta e che hanno nascosto!”, “Andiamo da don Piddu Maggiore chissà quanto grano e quanti gioielli ha in casa!, “Andiamo da don Giuseppe Policastro che si è rubato i soldi della cassa di San Bartolo!” “Andiamo da….”.
Ancora le grida non si erano calmate che già don Piddu non c’era più dinnanzi alla farmacia e questa era già chiusa e sprangata. Ma non fece a tempo a raggiungere il portone di casa sua che era qualche decina di metri distante che una legnata lo prese sulla fronte e lo stordì. Si riprese subito e guadagnò il portone che era ormai a due passi barricandosi dentro. Ma i protestatari non lasciavano la presa e cominciarono a picchiare sul portone minacciando di gettarlo giù. E così don Piddu si fece le scale di corsa raggiungendo il terrazzo e di là, tetti tetti, raggiunse l’abbaino di una casa di amici e vi si rifuggiò.
“Lasciate stare quello!” gridò una voce mentre l’orologio del Seminario suonava le undici “Se l’è già fatta sotto. Andiamo a casa di Policastro che ha rubato i soldi dei poveri. La ci sono già i Marii e gli altri che stanno dando l’assalto.”. E subito la turba si diresse verso l’abitazione dell’ex sindaco che era a un centinaio di metri.
Oggi via Umberto I allora via del Fosso
Quando vide che smettevano di pestare al suo portone e gridando si dirigevano verso la casa di Policastro, don Piddu gridò che era scoppiata la rivoluzione e che appena finito con Policastro sarebbero tornati da lui per ammazzarlo. Nella casa dove s’era riparato c’era anche don Antonino Ziino, il cappellano di San Giuseppe. “Non si preoccupi don Piddu - gli disse -ora la mettiamo in salvo”. E mandò a prendere a casa sua una tonaca ed un cappello da prete , che gli fecero indossare e così lo speziale potè uscire indisturbato facendo perdere le sue tracce e rifugiandosi in campagna da suoi parenti.
Intanto la folla era tutta intorno alla casa di Policastro ma la furia sembrava essersi calmata.
Come doveva apparire via del Fosso all'epoca dei fatti.
In via del Fosso alla casa del Sindaco
“Don Giuseppe, si affacci al balcone – dicevano da sotto – nessuno vuole farle del male. Vogliamo solo discutere”. Ma proprio sotto il balcone, in prima fila, c’era Vanni Mario e don Giuseppe non si fidava. Intanto temeva che dagli inviti suadenti si passasse ad azioni più risolute e che alla fine sfasciassero il portone entrandogli in casa. “Dove posso nascondermi? “ andava dicendo”Dove posso rifugiarmi?”Ed ad un certo punto gli venne in mente che aveva una cisterna che aveva fatta riparare da poco e che non era stata ancora riempita. E così si fece calare dentro e raccomandò che rimettessero il coperchio e se ne tornassero sopra a parlare con i ribelli e cercare di tenerli buoni dicendo che don Giuseppe stava male e si era messo a letto.
Quella che era la casa di don Giuseppe Policastro
E così mentre don Giuseppe se ne stava acquattato nella cisterna mamma Francesca andò sul balcone e prese a supplicare la gente che cingeva d’assedio l’edificio. Ed insieme a mamma Francesca anche i loro servitori ed i mezzadri che erano venuti in città, facevano di tutto, dall’interno e dall’esterno per fare ragionare gli assedianti, implorandoli di tornare a casa loro.
Guardie municipali ufficiali non ce n’erano perché il nuovo corpo non era stato ancora investito di autorità. Vi erano quelle designate che ad un certo punto intervennero in forma privata cercando di rabbonire la gente.
Ma malgrado tutto la tensione continuava a rimanere alta e ad un certo punto scoppiò il “casus belli”. Un colono di Policastro, Domenico Barbuto di Canneto, stava discutendo con Giuseppe Ventrice e via via i toni divennero sempre più alti. Ad un certo punto dalle parole si passò alle mani ed i Barbuto si avventò sul Ventrice e gli assestò una coltellata allo stomaco.
Il clima si surriscalda
Per un momento ci fu un silenzio di tomba come se improvvisamente il tempo si fosse fermato. Poi si udì un grido “Assassini!Assassini! ci vogliono ammazzare! Non basta che ci hanno derubato vogliono anche il nostro sangue!”. E scoppiò il finimondo. Qualcuno si chinò sul ferito e lo trasportò sull’alto ciglio della strada cercando di fermargli il sangue che usciva dalla ferita. Ma altri si gettarono sul Barbuto che tentava di scappare, lo agguantarono ed uno con una roncola gli squarciò il fianco. Barbuto cadde a terra in un lago di sangue e nello scompiglio che ne seguì qualcuno riuscì a trascinare in casa il corpo del ferito che dava ancora segni di vita malgrado continuasse a perdere tanto sangue. Il Barbuto e il Ventrice spirarono nello stesso momento, uno nel magazzino della casa di Policastro, l’altro sul ciglio della strada ‘u Fossu che non era ancora suonata la mezza.
E malgrado il bilancio fosse ora di un morto per parte la calma e il buon senso non si facevano strada. Anzi la ressa si fece più serrata e il vociare più forte. Qualcuno gridò: “Vogliamo Policastro vivo o morto!” e poco dopo arrivarono dei giovani due grossi fasci di sterpi secchi che poggiarono al portone cercando un acciarino per dar loro fuoco. Un altro gruppo cercava di scardinare la porta di servizio che dava sulla stradina.
A questo punto i servitori pensarono che era meglio cercare per don Giuseppe una via di fuga attraverso i tetti. E mentre veniva sistemata una scala a pioli a mo’ di ponte con il vicino terrazzo del Municipio, l’ex sindaco veniva issato dalla cisterna e portato sul terrazzino basso della casa. Da lì, attraverso la scala doveva scappare per i tetti.
Il vicoletto che separava casa Policastro dal Municipio
Mentre si studiava il modo migliore di organizzarsi per questa impresa, mamma Francesca dal balcone, in lacrime, col volto disfatto, protendendo le falde del grembiale nero ricolmo di ori e denaro di grosso taglio, implorava:”Prendetevi tutto! Ecco è quello che abbiamo! Ma lasciate stare mio figlio! Vi prego, lasciate stare mio figlio!”. Nessuno fece un gesto di pietà. Nessuno pareva dare ascolto. E la scena della madre implorante sul balcone e della folla sorda nella strada rimase a lungo nella mente degli eoliani.
In prima fila, sotto il balcone c’era sempre Vanni Mario con il suo clan, ma non c’erano più i fratelli Cappadona. Appena aveva visto la scala a pioli sul terrazzo al giovane era venuta un’idea. Era corso a casa a prendere lo “scopettone” che aveva portato da Milazzo e aveva raggiunto il fratello che lo aspettava all’angolo di un vicoletto da dove potevano vedere il terrazzo della casa senza essere visti. E lì appostati caricano il fucile con polvere da sparo e una manciata di brecciame.
L'uccisione di Policastro
Ad un certo punto videro comparire sul terrazzo don Giuseppe che incerto, avanzando carponi sulla scala si apprestava a passare da un terrazzo all’altro. Quando Policastro fu nel mezzo del cammino, sospeso in aria, Nicola Cappadona prese la mira e sparò. Ciò che la gente ricordò di quel momento fu l’urlo disperato della madre che, mentre il figlio precipitava nella strada, si lanciò per le scale per raggiungerlo. Don Giuseppe non era morto sul colpo, era ancora in terra e rantolava. E su di lui infieriva a parole con pedate Vanni Mario Cannistrà.
“Hai fatto la fine che meritavi, porco!” gli gridava il ribelle di Quattropani. Fu a quel punto che Angelo Megna e Bartolo D’Albora, le due guardie, che per tutto il tempo avevano cercato di sedare gli animi pur non avendo un ruolo ufficiale, si sentirono in dovere di intervenire e bloccarono il Cannistrà insieme a Nicola Cappadona che aveva ancora in mano lo schioppo fumante e lo sguardo allucinato. Antonino Cappadona invece fuggì via e di lui non si seppe più nulla per diverse settimane.
La folla era come di sasso, inebetita. Automaticamente si scansò per fare spazio a mamma Francesca che, il viso bagnato dalle lacrime e i capelli scarmigliati, si getto sul corpo del figlio.
“Giuseppino, Giuseppino mio che ti hanno fatto! Oh figlio, figlio..”. E gli asciugava con lo scialle il volto insanguinato e lo baciava sugli occhi e sulla fronte.
A questo punto, richiamato dallo sparo giunse sulla strada del Fosso lo studente Giuseppe Palamara, anche lui un reduce della battaglia di Milazzo, e per questo autorevole fra i giovani liberali liparesi con una fama di persona assennata e aliena dagli eccessi. Palamara si fece largo fra la folla e vista la scena straziante della madre col figlio moribondo, girò gli occhi verso quelli della prima fila e puntandoli su Vanni Mario e Nicola gridò loro:”Vigliacchi, almeno scopritevi dinanzi al dolore di una madre”. E tutti, Vanni Mario e Nicola per primi, si tolsero la coppola del capo.
Il corpo di don Policastro fu sollevato da terra e portato, agonizzante, in casa e adagiato sul letto grande. Ed alle quattro del pomeriggio il giovane cessava di vivere fra lo strazio della madre ed il pianto dei congiunti.
Spirato il Policastro, le due guardie Angelo Megna e Bartolo D’Albora, si recarono al Municipio per dichiarare i decessi. Negli atti del Comune è scritto che il Policastro morì alle 22, il Ventrice alle 18 ed il Barbuto alle 18,30. Potrebbe essere che orari scritti nei documenti ufficiali siano ancora con l’ora siciliana e non con l’ora italiana. Altra stranezza è che negli atti del municipio è detto che sia il Barbuto che il Policastro erano morti, non nella casa di via del Fosso dove la memoria di chi ha riferito li colloca, ma nella casa del dott. don Filippo De Pasquale che, come abbiamo detto, doveva trovarsi in vico Sant’Antonio dietro la Marina San Giovanni[1]e quindi abbastanza lontano da dove si sarebbero svolti i fatti.
Di questo drammatico episodio l’unico segno che rimane è la lapide sulla tomba posta nella chiesa dei Cappuccini. Essa dice: “Il 2 ottobre 1860, mano assassina, giovandosi dell’anarchia nell’isola, trucidava sotto gli occhi materni Giuseppe Policastro di animo nobile e costumi semplici onesti, la inconsolabile madre Francesca Salpietro a perpetuare la memoria del suo unico figlio ucciso a 37 anni lacrimando pose”. Nel Consiglio comunale che si tenne l’11 ottobre nessuno osò dire una parola di commemorazione o proporre un momento di raccoglimento.
All’indomani dell’eccidio giunse a Lipari un distaccamento di carabinieri reali comandati da un capitano che prese alloggio in via Santo Pietro – oggi via Maurolico - in un appartamento di don Onofrio Paino. Il primo atto che compirono fu quello di prendere in consegna e di inviare alle carceri di Milazzo Nicola Cappadona, Vanni Mario Cannistrà e Giovanni Ventrice imputati di omicidio e di concorso in omicidio[2]. Nicola e Vanni Mario saranno anche condannati[3].
Un delitto su commissione?
Possiamo concludere che giustizia fu fatta per questo orrendo episodio? Non ne saremmo così sicuri. Certo stando alla ricostruzione i maggiori responsabili sarebbero stati arrestati e condannati. Compreso Antonino Cappadona che aveva fatto perdere le sue tracce e poi fu arrestato a Lipari il 23 novembre[4].
Il problema non è questo. Il problema è di capire se si trattò di un moto spontaneo che andò via via crescendo, episodio che innesca un altro episodio o il delitto di Giuseppe Policastro era premeditato ed aveva non solo degli esecutori ma anche dei mandanti, o meglio, un mandante che è rimasto dietro le quinte. Il problema lo pone lo stesso Iacolino che ha trovato fra le carte della famiglia Bongiorno la minuta di una lettera senza data, senza firma, senza destinatario e per di più rosicchiata dai topi e quindi in alcune parti illeggibile. L’unica cosa certa – afferma Iacolino - è che la calligrafia è quella di don Giovanni Bongiorno e che fu scritta nell’arco degli ultimi due mesi del 1860. Don Giovanni Bongiorno aveva nel 1860 la stessa età di Giuseppe Policastro ed era stato nel 1848 caporale della Guardia nazionale ora, con ogni probabilità era ufficiale postale.
Don Giovanni sul finire del 1860 scrive una lettera ad un personaggio che rimane sconosciuto e riporta quanto gli aveva detto don Rosario Rodriquez un eminente personaggio di Lipari che “in casa sua riceveva tutti” e cioè “essere cosa notoria a tutti che il principale autore dei luttuosi fatti del due ottobre 1860 siete stato voi per soddisfare la vostra sciocca e smodata ambizione e per sfogare pravi sentimenti di vendetta, ma pure vi ha egli perdonato nel suo animo. Questo perdono rimane sopito dalla pietosa memoria del sangue dell’innocente Policastro, il quale grida vendetta dinnanzi Iddio ed agli uomini, e le perenni lagrime di quella infelice madre devono anche laniarvi il cuore e logorarvi il pensiero mentre un’ombra di sentimento in voi rimane !!”.Per quello che si capisce dal resto della lettera, in certi passaggi illeggibile, e che questo ignoto personaggio era stato preso in società da padre di don Rosario, beneficato dallo stesso che lo aveva soccorso nelle più “ dure emergenze” ed ora quindi lo accusa di “indicibile ingratitudine”. Ma Bongiorno rassicura il suo ignoto interlocutore. Don Rosario non ha mai pensato alla vendetta e si è meravigliato quando ha sentito che gli si attribuisce la volontà di vorrebbe portare il caso alla luce. Questo potrebbe essere una preoccupazione dei cognati dello sconosciuto interlocutore ma “egli non ne sa una iot. Anzi mi soggiunse che in ottobre ultimo …parlato di questo affare dai vostri cognati egli rispose evasivamente, nel fermo proposito di non far nulla”[5]. Secondo don Giuseppe Aricò l’arresto dei fratelli Cappadona ha sicuramento creato problemi in certi ambienti liparesi infatti “più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli la contassero bene”[6].
Un ultima considerazione. Sulla correttezza dell’amministrazione Policastro – che “don Salvatore” ed alcuni manifestanti mettevano in discussione - vi è un giudizio della commissione che fu chiamata a fare l’”esame del conto morale e materiale del 1860” che dice: “La Giunta [del 1860] ha agito con tutta legalità ed ha adempiuto tutti gli obblighi che la legge metteva a suo carico. Non mancò mai di solerzia e di operosità nell’immigliamento dell’Amministrazione e miglioramento del paese. Si conviene inoltre che gli sconvolgimenti politici avvenuti in quel tempo non permettevano fare più di quanto fece[7]”.
[1] Archivio del Comune di Lipari, Registro ad annum degli atti morte del Comune di Lipari, annotazione n.78, n. 79, n.80.
[2] Nulla si sa della sorte del Ventrice. Quanto agli altri Iacolino riporta informazioni raccolte dai ricordi dei vecchi ma non documentate. Giovanni Mario Cannistrà sarebbe stato condannato ad una decina di anni nel bagno penale di Milazzo. Riuscito ad evadere e a tornare clandestinamente a Lipari, per un paio d’anni tenne in scacco le forze dell’ordine. Soltanto dopo che furono arrestati alcuni suoi congiunti, egli si decise a costituirsi. Nicola Cappadona invece sarebbe stato condannato a circa trent’anni da scontare nel bagno penale di Milazzo. Ne uscì nel 1890. Trasferitosi a S. Marina Salina, dove esercitò il mestiere di sarto, si sposò nel 1903. Morì a ottantatrè anni il 25 gennaio del 1924. Di Antonino Cappadona i carabinieri non trovarono alcuna traccia e su di lui si fantasticò a lungo. Qualcuno avanzò anche il sospetto che fosse stato lui a sparare e non il fratello.
[3] Di parere diverso è Angelo Raffa (E. Melena, op. cit., nota n. 122, pag. 181. “Non si sono rintracciati documenti relativi all’inchiesta e al procedimento penale che avrebbero dovuto aver luogo. Ma se l’inchiesta vi fu, e se gli uccisori vennero individuati, ad essi sicuramente non toccò alcuna condanna. Infatti, con Decreto dittatoriale firmato da Garibaldi a Caserta il 29 ottobre 1860 si dichiarava all’art.1 “abolita l’azione penale a favore degli autori e complici di reati di sangue commessi durante l’insurrezione o in conseguenza dell’insurrezione”: v. Giornale Officiale di Sicilia, Palermo 4 novembre 1860, n. 127 – Parte Officiale. L’Unico onere che incombeva ai processati per delitti di sangue durante l’insurrezione, era la presentazione di apposita domanda al Procuratore generale del re, affinché la Corte dichiarasse estinta l’azione penale per l’applicazione dell’indulto”. Il problema è: i fatti della strada del Fosso potevano rientrare nei delitti di sangue durante l’insurrezione?
[4] Da una lettera di don Giuseppe Aricò a suao figlio Giovanni del 24 novembre 1860 in G.Iacolino, inedito cit., pag. 454 a-d. A proposito di questa vicenda nella lettera si dice “Il figlio di maestro Nicola Capadona Sabbino arrestato fu qui spedito, e l’altro fratello Antonino, che dicesi essere stato colui che vibrò il colpo mortale al miserando Policastro, ieri sera alle 5 arrestato fu tradotto in carcere dai Carabinieri sorpreso ed occultato da quelli potentissimi buttani delle sorelle Cafarella che ne è il Direttore il Canonico Bonica Cartella. Per un tale arresto più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli Capadona la contassero bene”.
[5] Dall’Archivio priv. Del dott. Edoardo Bongiorno, riportata da G. Iacolino, inedito cit. Quaderno VII, pp. 358 a-b.
[6] G. Iacolino, inedito cit., p.354 b, lettera citata.
[7] Archivio Comune di Lipari. Seduta del Consiglio comunale del 25 nov. 1863.
Giuseppe Palamara
L'uccisione del sindaco borbonico. Le premesse: due tesi a confronto
La versione di “don Salvatore”
 L'immagine di Elpis Melena e il suo libro in cui parla delle Eolie
L'immagine di Elpis Melena e il suo libro in cui parla delle Eolie
Ma il calmiere sui prezzi non risolse la situazione di disaggio sociale e di forte tensione che c’era nel paese. Già a fine agosto, il 28 per l’esattezza, aveva colpito l’opinione pubblica l’uccisione di don Giovanni Amendola, ex consigliere e drammaturgo, che si era ritirato nella sua casa di Quattropani. Ora il due ottobre, il giorno dopo l’applicazione delle misure annonarie, si hanno ben tre vittime di morte violenta anche se quella che fa più scalpore è l’uccisione di don Giuseppe Policastro ex sindaco che era rientrato da Salina qualche giorno prima.
Perché viene ucciso Policastro e come? Una versione è quella che ne dà Elpis Melena, pseudonimo di Marie Esperance Brandt von Schwartz, giornalista e scrittrice, legata a Garibaldi da una affettuosa amicizia, che visitò le Eolie dal 7 al 13 ottobre del 1860 e fu a Lipari 9 giorni dopo i tragici fatti raccogliendo quindi ,su di essi, un racconto di prima mano.
La causa dello scontro, secondo la scrittrice anglo tedesca, fu l’accusa che si faceva al Policastro di essersi appropriato della “cassa di San Bartolomeo” e cioè di un fondo costituito con i soldi che dovevano essere pagati, nel 1672, al proprietario del vascello di nome Bartolomeo che portò a Lipari miracolosamente un carico di grano e poi partì di notte senza riscuotere il corrispettivo. Una versione tutta particolare dell’episodio narrato dal Campis che non parla né del corrispettivo né di questa “cassa di S.Bartolomeo”[1]. Comunque il narratore, un non meglio precisato don Salvatore liberale e antiborbonico[2], afferma che l’amministrazione di questa “cassa” era stata affidata al Sindaco e doveva servire ai liparesi come sostentamento in caso di rincaro dei prezzi annonari.
“Questo momento era giunto. L’aumentata tassa sull’olio e sul grano spinse il popolo a chiedere l’aiuto della ‘cassa di San Bartolomeo’, ma invano. E poiché negli ultimi vent’anni ogni aiuto è stato sempre negato e l’ultimo sindaco [ il Policastro] (…) affermò persino che nella cassa non vi era più alcun denaro, il popolo fu condotto all’ira e all’esasperazione. Gli abitanti della città e della campagna si armarono e si unirono per assalire la casa del sindaco, per impossessarsi della cassa trattenuta ingiustamente e compiere vendetta contro l’amministratore infedele e disonesto.
Ma questi si era trincerato con trenta seguaci ben armati, e non accontentandosi di dare l’ordine di sparare sulla popolazione, fu anche colui che fece fuoco per primo e più frequentemente. L’esasperazione cresceva ogni istante da tutte e due le parti, finché il conflitto non degenerò in una generale lotta politica, in cui prevalsero gli odi partitici a lungo repressi. Quando infine il sindaco riuscì a stendere al suolo, con un colpo ben mirato, il capo dei liberali[3] – uno dei nostri cittadini più insigni – allora per lui fu finita. Egli tentò di salvarsi saltando da una finestra; ma nello stesso momento fu afferrato dal popolo e letteralmente fatto a pezzi. Sua madre fuggì in campagna, i suoi seguaci si dispersero, e la popolazione, placata da questa terribile, anche se ben meritata vendetta, si preoccupò soltanto di curare i feriti e seppellire i morti”.

Questa parte di Via Garibaldi fu parte della tragedia
Nella casa del Policastro viene trovata “la cassa di San Bartolomeo” con settemila once. “. “ Il sindaco – continua la narrazione di “don Salvatore” – era un uomo di ancora neanche 36 anni ed aveva rivestito già da circa undici anni la carica a lui affidata da Francesco II. La sua dipendenza dalla dinastia borbonica l’aveva reso odioso presso molti uomini illuminati della nostra cittadina. Con lui si è estinta la sua famiglia, cosa che non è certo da considerare una sventura, visto che essa ha portato da secoli soltanto miseria e dolore su quest’isola. Tre volte i suoi antenati hanno commesso tradimento contro Lipari e l’hanno consegnata al saccheggio dei pirati. Mio padre mi raccontava spesso che Policastro, il nonno di questo sindaco assassinato, non ha fatto nulla di meglio, per favorire certi interessi privati, che far pervenire segretamente al nemico assediante le chiavi della fortezza, in cui si era rifugiata la spaventata popolazione, e lasciare, col peggiore tradimento, tutti gli isolani in balia dei pirati”[4].
Fin qui il racconto di “don Salvatore” per la penna di Elpis Melena.. Sgomberiamo subito il campo circa la responsabilità “storica”. Se “don Salvatore” allude al tempo della “ruina” del Barbarossa, non vi era nessun Policastro fra le famiglie “cospicue” di Lipari prima della distruzione[5]. I sospetti allora circa chi avesse venduto la città al Barbarossa si appuntarono, come abbiamo visto, sul Camagna – che non risulta appartenesse alla casata dei Policastro -, ma anche di queste dicerie abbiamo dimostrato l’inconsistenza. I Policastro risultano invece fra le famiglie che esistevano al principio dell’anno 1600[6] e quindi potrebbero essere fra quelle immigrate a Lipari subito dopo la “ruina” e visto il cognome, potrebbe essere di origine calabra.
Altre due punti dell’esposizione ci sembra di dover confutare. Il Policastro era divenuto sindaco il 18 maggio 1859 e dovette rimane in carica sino all’8 luglio 1860[7], non può avere ricoperto quella carica per gli ultimi undici anni perché come abbiamo visto in questo periodo diverse personalità si erano susseguite in questa responsabilità. La seconda osservazione riguarda la cosiddetta “cassa di S.Bartolomeo”. Esisteva questo fondo? E chi ne era depositario? E se esisteva come mai non si era fatto ricorso ad esso in tanti anni? Come mai il vescovo Attanasio aveva chiesto al governo nel 1853 un soccorso economico per la miseria che si era prodotta anche a causa della malattia che aveva colpito la vite? Giuseppe Iacolino osserva che nella seduta consiliare dell’11 maggio 1859 e ancora in altre successive si discusse della pretesa dell’Intendente di Messina che voleva aver restituiti, da parte del Comune di Lipari, la somma di 3.600 ducati che proprio il governo aveva inviato al vescovo “a sollievo dei poveri delle isole Eolie”. Pretesa alla quale Sindaco e consiglio si erano opposti energicamente. Potrebbe essere stato questo episodio, mal interpretato e distorto, alla base della diceria secondo la quale il Policatro si sarebbe appropriato di certo denaro destinato ai poveri. A sentire altre voci – conclude Iacolino – si sarebbe trattato addirittura del denaro della cassa dell’amministrazione di S. Bartolomeo confusa o identificata con la cassa della Mensa vescovile[8].
La ricostruzione di Iacolino
Vogliamo sottoporre tutto il racconto di “don Salvatore” ad una verifica alla luce delle ricerche fatte dal prof. Giuseppe Iacolino[9]. E dobbiamo dire che la vicenda si tinge di giallo perché non solo si definisce il contesto ed in qualche modo si precisano gli attori ma addirittura si suggerisce che dietro l’assassinio di Policastro ci possa essere la regia di un personaggio di spicco della Lipari d’allora che sia rimasto nell’ombra. Ma procediamo con ordine.
“ Quando morì il padre don Antonio Policastro, Giuseppino (così è indicato nel testamento del genitore) aveva appena tre anni, e la madre donna Francesca, ventottenne, lasciò la propria abitazione di vico Sant’Antonio ( il signorile edificio che guarda su Marina San Giovanni ) per ritirarsi in un’altra casa Salpietro, parte della quale era abitata dal cognato Bartolo De Pasquale. Codesta casa è quel severo palazzetto, il penultimo a sinistra, che si scorge salendo per l’odierna via Umberto. A quel tempo la via Umberto era detta la strada del Fosso a causa di un modesto slargo, il Fosso appunto, che s’apriva lì accanto, nel bel mezzo di quel fitto reticolato di vicoletti e povere abitazioni che ricadevano nell’area dell’odierna piazza Arciduca d’Austria. Sul retro, il palazzetto dava sul tratto iniziale del vico Milio, oggi chiamato vico Montebello. Del fabbricato donna Francesca venne ad occupare il primo piano.

La Lipari dell' '800
Educato con ogni amorevole cura, Giuseppe Policastro concluse gli studi laureandosi in giurisprudenza. Poi, oltre che interessarsi dell’amministrazione dei beni e delle vaste tenute ( ma in siffatte cose - e, a quanto si dice, nella pratica dell’usura – dava ottima prova l’abilità di mamma Francesca) egli, “come si conveniva ad un giovane del suo rango, attivamente partecipò al gioco della politica paesana”[10]nel quale ebbe successo divenendo sindaco. Sindaco dei Borboni e quindi in qualche modo tagliato fuori dei nuovi giochi che si andavano aprendo. Ma il nostro era giovane, era dinamico era fattivo e quindi aveva ancora molte carte che si potevano giocare. E poi in quei giorni erano in molti a convertirsi al nuovo corso e quindi il futuro poteva ancora riservagli delle prospettive. E magari un futuro non troppo lontano visto che presto si sarebbe andati alle elezioni per il nuovo sindaco. Quindi Policastro poteva essere un avversario temibile in una eventuale competizione elettorale… Avversario temibile o capro espiatorio di un regime che si era macchiato certo di abusi e aveva lasciato dietro le sue spalle odi e rancori? Rancori magari nemmeno legati a fatti specifici ma coltivati da giovani che avevano assaporato l’aria nuova partecipando anche alle lotte delle ultime settimane nella vicina Milazzo e ritenevano che la rivoluzione dovesse essere portata più a fondo al di là delle istituzioni, nei confronti dei ceti aristocratici e borghesi che avevano comunque fatto parte del vecchio potere. Ritenevano che andando a sparare a Milazzo avevano acquisito un credito che dovesse essere messo all’incasso, superando le disparità sociali che a lungo avevano subito.
Tutto questo certamente era presente quella mattina del martedì 2 ottobre quando, di buon’ora, gli uomini cominciarono a raccogliersi dinnanzi alla porta del Municipio. Prima una ventina, poi una trentina, poi circa cinquanta. A gruppetti e sparpagliati. E c’era chi andava su e giù per la via del Timparozzo, da Sopra la Civita a Marina San Giovanni, a via del Pozzo per incontrarsi con chi arrivava dal Vallone, da Diana, da Marina San Nicolò e con cui si erano dati appuntamenti fin dal pomeriggio precedente quando la manifestazione era stata decisa. Si doveva manifestare contro il caro prezzi, contro una amministrazione che sembrava immobile, che non risolveva il problema. I benestanti ed i galantuomini – i Marchese, gli Scolarici, i Tricoli, i Bongiorno, i Maggiore, i De Mauro, i Florio, i La Rosa, i Peluso, i Morsillo, i Palamara, i Rodriquez, i Favaloro - se ne stavano chiusi nelle loro case che davano sulla via del Timparozzo che ora si chiamava via del Municipio, spiando da dietro le persiane dei balconi la gente che andava crescendo e che era sempre più rumorosa. Appena più in là vi erano i De Pasquale ed i Policastro. Ma rimanevano chiusi nelle loro case della Marina San Giovanni, come in attesa di qualcosa che doveva succedere, anche i Carnevale, gli Aricò, i Rossi, gli Amendola. Mentre don Onofrio Paino era asserragliato nella sua casa in via Santo Petro. Tutti guardavano nelle strade per vedere chi c’era fra i manifestanti. E c’erano i Marii con a capo Vanni Mario Cannistrà, c’erano i Cappadona, Antonino e suo fratello Nicola che da quando era tornato da Milazzo si credeva chissàcchi, c’erano Giovanni e Giuseppe Ventrici. C’erano insomma tutte le teste più calde dell’isola e molti altri ancora, gente che in città non era mai venuta e scendeva ora dalle campagne per protestare.
Erano chiusi balconi con le persiane abbassate, i portoni sprangati, serrate le botteghe, Solo don Piddu Maggiore, lo speziale, che era anche un grosso proprietario di terre alla Vitusa, a valle S. Angelo, nella contrada ‘u voscu, ad un certo punto aprì la farmacia . E poco dopo anche don Antonio Incorvaja decise di andare al suo Caffè pubblico dove d’estate serviva una granita al limone e all’amarena fatta con la neve che d’inverno infossava a Monte Sant’Angelo in buche nel terreno rivestita di erba fresca e ben coperta da frasche e terriccio.

Finalmente alle dieci quando il cicaleccio si era fatto assordante sul portone del municipio apparve il presidente don Giuseppe La Rosa accompagnato dai due giurati don Michele Scafidi e don Antonino Megna. Subito dalla folla si levarono urla di minacce e il clamore aumentò ma dopo un po’ subentrò il silenzio perché la gente voleva sentire quello che veniva detto. Il presidente disse parole, invitando alla calma ed alla responsabilità e subito passo la parola a don Michele Scafidi che ripetè il discorso che aveva fatto in Consiglio. La penuria dei beni alimentari dipende dalla situazione in cui si trova la nazione che per le isole sono accresciute dalla difficoltà di approvvigionarsi in Sicilia. L’Amministrazione può fare ben poco. Ha calmierato i prezzi e controllerà che questi vengano rispettati. Si spera che la situazione migliorerà nei prossimi giorni. Le parole di don Michele ebbero il potere di far abbassare in qualche modo la tensione. La gente si mise a discutere del calmiere interrogandosi se avesse funzionato e se si era in grado di farlo rispettare. Si discuteva a gruppetti, a capannelli e la gente cominciò lentamente a disperdersi in ogni direzione.
[1] Angelo Raffa nella nota n.119 al testo della E.Melena (In Calabria e alle Isole Eolie nell’anno 1860, Soveria Mannelli 1997, pag.180) osserva che l’ esistenza del Peculio Frumentario, a cui riconduce la cosiddetta “cassa di S. Bartolomeo”, è comunque documentata nell’800 da alcuni atti notarili.. Il Peculio Frumentario era un deposito per il grano per i periodi di carestia, distribuito in cambio di una piccola somma di denaro. Dai documenti citati da Raffa si deduce che a Lipari il Peculio aveva un “depositario della cassa”, un “magazeniero delle fromenti” che a Lipari si trovavano nel Borgo, quartiere il Pozzo, e due “deputati”.
[2] A.Raffa nella nota n. 124 ( idem, pag.182) al testo crede di identificare con don Salvatore Amendola, che alla fine del 1861 compare negli atti del Comune come “assessore funzionante da Sindaco”, oppure don Salvatore Favaloro che sarà Sindaco dal 1864 al 1865.
[3] Angelo Raffa nella nota n. 120 (idem, pag.181) osserva che dovrebbe trattarsi di Luigi Ventrice, sarto di 38 anni, perché era l’unico dei tre uccisi che sia morto per strada.
[4] E. Melena, op. cit., pp.115-116.
[5] G.La Rosa, Pyroologia..ecc., op. cit., vol II, v. “Rollo delle famiglie cospicue de’ Gentiluomini di Lipari, che si trovarono esistenti nella città di Lipari, in tempo della sempre memorabile invasione del barbaresco Ariadeno Barbarossa l’anno di nostra salute 1544” , pp.19-22.
[6] G. La Rosa, op.cit., vol II, pp.30-31. dove si dice che la famiglia Policastro è diramata in diverse casate.
[7] G. Iacolino, La fondazione della Communitas Eoliana agli albori della Rinascenza (1095- 1995), Lipari 1995, pag. 91
[8] G. Iacolino, inedito cit., quaderno VI, pag. 312 a.
[9] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VII, pp.344 e ss.”Nel tentativo che ci proponiamo di ricostruire la dinamica dei fatti di quel martedì di sangue, noi ci affidiamo ai pochi documenti che avanzano ( in primo luogo i registri anagrafici del Comune di Lipari) e a quelle frammentarie notizie – spesso anche contraddittorie e di scarsa attendibilità – che abbiamo raccolto dalla bocca di concittadini non più giovani i quali ci assicurano di avere appreso a loro volta dai più antichi ascendenti. Nostro compito darà esclusivamente quello di vagliare e di legare le varie informazioni in un ordine il più possibile logico e consequenziale”.
[10] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VI pp. 345- 345 a.
Vanni Cannistrà
La rivoluzione raggiunge Lipari
Lipari ed i liparesi di fronte alla spedizione

Una immagine della battaglia di Milazzo
Fra i volontari che combatterono a Milazzo vi erano anche alcuni eoliani. Innanzitutto Giovanni Canale, l’animatore della cellula rivoluzionaria di Lipari, che si buscò due ferite e fu promosso maggiore da Garibaldi sul campo e lo stesso Garibaldi lo nominò governatore provvisorio delle isole Eolie mettendo ai suoi ordini un gruppo di garibaldini per sostenerlo nella liberazione di Lipari. Oltre al Canale altri volontari furono Domenico Pirejra classe 1831, Nicola Cappadona che all’epoca dei fatti aveva 19 anni e Giuseppe Palamara che di anni ne aveva 21 ed era studente in chimica all’Università di Messina. Sicuramente il Palamara, ma probabilmente anche gli altri, una volta avvenuta la capitolazione dei borbonici, tornarono a Lipari con il Canali per procedere alla liberazione delle isole ed alla costituzione della nuova amministrazione.
Ma andiamo per ordine e facciamo un passo indietro. Quando nel mese di aprile corre la notizia in ogni parte della Sicilia che Palermo è insorta e poi anche Messina e le altre città, anche a Lipari ci furono tensioni ed in qualche modo manifestazioni di cambiamento anche forti e violente. Anzi il 17 marzo, prima quindi che avvenisse l’occupazione della Gancia, vi era stata una manifestazione di liberali liparesi che avevano esposto nella Marina di San Giovanni ribattezzata Piazza del Commercio, il tricolore, fissandolo al braccio della statua di S.Bartolomeo[1].

Ma a Lipari vi era una situazione particolare. Da una parte vi erano i carcerati della colonia coatta fra cui diversi politici che speravano in un cambiamento che potesse farli tornare liberi e dall’altra una forte guarnigione militare. Ed è forse proprio per la preoccupazione di questo contingente militare che gli atti di insofferenza assunsero una fisionomia non solo violenta ma anche delittuosa attirandosi l’accusa, da parte, dei borghesi e dei benestanti locali, di brigantaggio. E questi briganti, da qualche anno, si erano manifestati nell’area di Quattropani facendosi sempre più arditi e intraprendenti. Si trattava, si diceva, di caprai ignoranti e analfabeti che avevano dato vita ad una sorta di potere illegale facendo taglieggiamenti, grassazioni, minacce e, di tanto in tanto, anche qualche omicidio. Appartenevano quasi tutti alla banda dei Cannistrà, meglio conosciuta come la banda dei Marii. Si trattava di sei o sette famiglie dove ricorreva frequentemente, almeno nella generazione più giovane che si avvicinava ai vent’anni o li aveva da poco superati, il nome di Mario. C’era Mario Cannistrà figlio di Andrea che era del 1834, Mario Cannistrà figlio di Giuseppe nato nel 1841, Mario Cannistrà di Giovanni nato nel 1841, Mario Cannistrà di Bartolo nato nel 1847, Antonino Cannistrà, Mario Vanni Cannistrà e altri. Il capo sembrava essere Mario Vanni che aveva sposato Grazia Rijitano e si distingueva per il suo fisico possente e il suo abbigliamento rustico e stravagante. Infatti andava in giro con un giaccone e cosciali di pelle di pecora che insieme alla barba incolta ed i capelli lunghissimi che fuoriuscivano da un berrettone di lana grezza che calzava costantemente conferivano alla sua figura un che di selvaggio. Eppure contrariamente a quanto si diceva, Mario Vanni non solo sapeva leggere e scrivere, come altri membri del gruppo, ma teneva in casa molti libri dai quali attingeva quelle idee di giustizia e di libertà che professava e per le quali godevano di considerazione e di rispetto fra i contadini della contrada e delle campagne vicine dove era diventato famoso assieme agli altri del suo gruppo[2]. Comunque i Marii non erano i soli nell’isola ad avere fama di essere irrequieti e violenti. Anche in città si mormorava di appartenenti alle casate dei Cappadona[3] e dei Ventrici[4] che avessero la lingua e anche la mano e qualche volta il coltello facile. Fatto sta che il 1858 ed 1860 si erano registrati a Lipari ben sei “morti violente” un fatto certamente tutt’altro che usuale per una comunità solitamente tranquilla.

Contadini delle contrade
Era sindaco di Lipari in quel tempo don Giuseppe Policastro[5], un trentaseienne avvocato colto e facoltoso che cercò di barcamenarsi in una situazione sempre più difficile e poi nel 1860, nell’isolamento più completo, senza notizie di quello che avveniva all’esterno, solo voci confuse. Soprattutto dette la caccia ai Marii e probabilmente a Vanni Mario che era latitante.
In quei mesi di forti speranze e preoccupazioni l’attenzione dei liparesi fu attratta dal forte fulmine che alle sette della sera del 19 febbraio 1859 si abbatté sul timpano della Cattedrale facendolo rovinare e provocando diverse crepe nella volta. Subito la gente vide in questo evento un presagio negativo magari anche politico data l’incertezza dei tempi. Comunque il vescovo mons. Ideo[6] non frappose tempo in mezzo e fece arrivare da Napoli, in poco tempo, le pietre per la riparazione grazie anche alla somma inviatagli, in tutta fretta, da Ferdinando II per riparare il frontone[7] e magari…per nascondere il presagio.
Le difficoltà del sindaco Policastro
Comunque, dal punto di vista ufficiale, tutto procede come al solito in municipio ed al vescovato fino all’aprile del 1960. Nell’ottobre e nel novembre del 1859 si celebrano con rito religioso in Cattedrale le ultime due ricorrenze dei Borboni: l’onomastico di Francesco II e la commemorazione per il sesto mese dalla morte di Federico II. Ed in Comune ancora nelle sedute consiliari del 1960 si discute normalmente dei problemi dei collegamenti marittimi e dei prezzi annonari. Sui collegamenti marittimi il 13 febbraio si avanzò richiesta al governo di fare eseguire al vapore della tratta Lipari- Messina altre due corse passando così a quattro la settimana.[8]
I prezzi annonari creavano molti malumori. Quelli della carne produssero addirittura una serrata da parte dei macellai ed il malumore crebbe fra la popolazione. Nella seduta dell’1 aprile, l’ultima presieduta da Policastro, si discute proprio di questo malcontento che circola nel paese sia per i prezzi sia per la penuria di merci nei negozi e che si indirizza in particolare nei confronti del sindaco tanto che Policastro nella stessa seduta ritiene di doversi “discaricare per la responsabilità … dopo aver fatto noto al Colleggio lo stato di deficienza in cui attualmente trovasi il paese”.
Che la rivoluzione fosse ormai vicino i liparesi lo intuiscono il 10 luglio quando si sparge la voce che il Duca di Calabria, il vapore proveniente da Messina e diretto a Napoli, proprio nei pressi di Lipari era stato catturato da una corvetta della Marina Dittatoriale Siciliana e dirottato a Palermo.

Quando si ha notizia che Garibaldi ha conquistato Palermo buona parte dei sindaci siciliani spariscono o erano fuggiti o, chi non aveva fatto in tempo, era stato soppresso[9]. Il Policastro se ne va a Salina nelle sue terre sia per sfuggire alle proteste annonarie ed al malcontento dei cittadini in genere, sia temendo una vendetta da parte dei Marii. E dal 13 luglio non compare più la sua firma nei registri del Comune. Non potendo fare conto sulla pubblica amministrazione il governo della Sicilia scrive ai vescovi chiedendo la loro collaborazione e quella del clero “acciocché con la predicazione s’insinui negli animi de’cittadini d’abbracciar questa misura [quella della leva dell’esercito] non come una gravezza, ma come un sacro dovere, gloria vera e degna d’un popolo che vuole conservare la sua libertà[10]”.
Giovanni Casale governatore di Lipari
Quando il 25 luglio Garibaldi, dopo la vittoria di Milazzo, parte per Messina chiama a se il maggiore Giovanni Canale e gli dà disposizioni per l’occupazione di Lipari e delle Eolie. Il contingente militare che era di guardia ai coatti non avrebbe opposto resistenza, se qualche preoccupazione ci poteva essere riguardava la Regia Marina che sorvegliava l’intera area dello Stretto, ma visto che la capitolazione era stata firmata dal colonnello Anzani dello stato maggiore borbonico, anche questa eventualità appariva improbabile. Quindi il Canale prendesse il gruppetto di liparesi che avevano combattuto a Milazzo ed un altro gruppetto della guarnigione locale e andasse a Lipari assumendo le funzioni di governatore provvisorio delle Eolie e lo comunicasse a tutte le autorità.
E così avviene . Tra il 26 ed il 28 il maggiore Giovanni Canale parte per il Lipari con il suo gruppetto, indossando la camicia rossa, un poncho grigio- marrone, un berretto di velluto scuro ricamato. La prima visita sarà per il vescovo Ideo, quindi si recò al municipio sul Timparozzo dove incontrò quelli dei decurioni che non si erano nascosti, i gentiluomini del paese, gli ufficiali borbonici del Castello. Ad essi Canale comunicò la decadenza del Sindaco e del decurionato borbonico, lo scioglimento del corpo delle guardie municipali con il passaggio dell’incarico di pubblica sicurezza alla guardia nazionale e mostrò la sua nomina a Governatore e Presidente del Municipio, firmata da Garibaldi. Dichiarò che riceveva ordini solo dal Governatore della Provincia. Emanò alcune urgenti ordinanze di polizia compreso quella che aboliva la pena del bastone nei confronti dei relegati coatti e infine firmò il primo atto anagrafico, una registrazione di nascita. Era il 29 luglio 1960.
Il Canali annunciò che presto vi sarebbero state le elezioni per il nuovo Consiglio comunale che sarebbe stato presieduto da un Presidente del Consiglio e il Consiglio avrebbe eletto il Magistrato Giuratorio che doveva comprendere il Predente del municipio e due giurati. Il Consiglio comunale sarebbe stato eletto da elettori che sapessero leggere e scrivere e fossero iscritti ai ruoli dei contribuenti con un certo censo: una settantina o poco più[11] . I comizi furono indetti per i primi giorni di agosto. Furono eletti quarantesi consiglieri di cui sette canonici ed un sacerdote, cinque erano i confermati rispetto alla precedente assise, il più anziano e quindi presidente provvisorio era il dott. Antonino Megna.. Fra i consiglieri vi era anche Giovanni Canale.
Anche a Lipari la Guardia nazionale
Il Consiglio si riunisce per la prima volta il 25 agosto per prendere visione di una circolare del Governo del Distretto di Messina sui Consigli civici, ma siccome si tratta dei consigli da eleggere mentre a Lipari questo è giù costituito si procede solo alla nomina del Presidente e del Segretario nelle persone del signor Felice De Gregorio e del signor Giuseppe Mercorella. In un successivo consiglio del 31 agosto si provvide ad alcune sostituzioni e cancellazioni in seno al Consiglio per ricondurlo al numero di quaranta membri, ma non si procedette alla nomina dei componenti del Magistrato Giuratorio che insieme al Presidente del Municipio avrebbero costituito l’esecutivo. Non si parlò affatto del corpo dei vigili urbani come non si parlò dei problemi del Comune. Probabilmente si aspettava che la situazione si chiarisse meglio ed intanto ci si dedicava ai lavori dei campi visto che era arrivata la stagione del raccolto a Lipari come nelle isole minori.
Aveva preso ad operare la guardia nazionale a Lipari e nelle isole[12] mentre Giovanni Canale dovette partire per qualche tempo lasciando il suo incarico ad interim al giurato don Antonino Aricò.
Francesco II a Gaeta
Settembre si apre con le notizie contraddittorie che arrivavano dalla Sicilia e dall’Italia, della coscrizione obbligatoria che era stata imposta dai piemontesi e dello Statuto Albertino che Depretis aveva esteso all’isola, del re Francesco II che si era rinchiuso a Gaeta e di Garibaldi che aveva occupato Napoli, e anche delle camice rosse che erano state sconfitte a Caiazzo. Ma a Lipari si parlava anche dei beni di prima necessità che scarseggiavano, dei prezzi che erano saliti alle stelle e di cui si dava la colpa ai bottegai e agli speculatori, dell’anarchia che ormai sembrava impossessarsi del paese. Così il 23 settembre si riunì il Consiglio sotto la presidenza di don Felice De Gregorio con all’ordine del giorno la nomina delle guardie municipali e la nomina del Magistrato municipale. Presidente a maggioranza di voti fu eletto don Giuseppe La Rosa mentre il dott. Michele Scafidi e il dott. Antonino Megna vengono eletti primo e secondo giurato. Per quanto riguarda la Guardia municipale la scelta era stata fatta cadere , di preferenza, su individui che erano stati assunti nel 1848 e qualche mese dopo dimessi, per cui risultò un corpo di vigili per lo più anziani per la gran parte superiori ai cinquant’anni ed anche, per la gran parte, analfabeti.
Ma il problema che rimaneva grave era quello dei beni alimentari e dei loro prezzi. Che fare? Gli amministratori sapevano che la mancanza di grano, olio e carne dipendeva dallo stato di guerra che ancora affliggeva il territorio del regno per cui l’unica strada, se vera strada si poteva chiamare, era quella del blocco dei prezzi a dettaglio pur con qualche aggiustamento “onde togliere qualunque attentato all’ordine per l’imprudenza dei venditori”. Ed è con questo obiettivo che viene convocato d’urgenza il Consiglio in seduta straordinaria solo una settimana dopo, il 30 settembre che definisce, su proposta del giurato dott. Scafidi i prezzi per tutta una serie di merci: pane, vino, olio, pasta, carne di vacca, di montone e becco, di capra e pecora, e quindi dei pesci dalla cernia, al dentice,alle occhiate, agli scorfani, alle ope, alle morene e mostine, alle aragoste, al tonno sotto sale.
[1] Elpis Melena – In Calabria ed alle isole Eolie nell’anno 1860 , Soveria Mannelli 1997, pag. 116.
[2] Mario Cannistrà di Andrea nato a Quiattropani il il 25 aprile 1834 nel 1870 sarà condannato a venticinque anni di lavori forzati per grassazione. Morirà nel bagno penale di Procisa il 22 luglio del 1871. Un altro Mario Cannistrà detto anche Mariano di Bartolo, nato il 4 ottobre del 1847 verso il 1867 trovandosi in servizio di leva ucciderà un capitano dell’esercito. Sconterà trent’anni in un carcere romano. Tornato a Lipari verso il 1900 vivrà sin oltre il 1920. Queste notizie sui Marii come altre riguardo a Lipari in questo periodo, dove non diversamente indicato, sono presi da Giuseppe Iacolino, indedito cit. Quaderno VII, pp 312-314 e pag. 348.
[3] Un Nicola Cappadona, diciannovenne, sarà a Milazzo a combattere con i garibaldini. Faceva parte di una famiglia numerosa giacchè la madre, Nicolina Mellina, aveva messo al mondo tredici figli e una decina erano viventi nel 1860. Il padre Nicola, detto Sabina, era calzolaio e guardia municipale. Vivevano in una casupola in una stradina sotto le mura del Castello. Oltre a Nicola fra i più attivi vi era il fratello Antonino più anziano di sei anni.
[4] I Ventrice erano un clan di sei o sette famiglie dislocate in vari quartieri della città ed esercitavano i più svariati mestieri. Qualcuno aveva fatto il militare nell’esercito borbonico, vi erano sarti, calzolai, fabbri e agricoltori. Probabilmente erano originari di Ustica e avevano vissuto per qualche tempo a Palermo.
[5] Giuseppe Carlo Bartolomeo Policastro era nato a Lipari il 12 maggio 1823 dal settantenne don Antonio, dottore in legge e grosso proprietario terriero, e da donna Francesca Salpietro, una fanciulla di venticinque anni ed anche lei erede di grosse fortune patrimoniali. Era cugino di don Filippo De Pasquale che abbiamo conosciuto sindaco di Lipari e partecipante a Palermo all’insurrezione del 1848 e alla conquista di Palermo da parte di Garibaldi. Era imparentato anche con don Onofrio Paino meglio conosciuto come don Nofriu ‘u pirata.
[6] Mons. Ludovico Maria Ideo, domenicano, era nato a Pietraporzia in provincia di Enna il 21 aprile 1811. Era un predicatore eccellente e nel 1852 aveva pubblicato a Palermo il quaresimale predicato nel 1840, Venne nominato vescovo di Lipari il 25 giugno 1858 e prende possesso della diocesi l’8 ottobre. Il problema più grave che il nuovo vescovo si trovò di fronte era quello di una diocesi distribuita fra tante isole così distanti fra loro mentre la sua salute era cagionevole e non gli permetteva di sopportare gli strapazzi del viaggio e dei soggiorni disagiati. Per questo aveva chiesto subito al papa di essere dispensato dalle visite pastorali nelle isole in prima persona e di potere delegare qualcuno per le cresime.(Archivio vescovile, Corrispondenza, carp.E).Sera anche un letterato e poeta. Nel 1880 uscì a Palermo un suo libro dal titolo “Poesie edite ed inedite di Monsignor F.Ludovico Maria Ideo dell’Ordine dei Predicatori Vescovo di Lipari”. Collaborò a diverse riviste fra cui “Vera Buona Novella” di Firenze e “Sicilia Cattolica”.Morì il 3 dicembre 1880.
[7] Dal Manoscritto anonimo di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, p.636.
[8] Probabilmente due corse Lipari-Messina si effettuavano già da qualche anno ed erano inserite nella linea bisettimanale Napoli –Messina una della Compagnia Calabro Sicula ed una della Compagnia delle Due Sicilie. Una volta al mese un vapore faceva il viaggio da Palermo per Lipari. S.Lanza, Guida del viaggiatore in Sicilia, Palermo 1859.
[9] F. Ioli, Roccavaldina, Torino 1972, p.86. Il 19 luglio a Roccavaldina i patrioti avevano ucciso il sindaco Carmelo Bottaro ed un suo messo. Entrambi sgozzati e lasciati in mezzo alla piazza del paese in un lago di sangue.
[10] Lettera del 19 giugno 1860 della “Segreteria di Stato dell’Istruzione Pubblica e del Culto” al Vescovo di Lipari, Archivio Vescovile, Corrispondenza, Carp.C.
[11] La lista degli elettori alle elezioni del 12 maggio 1864 erano 72, quindi supergiù lo stesso numero del 1860.
[12] Sappiamo che a Salina era già operante prima del 10 ottobre da una lettera che il governatore Giovanni Canale scrive a don Giovanni Aricò, capitano della terza compagnia dei Militi Nazionali in Santa Marina e in cui si parla del luogotenente Domenico Giuffré e dei sottotenenti Gaetano Favazza e Giuseppe Lo Schiavo, insieme ai quali l’Aricò deve procedere alla nomina dei “bassi ufficiali” e cioè un sergente foriere, sei sergenti, dodici caporali ed un caporale forire. Forse Giovanni Arico era uno dei volontari che aveva combattuto a Milazzo. Documenti riguardanti Giovanni Aricò sono di proprietà della dott.ssa Giulia Mammana in Amendola.
Giuseppe Policastro
L’impresa di Garibaldi in Sicilia
Le premesse siciliane dell'impresa di Garibaldi

Francesco II di Borbone e Maria Sofia
La rivoluzione che non riuscì nel 1848 ebbe tutt’altro destino nel 1860. Intanto al trono del Regno delle Due Sicilie, a Ferdinando II, il 22 maggio del 1859, era succeduto il figlio Francesco II, giovane ed inesperto, che dovette vedersela da una parte con le turbolenze sociali e politiche che non mancarono dopo la sollevazione del 1848, e, dall’altra, con l’isolamento politico in cui il regno si era relegato, mentre l’esercito e l’amministrazione dello stato erano sempre più demotivati e disorganizzati.
Quindi la insurrezione del 1860 ebbe tutt’altro esito grazie anche all’apporto di Garibaldi e delle sue camice rosse. Ma la spedizione dei garibaldini ha una premessa tutta siciliana come riconobbe lo steso Garibaldi.
“Io ero in Caprera – scrive nelle sue memorie il generale - quando mi giunsero le prime notizie d'un movimento in Palermo: notizie incerte, or di propagante insurrezione, ora annientata alle prime manifestazioni. Le voci continuavano però a mormorare d'un moto; e questo, soffocato o no, aveva avuto luogo. Ebbi l'avviso dell'accaduto dagli amici del continente. Mi richiedevano le armi e i mezzi del millione di fucili: titolo che s'era dato ad una sottoscrizione per l'acquisto d'armi. Rosolino Pilo, con Corrao, si disponevano a partire per la Sicilia. Io conoscendo lo spirito di chi reggeva le sorti dell'Italia settentrionale e non ancora desto dallo scetticismo in cui m'avevano precipitato i fatti recenti degli ultimi mesi del 1859, sconsigliavo di fare, se non si avevano nuove più positive dell'insurrezione. Gettavo il mio ghiaccio di mezzo secolo nella fervida, potente rivoluzione di 25 anni. Ma era scritto sul libro del destino! Il ghiaccio, la dottrina, il pedantismo seminava il vano di ostacoli la marcia incalzante delle sorti Italiane! Io consigliavo di non fare, ma per Dio! si faceva; ed un barlume di notizie annunciava che l'insurrezione della Sicilia non era spenta. Io consigliavo di non fare? Ma l'Italiano non dev'essere ove l'Italiano combatte per la causa nazionale contro la tirannide? Lasciai la Caprera per Genova; e nelle case de' miei amici Angier e Coltelletti si cominciò a ciarlare della Sicilia e delle cose nostre. A villa Spinola, poi, in casa dell'amico Augusto Vecchi, si principiò a fare dei preparativi per una spedizione”..
L’insurrezione di cui parla Garibaldi è quella del 4 Aprile 1860 quando un gruppo di patrioti mazziniani e liberali si barricano, nel centro storico di Palermo, nel complesso della chiesa e nel convento di S.Maria degli Angeli conosciuta come la Gancia, un ricovero francescano per forestieri, e da lì danno il segnale della rivolta contro il governo del Borbone. Malgrado siano un piccolo gruppo essi riescono a resistere per diversi giorni anche se in città vi è una forte guarnigione militare. Ma i ribelli hanno la solidarietà dei frati e inoltre la popolazione, che è sempre più ostile ai Borboni, fa loro da cordone di protezione quantomeno a livello di opinione anche se va osservato che la protesta del popolo aveva una motivazione ed una dinamica sua propria che non sempre riusciva ad essere controllata dai liberali che appartenevano, per lo più, ad un ceto culturale . Dei frati parla anche Garibaldi nelle memorie della spedizione: “Il contegno dei poveri frati della Gancia fu lodevolissimo. Essi non pugnarono, non macchiaronsi di sangue, ma identificaronsi colle aspirazioni d’un popolo generoso ed oppresso, lo favorirono e ne divisero i pericoli e le miserie”[1].

Palermo i primi moti del 1848
Così Palermo accende la scintilla. E malgrado tutti gli uffici pubblici rimangano chiusi e la città è isolata fino al 12 aprile per cui l’unico collegamento possibile è quello con le navi militari, il fermento si propaga in tutta la Sicilia.
Il 6 Aprile gruppi di rivoltosi attaccano le guarnigioni borboniche di Monreale e Boccadifalco. L'8 Aprile, giorno di Pasqua, a Messina viene dichiarato lo stato di assedio. Per tutto il mese di aprile nelle strade e nelle piazze di Messina circolavano, in atteggiamento minaccioso, non meno di venticinquemila fra braccianti agricoli, pastori e montanari.
Il 10 Aprile Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, entrambi mazziniani, dopo un colloquio con Garibaldi, sbarcano in Sicilia, tra Messina e il capo di Torre Faro, incitando alla resistenza in attesa del prossimo arrivo del generale. In molte città vengono ripristinate le guardie nazionali che erano state istituite durante l’insurrezione del 1848. Questo toglie all'amministrazione borbonica il controllo della sicurezza pubblica demandandola alla borghesia.
Ai primi di maggio – commenta una lettera scritta in quei giorni – “la bandiera tricolore sventola da per tutto, la guardia Nazionale è da per tutto ordinata, il dazio sul macino non si paga. Dove sono i soldati, ivi la compressione, dove soldati non sono, ivi l'indipendenza[2]” .E furono soprattutto i piccoli centri a sperimentare questa maggiore indipendenza che spesso si delineava abbastanza confusa fra la rivendicazione dei popolani e dei contadini che erano soprattutto sociali e spesso molto elementari, quelle dei liberali e democratici che erano essenzialmente politiche e miravano alle libertà costituzionali ed all’unità d’Italia ed infine quella dei nobili e di molti borghesi che fiutavano il clima e stavano attenti a che – come fa dire Tommasi di Lampedusa al Principe di Salina nel Gattopardo – tutto cambiasse perché nulla cambiasse.
Garibaldi accellera i tempi

La partenza dei Mille da Quarto
I sommovimenti di Sicilia sollecitano Garibaldi a fare presto. Il 4 maggio a Torino si stipula il contratto per l’acquisto dall'armatore Rubattino dei due vapori Piemonte e Lombardo. La sera del 5 la spedizione di circa 1162 volontari si imbarcava dallo scoglio di Quarto armati di vecchi fucili. L’11 sbarcava nel porto di Marsala proclamandosi dittatore della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II. Il 14 è a Salemi dove viene accolto con grande entusiasmo dalla popolazione. Il 15 a Calatafimi c’è il vero primo scontro con i borbonici. Garibaldi ha le sue camice rosse e 500 “picciotti” del barone di Alcamo, il gen. Landi aveva invece 2.300 uomini, uno squadrone di cavalleria e 4 pezzi d’artiglieria. Lo scontro fu cruento e durò quasi tutta la giornata ma alla fine i garibaldini ebbero la meglio. La strada per Palermo era così spianata.

Garibaldi sbarca a Marsala
Garibaldi pose il suo quartiere generale a Gibilrossa una piccola frazione di Misilmeri a 12 chilometri da Palermo. Qui sosta dal 19 al 26 maggio attendendo le squadre siciliane .di La Masi, che nel frattempo erano cresciute per nuove adesioni e contavano circa 3000 uomini. A Palermo si aggregano all’esercito di Garibaldi anche alcuni liparesi. I primo a farsi presente è don Filippo De Pasquale che viveva in quella città ed era amministratore dei beni Magione e Ficuzza e che il generale incaricherà di amministrare i beni della casa reale. Un altro liparese che si fece onore in battaglia fu Antonino Natoli che raggiunse il generale a Gibilrossa “dopo aver piantato il vessillo tricolore in Baucina” dove abitava e poi partecipò alla battaglia nelle strade di Palermo[3].
A Gibilrossa Garibaldi decide di dare l’assalto a Palermo nella notte. Ci si muove alle 4 di mattina e Garibaldi pone il suo quartier generale a palazzo Pretorio, nel cuore della città. Subito le campane suonarono a festa e la popolazione insorse. Molte carceri furono aperte e parecchi detenuti si unirono ai rivoltosi costruendo delle barricate in diversi quartieri della città mentre i borbonici si rinchiudevano in alcune postazioni come Palazzo reale, la Prefettura, il Forte di Castellammare. Il gen. Lanza, spaventato e disorientato, diede ordine di sparare sui quartieri occupati dai garibaldini dalle navi nel porto e dal forte. Fu un bombardamento che durò per tre giorni con diverse centinaia di morti e di feriti fra la popolazione. Il 30 si cominciò a trattare per l’armistizio su sollecitazione degli inglesi. Questo fu concluso il 31 mentre l’esodo dei borbonici avvenne fra il 7 ed il 19 giugno.
 Garibaldi entra in Palermo
Garibaldi entra in Palermo
La piazzaforte di Milazzo
Per scacciare completamente i Borboni della Sicilia era necessario prendere la piazzaforte di Milazzo. I garibaldini con i “picciotti” che crescevano continuamente di numero al comando del Gen. Medici marciarono da Palermo verso lo stretto di Messina mentre Garibaldi era ancora a Palermo e raggiungerà il resto dell’esercito il 19 con una nave di volontari che venivano dal continente sbarcando a Marina di Patti. Lo scontro di Milazzo vide di fronte 6000 uomini di Garibaldi contro 3.400 al comando del gen. Del Bosco anche se questi ultimi erano meglio organizzati ed armati. Lo scontro fu durissimo: si sparava fra le case, dalle barche del porto e dalla fortezza. Le truppe di Garibaldi persero mille persone. Il 20 trascorse combattendo tutto il giorno mentre il 21 ed il 22 furono giornate relativamente tranquille con gli eserciti che si sorvegliavano dalle barricate. Il 23 si trattò tutto il giorno e la notte fra il 23 ed il 24 si firmò la titolazione dei borbonici. Ora tutta la Sicilia era liberata ed ai borbonici rimaneva solo la cittadella di Messina.

La battaglia di Milazzo
[1] G. Garibaldi, I mille, in http://cronologia.leonardo.it/mille/058.htm
[2] Da una lettera del 2 maggio pubblicata nel volume “I cento anni della provincia di Palermo”, Manfredi editore, Palermo, 1961.
[3] Antonino Natoli, classe 1817. Per decreto del “Generale Dittatore” il 3 novembre 1860 è nominato sottotenente della brigata Corrao. Lascerà il servizio e il grado il 27 novembre dello stesso anno. A Lipari farà il negoziante e morirà a 86 anni il 21 agosto del 1903. Il figlio Giuseppe morirà ad Aspromonte il 30 agosto 1862. La documentazione in Giuseppe Iacolino, indedito cit., Quaderno VII, pp.219 a-b.
Milazzo
La rivoluzione del 1848
"Sicilia all'armi!"

La rivoluzione a Palermo nel 1848
La prima a partire fu Messina. All'alba del 3 giugno 1847, nel giorno della festa cittadina della Madonna della Lettera, la statua di bronzo del re, che era in piazza Duomo, oggi in via Garibaldi, appariva con le orecchie tappate da bambagia e con la benda agli occhi, ad indicare che Ferdinando era sordo alle richieste dei siciliani e cieco perché non vedeva quale era la situazione. Era un primo segnale che qualcosa bolliva in pentola. E ciò a cui ci si apprestava era una insurrezione che sarebbe dovuta scoppiare congiuntamente il 2 settembre a Messina e Reggio Calabria. Ma l’1 settembre si presentò l’occasione di catturare tutto lo stato maggiore borbonico in un colpo solo,e quindi si decise di anticipare gli eventi. Il 1° Settembre 1847 alle ore sei del pomeriggio cinque gruppi partirono da diversi punti della città chiamando alle armi tutti i cittadini. Gli ufficiali, avvertiti tempestivamente della rivolta, erano scappati per rifugiarsi nei quartieri militari e nelle fortezze. In un primo tempo i messinesi sembrarono avere la meglio. Erano numerosi quanti dalla marina si dirigevano al forte ed avevano occupato diversi posti doganali. Ma poi l’esercito ebbe la meglio ed a sera la rivolta era stroncata. Gli insorti trovarono riparo e ospitalità sui colli della città e malgrado gli ufficiali borbonici incitassero i cittadini a denunciare gli insorti, con una taglia di 300 ducati per ogni ribelle ucciso e 1.000 ducati per ogni ribelle catturato, nessuno fece denuncia. Non solo ma lo sdegno popolare si radicò e assunse forme pubbliche di contestazione quando si cercò di far passare la rivolta per opera di alcuni pazzi.
 Allegoria. La Sicilia butta Pulcinella che raffigura i Borbone napoletano a mare.
Allegoria. La Sicilia butta Pulcinella che raffigura i Borbone napoletano a mare.
La mattina del 9 gennaio 1848 per le strade di Palermo apparve un manifesto. Esso diceva:
“ Siciliani! Il tempo delle preghiere inutilmente passò, inutili le proteste, le suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando tutto ha spezzato. E noi popolo nato libero, ridotto fra catene e nella miseria, ardiremo ancora a riconquistare i legittimi diritti. All’armi figli della Sicilia! La forza dei popoli è onnipossente: l’unirsi dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 gennaio, all’alba, segnerà l’epoca gloriosa della universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quanti siciliani armati si presenteranno a sostegno della causa comune, a stabilire riforme ed istituzioni analoghe al progresso del secolo, volute dall’Europa, dall’Italia, da Pio IX. Unione, ordine, subordinazione ai capi, rispetto a tutte le proprietà. Il furto si dichiara tradimento alla causa della patria e come tale punito. Chi sarà mancante di mezzi ne sarà provveduto. Con questi principi il cielo seconderà la giustissima impresa. Sicilia, all’armi!”
.
 La lapide che ricorda i moti a Messina
La lapide che ricorda i moti a Messina
Era l’annuncio di quella rivoluzione siciliana che inaugurerà i moti del 1848. A questo ne seguono altri il giorno dopo, che invitano i cittadini a scendere per le strade all’alba del 12 con le armi. Ma è una rivoluzione improvvisata. E questo apparirà chiaro proprio la mattina del 12 quando un gruppetto di cittadini armati alla meno peggio diede inizio alla rivolta. Sulla tarda mattinata la cavalleria attacca la folla che inneggiava a Pio IX e non riesce a disperderla anzi un ufficiale rimane ferito e 10-11 soldati uccisi. Quindi è costretta a ripiegare. E’ questa la molla che fa divampare la rivolta. Battere i soldati è possibile! E come se si fosse dato fuoco ad una polveriera la rivolta dilaga nella provincia e nelle campagne. Giungono a Palermo per unirsi ai popolani rivoltosi aristocratici, intellettuali, borghesi, possidenti, contadini. Gli scontri durarono una decina di giorni e i rivoltosi si impadronirono di gran parte della città. A presiedere il Comitato Generale venne designato Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, un anziano liberale, già brigadiere della marina napoleonica e ministro nel governo del 1812.
I Borboni tentano una contromossa facendo giungere da Napoli rinforzi con cinquemila uomini ma questi non riuscirono a collegarsi con le truppe assediate a palazzo reale e il 26 gennaio furono costrette ad abbandonare le posizioni e fuggire per Napoli.
Alla notizia dei fatti di Palermo insorsero anche Messina, Catania e via via tutte le città dell’isola.
A Messina il 28 gennaio un comitato di 300 cittadini pubblicò un proclama: "All'armi ai messinesi! ecco il giorno tanto sospirato! Siete tutti ormai armati e organizzati. Messina che diè prima il segno dell'insurrezione finisce in questo giorno la grande Rivoluzione Siciliana, trionfante per opera dell'immortale Palermo. Pronti alla difesa, pronti al fuoco, se una mano di capi pazzi e venduti, un armento di ciechi soldati, che son trascinati come vittime al macello, tenteranno di turbare la gioia cittadina del trionfo siciliano"[1].
Il giorno dopo i messinesi scesero in piazza. I soldati sparavano sulla città dai forti e alle 23 entrarono in città. Fu una battaglia feroce soldati contro cittadini. I reparti sconfitti si ritirarono scappando nel campo d'armi di Terranova, dove adesso c'è la stazione ferroviaria. I combattimenti durarono molti giorni a Messina, ma alla fine il popolo ebbe la meglio. In meno di un mese la Sicilia fu in mano al governo provvisorio meno la cittadella di Messina.


Palermo. Combattimenti di fronte alla Cattedrale
Una miccia che si propagò in tutta Europa
Quella della Sicilia fu la miccia che si propagò per tutta l’Europa. Il 10 febbraio insorse Napoli malgrado re Ferdinando - lo stesso giorno, pressato dagli inglesi -, avesse in tutta fretta promulgato una Costituzione; il 15 Firenze, il 27 Parigi, i 5 marzo Torino, il 14 Roma, il 15 Vienna e Budapest, il 19 Berlino, il 22 Venezia, il 23 Milano.
Sempre su pressione degli inglesi, e cioè degli ambasciatori Napier e Minto, Ferdinando estende la costituzione napoletana anche alla Sicilia ma il Comitato rivoluzionario la rifiutò con una motivazione che dice chiaramente come quella siciliana era soprattutto una rivoluzione per l’autonomia della Sicilia ed il vero nemico non era il re ma il governo di Napoli. Infatti i siciliani non avevano mai digerito che Ferdinando, dopo il Congresso di Vienna, avesse riunificato i regni stabilendo la capitale a Napoli ed avesse abolito il Parlamento siciliano e la costituzione del 1812.
Ecco, in sintesi, la risposta del Comitato siciliano:
“1. Che il Re avesse ripreso l’antico titolo di re delle Due Sicilie (e non del Regno delle Due Sicilie). 2. Che il suo rappresentante in Sicilia si fosse chiamato Vicerè e che fosse un membro della famiglia reale o un siciliano. 3. Che l’atto di convocazione del Parlamento, facesse parte della costituzione. 4. Che gli impieghi civili, militari ed ecclesiastici fossero appannaggio dei siciliani. 5. Che si consegnasse alla Sicilia la quarta parte della flotta, delle armi e del materiale di guerra o l’equivalente in denaro. 6. Che fossero restituiti i battelli doganali e postali acquistati per conto della Sicilia. 7. Che gli affari d’interesse comune fossero trattati e determinati dai due parlamenti. 8. Che in una lega politica o commerciale degli Stati italiani vi dovesse essere rappresentata la Sicilia come Stato indipendente. 9. Che la Sicilia potesse coniare moneta”[2].
Il 22 marzo Ferdinando respinge le proposte e provocatoriamente fa notare che con le loro richieste di autonomia, i siciliani andavano contro lo spirito risorgimentale e di fratellanza che traversava l’Italia intera. Ora il Comitato deve decidere se andare avanti o tornare sui propri passi. E decide di andare avanti dichiarando Ferdinando e la dinastia dei Borbone decaduti dal trono di Sicilia, affermando che la Sicilia si reggerà con un governo costituzionale e che sarebbe stato chiamato al trono un principe italiano dopo che si sarà definito lo statuto.
 Ferdinando di Borbone
Ferdinando di Borbone
La costituzione fu emanata il 10 luglio ed era , per i tempi, fortemente ispirata ad una concezione liberal-democratica, ma la ricerca di un principe italiano disposto ad assumersi la guida di Sicilia non approdò a nulla. Intanto l’esercito napoletano il 7 di settembre dopo tre giorni di bombardamenti occupò Messina ed il 9 la fortezza di Milazzo. Il 22 aprile 1849 il governo di Ruggero Settimo rassegnò le dimissioni, il primo maggio Palermo offrì la capitolazione alle truppe napoletane al comando del colonnello Nunziante ed il 15 maggio i Borboni avevano nuovamente il pieno controllo dell’isola. La rivoluzione siciliana era durata circa 16 mesi. Il re offrì amnistia generale salvo 43 esponenti della rivoluzione. La maggior parte di loro si imbarcò per Genova e parecchi di essi , undici anni più tardi, furono alla base della spedizione dei mille. Ruggero Settimo invece riparò a Malta dove venne accolto con onori di un sovrano.[3]
La rivoluzione del 1848 a Lipari
Come vissero i liparesi i fatti di Messina e di Palermo? Non ci sono narrazioni che riguardano quei mesi ma solo degli indizi che ci fanno comprendere che anche Lipari partecipò agli eventi anche se forse senza momenti di tensioni.
Anche a Lipari, come in altre parti della Sicilia e d’Italia, si era costituito un gruppo rivoluzionario clandestino in contatto con il Comitato rivoluzionario di Palermo. La persona più attiva era certamente Giovanni Canale[4],coadiuvato da Giovanni Amendola, di quindici anni più anziano, cognato del prof. Serafino De Angelis. Del comitato dovevano far parte anche don Filippo de Pasquale e il De Angelis.
Ci fu un cambiamento di amministrazione. Decadde il sindaco don Giuseppe Milio e per due mesi, da metà luglio a tutto settembre del 1848, i poteri furono assunti dal barone avv. Leopoldo Rodriquez[5] in qualità di presidente del Magistrato Municipale quindi divenne sindaco e vi rimase fino al 1855. In città inoltre fu costituita la Guardia nazionale. Erano dei corpi militari formati da giovani di famiglie nobili e borghesi, col compito di mantenere l’ordine pubblico. Questa istituzione ereditata dalla Francia rivoluzionaria in Italia si affermò proprio in occasione dei moti del 1848, si ripresentò nel 1860 fino a quando il governo italiano la sciolse decisamente nel 1867.
La guardia urbana
Della guardia nazionale, o meglio urbana come veniva chiamata, liparese del 1848 si conoscono due nominativi del tenente Emanuele Carnevale[6], che la comandava, e del caporale Giovanni Bongiorno della classe del 1823.
Comunque alcune giornate di turbolenza Lipari dovette viverle perché questo risulta da due comunicazioni del vescovo del tempo che era mons. Bonaventura Attanasio[7]. Nella relazione del 1854 alla Santa Sede egli confessa di essersi allontanato dalla sede durante le “vicissitudini” del 1848 e più avanti aggiunge che quello fu un anno di “turbolentissima tempesta” (turbolentissima erupit tempestas”) che distrusse il lavoro fatto[8]. Ancora ad una nota del 12 novembre del 1849 del luogotenente generale di Palermo che invitava mons. Attanasio a ripristinare gli stemmi reali, questi rispondeva che si era provveduto a rimettere quelli che “n’ tempi del disordine venivano tolti”[9].
Alla rivoluzione parteciparono anche alcuni personaggi della comunità eoliana che in quel periodo erano assenti da Lipari. Vi partecipò sicuramente don Filippo De Pasquale, già sindaco di Lipari, che in quel periodo era a Palermo ed entrò a fare parte del nuovo Parlamento siciliano che si era riunito solennemente nella Chiesa di S. Domenico il 25 marzo del 1848 e che il 13 aprile approvò la dichiarazione della decadenza della dinastia borbonica dal regno di Sicilia. Il De Pasquale in quegli anni strinse rapporti e rinsaldò antichi legami con Ruggero Settimo, Giuseppe La Farina, Vincenzo Florio, Francesco Crispi, Michele e Enrico Amari e altri personaggi che avevano fatto la rivoluzione e che saranno poi al centro di vicende della nostra storia nazionale. Dovette parteciparvi anche Giovanni Canale[10] che farà parte delle formazioni garibaldine e che in quei mesi risultava assente da Lipari.
Durante i mesi della rivoluzione Lipari rimase priva dei regolari collegamenti con la terraferma giacchè alcuni battelli erano stati requisiti dal governo di Napoli ed altri, come il Giglio dell’Onde e il Vesuvio, dagli insorti siciliani.

Mons. Bonaventura Attanasio
E proprio il Giglio e il Vesuvio furono protagonisti dell’unica vicenda della rivoluzione che in qualche modo tocca le Eolie ed in particolare Stromboli. Il 12 giugno del 1848 i due piroscafi partono da Milazzo con a bordo un corpo di volontari, 624 uomini in tutto, per andare , muniti di cannoni e con dodici muli, a Bagnara a dare man forte ai liberali calabresi insorti. Ma lungo il tragitto vengono avvistati da navi armate napoletane che uscivano da Pizzo. I due piroscafi con gli insorti per non essere intercettati si rifugiano a Stromboli dove rimangono nascosti per tutta la giornata del 13. Ma ad una certa ora della giornata il comandante, che era il nizzardo Ignazio Ribotti, e gli ufficiali che si trovavano sul Giglio vengono richiamati da clamori che si levavano dal Vesuvio. Accostano e scoprono che è in corso una discussione vivace fra chi volevano procedere verso l’obiettivo, ed erano la gran parte, ed i pochi invece che volevano tornare indietro. Il comandante decide che chi vuole proseguire lo faccia con il Vesuvio e chi invece vuole tornare trasbordi sul Giglio che sarebbe andato a Milazzo. E così undici ufficiali trasbordarono “accompagnati da fischi e da urli di disprezzo[11]”.
Quando ,conclusa la rivoluzione, arrivò il momento della repressione poliziesca , questa si fece sentire anche a Lipari. Si ha notizia che furono colpiti anche dei monaci dei Minori Osservanti, come un certo padre Calcedonio da Lipari le cui responsabilità il suo superiore cercava di ridimensionare sostenendo che quello che aveva agito per “ignoranza e leggerezza” e che era uno che “aveva il vizio di parlare troppo”.
Inoltre a Lipari arrivò un nuovo stuolo di detenuti, delinquenti comuni e esiliati politici, fra cui diversi ecclesiastici che erano obbligati a dimorare nei due conventi sotto la responsabilità del vescovo.
[2] Le condizioni per intero si possono leggere nel testo “Memorie” di Fardella di Torrearsa, riportate da Renda in Storia di Sicilia , 2° volume. Pag 932, edizioni Sellerio.
[3] Per la redazione di questo paragrafo abbiamo consultato F.Renda, Storia della Sicilia, Palermo 2003; R.Romeo, il risorgimento in Italia, Laterza, 1950; W. Dickinson, Patriotti e galeotti, Sicilia 1848. Diario di una rivoluzione, 2003. F.Misuraza e Alfonso Grasso, Il regno siculo-partenopeo tra il 1821 ed il 1848, Parte I e II in “Brigantino- Il portale del Sud”, www.ilportaledelsud.org. ; R. Baeli in www.messinacity.com .
[4] Giovanni Canale di Zaccaria e Maria Rodriquez era nato a Lipari il 28 settembre 1823. Morirà in Lipari il 26 aprile 1887.
[5] Leopoldo Rodriquez era figlio del barone don Giovanni Antonio e di donna Maria Odavene e fratello di quel can. Carlo Rodriquez che abbiamo già incontrato.
[6] Emanuele Carnevale di Onofrio e di donna Giovanna Salpietro nacque a Lipari il 25 luglio 1827 e morì il 13 novembre 1873. Abitava nella villa di S. Lucia oggi villa Lo Cascio.
[7] Mons. Bonaventura Attanasio era nato a Lucera in provincia di Foggia il 13 ottobre 1807. Fu nominato vescovo il 22 luglio del 1844 e giunse a Lipari nei primi di marzo del 1845. Notevole fu la sua attività sia sul piano della cura degli edifici di culto come del patrimonio della mensa, sia in ordine all’attività pastorale dedicando molto spazio alla visita nelle chiese sia di Lipari che delle isole e garantendo che tutte le chiese avessero almeno un prete. Aprì finalmente il seminario che era stata l’aspirazione di molti vescovi ,restaurando l’edificio destinato da mons. Coppola a Conservatorio femminile; realizzò l’ampliamento del Palazzo vescovile di Diana; fece costruire la chiesa nuova a Quattropani e quella di S. Gaetano a Rinella. Nell’ottobre del 1857 rassegnò le dimissioni da vescovo di Lipari che furono accettate purchè rimanesse a reggere la diocesi di Lipari fino all’arrivo del successore per evitare la “vacanza di Sede”. Il successore fu mons. Ludovico Ideo che venne nominato il 25 giugno del 1858. Dopo aver lasciato Lipari mons. Attanasio si ritirò a Napoli dove Ferdinando II lo nominò Presidente della Pubblica Istruzione del Regno. Collaborò inoltre con l’Arcivescovo di Napoli nelle opere caritative a favore dei malati di colera. Fondò nel 1861 la Pia unione di Gesù crocifisso per la conservazione della Fede e della Pietà. Mori a Napoli il 3 settembre del 1877.
[8] Relatio status Liparensis Ecclesiae, anno 1854, in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff. 192 e 193.
[9] Archivio Vescovile, Carpetta Corrispondenza D. Circa il lavoro fatto che era andato in fumo, l’Attanasio si riferisce, fra l’altro, all’iniziativa, verso la fine del 1846, di “radunare in un’unica casa e sotto la vigilanza diretta di due donne di provata integrità, ventidue donne che vivevano nell’immoralità e nel peccato. …per lo spazio di circa sedici mesi io a quelle fornivo e gli alimenti e ogni altra cosa necessari”. Come anche all’aver fatto venire sei sacerdoti Redentoristi che per quasi sei mesi predicarono missioni nella città e nelle isole.Archivio Segreto del Vaticano, Relatio status Liparensis eccl. Cass. 456 B, ff.196 e 193.
[10] Giovanni Canale di Zaccaria e Maria Rodriquez era nato a Lipari il 28 settembre 1823 e proprio il 28 novembre del 1848 si sposa per procura con donna Marianna Favaloro. Torna a Lipari solo nei primi mesi del 1849 per dichiarare la nascita della primogenita.
[11] T. Landi, Memorie di Calabria, Ricordi della spedizione di Sicilia in Calabria nel 1848, in F.Giannetto, Memoria indedita di Tommaso Landi sulla spedizione siciliana del 1848 in Calabria, in “Messina e la Calabria”, Atti del I Colloquio Calabro-Siculo, Reggio C.- Messina, nov. 1986, Messina 1988, pp586-87.
Serafino De Angelis
Un complotto contro il vescovo che voleva riformare la raccolta delle decime
L’epidemia di colera

Comunque già il 1832 si apriva all’insegna di un ben più grave problema che doveva impegnare il nuovo vescovo, l’amministrazione comunale e la popolazione di Lipari ed era il manifestarsi anche nelle Eolie – e forse prima che in altre parti d’Italia - di quell’epidemia di colera che proprio in quegli anni terrorizzava l’Europa ed il mondo intero.
Era dal 1817 che si parlava nel mondo di questa malattia, da quando cioè era uscita dei confini storici dell’India e dalla regione del Bengala in particolare. Indubbiamente l’incremento dei traffici e dei trasporti sia per ferrovia, sia per la navigazione a vapore, favorì la diffusione anche se non si comprendeva in che consistesse questo morbo, quale ne fosse la causa e come si propagasse. Comunque nel 1831 arrivò in Inghilterra, Ungheria e Germania e nel 1832 a Parigi. Si dice che in Italia il colera si affacciò per la prima volta nel luglio del 1835 probabilmente portato per via di mare da un gruppo di contrabbandieri provenienti dai territori d’oltralpe e entrati nel Regno di Sardegna dopo aver infranto il cordone sanitario[1]. Se questo è vero, Lipari dovette vivere l’esperienza in anteprima, nel febbraio del 1832, anche qui arrivata attraverso contrabbandieri. Infatti è l’anonimo cronista che ci informa che “in febbraio per certi contrabbandi sviluppassi in questa Città una febbre epidemica contagiosa”[2] .Nel 1832 i morti furono 213 in più dell’anno precedente. E il morbo non risparmiò nessuno anche se furono colpite più le donne che gli uomini. Ma comunque tutte le classi sociali pagarono il loro tributo: morirono filandiere, contadini, operai ma anche notabili ed esponenti del clero.
E come succede quando un pericolo giunge all’improvviso ignorandone la causa ed il modo per combatterlo, il popolo chiese aiuto alla religione affollando le chiese ed aiuto alla preghiera chiese anche il governo. Infatti il vescovo di Lipari ricevette il 14 Maggio del 1832 un dispaccio a nome del re nel quale si sollecitavano i prelati “a raddoppiare nelle Chiese delle rispettive Diocesi fervide preci all’altissimo onde impetrare dalla Divina misericordia la cessazione di un tanto flagello”[3].

Alexandre Dumas in un dipinto della gioventù.
Nell’ottobre del 1835 quando lo scrittore francese Alexandre Dumas e il suo compagno visitano Lipari la paura del colera è ancora forte tanto che per fare verificare i passaporti li dovettero passare attraverso una inferriata ed essi “ci furono presi dalle mani con delle pinze gigantesche” e dovettero dimostrare che venivano da Palermo e non da Alessandria o Tunisi. Solo allora “aprirono il cancello e consentirono a lasciarci passare”.
E se anche le morti non toccarono più le cifre del 1832 il colera continuò a farsi sentire ad intervalli come nel 1840 con un centinaio di morti oltre la media annuale e nel 1834 con circa centocinquanta in più[4]. Comunque il 1855 fu salutato come l’anno della fine del “colera morbus” e considerato che i danni che avevano colpito i liparesi erano abbastanza contenuti rispetto a quelli di cui si diceva nel resto del mondo, il vescovo e la civica amministrazione decisero di ringraziare San Bartolomeo con una nuova statua di marmo al posto di quella collocata nel 1813, la costruzione di un piedistallo in cui vennero affisse due epigrafi in marmo, una del vescovo ed una del Comune il tutto salvaguardata da una cancellata di ferro donata da don Onofrio Paino[5].
Si supera la crittogama
Il 1855 fu salutato a Lipari come l’anno della liberazione da un altro malanno. Questo non colpiva le persone ma la vite che era una delle principali risorse dell’arcipelago. Era il male della crittogama un fungo riscontrabile come un pulviscolo biancastro e per questo si chiama anche “mal bianco”. Nella vite porta al rallentamento della crescita ed alla perdita del raccolto. Nelle Eolie questo flagello aveva imperversato a lungo, come appunto il colera. Si era manifestato nel 1831 e si era trascinato fino al 1854. A Lipari però era giunto solo nel 1853 ed aveva subito creato gravi problemi negli strati più miseri della popolazione tanto che il vescovo, proprio quell’anno, chiedeva al Governo “un soccorso” economico per far fronte agli effetti della “ sperimentata malattia della vite detta crittogama” ed otteneva in risposta 3.500 ducati che spendeva tutti in elemosina ed acquisto di cereali per i poveri[6].
Nel marzo dello stesso anno era giunta la notizia che in Italia era stato trovato un rimedio: cospargere la vite di zolfo polverizzato. Ma a Lipari, come del resto nel resto del regno, si era piuttosto scettici. Cominciò per primo don Filippo De Pasquale con molta circospezione. E visto il buon risultato fu subito seguito da alcuni mentre altri continuarono a rimanere scettici. Così si liberò del male solo parte dell’isola di Lipari. La strada però era stata tracciata[7].
Il complotto contro il vescovo
Nella storia delle Eolie i tentativi riusciti o meno di risolvere con la soppressione fisica dell’avversario delle controversie, sono piuttosto rari. Abbiamo visto il caso di un vescovo che ferì a morte il governatore della città ma dovette trattarsi di un atto inconsulto determinato dall’ira. Ma che si ordisca un complotto per uccidere il vescovo, quello che accadde nel 1840, è un caso più unico che raro. Eppure come vedremo forse non rimase isolato nei decenni che seguirono. Sarà stato il fatto che gli interessi cominciavano a farsi sostanziosi e con essi cresceva anche la propensione a tutelarli e difenderli. Sarà stata la prossimità con la delinquenza comune che rendeva più facile ricorrere alla violenza affidandola a terzi. Comunque sia, questo episodio ha diversi elementi che lo rimandano ad un’azione di tipo mafioso. C’è un notabile locale che vuole difendere i suoi interessi che vede minacciati e lo fa ricorrendo alla violenza. Può farlo perché è inserito in una rete di protezioni che arrivano sino ai pubblici poteri. C’è una manovalanza criminale che sembra a disposizione. C’è un’opinione pubblica praticamente inesistente. Non perché mancassero personalità di spicco[8] ma perché la gran massa era chiusa nel proprio “particolare” e uno dei problemi più avvertiti era quello di liberarsi dal peso dei censi e delle decime dovuti alla mensa vescovile. Di questo evento si sa quasi tutto almeno per quanto riguarda la sua programmazione. Ciò che manca, come in molti casi di stampo mafioso, è la parte conclusiva: il trionfo della giustizia. Ma andiamo per ordine.

Il Vescovo Mons. Giovanni Proto
E cominciamo dalla vittima che è mons. Giovanni Proto[9] divenuto vescovo di Lipari il 18 febbraio del 1839. Mons. Proto era un uomo inflessibile e intransigente. Lo era con il clero a cui rimproverava di essere ozioso e infingardo dimenticando il dovere della carità[10], lo era con i proprietari terrieri a cui non perdonò il fatto che avessero messo in discussione i diritti della Mensa vescovile circa i censi e le decime. Non era quindi improbabile che si attirasse antipatie ed anche odio. Ma chi pensò a sopprimerlo – almeno per quello che sembrò emergere dalle indagini -fu un personaggio importante della Lipari d’allora che abbiamo già incontrato nel nostro racconto e cioè don Onofrio Paino[11], detto “don ‘Nofriu ‘u pirata”, figlio di quell’Antonio Paino che si era arricchito con il commercio, e fratello del canonico Antonio, nominato esattore delle decime e dei censi da parte del predecessore di Giovanni Proto. E sembra che fosse proprio il fatto che il vescovo fosse addivenuto alla determinazione di revocare quell’appalto alla scadenza del contratto e cioè il successivo autunno, che fece scattare nel Paino - personaggio senza scrupoli, assai influente con amicizie altolocate e dalle risorse economiche illimitate - la determinazione di sopprimere il vescovo. Il Paino chiama il chierico Giovanni Cafarella e don Felice Franza e da loro l’incarico di trovare il sicario. E la scelta cade su un confinato coatto, tal Filippo Pucci. A questo erano stati promessi cento onze oltre l’impunità e la fuga dall’isola verso la Calabria o altre destinazione di suo gradimento. Ma il Pucci tergiversa per tre mesi, infine, messo alle strette dal Franza e dal Cafarella, forse temendo di essere scoperto, il 28 agosto preferisce vuotare il sacco denunciando mandante ed intermediari.
Don 'Nofriu u pirata

Onofrio Pajno detto 'Nofriu u pirata
Informato, il vescovo scrive subito al Ministro di Polizia, al Ministro degli affari ecclesiastici, al Luogotenente generale ed al Procuratore generale e chiama in causa non solo Onofrio ed il can. Antonio ma anche l’altro fratello Giuseppe che ambivano, insieme, a divenire “gli arbitri della mia Chiesa”. Ed avendo – sostiene il prelato - colto le loro mire ed avendoli allontanati dall’episcopio essi adoperarono ogni mezzo per togliergli la pace e minacciarlo. Ma il più determinato è il mercante Onofrio che si è arricchito come gabelliere della Mensa ed ora non vuole lasciare questo incarico e spera o nel trasferimento del vescovo o nella sua morte. Ed è per questo che ha messo a disposizione 300 onze per il complotto. Onofrio si sente intoccabile da quando si guadagnò l’impunità per dei fatti accaduti il 5 marzo[12] usando la “via dell’oro” e la via della “protezione smodata” dell’Intendente Commendatore De Liguori lautamente foraggiato dalla “casa Paino”. E sicuramente questo Intendente farà di tutto per assecondare il Paino anche in questa situazione.[13]
La lettera provocò una serie di risposte rassicuranti. Stesse sicuro il vescovo, giustizia sarebbe stata fatta. Invece le cose andarono come lui aveva previsto. Già la nota del 16 settembre 1840 del Ministro della Polizia Generale di Lavori lasciava intravedere come la vicenda si sarebbe conclusa.
“Quantunque – si diceva in questa nota – fino a questo momento tutto sia basato sull’assertura di esso Pucci, pur troppo noto per diffamato carattere e perversa indole. Io dal mio canto ho inculcato all’Intendente medesimo di agire nel riscontro con ogni efficacia, e di dare quelle provvidenze che si convengono onde tranquillizzare quel Prelato; e poiché avea egli già disposto la traduzione in carcere del Pucci in Messina, io ho pure prescritto di farvelo rimanere, sotto il medesimo modo di custodia, fino a che non si sarebbe interamente acclarata la faccenda”.
Cosa che non avvenne mai e presto tutta la faccenda venne dimenticata.
 Ma mentre mons. Proto doveva combattere su un fronte con don ‘Nofriu ‘u pirata che non voleva perdere l’incarico di gabelliere della mensa, dall’altra doveva contendere col sindaco di Lipari, don Filippo De Pasquale che propugnava il diritto dei contadini delle isole minori di affrancarsi dal peso delle decime e delle gabelle vescovili ritenute un avanzo della feudalità abolita con le leggi del 1812 e poi, ancora più chiaramente, con i decreti del 1841. Scrisse così una memoria “Su’ diritti della Chiesa di Lipari”[14]. La tesi sostenuta dal vescovo era che il diritto dei prelati liparesi non era frutto di un feudo ma di una donazione di terre che non erano proprietà di alcuno, donazione che i principi normanni avevano fatto agli abati benedettini e quindi alla Mensa dei vescovi che agli abati erano succeduti. Una donazione puramente civile senza implicanze politiche giacchè il re rimaneva il sovrano e il vescovo solo un possessore. Da qui derivava il diritto alle decime ed ai censi enfiteutici con i quali si provvedeva ai cappellani, al culto divino , ad un gran numero di poveri con onze 400 ogni anno, a trovatelli con onze 50, alle missioni nelle isole adiacenti e a tanti altri carichi della cura d’anime. Le entrate bastavano appena a questo scopo e se qualcosa avanza andava subito in beneficenza.
Ma mentre mons. Proto doveva combattere su un fronte con don ‘Nofriu ‘u pirata che non voleva perdere l’incarico di gabelliere della mensa, dall’altra doveva contendere col sindaco di Lipari, don Filippo De Pasquale che propugnava il diritto dei contadini delle isole minori di affrancarsi dal peso delle decime e delle gabelle vescovili ritenute un avanzo della feudalità abolita con le leggi del 1812 e poi, ancora più chiaramente, con i decreti del 1841. Scrisse così una memoria “Su’ diritti della Chiesa di Lipari”[14]. La tesi sostenuta dal vescovo era che il diritto dei prelati liparesi non era frutto di un feudo ma di una donazione di terre che non erano proprietà di alcuno, donazione che i principi normanni avevano fatto agli abati benedettini e quindi alla Mensa dei vescovi che agli abati erano succeduti. Una donazione puramente civile senza implicanze politiche giacchè il re rimaneva il sovrano e il vescovo solo un possessore. Da qui derivava il diritto alle decime ed ai censi enfiteutici con i quali si provvedeva ai cappellani, al culto divino , ad un gran numero di poveri con onze 400 ogni anno, a trovatelli con onze 50, alle missioni nelle isole adiacenti e a tanti altri carichi della cura d’anime. Le entrate bastavano appena a questo scopo e se qualcosa avanza andava subito in beneficenza.
Comunque lo scontro divenne durissimo tanto che re e papa di comune accordo decisero di trasferire mons. Proto a Cefalù e questo avvenne con bolla pontificia del 17 giugno 1844.
[1] E. Tognotti, Il morbo asiatico. Storia del colera in Italia, Roma-Bari 2000
[2] Dal manoscritto di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, pag. 612.
[3] Archivio vescovile, Carpetta corrispondenze D.
[4] Dai registri dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Lipari riportati da G.Iacolino in manoscritto, cit. , Quaderno VI, pag. 294. Sull’argomento nel 1844 il dottor don Ferdinando Rodriquez pubblicò una “Lezione pratico-clinica per gli addiscenti in medicina sull’epidemia morbillosa avvenuta nel 1844 in Lipari”, Messina, Stamperia Fiumara, 1844.
[5] Manoscritto di proprietà della famiglia Luigi Mancuso, pag. 627 e ss. Quando nel 1939 si procedette al riassetto della piazza che allora era chiamata del Commercio fu spostata la statua dal centro nella posizione in cui si trova oggi, fu rifatto il basamento e venne tolta la cancellata.
[6] Dal verbale del Consiglio Comunale di Lipari dell’’11 marzo 1859. Archivio del Comune di Lipari.
[7] Manoscritto cit, idem.
[8] Fra le personalità di spicco del periodo oltre al can. Carlo Rodriquez di cui abbiamo detto; ricordiamo il giurista e principe del foro avv. Giuseppe Pisano Rodriquez che aveva pubblicato nel 1838 un’opera in più volumi dal titolo “Studio di giurisprudenza (edito dalla Real Stamperia di Palermo) e alcuni testi per il teatro; don Serafino De Angelis che insegnava retorica e filosofia nel Ginnasio vescovile di Lipari e si dilettava di poesia traducendo in versi quattro libri dell’Eneide e le Confessioni di S. Agostino; don Giovanni Amendola anche lui scrittore di testi teatrali che si rappresentavano a Lipari; don Filippo de Pasquale sindaco di Lipari dal 1837 al 1840. Queste notizie in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag 287, 287a-c.
[9] Mons. Giovanni Proto, dell’ordine dei benedettini cassinesi, nacque a Milazzo il 15 febbraio del 1781. Prima di essere nominato vescovo di Lipari occupò diversi incarichi di prestigio e fra l’altro fu abate di San Paolo fuori le mura a Roma e visitatore generale per la Sicilia. Fu nominato vescovo di Lipari il 18 febbraio 1839 e si distinse per l’impegno profuso a restituire decoro alle chiese a cominciare dalla Cattedrale ed alle scuole che riordinò aprendo una nuova scuola , il Ginnasio vescovile .Essendo ormai disabitato il Conservatorio si adoperò perché si desse vita al Seminario giacchè una delle sue preoccupazioni maggiori era la formazione del clero. Ripristinò e ridisciplinò le cinque confraternite locali: S. Bartolomeo, Maria SS Addolorata, S. Giuseppe. S. Pietro e Maria SS del Rosario. Delle cinque feste dedicate a S. Bartolomeo ne abolì due: quella del 17 giugno per lo scampato pericolo dalla pestilenza del 1541 e dell’11 gennaio relativa al grande terremoto del 1693. Morì a Cefalù contagiato dal colera il 13 ottobre del 1854.
[10] “…l’ozio e la infingardaggine ch’esiste nei Sacerdoti dei tempi presenti li rende dimentichi di quel dovere di carità che continuamente l’invita a procurare la salute de’ Cristiani ancor in quel momento fatale da cui dipende l’eternità. Non poche querimonie, nel corso di questa santa Visitazione, sono de’ fedeli a noi portate per lo scandaloso rifiuto che danno i Cappellani ed i Sacerdoti a coloro i quali li scongiurano a correre al letto dei fratelli che agonizzano”. Raccolta di alcune notificazioni, editti, istruzioni e decreti pubblicate per buon governo della sua Diocesi dall’Ill.mo e Rev. Mo Monsignor D. Visconte Maria Proto Cassinese Vescovo di Lipari, Napoli 1840 ( se ne conserva copia nella Biblioteca Ursino di Catania); G.Iacolino. manoscritto cit., Quaderno VI, pp. 285,285°.
[11] Onofrio Paino era nato a Lipari il 28 dicembre del 1799. Utilizzò le risorse paterne e materne per farne la base di un nuovo arricchimento trafficando anche nel campo dell’usura, del contrabbando e della rapina sul mare. Aveva agenzie oltre che a Lipari a Messina, Palermo e Napoli. A Napoli aveva libero accesso alla casa reale prestando denaro allo stesso re Ferdinando II. Fu molto influente nella Lipari borbonica e determinante anche nel voto cittadino. Fu molto devoto ai santi ed alle chiese con particolare predilezione verso il convento dei Cappuccini. Ma la sua religiosità passava in secondo piano se si mettevano in discussione i suoi interessi finanziari. Grazie alla liquidazione della proprietà ecclesiastica nel primo decennio dell’Unità d’Italia incrementò notevolmente il suo patrimonio che ammontò ad un milione di lire. La sua abitazione in Strada Santo Pietro oggi via Maurolico aveva addobbi degni di una reggia. Le posate, tutte d’argento, avevano le sue iniziali come le cristallerie e le tazze da caffè. Sotto casa, nei magazzini vi era il deposito dell’abbondanza. Gli appartenevano anche i magazzini che erano a fianco e sotto la chiesa delle Anime del Purgatorio ed erano sempre stracolme di mercanzie in arrivo destinate ad essere esportate. Morì a Lipari il 30 luglio 1872. (G. Iacolino, manoscritto cit,, Quaderno VI, pp. 299 a-b.
[12] Il Proto non dice e noi non sappiamo quali fatti siano quelli accaduti il 5 marzo e citati nella lettera.
[13] Tutta la documentazione su questa vicenda si trova nell’Archivio Vescovile , Corrispondenze, Carpetta H.
[14] Tipografia Francesco Lao, Palermo 1842, pagine 38.
mons. Giovanni Proto
Un imprenditore coraggioso e un vescovo lungimirante
Vito Nunziante soldato e imprenditore

Napoli nei primi decenni dell'800
Intanto l’Europa assisteva. parte attonita e parte preoccupata, alle imprese di Napoleone Bonaparte. Sopratutto gli stati italiani si trovavano in grandi turbolenze politiche e il regno di Napoli era, insieme alla S. Sede, uno dei più travagliati. Ferdinando che era tornato a Napoli vedeva nuovamente in pericolo il trono e aveva messo completamente da parte le idee massoniche che lo avevano caratterizzato in passato. Ora si affidava ai vescovi perché gli garantissero preghiere e consenso sociale. Ed in questo senso scrisse anche il 23 settembre del 1805 al vescovo di Lipari e il vescovo, che era mons. Antonio Riggio[1], nell’ottobre del 1805 informava il re di avere dato vita ad una serie di iniziative - processione, prediche in Cattedrale e nelle chiese e nei conventi della città – per far “comprendere alla popolazione la spietata persecuzione cui soggiace l’attuale Sommo Pontefice” e “l’avvilimento cui è ridotta la Chiesa per opera di uno irreconciliabile inimico” e pregare “per ridurre i traviati al giusto sentiero e placare lo sdegno del Sommo Dio nell’attuale oppressione in cui languisce il Capo Visibile della Chiesa Cattolica, per la sicurezza dello Stato e conservazione della Maestà Vostra e dell’augusta Real famiglia[2]”.
Ma l’”irreconciliabile nemico”qualche mese dopo costringeva il re a fuggire nuovamente in Sicilia mentre a Napoli Napoleone insediava il proprio fratello Giuseppe. Il re a Palermo vive sotto la protezione degli inglesi ma anche nel timore che i francesi tentino un colpo di mano per prendere la Sicilia. E quale migliore base d’appoggio che quella delle Eolie per una operazione di questo tipo? E’ questa la paura che si vive a Palermo sul finire del 1808. E così il re incarica il sergente Vito Nunziante che comandava la guarnigione di Milazzo di andare a Lipari per consegnare al vescovo una sua missiva.
 Re Ferdinando
Re Ferdinando
Che cosa chiedeva Ferdinando? Che il vescovo si adoperasse per creare quattro o sei compagnie di cento persone ciascuna di volontari e riferisse, nel contempo sulle idee politiche dei liparesi. Vescovo di Lipari era divenuto nel frattempo mons. Silvestro Todaro[3], un monaco conventuale, mite e prudente, che prima di rispondere si guarda intorno, chiede, ascolta e poi prende la penna e scrive. Ci sono 8-900 giovani liparesi, la gioventù più robusta è coraggiosa, impiegata nella Regia Marina che, essendo impedito il commercio marittimo, è rimasta l’unica risorsa dei locali. Per il resto nelle isole si soffre una grandissima povertà e la gente, lavorando tutto il giorno, riesce a racimolare appena di che vivere. Quindi vi è molta ritrosia ad assumere impegni che possano distogliere da questo compito anche perché vi è il sospetto di essere poi spediti nella Sicilia e nelle Calabrie. Quanto alle “velenose massime che tanto hanno perturbato e perturbano l’Europa”, il re stia tranquillo, esse non sono approdate nelle Eolie e il popolo è fedele ed attaccatissimo al re.
Anzi per evitare qualsiasi rischio, visto che i mosaici delle terme erano continuamente visitati da turisti curiosi e da esperti anche forestieri che potevano dar luogo a qualche contagio con le “velenose massine” il vescovo aveva pensato bene di fare risotterrare le terme romane e così evitava anche le seccature di quelli che continuavano a disturbarlo per visitarle.
Finalmente si valorizzano le risorse di Vulcano
Non sappiamo se la missione di portare il messaggio del re al vescovo, fu anche l’occasione per conoscere le Eolie o Nunziante[4] già le conosceva. Il fatto è che da quel momento esse entrano nella sua vita di prepotenza e lui nella vita delle Eolie. A Lipari conosce una “leggiadra e ricca donzella”, forse di origine napoletana, Camilla Barresi ed il 4 agosto 1809 la sposa. Probabilmente mette casa a Lipari perché quando nel 1813 il vescovo Todaro, su autorizzazione del vicario regio in Sicilia, gli concederà un terreno in enfiteusi a Vulcano, nel contratto il Nunziante risulta “domiciliato in questo suddetto Comune di Lipari in questa medesima Marina di San Giovanni”[5].
Vito Nunziante
Questo terreno consiste in ventidue salmate e mezza di terra - che dal porto andava sino al cratere grande - con licenza di estrazione di minerali e dell’erezione di una cappella per la messa domenicale dei lavoratori. E alla conoscenza di Vulcano, delle sue risorse, e delle potenzialità di queste – nei quattro anni che vanno dal 1809 al 1813 il nostro tenente generale aveva dedicato diverse visite, diverse escursioni[6] magari anche con degli esperti magari provenienti dall’Inghilterra – visti i rapporti che aveva con gli alleati inglesi ed in particolare con il Lord William Bentick - dove vi erano industrie che producevano acido solforico e soda artificiale e usavano lo zolfo come materia prima.
Fino allora, come abbiamo visto, sempre i tentativi di creare attività estrattive o di coltivare i terreni di Vulcano da parte dei vescovi, erano fallite, anche se nell’isola, abusivamente, risiedevano alcune famiglie di contadini. Ora l’operazione a favore di questo importante personaggio apre la strada anche ad altre concessioni ed infatti il vescovo assegna dei lotti di terreno in contrada Gelso perché si mettano a coltura. Si piantarono così viti, fichi e legumi e qualcuno fece anche sorgere delle “carcere” per la produzione della calce viva.[7]
Sempre nel 1813 e precisamente l’8 aprile, il vescovo, su autorizzazione reale concede a Nunziante anche la possibilità di impiantare una fabbrica per l’estrazione e la purificazione dello zolfo e di altri minerali.
Avute le autorizzazioni il novello imprenditore sa che deve vincere la paura che vi era a frequentare Vulcano ed a vivervi perché altrimenti sarebbe stato difficile avere manovali. Così decise di organizzare un pranzo nell’isola invitandovi militari inglesi e gentiluomini eoliani e finalmente chiamò il chimico che aveva contattato e cominciò l’estrazione e la lavorazione dei minerali - zolfo e allume, sale ammoniaco e acido borico – che occorreva depurare perché non si trovavano in natura “belli e schietti” ma mischiati fra loro o “con altre mondiglie[8]”.
Nei primi tempi – sebbene l’impegno del chimico e le risorse che vi profondeva Nunziante – i risultati erano alquanto deludenti. Ma la perseveranza era propria di quest’uomo che si fece costruire nell’isola “una capannuccia con pali e frasche” e “molti mesi ci dimorò selvaticamente”[9].
La riforma delle poste

E finalmente la spuntò. Cominciò a fabbricare alloggi per i lavoranti, a piantare alberi per fare legna da ardere necessaria come combustibile per le macchine. Intagliò persino nella montagna una strada perché i carri potessero andare a caricare fino in cima i materiali e costruì un villaggio per chi ci lavorava. e cioè una colonia di coatti che erano relegati a Lipari, ed una chiesa che volle intitolare a san Vito con l’alloggio per il prete. Quando Dumas visiterà Vulcano nel 1835 ed incontrerà i figli di Nunziante così descrive questo villaggio dei forzati che lavoravano alle miniere: “costeggiammo una montagna piena di gallerie; talune erano chiuse da una porta e anche da una finestra, altre sembravano più semplicemente delle tane di animali selvaggi”; “circa quattrocento uomini abitavano in questa montagna e secondo l’indole più o meno industriosa lasciavano abbruttire la loro dimora oppure cercavano di renderla un pochino più confortevole”[10]
L’impresa di Vulcano non fu che la prima dell’intraprendente napoletano perché si dedicò alle miniere di ferro in Calabria, di piombo e carbon fossile in vari siti, alle cave di marmo in Basilicata,e così via. Nelle Eolie acquistò poderi a Stromboli e a Salina nella contrada di Malfa dove diede prova anche di buone doti di imprenditore agricolo. Ma sotto questo aspetto l’opera sua più imponente fu la bonifica di una piana nei pressi di Rosarno dove realizzò un villaggio che chiamò San Ferdinando. Per la costruzione di abitazione fece arrivare grossi quantitativi di pietra lavica e di tufo da Lipari, Stromboli e Vulcano avvalendosi di padroni di barche eoliani e molti marinai delle isole decisero di rimanere a San Ferdinando vivendo di agricoltura e di pesca.[11] A Lipari, ancora, trovò “un reniccio vulcanico” con cui fece una pasta e fabbricò delle stoviglie “che belle riuscirono come quelle di porcellana[12]”.
Innovazioni nell’amministrazione e nei servizi
Il vescovo mons. Todaro intanto entra di diritto nella Camera dei Pari che era uno dei due rami del nuovo Parlamento siciliano, quello in cui facevano parte baroni ed ecclesiastici e praticamente risiede quasi ininterrottamente a Palermo dal 13 maggio 1813 al 14 maggio 1815. Il 4 ottobre 1816 viene trasferito alla diocesi di Patti e Lipari rimane per 19 mesi sede vacante[13].
Ma nel periodo in cui rimane vescovo di Lipari tre sono le notizie che vogliamo ricordare. Il 30 gennaio del 1812 gli viene comunicato che, per decisione del re, viene tolta la santabarbara[14] che il governatore Mensingher aveva collocato in una cisterna proprio dietro la Cattedrale e che tanto preoccupava soprattutto i canonici che quando si riunivano nel coro temevano di poter saltare in aria da un momento all’altro.

Il 19 agosto dello stesso anno, probabilmente nel clima della nuova Costituzione siciliana che era stata approvata giusto il mese prima, giunge al vescovo una lettera che riguarda le “projette” che giunte ai sette anni, rimanevano senza assistenza e finivano per le strade. Ora il governo si raccomanda al vescovo che questo non accada più. Le ragazze devono essere collocate o “ne’ Reclusori, o di tenerle presso oneste Donne alimentandole coi frutti delle loro Mense e con i legati di genere incerto assegnati ad essi a quest’oggetto”[15].
Infine, in quegli anni, nelle isole, vennero istituite ben otto scuole elementari pluriclasse con un maestro e cinque o sei allievi ciascuna. Non si sa di chi fosse l’iniziativa, né fino a che periodo andarono avanti ma quando venne a Lipari lo Smith esse erano ancora attive ed anzi il capitano inglese si disse molto sorpreso di trovare a Quattropani “una scuola molto ben condotta, sotto la guida di un uomo di considerevole intelligenza, giacché il luogo in sé sembra selvaggio e pochissimo civilizzato”[16].
Il 9 giugno 1815 il Congresso di Vienna restaurò a Napoli il Regno dei Borboni e l’anno successivo Ferdinando unificò i due regni costituendo il Regno delle Due Sicilie. Viene dichiarato decaduto il Parlamento siciliano mentre viene sostanzialmente preservato l’ordinamento amministrativo che i francesi avevano introdotto a Napoli e lo estende anche alla Sicilia. Finisce così l’era dei giurati e comincia quella dei sindaci. Infatti così d’ora in poi si chiamerà il capo della civica amministrazione e questa, invece di “università”, prenderà il nome di “municipalità” con l’obbligo di tenere i registri anagrafici A fianco al sindaco, nominato e non eletto[17], era istituito il “decurionato” che aveva funzione di consiglio. A Lipari i decurioni erano dodici.

Congresso di Vienna
Il primo aprile 1820 in Sicilia entra in vigore anche la riforma dell’Amministrazione postale. Vengono istituite 115 “officine di posta” fra cui quella di Lipari che fu aperta nel 1822 e venne inserita nel cammino principale”Palermo-Messina per via delle marine”. Quando l’anno successivo l’officina di posta verrà chiusa il servizio dovette essere affidato – secondo quanto previsto dalla stessa riforma – alla Cancelleria comunale che provvedeva ad assemblare la corrispondenza locale e consegnarla a qualche veliero che periodicamente svolgeva il percorso fra Lipari e Messina o Milazzo
Nella prima metà dell’800 c’è da registrare il miglioramento dei collegamenti delle isole con la Sicilia e con Napoli. Infatti intorno al 1830 le isole vengono toccate – con frequenza quindicinale -dalle prime navi a vapore che facevano regolare servizio di linea fra Napoli, Messina e Palermo[18] ed alle quali venne affidato anche il trasporto della corrispondenza postale. Inoltre nel periodo estivo queste navi effettuavano delle brevi crociere nel golfo di Napoli, nelle Eolie con particolare riferimento a Stromboli ed a Taormina. Fuori dalla frequenza quindicinale chi aveva necessità di viaggiare doveva profittare di battelli privati da carico, di passaggio.
Un approdo regolare a Lipari

Un approdo[19] regolare a Lipari, con imbarco e sbarco dei passeggeri, sulla linea Napoli-Messina avvenne però solo intorno al 1837 e grazie all’impegno di un giovane e dinamico sindaco, don Filippo De Pasquale[20].
In questo clima di novità una esigenza di decoro per il prestigio della pubblica amministrazione fu avvertita anche dal Sindaco e dai “decurioni” che da qualche tempo avevano anche loro abbandonato il Castello e trovato sede sul Timparozzo in un edificio dai tratti signorili vicino all’abitazione del barone Tricoli[21]. Ma questa collocazione non appariva ai loro occhi soddisfacente forse perché troppo a ridosso dalle mura del Castello costretta fra due stradine strette se non anguste. E fu così che il Sindaco, don Giuseppe Natoli, prendendo lo spunto da un memoriale regio di qualche mese prima che invitava a verificare se vi erano conventi e case religiose inutilizzate per destinarli ad uffici municipali, saputo che le monache avevano abbandonato il Conservatorio nei pressi del Palazzo vescovile, pensò che quella potesse essere la sede più degna ed adeguata per l’amministrazione comunale per la cancelleria e per gli uffici. Inoltre, da qualche tempo, gli amministratori comunali non erano proprio in sintonia con il vescovo e l’ambiente ecclesiastico perché praticamente tutti appartenenti alla massoneria e comunque per lo più ostili alla Mensa vescovile da cui, tutti più o meno, dipendevano per i censi e per le decime che vivevano come una sopraffazione.
La diocesi di Lipari era sede vacante dal 1827 quando mons. Tasca fu trasferito a Cefalù ed era retta dal vicario generale can. Giovanni Portelli[22]. E toccò al can. Portelli – che diventerà vescovo in agosto – scrivere il 3 luglio del 1831 all’Intendente di Messina sostenendo che l’edificio nasceva nei recinti del Palazzo vescovile e non in terreno comunale, che era stato destinato dal mons. Coppola per l’educazione delle ragazze e ad altre finalità connesse con la dignità della donna[23]. E’ vero che al momento non c’erano più le suore nel Conservatorio ma vi erano ugualmente diciassette conviventi che si mantengono a proprie spese, oltre alla portinaia, che vivono nella osservanza dei valori religiosi sotto la guida dell’Ordinario ecclesiastico. Distogliere l’edificio dalle sue finalità voleva dire far gravare sul Comune il costo di chi attualmente vi alloggia oltre a privare la comunità eoliana di un centro di formazione per le ragazze che numerose ogni giorno partecipano ai corsi di formazione domestica. Comunque, concludeva il Portelli, se l’edificio non dovesse essere più adibito a Consultorio femminile la sua destinazione più propria sarebbe stata a Seminario per l’apertura del quale vi era già la regia approvazione.
[1] A mons. Santacolomba era succeduto mons. Domenico Spoto eletto vescovo di Lipari il 9 agosto 1802 ed il 28 giugno 1804 viene trasferito a Cefalù. A mons. Spoto succede mons. Antonio Riggio, messinese, nominato vescovo il 29 ottobre 1804 e giunto a Lipari il 12 febbraio 1805. Di lui si ricorda che abolì il “conservatorio femminile” e consegnò lo stabile alle suore Cappuccine di S. Benedetto fatte venire da S.Marco d’Alunzio e che riordinò il materiale archeologico raccolto dal Coppola e fece di nuovo riportare alla luce i mosaici a fianco del Conservatorio che il Santacolomba, per cautela, aveva fatto interrare. Così ci fu un certo flusso di amatori dell’arte italiani e stranieri, soprattutto inglesi. Morì il 14 dicembre 1806.
[2] Archivio Vescovile, In scritture Varie e Visite Date ( Miscellanea) vol 9, f. 605. Si tratta di una minuta che non ha né data, né firma, in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 264.
[3] Mons. Silvestro Todaro era nato a Messina il 29 dicembre 1752 era stato nominato vescovo il 22 marzo 1808 ed un mese dopo il Papa lo nominava Assistente al Soglio Pontificio.. Fu trasferito a reggere la diocesi di Patti il 4 ottobre 1816 e morì a Messina il 21 aprile del 182. Morendo lasciò un legato per la chiesa di Lipari di 3 mila onze, buona parte delle quali da destinare ai poveri.
[4] Vito Nunziante nacque a Campagna (Salerno) il 12 aprile 1775 e muore a Torre Annunziata il 22 settembre del 1836. Militare, politico ed imprenditore. Diventa ufficiale dell’esercito napoletano nel 1798. Dopo la fuga del re in Sicilia nel 1798 si unisce all’armata sanfedista del cardinale Ruffo. Al rientro del re a Napoli rientra nell’esercito napoletano col grado di colonnello. Nel 1806 quando il re fugge in Sicilia lo segue e gli viene dato l’incarico di tenere Reggio. Nel 1808 viene messo a capo delle forze di Milazzo. Nello stesso periodo, essendo rimasto vedovo dalla prima moglie Faustina Onesti, sposa una ragazza di Lipari da cui ha otto figli che con i quattro del precedente matrimonio fanno dodici. Nel 1815 ha l’incarico di nominare la corte che deve condannare a morte Giacchino Murat che gli procura il titolo di marchese. Dal 1821 ottiene diversi incarichi di governo ed infine il comando supremo dell’esercito continentale. Fu anche imprenditore e la prima attività fu nell’isola di Vulcano. In Calabria si occupò della bonifica di una piana di Rosarno e fondò il borgo di San Ferdinando. Si occupò anche di miniere di ferro e di piombo, di ricerche per il carbon fossile e avviò una cava di marmo in Basilicata
[5] In Titoli e documenti di provenienza …di terre nell’isola di Vulcano vendute dagli eredi di Nunziante ecc. presso il comm. Francesco Vitale f. 29v, in G. Iacolino, manoscritto cit. , quaderno VI pag. 265f .
[6] “E spesso ci andava, e con meraviglia di quelle genti, calava giù nel vano della montagna. Di dove avendo raccolto e zolfo e altre misture, tornato che fu in Sicilia. Diè a saggiare a un chimico, per sapere se fosse cosa da ridurre commerciabile: e avuto di sì, incoltamente chiese al vescovo di Lipari in censo Vulcano: il quale ebbe con agevolezza, e a sottil costo, perché nulla rendeva”in “Vita e fatti di Vito Nunziante”, di Francesco Palermo, Firenze 1839, pag. 79.
[7] Questa comunità fu formata dalle famiglie dei Bongiorno, Carnevale, Amendola, Trovatino, Basile e Ferlazzo. Qualche anno dopo l’insediamento costruirono una chiesetta nei pressi di Punta ‘a Sciarazza della quale non esiste più traccia. G. Iacolino, manoscritto cit., pag. 266°.
[8] F. Palermo, op. cit., pag. 80.
[9] Idem, pag. 81.
[10] A. Dumas, op. cit., pag.41.
[11] B. Polimeni, Rapporti sociali ed economici tra Sanferdinandesi ed Eoliani…, in “Messina e Calabria “, atti del I convegno calabro-siculo del novembre 1988, pp. 627 e ss.
[12] F. Palermo, op.cit., pag. 85.
[13] A mons. Todaro succederà mons. Carlo Maria Lenzi nato a Palermo l’1 febbraio 1761, appartenente alla congregazione degli Scolopi. Nominato vescovo di Lipari il 25 maggio del 1818 fece il suo ingresso in diocesi solo il 13 febbraio 1819 perché proprio qualche giorno prima della sua nomina era stato eletto alla guida della congregazione e occorse un certo tempo per poter rassegnare le dimissioni. Giunto a Lipari, rispettando la sua vocazione,si dedicò in maniera particolare a ristrutturare i programmi di studio delle scuole vescovili. Una particolare attenzione la dedicò alla formazione delle giovani per cui abolì il Collegio di Maria che era nell’edificio del Conservatorio femminile e istituì, al suo posto, una casa di Educazione sotto la direzione di due suore benedettine fatte venire da Palermo. Sperava il vescovo che un monastero delle benedettine oltre a suscitare vocazioni fra le fanciulle poteva convogliare quelle “monache di casa” che erano rimaste dopo l’editto promosso da mons. Santacolomba. Purtroppo mancando i finanziamenti il monastero non ebbe lunga durata e mons. Lenzi dovette tornare sui suoi passi ricostituendo il collegio di Maria cioè una gestione più modesta e familiare ( Archivio vescovile, Scritture varie e visite Date, Miscellanea, vol. 9 ff 272.272v.) G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pp. 262 a-d. A seguito del terremoto del 5 marzo 1823 accettò la richiesta della gente delle campagne di istituire una nuova festa dedicata a S. Bartolomeo che divenne la quinta. Morì il 5 aprile del 1825 all’età di sessantaquattro anni. Venne ricordato come un uomo di “straordinaria saggezza e fermezza che riuscì a sedare le discordie dei cittadini” come si legge nella epigrafe sulla sua tomba in Cattedrale.
A mons. Lenzi successe mons. Pietro Tasca nominato vescovo il 13 marzo del 1826 ma trasferito a Cefalù il 27 settembre del 1827. Durante il suo governo della diocesi si verificò, nel 1826, una eruzione di Vulcano che preoccupò i liparesi per alcune settimane. Partito mons. Tasca la sede rimase vacante per quattro anni, dal 1827 al 1831, ed affidata al vicario generale don Giovanni Portelli.
[14] Archivio Vescovile, Carp. Corrisp. D.
[15] Idem.
[16] W.H.Smith, op. cit., pp 262-263.
[17] Lipari aveva perso il privilegio di eleggere i giurati già dal 1673 a seguito della repressione della rivoluzione di Messina e la loro nomina era stata riservata al viceré ( Manoscritto anonimo di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, pag. 506).
[18] L' Italia descritta e dipinta con le sue isole di Sicilia, Sardegna, Elba, Malta, Eolie, di Calipso, ecc. : secondo le ispirazioni, le indagini ed i lavori de' seguenti autori ed artisti : Di Chateaubriand ... [et al.] per cura di D. B, 2: Regno di Napoli. - Torino : presso Giuseppe Pomba e C., 1837. pag. 280. Nel Regno delle Due Sicilie le navi adibite al trasporto dei passeggeri erano state introdotte con decreto del 2 dicembre 1823 n. 876 ed il servizio era gestito dalla società “Amministrazione privilegiata di pacchetti a vapore delle Due Sicilie”. Si ricorda il famoso Real Ferdinando, bastimento di legno con propulsori a ruota costruito a Glasgow ed apparso per la prima volta a Messina nel giugno del 1824. Poteva trasportare duecento passeggeri ed il viaggio in prima classe fra Napoli e Messina costava 27 ducati e comprendeva la mensa, il letto e il trasporto di un bagaglio. B. Villari, Collegamenti pubblici e privati sullo stretto di Messina, in “Messina e Calabria” Atti del I Colloquio Calabro- Siculo, Reggio C.-Messina, nov. 1986, Messina 1988p. 526.v. anche L. Radogna, La marineria mercantile delle Due Sicilie, Milano 1982, p.58. G. Iacolino, manoscritto cit., quaderno VI, pag. 270a,b.
Dal 1831 in poi andò ampliandosi la rete di corse marittime in partenza da Napoli. I battelli oltre al Real Ferdinando furono il Francesco I, il Maria Luigia, il San Venefredo, il Veloce e il Nettuno. Nel 1842 verrà immesso il Duca di Calabria che compirà la Napoli- Messina due volte alla settimana.Nel 1847 l’”Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle Due Sicilie” si unirà alla “Società Vapori Sardi” e metterà in servizio il Capri e il Vesuvio che nel 1847 serviranno la Napoli- Messina – Palermo.(G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 270d.
[19] In realtà si trattava di un accostamento e il carico e scarico dei passeggeri e delle merci avveniva con le barche.
[20] Filippo De Pasquale fu sindaco di Lipari dal 23 marzo 1837 a soli 26 anni fino al gennaio 1840. Si era laureato in legge a Napoli ed aveva mantenuto nella capitale del Regno delle amicizie importanti che seppe mettere a frutto durante la sua amministrazione. Morì nel 1886.
[21] L’edificio che oggi si incunea tra via Garibaldi e via Umberto I, che è stato completamente ristrutturato, non era tutto dedicato a Municipio. Questo era collocato nella parte centrale. Il settore nord apparteneva agli Scolarici, mentre il settore sud, lussuosissimo, era del barone Tricoli.
[22] Giovanni Portelli era nato a Lipari ai primi di novembre del 1768 da Antonio e Giovanna Megna. Anche se era privo di diplomi accademici aveva maturato una buona esperienza giuridica-amministrativa e furono diversi i vescovi della Sicilia che lo vollero come vicario generale e visitatore. Dopo il trasferimento di mons. Tasca egli rientrò a Lipari per assumere la reggenza della diocesi con il titolo di vicario capitolare. Venne eletto vescovo di Lipari l’8 agosto 1831e consacrato vescovo dal Metropolita di Messina che ritornava a svolgere questa funzione sebbene ancora il 25 maggio 1818 in occasione della nomina di mons. Lenzi la bolla pontificia ribadisse la esclusiva dipendenza della chiesa di Lipari dalla Santa Sede. Mons. Portelli durante il periodo della sua reggenza affrontò il problema della esazione delle decime che fino ad allora veniva eseguita a cura di un ecclesiastico. Il vescovo – soprattutto per i modi duri e rudi con cui operavano gli agenti preposti all’esecuzione e la natura fortemente fiscale fino ad apparire inumana dell’azione degli operatori – dispose che l’esazione delle decime non fosse più di competenza di un prete ma di un laico e scelse per questo Onofrio Paino( Archivio Vescovile, Mensa, secc.XVI,XVII.XVIII, XIX,XX, ff. 127-28).. Portelli morirà a Lipari il 28 gennaio 1838.
[23] La prima finalità afferma il can.Portelli era “far apprendere alle ragazze le arti donnesche e i principij della Religione Cristiana”. Quindi esso serviva anche come “rifugio alle orfane, asilo per le vergini, per custodia a quelle figlie che non potevano convivere sotto il tetto paterno, e per scampo alle mogli che non conveniva coabitare con il marito e, di mezzo a’ Magistrati, per depositare quelle donne che temporaneamente dovevano allontanarsi dalla famiglia mancando in Lipari altra casa che potesse avere lo stesso destino”. E questo sotto la cura di una direttrice e la dipendenza e la sorveglianza del vescovo.(Archivio Vescovile, Scritture varie e visite Date (Miscellanea) ff. 275v, 272, 272v.
Otto scuole elementari. Giovanni Portelli
XIX secolo. Fra segni di crescita ed eventi rivoluzionari
Il volano dei commerci e dei traffici marittimi

La rotta Eolie- Napoli era fra le più frequenti nell' '800
L’800 si apre con un intensificarsi dei rapporti commerciali marittimi in tutto il Mediterraneo e le Eolie vengono a trovarsi al centro di una rete di rapporti e di scambi sia fra la Sicilia e la penisola soprattutto la costa tirrenica ma anche con la Sardegna, la Corsica , la Spagna e la Francia. Sono soprattutto Lipari e Stromboli a essere sulle più importanti rotte ma oltre a Lipari è Salina a saper cogliere le opportunità che si aprono attraverso queste relazioni e questi scambi e a cimentarsi in attività commerciali di un certo respiro e a in attività artigianali ad esse collegate come la lavorazione del legno e la costruzione di barche e di paranze. Ed anche all’inizio dell’ottocento cominciano ad attivarsi attività industriali come l’estrazione della pomice, la raccolta e la lavorazione dello zolfo e dell’allume che fino allora erano state del tutto marginali o addirittura inesistenti perché non autorizzate.
Le terre pomicifere, considerate da sempre terre comuni, oltre al fatto che su di esse pesava la rivendicazione della Mensa vescovile che le riteneva sua proprietà, erano anche oggetto di appropriazioni indebite da parte dei privati. L’una e l’altra ragione frustravano – come vedremo - i propositi della civica amministrazione di darle in concessione, percependone il dazio sull’escavazione. Esse erano così meta di cavaioli, sia singoli sia a gruppi, che prendevano ciò che potevano, alimentando comunque un discreto commercio di esportazione che nel 1825 era di ben 700 tonnellate.
Questo lento ma progressivo emergere dell’economia sotto l’impulso del commercio e dei traffici trova soprattutto nell’agricoltura e nei prodotti della terra una sponda capace di offrire beni per l’esportazione. Certo non il grano, i legumi, l’olio, la stessa frutta che o venivano tutti assorbiti dal consumo interno ed anzi risultavano insufficienti e dovevano essere importati, ma prodotti che si indirizzavano verso un consumatore più esigente attento alla qualità ed alle specialità e quindi , oltre ai capperi, innanzitutto i prodotti dell’uva a cominciare dai passoli e dalla passolina che derivavano dalla sua essiccatura e quindi il vino sia quello rosso corposo ad alta gradazione, sia quello bianco aspro e leggero, sia in particolare la malvasia di cui le aree di eccellenza erano a Malfa, nell’isola di Salina, ed a Stromboli. Nel 1800 gli eoliani smerciarono 18 mila barili di vino pari a 6.190 ettolitri a Napoli, Palermo, Messina e persino a Roma, Livorno, Marsiglia e Trieste.[1] Nel 1834 si ha una flessione nella esportazione di vino dal porto di Lipari perché - come sostiene il can. Carlo Rodriquez[2] - si sostituirono viti che davano uva da vino con viti per passolina[3] o piuttosto, più credibilmente, perché fin dal 1820 comincia a funzionare una postazione doganale a S.Marina Salina e quindi il vino in partenza da quest’isola viene imputato a questa nuova postazione evidenziando “la perdita dell’egemonia commerciale di Lipari sull’isola minore”[4]. Ma sono da diversi anni che S. Marina ha assunto un ruolo importante nello smercio della malvasia. Da quando cioè a Messina, a partire dal 1806, si è insediata una guarnigione britannica che diventa commissionaria di vino e malvasia proprio dell’isola di Salina[5]. Comunque, con prevalenza di un’isola o dell’altra, - di Lipari per quanto riguarda la passolina, di Salina per il vino e la malvasia - per larga parte dell’800 la vite sarà la caratteristica del paesaggio agricolo eoliano.

Malfa era fra le contrade che producevano più uva per la malvasia e la passolina
Ed è proprio questa monocultura, secondo il Rodriquez, che rende l’economia povera. “Qui si è generalizzata la piantagione di viti di uva passolina; ma tal genere, per lusso e per l’abbondanza, fa talvolta che rimanga invenduto o a minimo prezzo si smercia; e quando politiche circostanze non permettono che i Russi, i Germani, i Polacchi, gl’Inglesi ne acquistino, la miseria in questo paese diviene più grande e più universale”[6].
Non era ancora assurta ad una vera attività economica invece la pesca. Sebbene il mare fosse molto pescoso, nelle isole essa era praticata come attività integrativa che permetteva di arrotondare le entrate dell’agricoltura. Comunque era la piccola proprietà contadina a conduzione familiare la struttura portante dell’economia che finiva col caratterizzare il modello culturale eoliano. Altri elementi caratterizzanti erano l’essere un ambiente isolato e chiuso,l’assoluta assenza di spreco, l’utilizzo di ogni bene sino all’esaurimento.
All’interno della famiglia eoliana tutto veniva consumato e ciò che avanzava dall’alimentazione delle persone diventava cibo per le galline e le capre, concime per le piante, combustibile per il forno. Era la donna la principale artefice della trasformazione dei prodotti della terra in prodotti di consumo, ad essa spettava al cura degli animali, essa tesseva, filava, rattoppava[7]
I contadini erano la categoria sociale più numerosa dei 17 mila abitanti che ora contano le isole. Erano per lo più mezzadri ( parsunala )ma c’erano anche i giornalieri che andavano a giornata nelle proprietà. Ogni contadino di Lipari possedeva la sua casa e il suo podere – ma erano poche le famiglie che arrivavano ad avere una salma di terra, molte dovevano contentarsi di poche pergole[8] - quindi solitamente questo era insufficiente per tenere fronte ai bisogni della famiglia e il contadino doveva lavorare anche per altri divenendo così mezzadro.
Sull’agricoltura delle isole nella prima metà del secolo ha scritto pagine di grande interesse e di critica sui metodi di conduzione dei campi, il can. Carlo Rodriquez che fu certamente la figura culturalmente più eminente di quel periodo.
Se il commercio e i traffici marittimi furono il volano della crescita delle isole questo lo dovette anche ad alcuni personaggi che seppero sfruttare la situazione e divenire infaticabili creatori di collegamenti e di relazioni ad ampio raggio fin oltre i confini del Regno. Uno di questi fu don Antonio Paino[9] che dopo aver sposato una donna di uno dei più ricchi casati, vide crescere in misura notevole il suo volume di affari e da modesto commerciante divenne il titolare di una fortunata ditta di spedizioni intestata a lui ed ai figli. I frutti dei suoi guadagni venivano investiti in barche, case e terra nelle varie isole. La sua attività fu continuata poi dal figlio Onofrio.
Un altro mercante liparese che teneva rapporto con diverse piazze, spingendosi fino a Trieste fu Giovanni Bongiorno[10] che insieme al fratello commerciava soprattutto in capperi, passolina, malvasia e vini. A Salina, all’inizio del secolo, è Domenico Giuffré che si distingue per produrre vino, passolina, passoli, olio, capperi, fichi secchi e malafria e commerciarli con le sue barche. “Accanto alla sua casa al Barone – racconta in una intervista Vittorio Lopes,suo discendente – egli possedeva tanti magazzini quanto erano gli apostoli, sempre carichi della merce che i suoi velieri trasportavano[11]”. Domenico Giuffrè[12] come prima suo padre Angelo e con lui diversi altri commercianti e “mercanti di mare” salinari sono all’origine di quel “sorpasso” di Salina su Lipari nella produzione e nel commercio del vino ma anche nella navigazione marittima di cui parlano Saija e Cervellera e che si verifica nella prima metà dell’800.

Una scena abituale sulle spiagge delle Eolie nell' '800. La passolina messa ad asciugare sulle "cannizze".
Un passo verso la qualità nel vivere e nell’abitare
Negli ultimi decenni del 700 il governo borbonico aveva dichiarato Lipari luogo di esilio coatto ed aveva destinato proprio la città alta a luogo di abitazione degli esiliati. Così la popolazione che ancora abitava al Castello cominciò ad abbandonare il proprio domicilio e a stabilirsi nel borgo. “E talmente s’ingrandì cotesto che prese il nome di Città di Lipari”[13].
Ma il rapporto della città con i coatti non era facile. Sebbene non mancassero fra questi relegati gente condannati per reati di opinione la gran parte erano delinquenti comuni. Qualche decina era andata a lavorare a vulcano nelle industrie di Nunziante, altri erano andati a Filicudi per lavorare nei campi o terrazzare le pendici collinari, alcuni erano trattenuti nelle carceri di sicurezza del Castello, la maggior parte però circolava liberamente per Lipari creando apprensione nella popolazione. Quando il can. Rodriquez scrive nel 1840 il suo “Breve cenno storico” i coatti sono divenuti ormai 500, di cui la gran parte condannati per furti, e sostiene che essi sono all’origine di aggressioni alle persone o di assalti alle abitazioni o perché praticano direttamente queste azioni o perché in qualche modo fanno scuola ai “malnati naturali”[14].
Rodriquez suggerisce che si pensi ad illuminare Lipari proprio per evitare degli inconvenienti ed è questo un argomento che gli sta particolarmente a cuore, di cui aveva scritto qualche anno prima, affermando che dalle 24 ( le 17 di oggi) in poi, nella stagione invernale, le strade cittadine diventano impraticabili perché esposti agli urti continui “con le bestie che vengono dalle campagne e con gli uomini che vanno per i propri affari”. Ma non è solo questione di sicurezza ma anche, diremmo oggi, di decoro urbano che renderebbe più vivibile la cittadina. Per esempio, nelle ore serali, si potrebbe sviluppare il passeggio che “avvicinerebbe i singoli e li renderebbe tra loro più amici, più socievoli, ed in generale più civili”. Quindi una decisione indispensabile per “il pubblico bene”tanto che, sostiene Rodriquez, “isole di minor considerazione, come Favignana e Pantelleria, non sono mancanti di tale vantaggio”.[15]

U "Timparozzu"
La Lipari delle attività commerciali ed artigiane era venuta sviluppandosi nei quartieri intorno alla Marina di S.Giovanni che, da qualche tempo, avevano preso il nome di Piazza del Commercio, la salita che dalla Marina arrivava al Timparozzo, quindi la strada di Santo Pietro – l’attuale via Maurolico – e quindi la strada del Pozzo, oggi il tratto più centrale di corso Vittorio Emanuele. Il Piano del Pozzo cominciava a registrare una vivacità pittoresca con le botteghe artigiane – stagnari, fabbri, falegnami, tintori, barbieri, sarti, calzolai -, le bottegucce dei piccoli commercianti, le taverne numerose quanto sudice. E poi, fin dalle prime ore del mattino, il vocio de i rumori di facchini e di carrette che con secchie e barilotti venivano ad attingere acqua alle gibbie.
Già intono agli anni 30 la Piana del Pozzo, malgrado si trattasse di un greto limaccioso ed accidentato, andava assumendo una precisa caratteristica con alcuni edifici pubblici importanti. Vi era nell’arco di un centinaio di metri o poco più la Chiesetta del Rosario con di fronte l’ospedale dell’Annunciata; più avanti, in direzione della chiesa di San Pietro, le due gibbie con dietro le scuole vescovili da un lato e dall’altro in grande fabbricato del Conservatorio con all’angolo la cappella dell’Addolorata; sullo sfondo l’edificio del Palazzo vescovile[16].

La Chiesa di San Pietro nell'800.
La separazione della Strada del Pozzo dalle scuole e dal conservatorio femminile che si trovavano ai lati dell’attuale viale mons. Bernardino Re, con un muro orlato ed un grande cancello di ferro avverrà intorno al 1840 per volontà del vescovo Proto.
Quando Dumas visitò le Eolie
Ancora nel 1835, quando Alexandre Dumas visitò le Eolie, Lipari non aveva una locanda che potesse ospitare dei viaggiatori. “Appena sbarcati – scrive lo scrittore francese – ci mettemmo alla ricerca di un albergo: sfortunatamente era una cosa del tutto sconosciuta nel capoluogo. Cercammo da un capo all’altro della cittadina: non la più piccola insegna né alcun segno di locanda”[17]. A stare a Dumas però non mancava una sala da bigliardo che dopo le dieci di sera era ancora aperta e dove non solo riuscì a fare una partita ma anche consumare uno spuntino a base di torte e frutta graziosamente offerto dalla padrona del locale[18].
Fu per la trasformazione dell’abitato e lo sviluppo della città bassa che la chiesa di S.Pietro, il 4 giugno del 1808 divenne chiesa sacramentale e chiesa filiale come lo era già quella di S. Giuseppe e nella Marina di S. Giovanni fu innalzata una statua di marmo a S. Bartolomeo. Non era la statua che si vede ora nella piazza di Marina corta ma una di dimensioni più modeste. Negli anni ’20, l’ammiraglio inglese sir William Henry Smith che visitò le Eolie disse di questa che si trattava di “una bella statua greca che è stata trasformata in santo con l’aggiunta di un’aureola di rame; molti sostengono che sia stata fatta in onere di Timasiteo”[19]
Mentre si scavava per il fondamento della statua si trovò “una bella sorgente di acqua con sua artificiale fontana e margherita di bronzo”. Fu fatto venire da Palermo un esperto ma si constatò che si trattava di acqua salmastra per cui si costruì un pozzo “che con l’andare del tempo si disperse[20]”.
All’inizio dell’800 c’è da registrare due opere pubbliche realizzate per iniziativa del governatore del tempo, il colonnello Carlo Mensingher[21]. La prima riguarda la mulattiera che da Lipari, attraverso lo Zinzolo, porta a Pianoconte ed oggi si chiama Strada Vecchia. Fu lastricata nel 1801 per collegare le colline con la cittadina e probabilmente anche con il piccolo porto. Si era creata infatti, a Lipari come a Salina, una certa attenzione verso l’agricoltura e chi aveva capitali li investiva nel bonificare le terre nelle zone alte, piantandovi alberi e vitigni. In quel periodo si disboscarono abusivamente anche le pendici di monte Sant’Angelo creando tensioni e discussioni sulla proprietà di quelle aree, disappunto nei giurati e proteste fra i pastori di Quattropani che usavano quei terreni per il pascolo di capre e ora se lo vedevano impedito. Forse ci scappò anche il morto: tale Antonio Paino di Pietro, di 46 anni che morì “ucciso in campagna” il 10 agosto del 1804 e fu sepolto nella chiesetta di Porto Salvo[22].
La seconda opera , che il Mensingher realizzò sempre con i contributi governativi, riguardava la trasformazione del vecchio ospedale S. Bartolomeo e poi Casa degli esercizi spirituali, ormai in rovina, in casa di cura e ospizio per i malati, i poveri ed i vecchi soldati che avevano servito la patria in armi[23]. L’ospedale era dotato di un cimitero che consisteva allora in una fossa comune scavata a mo’ di cisterna. Nel 1805 questa sepoltura era approntata ed è del 14 agosto la richiesta della certificazione di agibilità da parte della Deputazione di Salute.

Ma mentre a Lipari nobili e borghesia tendevano a qualificare i loro modo di vivere nelle isole la situazione era di tutt’altro tipo. W.H. Smith che visitò Salina, che contava già 4 mila abitanti, così descrive i suoi abitanti: “gli uomini sono robusti e laboriosi ma sporchi e feroci, mentre le donne, ugualmente sporche, sono le più rozze e mascoline che abbia visto in queste zone; i due sessi sono, senza distinzione, tormentati da rogna più o meno cronica. Nonostante ciò, e nonostante i modi non troppo seducenti, ho constatato una grande ospitalità e gentilezza in tutti i ceti durante il mio soggiorno, e nel buon prete di Amalfi trovai un intelletto più colto di quanto mi attendessi in un luogo così sperduto[24]”. E la situazione delle altre isole non doveva discostarsi di molto. A proposito di Alicudi A.Dumas nel 1835 dice che “è difficile vedere qualcosa di più triste, di più tetro, di più desolato di questa sfortunata isola”. Nessun sentiero conduce sulla cima o corre lungo le sue rive: alcune sinuosità scavate dalle acque piovane sono gli unici passaggi offerti. Non un albero su tutta l’isola né un poco di vegetazione che riposi gli occhi. “Ciò nonostante su questo angolo di terra rossastra, vivono in misere capanne centocinquanta o duecento pescatori che hanno cercato di sfruttare i rari fazzoletti di terra sfuggiti alla distruzione generale”.[25]
Oltre Alicudi, Lipari e – come vedremo più avanti – Vulcano lo scrittore francese visita anche Panarea – “una decina di case corona il pianoro dell’isola”[26]- e Stromboli. Di quest’isola annota che gli abitanti sono vignaiuoli e commercianti di uva passa, che sono le due principali attività, ma sono anche ottimi marinai[27].
[1] C. Rodriquez, Breve cenno storico-critico sull’isola di Lipari, in “Giornale delle Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, 1841, tomo LXXVI, p.246; G.A.M. Arena, op. cit., pag. 38.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] M.Saja e R. Cervellera, Mercnadi di Mare. Salina 1800-1953, Salina 1997, pag. 27.
[5] Idem, pp.20-25.
[6] C. Rodriquez, Breve cenno storico sull’Isola di Lipari, Palermo 1841, pp.37-38.
[7] G.A.M. Arena , op.cit., pp 37 ess.
[8] I riveli del 1815-16 delineano una proprietà molto frazionata. Archivio di Stato di Palermo, Deputazione del Regno 1815-16,; G.A. M. Arena, op. cit. pag. 39.
[9] Nacque a Lipari da Tomaso e Maria Tauro nel febbraio del 1775 Sposò donna Marianna Salpietro. Ebbe sei o setti figli di cui alcuni morirono in tenera età. Morì a Lipari all’età di 55 anni il 25 aprile del 1829. G. Iacolino, Gente delle Eolie, Lipari 1994, pp 172-175. v. anche G. Iacolino, manoscritto cit. Quaderno VI pp269 a-h.
[10] Giovanni Bongiorno di Emanuele era nato intorno al 1765 e morì il 1815. Sposato con donna Giovanna Maggiore ebbe due figli Emanuele e Giuseppa. Suoi discendenti in linea retta sono il maestro Edoardo e Leonida. G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pp 269 h2- h6.
[11] M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit. pag. 79 nota n.3.
[12] Domenico Giuffré ( 1778 – 1862) nasce a S. Marina Salina da Angelo e sposa in prime nozze Maria Lauricella da cui ha nove figli. In seconde nozze sposa Maria Famularo da cui ha un altro figlio.
[13] Dal manoscritto di proprietà della famiglia Mancuso, p.595.
[14] C. Rodriquez, op. cit., pp39-40.
[15] C:Rodriquez, Pubblica istruzione, in “Il Maurolico”, anno I, vol.II. N.4 del 10 giugno 1835, p.50.
[16] G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 274.
[17] A.Dumas, Dove il vento suona. Viaggio nelle Eolie, Marina di Patti 1986, pag. 21.
[18] Idem, p.30.
[19] Timasiteo come si ricorderà era il magistrato liparese che nella Lipara greca del IV secolo a. C. convinse i suoi concittadini a restituire a Roma la nave con i voti al dio Apollo destinata a Delfi che avevano rapito. W.H. Smith, Memoir descriptive of the resources, inhabitants and hydrografy of Sicily, London 1824, traduz. Ital. di G.A. Catinella e G. De Franchis dal titolo “La Sicilia e le sue isole”, Palermo 1989, p.262.
[20] Manoscritto di proprietà Luigi Mancuso, pag. 598.
[21] Mensingher desiderava che la gente lo ricordasse per quello che aveva realizzato ed infatti nella lapide che fece porre in via Zinzolo c’è scritto che la strada per Pianoconte si sarebbe chiamata “Via Mensingheriana” ma fu un nome che non entrò mai nell’uso dei liparesi. Di questo governatore la gente piuttosto ricordò anche che aveva avuto l’idea balzana di piazzare l’intera santabarbara del presidio proprio a ridosso della Cattedrale in una cisterna fuori uso e ridotta a magazzino col rischio che un qualsiasi incidente facesse saltare cattedrale e metà Castello. Il governatore morì l’11 gennaio 1803.
[22] Nel registro dei defunti dell’Archivio Vescovile, al n. 295 dell’anno 1804, è scritto “rure interfectus fuit et sepiltus est in Eccl.a Portus Salutis” in G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, p.260.
[23] Anche qui, come all’inizio della strada per piano conte, oggi in via Zinzolo, fece affiggere una lapide e i testi delle due epigrafi furono ricopiate da Luigi Salvatore D’Austria,Le isole Lipari, vol.III, a cura di Pino Paino, Lipari 1982, p.32, e p.33.
[24] S. Mazzarella, W.H.Smith, La Sicilia e le sue isole, Palermo 1989, p.266.
[25] A. Dumas, Dove il vento suona. Viaggio nelle Eolie, op. cit. pag. 12.
[26] Idem, p.52.
[27] Idem, p.68.
Carlo Mensingher
La "Recitazione" di Sciascia e la controversia liparitana
Dove le ragioni della speranza?


Leonardo Sciascia e la sua singolare statua a Regalmuto
Sulla vicenda della “controversia liparitana” Leonardo Sciascia pubblicò nel 1969 una “Recitazione” dedicata a Alexader Dubcek la cui primavera a Praga veniva schiacciata dai carri armati russi. Quello di Sciascia, partendo dalla vicenda di Lipari ed in qualche modo forzandola nel suo significato, voleva essere un inno alla laicità dello stato ma anche e forse sopratutto ad una tesi ottimistica: le ragioni del potere se avevano la meglio in un frangente storico grazie all’uso della forza, non l’avevano però nel lungo periodo. Infatti le ragioni degli uomini che hanno avuto speranza ed hanno mantenuto la schiena diritta di fronte al potere, finiranno, nel tempo, coll’evidenziarsi ed anche col fruttificare.
Le ragioni della speranza per Sciascia, in quella vicenda del settecento, erano rappresentate da uomini come Giacomo Longo, giudice del Tribunale della Monarchia, Francesco Ingastone, giudice della Gran Corte, Ignazio Perlongo, avvocato fiscale sempre della Gran Corte. Ma era proprio così? Che rappresentavano le due parti in competizione? La Sicilia illuminata contro quella reazionaria, come vorrebbe Sciascia sull’ala dell’ottimismo della fine degli anni 80 del secolo scorso? O piuttosto, più in sintonia col realismo disincantato di oggi, due sistemi di potere che cercavano di difendere o accrescere le proprie prerogative?
Cerchiamo di approfondire i fatti.
La “Recitazione” è, da una parte, una riflessione sul potere, sulla sua forza omologante, sulla capacità di piegare valori ed ideali, sulla tendenza al compromesso per la propria conservazione; dall’altra, sulla laicità dello stato che il potere temporale della S.Sede tende a condizionare ma anche sulla libertà della Chiesa che risulta impastoiata in mille logiche temporali che ne offuscano la missione religiosa. Qui, il libero pensatore del XX secolo può addirittura citare il cattolico Pascal in epigrafe al suo lavoro. Gesù sapeva che il potere esercitato in nome della religione “che detiene il ramo principale e si insinua dappertutto” facilmente poteva degenerare in tirannide e per questo aveva stabilito, citato da Luca (22,25-27), il precetto “Vos autem non sic”[1], “Per voi però non sia così”. Un precetto che, secondo Sciascia, moltissime volte o sempre, è stato contraddetto nel corso della storia, proprio per la natura stessa del potere.
 L’illuminista Sciascia sviluppa i suoi quattro atti sulla base di un diario del canonico Antonino Mongitore, uno storico del settecento che nella controversia si era schierato col papa sposandone le posizioni anche se fra i cosiddetti “curialisti”, era forse uno dei più obiettivi. Il nostro autore non solo fonda il suo racconto su questo testo che giudica di parte, ma pubblica in appendice alla “Recitazione” un estratto di quel diario, proprio ad evidenziarne la fonte ed a invitare a verificarne la fedeltà con la storia tradotta sulla scena. Così lo scrittore di Regalmuto vuole dimostrare al lettore e spettatore moderno come la coscienza storica e civile del nostro tempo è in grado di rendere giustizia ai fatti al di là della parzialità del narratore. E se la ragione del potere ha la meglio in quel frangente storico – come a Praga - le ragioni della speranza, alla lunga, finiranno col prevalere.
L’illuminista Sciascia sviluppa i suoi quattro atti sulla base di un diario del canonico Antonino Mongitore, uno storico del settecento che nella controversia si era schierato col papa sposandone le posizioni anche se fra i cosiddetti “curialisti”, era forse uno dei più obiettivi. Il nostro autore non solo fonda il suo racconto su questo testo che giudica di parte, ma pubblica in appendice alla “Recitazione” un estratto di quel diario, proprio ad evidenziarne la fonte ed a invitare a verificarne la fedeltà con la storia tradotta sulla scena. Così lo scrittore di Regalmuto vuole dimostrare al lettore e spettatore moderno come la coscienza storica e civile del nostro tempo è in grado di rendere giustizia ai fatti al di là della parzialità del narratore. E se la ragione del potere ha la meglio in quel frangente storico – come a Praga - le ragioni della speranza, alla lunga, finiranno col prevalere.
Ma quali sono le ragioni di Mongitore e con lui, secondo Sciascia, di chi si schierò con il papa? E dall’altra quali le ragioni di chi invece vi si oppose e non in nome di una visione antireligiosa ma, sempre secondo Sciascia, sulla base della concezione di una fede più genuina e più umana come in Giacomo Longo, giudice del Tribunale della Monarchia,o in nome di una giustizia redistributiva come in Francesco Ingastone , giudice della Gran Corte, che più concretamente mira ad eliminare o ridurre i privilegi patrimoniali del clero, degli ordini e dei monasteri che gravano sulle spalle della gente?
Per il Mongitore, come si evince dal suo Diario, la ragione nella controversia sta dalla parte del Vescovo di Lipari prima e quindi del papa che le ha sostenute dando loro una valenza più ampia e generale. Il Vescovo di Lipari ha ragione perché la scomunica che emise contro i due catapani Tesoriero e Cristò non poteva essere annullata dal Tribunale della Monarchia di Palermo ma solo dal papa giacchè la Diocesi di Lipari non era soggetta alla Legazia Apostolica siciliana ma immediatamente alla S.Sede per una concessione ancora più antica di quella della Legazia. La reazione dei “ministri di Sicilia con molte e gravi vessazioni” all’opposizione del Vescovo che si rifiutava di riconoscere la competenza giurisdizionale di detto Tribunale diede vita ad un’escalation che superò i confini diocesani e si propagò a tutto il Regno di Sicilia. Qui non era più in gioco il privilegio della Chiesa di Lipari ma prima l’autorità del papa su materie che egli riteneva di carattere dogmatico e quindi sottratte alla Legazia, poi la Legazia stessa che da un papa era stata concessa sei secoli prima e quindi solo un altro papa poteva togliere.
Una nuova "classe dirigente"?

Dall’altra parte, quella dei “regalisti” - come venivano chiamati i sostenitori delle tesi siciliane in opposizione ai “curialisti”, sostenitori delle tesi romane – sembrano ignorare il privilegio della Chiesa liparese e cioè la sua esclusione dalla Legazia e il suo legame diretto con la S.Sede e tendono a ridurre la controversia, se non ad un arbitrio, ad un eccesso di reazione del vescovo di Lipari ed a una impuntatura priva proprio di carità cristiana. La competenza del Tribunale della Monarchia in materie ecclesiastiche ma non dogmatiche viene fatta risalire “alla remunerazione concessa da Pontefici a quel Gran Ruggero che nel conquistare a se stesso la Sicilia, si rese tanto benemerito della Sede Apostolica, per avere discacciati da quel Regno i Saraceni Nemici della Fede, e per haver indi donata a le molte Chiese da lui fondate la terza parte dei Redditi di tutto il Regno[2]”. Questa peculiarità di cui gode la Sicilia – continua il documento dal titolo “Veridica Relatione” che si rifà chiaramente alle posizioni regaliste – non può destare meraviglia se si pensa che essa è totalmente separata dal Continente e quindi consente ai cittadini di non fare uscire le loro cause fuori dal Regno con aggravi intollerabili di spese e col rischio di dover viaggiare per mare spostandosi a Roma per chiedere ed ottenere riparazioni alle ordinanze e sentenze dei loro prelati[3].
Quanto alle motivazioni più idealiste e radicali tendenti ad una riforma della fede o delle istituzioni ecclesiastiche che Sciascia attribuisce a personaggi come Longo, Perlongo e Ingastone - facendone una sorta di pool riformista-illuminato, simboli in qualche modo di una nuova “classe dirigente” venuta fuori in quel frangente[4], nel conflitto fra regno di Sicilia e curia romana, anticipatore di visioni che matureranno, fra i cattolici, nei secoli XIX e XX - bisognerebbe quantomeno articolare il discorso. Dei tre personaggi, alla luce delle conoscenze storiche, quello che in qualche modo potrebbe essere all’altezza del ruolo che gli fa giocare lo scrittore di Regalmuto è il Longo. Avvocato, giudice, filosofo e letterato apparteneva a “quella scuola che sulle orme di Cartesio tendeva, tra la fine del XVII e il principio del XVIII secolo, a rompere in Sicilia i ceppi aristotelici”[5]. Al culmine di una carriera accompagnata da onori e generale rispetto, improvvisamente decide di dedicarsi alla vita religiosa ed entra in un convento dell’ordine dei Teatini dove va a trovarlo Vittorio Amedeo – che indubbiamente lo conosceva di fama – appena giunge a Palermo. Ma se una figura chiara e priva di ombre era quella del Longo, circondata da generale rispetto anche da parte di chi era su tutt’altro fronte[6], non altrettanto si può dire del Perlongo e dell’Ingastone. Del Perlongo gli storici annotano che girava per i conventi della Sicilia indagando sul comportamento dei religiosi per poterli denunziare e perseguire[7]. Ancora più ambigui sono i riscontri che riguardano l’Ingastone e il contributo che questi diede nella persecuzione degli osservanti le disposizioni di Roma servendosi dell’opera di un figuro come Matteo Lo Vecchio. Quel LoVecchio che Sciascia cerca in qualche modo di nobilitare attribuendogli, alla vigilia del suo assassinio, una crisi di coscienza e la manifestazione di scrupoli religiosi che non hanno riscontro nelle cronache dell’epoca[8].
 Il vicolo dedicato a Matteo Lo Vecchio a Palermo con il pozzo dove fu gettato il cadavere.
Il vicolo dedicato a Matteo Lo Vecchio a Palermo con il pozzo dove fu gettato il cadavere.
Anche volendo ammettere che il Longo facesse parte di un nuovo tipo di clero “che credeva in Dio e propugnava il diritto dello Stato”[9]ci sembra azzardato sostenere che esso fosse l’emblema di una nuova classe dirigente che la “restaurazione” del 1719 disperse. Una classe dirigente alla quale, in qualche modo, Sciascia sembra assimilare persino il Lo Vecchio dedicandogli idealmente una rosa – come Faulkner la dedicò ad Emily che dorme nel suo letto accanto al cadavere dell’uomo amato[10]- “per questo cadavere che da un secolo e mezzo dorme in fondo ad un pozzo secco, accanto al cadavere dello Stato”[11].
Comunque lo scontro, soprattutto in Sicilia, non fu allora fra una parte illuminata ed un’altra retriva e codina ma fra due sistemi di potere che cercavano di difendere o accrescere le proprie prerogative.
[1] “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande fra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve “, Luca 22, 25-27.
[2] Da “Veridica Relatione, e confronto de’ procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto del Tribunale della Monarchia”, testo a stampa, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. D2 d bis, pag. 4.
[3] Idem.
[4] In uno scritto del 1969 intitolato “Una rosa per Matteo Lo Vecchio ( in La corda pazza, L. Sciascia, Opere 1956-1971, Classici Bompiani, Milano, 1990, pag. 1017) Sciascia parla di “uomini nuovi, una vera e propria classe dirigente xhe mai la Sicilia aveva avuto ( e mai, purtroppo fino ad oggi, avrà). Corsero venature gianseniste, si ebbero più stretti rapporti conla cultura francese. Un clero che credeva in Dio e propugnava il diritto dello Stato contro la temporalità deella Chiesa veniva affermandosi contro il vecchio clero isolano sostanzialmente ateo, avido di benefici, intento a scrutare ed avallare prodigi e superstizioni”.
[5] I.LA LUMIA, Storie siciliane, IV, Palermo 1870, pag. 233.
[6] A. MONGITORE, Biblioteca sicula, Tomo I, pag.302; G.B. CARUSO, Discorso istorico apologetico della Monarchia in Sicilia, Palermo 1863, pag. 165, I. LA LUMIA, op.cit., pag. 232-233.
[7] I. LA LUMIA, Storie siciliane, IV, op.cit., pag. 237.
[8] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 237; pag. 254. Si veda anche G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno III a, man. cit., pag. 138.
[9] L. Sciascia, Una rosa per Matteo Lo Vecchio,
[10] W. Faulkner, Una rosa per Emily, Milano, Adelphi, 1997.
[11] L. Sciascia, Una rosa per Matteo Lo Vecchio, op. cit., pag. 1017. Precisiamo che quando Sciascia il 21 giugno del 1969 andò a cercare a Palermo la via intitolata a Matteo Lo Vecchio e scoprì che si trattava di “un vicolo corto e stretto, fatto di tristissime case; e una piuttosto antica, forse appunto quella del Lo Vecchio” erano trascorsi due secoli e mezzo e non uno e mezzo dalla sua morte. Inoltre anche volendo prendere le distanze dal canonico Mongitore che, nel suo diario, a proposito del vilipendio fatto al cadavere parla di “divina giustizia”, ci sembra azzardato sostenere che , in fondo al pozzo secco, accanto al cadavere di Lo Vecchio dorma il cadavere dello Stato di Sicilia stroncato dalla restaurazione prima spagnola e poi austriaca.
Matteo Lo Vecchio
La lenta conclusione di una lunga vicenda
Il Papa toglie l'interdetto

Clemente XI
Così il 2 settembre 1719 Clemente XI tolse l'interdetto col quale aveva colpito la diocesi di Lipari. La controversia liparitana esplosa il 22 gennaio 1711, può dirsi così conclusa. Nell’esperire le pratiche relative al sollevamento dell'interdetto della città di Lipari pare abbia avuto un ruolo importante il canonico Hurtado che fu insignito del titolo di Protonotario Apostolico. Mentre l'Hurtado faceva immediato ritorno all'isola il vescovo Tedeschi rimase a Roma e seguitò nella carica che il pontefice gli aveva conferito di Segretario della S. Congregazione dei Riti ed esame dei vescovi.
“Quindi, restituita a Lipari la primeva pace, si aprirono le Chiese, si ripigliò il primiero pubblico divino culto, con disumarsi i cadaveri de’ fedeli sepolti nelle campagne fuori le Chiese in tempo del suddetto Interdetto, e con pie esequie e funerali si portarono dentro le sepolture delle Chiese già benedette, ove si fecero dalli rispettivi parenti li suffraggy per l’anime de’ loro defunti[1]”.
Nel 1722 i liparesi cominciarono a protestare per l'assenza prolungata del loro vescovo anche perché la soldataglia austriaca aveva occupato il Palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale riducendolo ad una sudicia caserma e si lasciava andare ad ogni sorta di prevaricazione.
Tranquillizzatasi un po’ la situazione politica in Sicilia il vescovo fu messo di fronte all'alternativa se tornare a Lipari o rinunciare al vescovado. Tedeschi preferì rinunciare al vescovado confermando così, in qualche modo, il giudizio che di lui aveva dato l’abate del Maro scrivendo al re Vittorio Amedeo II il 10 dicembre 1713 e cioè che oltre ad essere “cabalista, astuto, ambizioso, maligno” ma anche “dotto, disinvolto e cortegiano all’usanza di Roma in grado supremo”, questo vescovo non poteva “ridursi a vivere nello scoglio di Lipari, e crede con accender fuoco , come ha fatto fin hora, di fare gran sbalzi, e di riuscir Cardinale”[2] . Non divenne però cardinale ma si contentò della posizione in Vaticano, di una pensione di 500 ducati a carico della mensa vescovile di Lipari e del titolo del tutto nominale di Arcivescovo di Apamea.
Papa Innocenzo III, succeduto a Clemente XI. nominò, al suo posto, mons. Pietro Vincenzo Platamone[3]che fu accolto con onori trionfali alla marina e dopo qualche giorno accompagnato in pompa magna in Cattedrale.[4]


A sinistra il Papa Innocenzo III. A destra mons. Platamone
Un nuovo statuto della Legazia
Per quanto riguardava la Legazia Apostolica, alla fine gli intransigenti delle due parti furono isolati e si pervenne alla normalizzazione dei rapporti tra la Santa Sede e la corona di Sicilia, e alla conseguente pacificazione religiosa dell’isola.
Benedetto XIII, divenuto papa il 29 maggio 1724, con la bolla “Fideli ac prudenti dispensatori” del 1728, chiamata per questo “concordia benedettina”, diede nuove basi all’istituto. Si riaffermava, con qualche limitazione, la giurisdizione del Tribunale di Regia monarchia sulla Chiesa siciliana anche se il Tribunale veniva presentato come una concessione pontificia non direttamente collegato col privilegio della Legazia Apostolica.[5].
Era rimasto irrisolto il nodo di Lipari: circa l'inclusione o l'esclusione dalla Legazia Apostolica. Così nel 1729 si verificò un nuovo incidente quando il giudice della Monarchia nominò un suo delegato a Lipari per controllare che l'uso delle immunità ecclesiastiche non favorisse il contrabbando del tabacco. Alla nomina si oppose il vescovo Platamone che scomunicò il delegato. Per fortuna, questa volta, il governo cedette revocando la nomina del delegato e imponendogli di chiedere l'assoluzione dalla scomunica[6].
Nel 1749 il re Carlo III di Borbone riconobbe la competenza del Tribunale della Monarchia per un ricorso contro il Vescovo di Lipari presentato dai fide-commissari dell'ospedale S. Bartolomeo e dispose l'istituzione a Lipari di un delegato della Regia Monarchia[7]. Poiché non si ebbero reazioni né da parte del Vescovo, né dalla S. Sede, da quel momento le Eolie furono sottoposte alla giurisdizione della Legazia Apostolica.
Ad indicare che gli anni della controversia non furono un fenomeno che colpì ed interessò solo i ceti dominanti vi è un canto popolare che ricorda questo periodo. Esso recita:
Lu Santu Patri ni livau la missa,
lu Re conza la furca a li parrini,
la Sicilia è fatta carni di sasizza,
cca c'è la liggi di li saracini[8].
La “concordia benedettina” se mise fine ai conflitti sulla Apostolica Legazia non chiuse però le discussioni su di essa e le dispute fra regalisti e curialisti. Inoltre all’inizio del XIX secolo gli stessi vescovi, anche se tutti di nomina regia e leali nei confronti del sovrano, chiesero, con una Memoria rivolta al re Borbone, una serie di riforme dell’istituto fra cui l’ applicazione meno rigida della Regia monarchia e la possibilità di trattare con la Santa Sede le riforme in ambito ecclesiastico ma questa perorazione non ottenne praticamente nessun risultato.
Comunque nessuno si dichiarava contrario alla Legazia e persino Garibaldi, quando arrivò in Sicilia nel 1860, fu salutato con tutti gli onori previsti per il legato: fu accolto dai canonici all’ingresso della cattedrale e accompagnato a sedersi sul trono regale più alto di quello episcopale. Può sembrare strano questo volere mantenere delle prerogative in materia ecclesiastica da parte di governanti che erano massoni ed anticlericali. Ma, probabilmente, al di là della logica dei principi, ebbe la meglio il ragionamento politico che intendeva sottrarre ad una Santa Sede fortemente contraria al nuovo regno prerogative e funzioni che certamente incidevano significativamente nella vita civile della nazione.


A sinistra, Garibaldi a Palermo. A destra Cavour.
Così, probabilmente per queste ragioni, quando la Sicilia entrò a far parte del Regno d’Italia in un primo tempo il governo italiano, sentendosi pienamente erede dei privilegi legaziali esercitati dal governo borbonico, per la Sicilia reclamava non solo l’exequatur come per il resto del paese, ma anche l’esercizio libero del diritto di nomina dei vescovi.
Di fronte a questo atteggiamento Pio IX decise di abolire definitivamente la Legazia Apostolica di Sicilia e il Tribunale della Regia monarchia con la bolla Suprema universi dominici gregis e il breve Multis gravissimi. Bolla e breve erano del 28 febbraio 1864 ma furono pubblicati solo il 12 ottobre 1867 dopo che fu raggiunto l’accordo col governo per la nomina dei nuovi vescovi e consumata la frattura con l’approvazione delle leggi eversive.
Finalmente il 13 maggio 1871, con la legge delle Guarentigie, anche il governo italiano rinunciava, come abbiamo accennato, al diritto di Legazia Apostolica in Sicilia rendendosi conto che essa contrastava nettamente con i principi liberali riassunti da Cavour nella celebre frase:”Libera Chiesa in libero Stato”[9] . Questo istituto medioevale era durato quasi 800 anni[10].
Bisogna osservare che può sembrare incredibile che per 800 grammi di ceci si sia scatenata una vicenda che ha sconvolto tutta la Sicilia e coinvolto, oltre la Santa Sede, anche diverse potenze europee, creando problemi a tanta gente compreso esili e carceri. Eppure non si tratta di una reazione abnorme ad un fatto estremamente modesto, una sorta di follia collettiva esplosa non si sa come e non si sa perché. Ma uno scontro duro fra due ordini di potere che avevano confini di competenza molto labili e quindi facilmente tracimavano, forse perché è proprio del potere non porsi limiti e confini.
 Pio IX
Pio IX
Un conflitto - prodotto scientemente - legato ad istituti paradossali quale quello della Legazia Apostolica e dell'exequatur. Ma la Legazia Apostolica e l'exequatur esistevano perchè esisteva la commistione fra potere politico e potere religioso che era il vero nodo perverso. Da una parte il re che oltre ad avere il potere politico poteva vantare, proprio in nome della Legazia, funzioni di ordine religioso e dall’altra un vescovo che ricopriva in se la funzione di signore politico e di capo religioso che era strattonato fra il Sovrano ed il Papa, fra le ragioni delle istituzioni politiche e quelle delle istituzioni ecclesiastiche. In più a questo problema si aggiungeva – complicanza nella complicanza - la questione della diocesi di Lipari direttamente soggetta alla Sede Apostolica. E' questa la miscela a cui Clemente XI e la Santa Sede decidono di dare fuoco scegliendo un vescovo ambizioso e battagliero – Mons. Tedeschi – ed inviandolo a Lipari col preciso incarico di fungere da detonatore. Missione che Tedeschi compie puntualmente[11].
[1] G. LA ROSA, op.cit., vol.I,pag.267.
[2] “Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’Isola di Sicilia dall’anno MDCCXIIII al MDCCXIX. Documenti raccolti e stampati per ordine della Maestà del Re d’Italia VittOrio Emanuele II”, Torino, Tipografia Eredi Botta, MDCCCLXII, ( a cura di V.E.STELLARDI), pag. 131.
[3] Pietro Vincenzo Platamone, domenicano, nato a Cammarata il 15 febbraio 1666, fu eletto vescovo di Lipari il 23 marzo 1722 ottenendo l’exequatur dal Tribunale della Monarchia di Palermo. Morì il 22 febbraio del 1733.
[4] La processione che si snodava dal Palazzo vescovile della villa vedeva prima il clero regolare e secolare quindi il vescovo “a cavallo dritto sopra una bianca mula, condotta con briglia in mano dal Giurato Seniore, e sotto baldacchino portato con aste a mano dall’intiero Magistrato Civico, seguitato dal Populaccio tutto con gridi di giubilo, che vedevano la loro Chiesa decorata con la presenza del suo Pastore che , per ott’anni circa [per la verità erano dieci] era stata priva per l’allontanamento del predecessore Monsignor Tedeschi, che gli la interdisse”. G. LA ROSA, op.cit., pag.268.
[5] G. ZITO, op. cit., pag.81.
[6] Se non esplose un'altra “controversia liparitana” fu solo perché le corti di Roma, Vienna e Palermo si preoccuparono immediatamente e il governo di Palermo volle gettare acqua sul fuoco. Se tutto invece fosse dipeso da Lipari probabilmente la vicenda non si sarebbe chiusa tanto in fretta perché lo scontro fra il vescovo ed il delegato del Tribunale della Monarchia –che poi era lo steso canonico Diego Hurtado che era stato vicario al tempo di mons. Tedeschi ed uno dei protagonisti della grande “controversia” – si sviluppò violentissimo e la scomunica aveva coinvolto non solo l’Hurtado ma anche i giurati, i loro segretari, il mastro notaro dell’Hurtado ed un altro sacerdote. Ai protagonisti secondari il vescovo concesse subito l’assoluzione mentre lasciò l’Hurtado almeno un mese “in un cantone di mia casa privo della comunione dei fedeli e con quelle amarezze che possono imaginarsi “. La reazione durissima del Platamone che, peraltro si era sempre comportato – a sentire il La Rosa - “con fina politica e prudenza”, sarebbe stata provocata dal fatto che l’Hurtado gli comunicò la sua nomina due mesi dopo averla ricevuta e il vescovo vide in questo ritardo l’ombra della macchinazione. La ricostruzione di questa vicenda, come la documentazione che il Diego Hurtado in questione è lo stesso del tempo di mons. Tedeschi - e non un suo omonimo come asserisce Leopoldo Zagami (Lipari e i suoi cinque millenni di storia, Messina, 1960., pag.276) - si trovano in G.IACOLINO, man. cit. Quaderno IIIA, pp.152 b, 153, 153°, 154,155. v. anche G.OLIVA, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese nei secoli XVII e XVIII, op. cit; G.CATALANO, Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia, Catania 1950.
[7] G.CATALANO, Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia, Catania 1950, p.91
[8] “ Il Santo Padre ci ha tolto la messa/ il re prepara la forca per i preti/ la Sicilia è fatta carne da salsiccia / qui vige la legge dei saraceni”in Brigantino. Il Portale del sud . Storie di Sicilia di F. MISURACA, www.ilportaledelsud.org.
[9] S. FODALE, op. cit., pag. 44.
[10] G. ZITO, op. cit., pag. 94-105.
[11] S. FODALE, Stato e chiesa: la prima controversia liparitana, in “Dal ‘constitutum’ alle ‘controversie liparitane’, op. cit.pp.115- 126. Anche se è stato fatto osservare che quello che si verificò soprattutto a partire dalla “controversi liparitana” fu “tanto strepito per nulla..”Il funzionamento dell’Apostolica Legazia non avea giammai intaccata l’autorità della Chiesa; il suo tribunale, che era presieduto da un ecclesiastico che si dava il titolo di Monsignor Giudice della Monarchia, limitavasi all’ingerenza di esso in poche quistioni riguardanti la disciplina, mai la fede, e soprattutto a conoscere le cause degli esenti ed in terza istanza quelle state decise dalla Curia Metropolitana; e ciò non che pregiudizio, talvolta di sommo vantaggio era tornato alla Chiesa, tanto che il Cattolicesimo in nessun luogo della terra ebbe mai più fervidi e convinti seguaci delle popolazioni siciliane”. G. OLIVA, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese nei secoli XVII e XVIII, Messina 1905, pp. 91-93.
Tag Cloud
Demetra Diodoro don Giovanni Rodriquez Eolo Eusebio Fabio Famularo La meligunis Mons. Ballo Mons. Todaro Pandolfo storia isole eolieAltro
La "controversia": il conflitto si estende
La “controversia” investe tutta la Sicilia


A sinistra il duomo di Catania. A destra il palazzo vescovile di Girgenti
Ma ormai la vicenda stava uscendo dalle mura diocesane. Ai primi di febbraio del 1712 a tutti i vescovi della Sicilia pervenne – tramite il vescovo di Catania secondo quanto afferma il documento “Veridica Relatione” - una lettera circolare della S. Congregazione, datata 16 gennaio, con ordine di affiggerla in tutte le cattedrali. In essa si ribadiva la nullità della sentenza assolutoria in favore di Tesoriero e Cristò e, più velatamente, si mettevano in discussione gli esorbitanti poteri di giurisdizione ecclesiastica che la Monarchia soleva esercitare. Ci vollero due mesi per tirare le somme di come era stata accolta dai vescovi siciliani questa iniziativa. I vescovi di Messina, Siracusa e Cefalù rappresentarono alla Santa Sede le loro preoccupazioni, i vescovi di Palermo, Patti e il vicario generale di Monreale chiesero l'exequatur al Tribunale della Monarchia che lo negò, solo i vescovi di Girgenti, Catania e Marsala – e cioè mons. Francesco Ramirez, mons. Andrea Riggio e mons. Bartolomeo Castelli - pubblicarono nello stesso giorno , il 21 marzo 1712, il documento senza nemmeno chiedere l'exequatur[1] . Il vicerè finse di credere che si fosse trattato, per questi presuli, di un caso di omissione involontaria e richiamò cortesemente i contravventori. Questi all'unisono risposero che trattandosi di materia dommatica, di fede, concernente la salute spirituale dei fedeli e non di pura e semplice giurisdizione, ne avrebbero risposto solo al Sommo Pontefice.
Della vicenda cominciò a parlarsene anche all'estero. In Spagna uscì un libello anonimo polemico contro i vescovi di Lipari, Girgenti, Catania e Mazara dove - rifacendo in qualche modo la storia della “controversia” - si giustificava l'agire del Tribunale della Regia Monarchia contro la diocesi di Lipari[2]. In Sicilia invece il viceré cercava di mantenere la calma e reagì convocando a Palermo una consulta di cinquantanove teologi – di cui parla Sciascia nel secondo atto della sua Recitazione - per sottoporre al loro esame la circolare della S. Congregazione dell'immunità ecclesiastica. Il responso fu, naturalmente, che non si trattava di materia di fede ma giurisdizionale e quindi non intaccava né la fede né il dogma.


A sinistra il palazzo vescovile di Marsala. A destra una raffigurazione di Mons. Riggio, arcivescovo di Catania
Intanto a Lipari il canonico Hurtado, che teneva i contatti col vescovo, - forte del fatto che il Sant’Uffizio di Lipari era riconosciuto direttamente dipendente dal Sommo Tribunale del Sant’Uffizio di Roma - decise di convocare, nel maggio del 1712, nel Palazzo vescovile della Lipari bassa, un consiglio di ecclesiastici liparesi, “con sopravveste di Sant' Uffizio”, per definire le opportune sanzioni canoniche contro l'Aucello e gli altri ecclesiastici che continuavano a celebrare messa alle Grazie che era stata interdetta. Il consiglio spiccò un monito di scomunica che fu recapitato al delegato speciale del Tribunale della Monarchia con tutti i requisiti formali.
La reazione dell'Aucello fu dura e scomposta. Fece imprigionare il povero prete che gli aveva consegnato il monito e anche l'altro che gli portò l'ultimatum di Hurtado. Non solo, ma messosi a capo di un manipolo di una cinquantina di soldati spagnoli circondò il Palazzo vescovile , vi entrò con la forza e mise agli arresti domiciliari Hurtado e il confessore del vescovo. Cercò gli altri ministri della corte vescovile e del tribunale dell'inquisizione e incarcerò anche loro mentre lanciò minacce verso tutti quei sacerdoti che si erano dichiarati ubbidienti al papa.
Quindi presentò al vicario una parcella per le spese sostenute da lui e dalla sua scorta nella missione a Lipari e, di fronte alla obiezione, che la mensa vescovile non possedeva quella somma, fece sequestrare i beni personali del vicario minacciando la loro vendita all'asta per cui il malcapitato si vide costretto a cercare prestiti personali per far fronte alla richiesta.
Soddisfatto il problema economico l’Aucello decise di tornarsene a Palermo e di portarsi dietro prigionieri l'Hurtado ed altri importanti ecclesiastici di Lipari. Ma, a suo scorno, l’Hurtado poté opporgli una lettera del Segretario di Stato Vaticano, giuntagli proprio in quei giorni, che gli comandava di non abbandonare Lipari per qualsiasi motivo. Così Aucello se ne partì da solo con la sua scorta intimando però agli ecclesiastici liparesi di raggiungerlo a Palermo entro due mesi. Partì, abbandonando Lipari in una confusione maggiore di quella che aveva trovato al suo arrivo[3].


A sinistra,Papa Clemente XI. A destra ritratto del canonico Mongitore
Roma non poteva lasciar passare sotto silenzio quanto era accaduto. Il 17 giugno 1712 papa Clemente emanò una lettera apostolica nella quale ribadiva che la Chiesa di Lipari era immediatamente soggetta alla Santa Sede e scomunicava l’ Aucello e tutti quelli, di qualsiasi grado e condizione, che gli avessero comandato, eseguito, consigliato e approvato gli atti che questi aveva compiuto contro la diocesi di Lipari. Naturalmente contro questa scomunica l’Aucello fece ricorso al giudice della Monarchia. Della risposta di Aucello e di Palermo ce ne parla il can. Antonino Mongitore nel suo Diario:”Ricorsero al giudice della Monarchia, allora D.Francesco Miranda, spagnuolo, il quale ordinò al canonico che celebrasse, andasse al coro e passeggiasse come al solito; e così ordinò agli altri. E in fatti, senza curarsi di essa, seguitò come se non fosse stato scomunicato, con pubblico scandalo; così fecero gli altri con manifesto disprezzo della scomunica”.[4]
La scomunica dell'Aucello questa volta papa Clemente la comunicò con due Brevi anche al Vescovo di Palermo ed al viceré mentre qualche settimana prima aveva avviato una forte opera di pressione nei confronti dei vescovi che si erano dimostrati pusillanimi mancando di affiggere la lettera circolare della S. Congregazione, lodando invece quelli di Girgenti, Marsala e Catania. Finalmente il 30 giugno 1712 i vescovi renitenti – dopo due mesi di titubanza – si decisero a pubblicare il foglio della S. Congregazione.
Più tempo impiegò il Vescovo di Palermo che pubblicò la lettera insieme alla bolla di scomunica dell'Aucello il 22 febbraio 1713. Ma c'era voluto, per convincerlo, la minaccia di “sospensione a divinis “ da parte del papa.
 Un'altra immagine del Canonico Mongitore
Un'altra immagine del Canonico Mongitore
Il viceré pazienta diverse settimane e il 22 marzo 1713 emana una ordinanza con la quale si riaffermavano i diritti dei sovrani della Sicilia e si dichiarava nulla la lettera della S. Congregazione dell'Immunità e qualunque altra disposizione provenienti da “corti estere” che venissero rese pubbliche senza il preventivo regio exequatur. Si scatena una forte contesa fra il potere della Regia Monarchia ed i vescovi costretti ad abbandonare le loro diocesi e rifugiarsi a Roma. Si cominciò col vescovo di Catania il 18 aprile 1713 – ed è quanto rappresenta Sciascia nell’Intermezzo fra il II ed il III atto – che dichiara di partire cedendo alla violenza. Mons. Riggio - di temperamento rude e focoso tanto da vantarsi delle ventotto liti che aveva in corso ma che non gli toglievano né il sonno , né l’appetito - aveva contrapposto all’ordinanza del viceré un suo editto a stampa nel quale bollava l’ingiunzione come “temeraria, orrida, scandalosa e perniciosa”. L’editto appariva come l’ennesima provocazione di questo vescovo nei confronti dell’autorità del viceré fra le quali spiccava la riesumazione di una vecchia scomunica inflitta al capitano d’arme e di giustizia di Catania, barone di Ficarazzi, annullata dal giudice della Monarchia, sentenza che di fatto il Riggio aveva accettata. Ricevuta l’intimazione a lasciare Catania, il vescovo “ bel lontano dal pentirsi di quel che haveva fatto, trascorse più oltre, fino a fulminare nell’atto della sua partenza l’Interdetto nella Diocesi, col pretesto d’essere stato espulso per pura violenza; e nello stesso tempo Scomunicò i due Officiali militari, dai quali gli era stata fatta l’intimatione dello Sfratto”[5]
All’espulsione del vescovo di Catania fa seguito quella del vescovo di Messina il 29 luglio, quindi il vescovo di Girgenti che partì il 28 agosto, il 27 febbraio del 1715 se ne partì il vescovo di Palermo A questo turbine di espulsioni – spesso scientemente provocate e ricercate[6] -i i vescovi reagivano con interdetti e scomuniche. Dovette partire anche il can. Hurtado[7] che abbandonò Lipari il 24 gennaio del 1714 lasciandosi anche lui alle spalle un editto di interdetto per l'intera diocesi.
Gli effetti sociali di scomuniche ed interdetti
Questo susseguirsi di scomuniche, interdetti, sfratti, arresti e quant’altro non lasciavano il popolo e molti degli stessi protagonisti indifferenti. La scomunica, come abbiamo visto, colpiva il singolo individuo e aveva effetti nelle relazioni sociali e se c’era chi non li rispettava c’era però chi li metteva in pratica ed anche chi, colpito, se ne faceva un tormento. Più grave. Come si è detto, era l’interdetto che praticamente impediva che nella comunità che ne veniva colpita potessero celebrarsi alcune funzioni religiose ed alcuni sacramenti e non solo la messa in pubblico ma soprattutto i funerali e anche la benedizione nuziale nei matrimoni ed il battesimo poteva avvenire in forma semplice e privata per non parlare dell’impossibilità di seppellire i morti i terra consacrata per cui i familiari dovevano trovare una collocazione provvisoria della salma in qualche giardino o podere.. Cioè la gente veniva colpita in momenti cruciali della vita che in una società com’era la Sicilia del 700 – ancora scarsamente secolarizzata – finivano coll’avere un risvolto sociale, alla lunga, traumatico.
Certo, era possibile trovare preti che ubbidivano alla Regia Monarchia e non tenevano conto di scomuniche ed interdetti ma non erano molti e spesso finivano con l’aumentare nel popolo confusione e disagio. Come accadde a Catania quando mons. Riggio partì, fu subito mandato nella diocesi il canonico Gaetano Buglio di Messina, in qualità di delegato del Tribunale della Monarchia e col compito di convincere i fedeli a disattendere scomuniche ed interdetto. Ma presto lui stesso fu raggiunto dalla scomunica pontificia e il popolo non sapeva più cosa pensare.
Fu il periodo in cui nelle zone di Catania, di Girgenti, di Mazara, di Messina ed anche di Lipari - cioè dove la gente era più frastornata da opposte sollecitazioni ad obbedire al re o al papa - cominciò a diffondersi una “cultura religiosa e pseudo teologica” di cui un anonimo[8] ci ha lasciato qualche memoria. Così la consacrazione da parte dei sacerdoti inosservanti non produceva nell’Ostia la venuta del “Sacrosanto Corpo, anima e divinità di Nostro Signore” ma quella di un demonio; “ si niega lecitamente il debito coniugale dalle mogli osservanti alli loro mariti inosservanti”; non si può pigliarsi nella Chiesa l’acqua benedetta perché in Chiesa inosservante e benedetta da sacerdote parimente inosservante, anzi stimano a grave peccato segnarsi con essa la fronte” e così via.
Per di più la stessa polemica che si diffondeva attraverso la stampa non lasciava indifferenti le autorità e la Regia Monarchia. Quando nei primi mesi del 1713 uscì il libretto “Difesa della verità” attributo a mons. Tedeschi, subito non produsse alcuna reazione, forse si pensò che l’avrebbero letto in pochi e quindi dimenticato. Ma non dovette essere così se Filippo V, nel febbraio del 1716, ordinò al Consiglio di Stato di farlo valutare da esperti per suggerire come farvi fronte. Ma gli esperti consigliarono al re di non prendere nessuna decisione per non provocare l’autore stimolandolo a procedere nella polemica con quella penna “tan empeinada y ensangrentada” cioè tanto corriva e infuriata[9].
Trovare una mediazione o abolire la Legazia?


A sinistra, Vittorio Amedeo II. A destra, il card. Tommasi.
Intanto il 10 giugno 1713 ad Utrecht, Filippo V di Spagna sottoscriveva la cessione della Sicilia al duca del Piemonte Vittorio Amedeo II di Savoia che veniva ad assumere il titolo di re. Nella disfida fra la Spagna e l'Austria il Piemonte, che in un primo tempo era schierato con la Spagna, era passato con l'Austria e, quando fu firmato il trattato, ottenne la Sicilia grazie alla volontà dell'Inghilterra che lo preferì ai Borboni ed all'Austria. Il nuovo re indugiò a prendere possesso della Sicilia e lo fece solo il 10 ottobre 1713. Egli per cercare di pacificare la situazione agì su due fronti. Da una parte confermò viceré e ministri e li esortò a tornare in lizza mentre intimò a preti, frati e fedeli di disattendere i moniti e i consigli di Roma minacciando carcerazioni, esili e confische. Dall'altra però cercò di intrecciare col Vaticano trattative diplomatiche tentando di fare intervenire anche l'ambasciatore di Francia.
Le attese della corte di Palermo dopo il cambio di regnante, sono espresse chiaramente nella seconda parte de la “Veridica Relatione”[10]: “Credevasi da ogni persona di buon senso, che la Corte di Roma, trovandosi sciolta verso del nuovo dominio, da quell’impegni, che haveva presi col precedente governo, non solamente si sarebbe astenuta dal far nuovi procedimenti ne’ primi mesi dell’acclamatione, ed incoronazione di Sua Maestà, ed in tutto quel tempo, che fusse necessario al nuovo Rè, per informarsi di questa contesa, ma di più havrebbe ricercate in ogni occasione le aperture, che potessero darle qualche speranza d’adequamento”.
Papa Clemente però non era disposto ad accomodamenti anzi, valutando che l’Inghilterra, sostenitrice dei Savoia, fosse poco interessata alle questioni religiose pensò che la nuova congiuntura gli permettesse finalmente di venire a capo di questo istituto della Legazìa che aveva creato tanti problemi. Così il 25 gennaio emise solenne scomunica contro il giudice della Regia Monarchia e contro tutti quelli che si erano adoperati a sfrattare i vescovi dalla Sicilia. Non era questo che l’ennesimo attacco che da Roma veniva al Regno di Sicilia dopo l’avvento di Vittorio Amedeo II. La “Veridica Relatione” li elenca tutti uno per uno.
Questa scomunica ebbe come effetto le dimissioni dalla carica di giudice del conte di Miranda perchè preso da scrupolo religioso e probabilmente colse anche l’occasione per sfilarsi da una realtà incandescente e tornarsene in Spagna . Fu messo al suo posto un dotto e pio canonico messinese, don Giacomo Longo forse con intenti di pacificazione. Il nuovo giudice però si manifestò determinato ed intransigente. E di questa sua determinatezza ed intransigenza se ne resero conto subito i Liparesi.
Il vicario generale don Diego Hurtado prima di partire da Lipari per via dello sfratto il 24 gennaio 1714, aveva predisposto, senza dare nulla a vedere, certo d’accordo col suo vescovo che era sempre a Roma, una sorta di bomba ad orologeria. Intrattenendosi in cordiale e familiare conversazione col luogotenente Giovanni Battista Castaldi, attendendo il mercantile che doveva portarlo a Civitavecchia, il canonico sembrava avere accettato con tranquillità e rassegnazione il provvedimento di espulsione. Ma la sera stessa della sua partenza, quando furono le otto, improvvisamente le campane della Cattedrale presero a suonare a morto e il mesto rintocco durò una buona mezz’ora. Ai curiosi ed alla guardia che raggiunsero la chiesa apparvero, affissi sulla porta, i “cedoloni” contenenti la scomunica per il luogotenente ed il suo aiutante e l’editto di interdetto per l’intera diocesi[11].
Uno dei primi provvedimenti del nuovo giudice don Longo fu quello di inviare a Lipari, quale delegato del Tribunale, il cappellano del Real Palazzo, don Giuseppe Marotta, col compito di convincere il clero a non tenere conto dell’interdetto e di garantire il normale esercizio del culto. Giunto a Lipari il 10 febbraio gli atti che il delegato compì non furono certo distensivi. Non solo mise in carcere i sei sacerdoti che apparivano come i più radicali e intransigenti del partito pontificio ed imprigionò i responsabili dell’affissione dei cedoloni della scomunica e dell’interdetto ed il sacrestano che aveva suonato le campane a morto, ma se la prese, mettendoli agli arresti, anche con quanti avevano negato il saluto ai due catapani per adeguarsi alle norme della scomunica.
Nello stesso tempo che usava il pugno duro, Marotta proclama “nullo, ingiusto, illegittimo, insussistente, irrito e di nessuna forza e valore” l’interdetto lanciato dal vicario Hurtado e minaccia di “scomunica maggiore riservata al Monsignor Giudice della Monarchia” chi si fosse comportato come se fosse ancora in vigore[12].
Quindi convoca il Capitolo della Cattedrale e pretende che si elegga il nuovo vicario episcopale in sostituzione dell’Hurtado. Risultò eletto il can. Emanuele Carnevale che si adoperò per riportare la tranquillità nelle isole. Ma era una pia illusione.
Il 17 settembre 1714 veniva pubblicata a Lipari la scomunica pontificia contro i militari che avevano espulso Hurtado, contro Marotta e i componenti la Curia di costui, contro il guardiano dei cappuccini e coloro che avevano officiato nelle chiese già interdette. Era l'atto che lasciava Lipari, per alcuni anni ancora, priva di funzioni religiose.
Il rincrudirsi del dissidio a Lipari si estese subito a tutta la Sicilia e innumerevoli furono le contestazioni tra i rappresentanti della Chiesa e le autorità governative, cui fecero seguito esili, carcerazioni e confische che si protrassero per tutto il tempo in cui Amedeo II di Savoia fu re di Sicilia.
Il lavoro in sordina della diplomazia
 Cardinale Paolucci
Cardinale Paolucci
Intanto proprio nel 1714 mentre lo scontro si diffonde sul territorio dello stato, dietro le quinte, la diplomazia continua ad operare per trovare una soluzione. L’iniziativa forse più significativa, in questo periodo, fu quella che partì il 24 dicembre del 1713, il giorno della cerimonia dell’incoronazione del re nella Cattedrale di Palermo. Ce ne parla una fonte di parte regalista[13]. L’iniziativa prese le mosse da un gruppo di vescovi e prelati siciliani lì presenti fra i quali quelli di Siracusa, Cefalù, di Palermo e di Mazzara. Non era possibile, ragionavano questi, che se al papa fossero state presentate, nel modo adeguato, le ragioni del Tribunale della Monarchia non si sarebbe potuto trovare una soluzione. E si convenne d’accordo monarca e vescovi che questi ultimi avrebbero scritto alla Corte di Roma sollecitando un chiarimento. Ma le lettere non ebbero risposta ed allora il re pensò di mandare a Roma un suo informatore ed incaricò di questa incombenza l’abate Barbara di Santa Lucia. Questa volta il cardinale Paulucci, segretario di stato del papa, scrive, il 4 marzo, al Cardinale della Tremoille che allora era ambasciatore a Roma di Luigi XIV e si era assunto il ruolo di mediatore nella vicenda, facendogli presente che l’abate Barbara non poteva essere ricevuto perché stava per essere scomunicato essendosi compromesso nella diocesi di Catania dopo l’interdetto del vescovo Riggio e l’insuccesso del canonico Buglio. Quanto alla possibilità di un accordo bisognava prima consentire a delle richieste preliminari e cioè: “1. che si rimuovino, e revochino gli impedimenti frapposti all’osservanza dell’Interdetto nelle Città, e Diocesi a quello sottoposte; 2. che si cessi da ogni vessazione contro di quei, che hanno ubbidito, & ubbidiscono agli ordini della Santa Sede; 3. che si scarcerino tutti quei, che restano carcerati per tali cause; 4. che si richiamino i vescovi espulsi, come altresì il Vicario di Lipari, e tutti gl’altri Ecclesiastici sì Secolari, come Regolari sfrattati per le medesime cause, e che detti Vescovi siano lasciati nel libero esercizio della loro ordinaria giurisdizione”[14].
Una dichiarazione di rottura vera e propria che il cardinale di Tremoille cerca di mitigare con una sua memoria del 4 aprile 1714, indirizzata all’abate del Maro che rappresentava il re al corte pontificia. Il porporato francese affermava che, al di là di quanto era scritto nel documento, egli aveva potuto raccogliere dal papa, dal cardinale Paolucci e dal cardinale Albani, nipote del papa, che Clemente XI potrebbe mostrarsi più disponibile se “il Rè di Sicilia le aprisse una porta per uscire dal suo impegno”[15].
Ma era proprio questa “porta” che era difficile trovare e lo sarà per molti anni, tutti quelli in cui Vittorio Amedeo rimane re di Sicilia. Il fatto era che per il papa, quello della Legazia apostolica e del suo Tribunale, era divenuta una vera e propria fissazione che si era radicalizzata col peggiorare del suo stato nervoso. Tutte le notti – aveva confidato – gli appariva in sogno lo spirito del cardinale Tommasi – siciliano, della famiglia dei Tommasi di Lampedusa – morto l’anno prima in fama di grande dottrina ed in odore di santità che lo sollecitava, “sotto pena di dannazione, a distruggere detta Regia Monarchia”[16]. Probabilmente una via d’uscita per il papa sarebbe stata quella che – in un’altra lettera del 4 gennaio 1714 scritta dall’abate del Maro al re[17] - viene riportata come una confidenza del cardinale Paolucci al cardinale La Tremoille: il papa avrebbe fatto intendere al suo segretario di stato, “in maniera enigmatica”, che avrebbe potuto accogliere alcune richieste del re a condizione che Vittorio Amedeo, “com’era di dovere, si determinasse a levare le Investiture dalla Santa Sede”. Clemente XI cioè cercava di alzare la posta e faceva riferimento ad una pretesa sovranità della Santa Sede sulla Sicilia per cui il re, per essere riconosciuto tale, avrebbe dovuto ricevere l’investitura da parte del papa[18].

La corte di Luigi XIV.
E’ un tema che tornerà ripetutamente negli anni a seguire nelle varie trattative che cercheranno un “aggiustamento” della vertenza, ma mai questo tema dell’”investitura” sarà preso in considerazione dal Savoia il quale non poteva concepire che in pieno settecento, il secolo dei lumi, si venisse a riproporre una stagione delle investiture di stampo prettamente medievale. Per quanto debole fosse il nuovo sovrano, vaso di coccio fra i vasi di ferro delle grandi potenze europee, e per quanto bisogno potesse avere dell’appoggio pontificio, Vittorio Amedeo aveva però una dignità ed una cultura a cui non poteva abdicare. Inoltre proprio il trattato di Utrecht lo obbligava a tenere in vigore tutte le norme e prerogative del regno che andava a governare.
Così mentre il difficile lavorìo dei mediatori andava avanti il papa preparava bolle e costituzioni apostoliche che avrebbe rese pubbliche all’inizio del 1715.
L'11 gennaio del 1715 emetteva la costituzione “Accepimus super” in cui condannava la pratica dell'exequatur giudicato un “temerario attentato a quella sublime potestà di legare e di sciogliere che a Noi e al Romano Pontefice pro tempore esistente è stata trasmessa dal Signore, e che non è serva ma libera dalla soggezione della secolare potestà”. Il 20 gennaio dello stesso anno pubblicava la costituzione “Romanus Pontifex”che aveva già pronta dall'anno prima in cui metteva fine alla Legazia Apostolica giudicandola ingiuriosa del primato della Chiesa Cattolica e usurpatrice dei diritti del Santuario. Vi si diceva anche che il presunto privilegio, a suo tempo concesso da Urbano II al re Ruggero, era un falso o, quanto meno, un documento alterato; ed anche ammesso che fosse veritiero non si poteva ritenere trasmissibile in perpetuo. Infine si accusava il Tribunale della Monarchia di avere introdotto un altro capo della Chiesa diverso da quello venerato in tutto il mondo. Alquanto roccambolesco il modo in cui si fece entrare in Palermo questo documento eludendo il divieto e la sorveglianza: furono inserite cinquanta copie della bolla dentro fiaschi che sembravano pieni di vino.
Il Tribunale della Monarchia se era il più importante non era però l’unico contenzioso esistente fra le due corti. Vi era anche in discussione, per esempio, la riconferma della Bolla della Crociata: un atto pontificio che autorizzava i sovrani a raccogliere fondi per la lotta agli infedeli in cambio appunto di benefici spirituali o esenzione da astinenze e penitenze. Un privilegio istituito, probabilmente, fin dai tempi della prima crociata e di cui godevano i sovrani spagnoli da oltre un secolo per ricavare proventi nella lotta contro i Turchi. Ora, però, Clemente XI non voleva concederlo a Vittorio Amedeo se non in cambio dell’investitura.
Ma se nel corso del 1714, mentre procedevano i contatti diplomatici, il papa affilava le armi di guerra non da meno faceva il re. Il 7 febbraio di quell’anno, infatti, istituì la Giunta stabile per gli Affari ecclesiastici, dotata di poteri illimitati, per la difesa dei diritti regali contro gli attentati della corte di Roma. Presto la Giunta si rivelò una sorta di inquisizione politica che si distinse per la sua aggressività ed efferatezza e soprattutto, a partire dal 1715, quando si conoscono le costituzioni pontificie contro l’exequatur e la Legazia, in Sicilia si diffonde un vero e proprio clima di terrore nel quale si distingue appunto quel Matteo Lo Vecchio che Sciascia ci presenta nell’atto quarto della sua Recitazione.
Il papa sperava che assumendo una posizione rigida nei confronti di Vittorio Amedeo e della Legazia avrebbe incontrato il favore delle potenze europee e del popolo siciliano che si sarebbe ribellato al sovrano. Invece gli stati stranieri, salvo l’Austria, si disinteressarono della questione ed il popolo non sapeva se prendersela col re o col papa, si lamentava per le restrizioni e le difficoltà che scomuniche e interdetti gli procuravano, ma aveva altre cose a cui pensare che alla ribellione. Il soli a mobilitarsi furono il clero ed i religiosi. In questa protesta si distinsero in particolare le suore come quelle di Girgenti che dopo aver murato le porte del loro convento esponevano sul campanile l’immagine del crocifisso coperta di veli neri in segno di lutto[19] o quelle di Palermo che rifiutarono il confessore straordinario Marotta e il loro cappellano perché erano stati a Lipari per conto del Tribunale della Monarchia e quindi scomunicati dal papa[20]. Ma la confusione nel popolo – quella confusione che già imperversava fin dai primi anni della “controversia” – ora cresceva di livello ed era sempre più difficile distinguere fra il clero patriottico su cui pesava la scomunica ed il clero di osservanza pontificia. E se più numerosi erano forse questi ultimi non mancavano nemmeno gli altri come quel padre Agostino Campanella, frate domenicano, che nella cattedrale di Palermo predicava che la gente ed il pontefice avevano tradito il Signore e faceva pregare “acciocché Dio illumini il Papa”[21],
Col tempo la situazione precipitò ulteriormente e numerosi furono gli ecclesiastici e i frati che abbandonarono la Sicilia. Nell'anno 1717, si è detto, nella sola Roma circolavano oltre millecinquecento sudditi siciliani perseguitati e sfrattati. Il 5 aprile furono scacciati da Palermo un centinaio di Cappuccini, altrettanti agostiniani e numerosi parroci e cappellani mentre il popolo appariva sempre più perplesso e confuso: si negavano i sacramenti a molti, si seppellivano i morti in luoghi non consacrati, matrimoni e battesimi si celebravano in fretta ed in una cornice di squallore, le processioni si tenevano con finti frati. Il re ed il viceré si videro costretti a richiamare la Giunta suggerendo maggiore moderazione, ma non la si volle fermare. Il re si limitò a ordinare che “i religiosi che debbono imbarcarsi non escano processionalmente dai loro conventi “ per evitare “le emozioni”.[22]


Lo scrittore Leonardo Sciscia che nella sua Recitazione sulla Controversia Liparitana fa di Matteo del Vecchio un personaggio quasi positivo. Il vicolo di Palermo intestato a questo "sbirro"
Il primo luglio 1718 gli spagnoli occuparono di nuovo la Sicilia e. Filippo V il 7 aprile del 1719 stipulò col papa un “trattato di accomodamento” nel quale, fra l’altro, si riconosceva l'efficacia delle scomuniche e si riammettevano i prelati esuli. Nel trattato non si diceva niente della “Legazia apostolica” e le cose sembravano andare come prima perché rimaneva il vigore il Tribunale della Monarchia. Il 1718 ed il 1719 furono due anni drammatici in cui gli “osservanti” a lungo repressi cercarono la loro rivincita nei confronti dei “patriottici”. Fu in questo clima che venne assassinato Matteo Lo Vecchio. Questo “sbirro” si era reso particolarmente odioso perché “passava di sacrestia in sacrestia, intimando e minacciando preti , e, senza distinzione, insultandoli tutti”[23]. Si appostava lungo le strade e fermava i passanti minacciandoli e questi per sottrarsi alle sue pressioni erano costretti a pagare. Ma intascati i soldi il Lo Vecchio riprendeva le sue vessazioni. Una volta si finse malato a morte e chiese un confessore. Accorsero i cappellani della vicina parrocchia e si dissero pronti ad assolverlo se si fosse dichiarato pentito di quello che aveva fatto contro la Chiesa. Ma a quel punto, il falso moribondo, balzò arzillo dal letto ed acciuffò i preti intimando loro lo sfratto dalla Sicilia.[24] Le sue angherie poterono andare avanti fino alla notte del 21 giugno del 1719 quando all’una, gli spararono due colpi di carabina proprio di fronte alla cattedrale. “Condotto a seppellire – racconta il La Lumia – nel giorno seguente, la plebe con fischi e dileggi accompagnò il cadavere, che, respinto da’ frati della chiesa di Santo Antonio, fu gettato in un pozzo secco fuori del sacrato di un antico cimitero suburbano”.
Nel maggio del 1719 gli austriaci subentrano al governo savoiardo e spagnolo in Sicilia e il Vaticano fiutando questo cambiamento cercò di rilanciare la bolla “Romanus Pontifex” ma la cosa , ora che comandava a Palermo, non piacque a Vienna. Il papa allora cambiò strategia e decise di applicare il “trattato di accomodamento” facendo pervenire i decreti abolitivi degli interdetti.
[1] “Veridica Relatione…”, doc. citato, pag. 8.
[2] Il libello senza data né luogo di stampa, pubblicato anonimo ma attribuito ad un certo don Francisco Amiglier recava un titolo chilometrico ed altisonante: “Propugnacolo dela real jurisdicion, protection de las regalias del regio exequatur y de la real Monarquia, patrocinio de la jurisdicion de los metropolitanos y de los privilegios del Reyno de Sicilia en respuesta de las rappresentaciones esparcidas por los illustrissimos Senores Obispos de Catania, Girgenti y Mazara, sobre la execution de las Cartas cuirculares de la Sagra Congregacion de la Immunidad, tocantes a recursos, ò Apelaciones de las declaratorias de censuras reservadas à la S. Sede Apostolica, y su assolucion à cautela, ò relaxacion por via de nullidad, ò injusticia”.A questo libello, aveva inteso rispondere il libretto di oltre 100 pagine, anch’esso anonimo e senza luogo di stampa, intitolato “Difesa della Veritè…” attribuito a mons. Tedeschi.
[3] Su questa vicenda della reazione dell’Aucello al monitorio di scomunica, della presentazione della nota spese, delle minacce ed in fine della sua partenza si fa riferimento al libretto più volte citato: Anonimo, Difesa della verità…., pp.28-29 ed al manoscritto di G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, quaderno IIIA, man. Cit., pp.104- 105.
[4] “Dal “Diario”del Canonico Mongitore”, Appendice, in , L.SCIASCIA, L’onorevole, Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D.. I mafiosi, Adelphi, Milano, 1995, pag. 147.
[5] “Veridica Relatione…”, doc. cit., pag.10.
[6] Mons. Riggio scriveva al vescovo di Girgenti in quei giorni:: “Che sorte di consolazione si è la mia di questa santa unione di queste Colleghe non può crederla! Brillo, giubilo, e salto pieno di giubilo e di contento. Viva V.S. Ill.ma, autore d’ogni bene, viva monsignor Vescovo di Mazzara che col suo zelo ci ha posto la sputazza al naso e sfida l’Inferno” in G.IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno IIIA, man. cit., pag. 106.
[7] La ragione dell’espulsione di Hurtado è da ricondurre ad un episodio specifico. Un tale Alfonso Mercorella volendo sposarsi ed avendo un impedimento chiede la dispensa alla S.Sede. Una volta ottenutala, la sottopone all’exequatur del Tribunale della Monarchia ma, a questo punto, quando si presenta a Hurtado se la vede rifiutare proprio perché aveva l’approvazione governativa. Proteste del Mercorella al governatore e ordine del viceré di espulsione del vicario.
[8] Manoscritto, già citato, “Delle Vertenze fra la Corte di Roma e il Governo della Sicilia”, Tomo Primo, Parte Quarta, pag. 127° e ss.
[9] Il documento si trova nell’Archivio General di Simanca, Legaio 6124, n. 34 e 38 citato da G. IACOLINO, nel dattiloscritto “La chiesa cattedrale di Lipari”, Quaderno IIIA, pagg. 107 a e b.
[10] “Veridica Relatione”, doc. cit. pp.12 e ss.
[11] “Delle vertenze fra la Corte di Roma e il Governo della Sicilia”, manoscritto cit., Tomo I, Parte II e III, pp.98-99°.
[12] “Delle vertenze…” manoscritto cit., pag. 99.
[13] “Veridica Relatione…”, doc. cit., pag.20 e ss.
[14] “Veridica Relatione…”, doc. cit., in allegato: “Nota delle memorie cennate nella veridica Relatione, e confronto de’ procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note Vertenze per Fatto del Tribunale della Monarchia”, “Memoria rimessa dal Cardinale Paulucci al Cardinale della Tremoille, continente le pretensioni della Corte di Roma per un adeguamento. Li 4 marzo 1714”.
[15] Memoria del Signor Cardinale della Tremoille rimessa al Signor Abate del Maro, li 4 Aprile 1714, in appendice alla “Veridica Relatione…”doc.cit.,.
[16] Lettera dell’abate del Maro al Rè del 24 dicembre 1713, in Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia, a cura di V.E. STELLARDI, vol. II, Torino, 1862, pagg. 27-28.
[17]Il Regno di Vittorio Amedeo II…., a cura di V.E. STELLARDI, vol.II, pagg. 135-137.
[18] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 206.
[19] I. LA LUMIA, op.cit., pag.241.
[20] G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno IIIA, datt. Cit., pag. 116.
[21] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 241.
[22] G. IACOLINO datt. cit. pag. 124.
[23] I. LA LUMIA, op. cit., pag.254.
[24] I. LA LUMIA op. cit., pag. 254. A. MONGITORE, Diario, VIII, pag. 251 e ss.
Il canonico HurtadoLa "controversia" ; il fatto scatenante e il formarsi di due opposte visioni
Due versioni a confronto

Una veduta di Marina corta dell'Arciduca d'Asburgo.
Il fatto accade, come abbiamo detto, nella Marina San Giovanni di Lipari il 22 gennaio del 1711, dinnanzi al negozio Nicolò Buzzanca dove erano in mostra, fra le altre merci, anche una modesta partita di ceci che aveva fatto recapitare il procuratore generale della mensa vescovile. Quando passano i catapani Battista Tesoriero e Jacopo Cristò prelevano, dalle merci esposte e quindi anche dai ceci. il “diritto di mostra”.
Di questo episodio abbiamo diverse versioni sia di parte regalista[1], sia di parte curialista.
Una versione, di parte regalista, ci rende edotti che i ceci che i due catapani prelevano non sono più di 800 grammi e i due non sapevano nemmeno che si trattasse di ceci della mensa vescovile perchè il bottegaio glielo avrebbe taciuto. Tanto è vero che quando il giorno dopo il Buzzanca glielo comunicò, Tesoriero e Cristò, per cortesia e rispetto verso il vescovo, restituirono immediatamente l'equivalente in denaro dei ceci che avevano prelevato. Tutto risolto? Niente affatto.

Un'altra immagine di Marina corta
Quando a Mons. Tedeschi raccontarono l'accaduto questi si infuriò, montando in escandescenze. “Parve che le due bocche d’Inferno, Stromboli e Vulcano…, soffiato avessero nel cuore del Santo Vescovo incendi di sì vehemente furore che, divenuto Mongibello di eccidi, eruttar parea fiamme di orrende minacce. Accorsero, per tranquillizzare la mente cos’ agitata, dal Vescovo l’accatapani medesimi protestandosi prima d’ogni altro ignoranti di essere quei ceci robba propria del lor Prelato, e in oltre pretesero tranquillarlo adducendo l’antico et inveterato costume de i loro antecessori soliti esigere simili paghe su le robbe degli Ecclesiatici.., protestandosi parimenti con enfasi di umiltà avere il dimani restituito…il prezzo delle due libre e mezzo di ceci”[2].
Accorsero anche i giurati ed il governatore che cercarono di spiegare al vescovo che egli poteva liberamente vendere a chi volesse i prodotti della sua terra nel proprio palazzo ed essi avrebbero chiuso un occhio, come era avvenuto con i suoi predecessori, ma se ricorreva alle botteghe pubbliche si sarebbe dovuto sottomettere alle regole annonarie della città.
Questa dichiarazione fece infuriare il vescovo ancora di più e pensò che era il momento in cui tutti i nodi dovessero venire al pettine e soprattutto che fosse venuto il momento di dichiarare guerra al Tribunale della regia Monarchia ed alla Legazia Apostolica adempiendo alla missione che gli era stata affidata.
Mons. Tedeschi “che avea fisso nel cuore valersi anche da così tenue congiuntura per devenire al disegno già preventivamente comminato col Vescovo di Catania e Girgenti, non poté lasciarsela scappare dalle mani; onde, sordo alle umiliazioni delli accatapani ed otturato l’orecchio alle rispettevoli rappresentazioni così de’ Giurati come del Governatore, senza mica riflettere agl’inconvenienti ed agli scandali che potean produrre le minacciate pubblicazioni di censure negli animi di quei naturali...” e ”senza badare alle circostanze del tempo e del luogo, del luogo, perché in Isola assai esposta all’invasione dei nemici, del tempo, perché così costituivasi quell’Isola in prossima disposizione di un Popolare sollevamento, con evidente pregiudicio del Ré cattolico…” chiamò il vicario generale, don Emanuele Carnevale, ed ordinò di imbastire il processo contro i due catapani. Di più, credendo con questo di tirarsi la gente dalla propria parte, ordinò al parroco di predicare in chiesa che la pena, per chi entrava in contesa con il vescovo, era la scomunica e questa sarebbe stata estesa anche a chi avesse solidarizzato con i contendenti. Una tale affermazione fu accolta da forte sdegno da parte del pubblico che fece “dalla Chiesa togliere le loro sedie per non più intervenirvi”[3].
“Ricorsero gl’Accatapani per riparo di questa strana Scomunica al Tribunale della Monarchia, ed ottennero primieramente, per poter comparire in giudicio, la necessaria assoluzione con reincidenza, ò sia la Sospensione delle Censure, ed indi poscia rapportarono la giustissima dichiarazione della loro nullità . Ma il Vescovo subito ch’ebbe la notitia del ricorso, portossi a Roma per sollecitare quella Corte a non perdere l’opportunità da lui procurata; ed ottenne per tal effetto dalla Congregazione dell’Immunità due lettere, una del 15 Agosto 1711 diretta à se medesimo, e l’altra del 16 Gennaro 1712 circolare a tutti i Vescovi del Regno, nella quale si dichiara non spettare né a’ Cardinali né a’ Legati à latere, né ad altri di qualsisia dignità l’autorità d’assolver con reincidenza, né di conoscer l’ingiustizia delle Censure dichiarate dagl’Ordinarj, e riferire al Papa per causa di lesa Immunità Ecclesiastica”[4].

Roma, palazzo del Sant'Uffizio con alle spalle San Pietro
La “verità del processo”
La mattina del 26 gennaio si tiene il processo[5] a porte chiuse, sotto la presidenza del vicario generale don Emanuele Carnevale e l’assistenza del procuratore fiscale don Bartolomeo Bongiorno, ed i punti che emersero nelle sette testimonianze delinearono un racconto diverso e per molti punti contrastante con quello dato dai magistrati locali e fatto circolare nel regno. Queste testimonianze furono raccolte e sottoscritte quasi tutte il 26 gennaio salvo due che portano la data del 30. Il canonico don Gaetano Cirino, liparense dichiarò di trovarsi la sera precedente nella piazza di Marina S. Giovanni e di avere sentito il Tesoriero ed il Cristò riconoscere che i ceci erano frutto della Mensa vescovile e malgrado ciò pretendere il diritto di “mostra”. Lo stesso negoziante Nicola Buzzanca, nativo di Gioiosa Guardia, testimonia di avere avuta una discussione con i catapani che prima volevano fargli abbassare il prezzo e poi, convalidato quello esposto pretesero la “mostra” dicendo che non importava che fosse “robba del Vescovo”. Alla conversazione, riferisce il Buzzanca, era presente Francesco Conti di Giovanni, pubblico pesatore. Iacopo Panitteri, liparese di 56 anni circa affermò di essere stato per nove anni pesatore e certificatore delle decime quando era vescovo mons. Ventimiglia ed i legumi riscossi come anche le pere, le prugne, le mele i carciofi ecc. venivano venduti nei negozi cittadini senza mai pagare alcun diritto di mostra ai catapani. Anzi per alcuni anni egli esercitò anche l’ufficio di catapano e “mai si prese mostra delli frutti e legumi che solia vendere questa Mensa vescovale alle pubbliche apoteche”. Pasquale Benenati, liparense di 76 anni circa riferisce come negli anni scorsi avesse macellato alcuni vitelli dentro il Vescovato e li avesse venduti senza licenza dei giurati e dei catapani e senza diritto di mostra, come diritto di mostra non ha mai pagato per la vendita dei legumi raccolti nei terreni del vescovo, né ha saputo di altri che li hanno pagati. Antonino Picone di anni 83, mastro Gaspare Matracia e il canonico Antonino Gauteri, questi il 30 dicembre, dichiarano cose simili a quelle emerse nelle precedenti testimonianze. Il canonico Giacomo Zichitelli, infine, anche lui in una deposizione del 30 gennaio, riferisce che per quattordici anni fu procuratore della mensa vescovile col defunto mons. Ventimiglia, ed afferma che “ non si pagò mai alli mastri di piazza di suddetta Città, vulgo Acatapanij, dritto alcuno per ragione di mostra tanto nella vendita del formaggio quanto di qualunque cosa commestibile; anzi, quando si macellavano, d’ordine di Monsignore Ill.mo, nel suo Palazzo le vitelle, i mastri di piazza non s’ingerivano mai a tastare il prezzo d’essi quantunque si vendevano pubblicamente quanto in città quanto nel borgo, né a loro si dava cosa alcuna per detta causa”.
Bastarono le dichiarazioni del giorno 26 perché il vescovo ed il vicario generale giudicassero che ci fosse materia sufficiente per emettere, lo stesso giorno, nei confronti dei catapani un “monitorio[6]”, nel quale erano chiamati, entro 24 ore, a discolparsi dell’accusa di aver ritirato “una aliquota – che dicesi di ragione di mostra –sui legumi che loro sapevano essere della Mensa Vescovile” pena la scomunica prevista per i violatori dell’immunità e della libertà ecclesiastica.
La risposta[7], stesa da mani esperte, presentata entro i termini previsti, aveva tono di supplica, ma produceva delle affermazioni che contrastavano decisamente con le testimonianze raccolte dalla Corte vescovile. In essa i catapani riferiscono di essere stati chiamati dal Buzzanca per verificare e fissare il prezzo a “tumini dui di ciciri” e fu stabilito, tenendo conto delle spese, il prezzo di “grani otto il rotulo” e fu lo stesso bottegaio a richiamarli perché si pigliassero “ la mostra secondo il solito ed antichissimo costume dandoci ad ogn’uno mezzo rotulo di detti ciceri”. Solo la sera dello stesso giorno il Buzzanca disse al Tesoriero che i ceci erano del vescovo, il quale, “per atto di venerazione” pagò al bottegaio grani quattro per la mostra ricevuta e lo stesso fece il Cristò, per cui del tutto inaspettatamente il giorno 26 ricevettero il “monitorio”. I supplicanti affermano che non era loro intenzione portare pregiudizio al vescovo, non sapevano che i ceci fossero suoi e, saputolo, restituirono la mostra “per atto di venerazione, stante che tutti l’antecessori di V.S. Ill. delle robbe commestibili che hanno fatto vendere alle Piazze pubbliche sempre hanno ricevuto le mostre competenti alli Capitani passati per ragione di meta così di carne pecorina, formaggi, come pure di frutti si come V.S. Ill. dalli decimieri passati e da’altri antichi Mastri di Piazza si potrà informare, come pure dallo hortolani delli Predecessori di V.S. Ill. sempre si ha pagato tarì uno alli Catapani per aggiustarci la bilancia e pesi, ed anche le mostre delle robbe che vendevano, essendo tutto ciò fatto di verità spettandoci pro iure laboris e non per dazio”. Così hanno seguitato a fare i firmatari dell’esposto, ignari del diritto, seguendo “il solito ed inveterato stile e costume”.
Conclusione, gli scriventi non hanno commesso ombra di peccato e, non essendoci peccato, “non può giammai cascare Scomunica” da qui la supplica di compatire la loro ignoranza e di cancellare il monitorio.
Come si può ben notare i punti maggiormente controversi risultano, come si è già fatto cenno: il fatto che i catapani sapessero o non sapessero che i ceci erano della mensa vescovile; la restituzione o meno da parte dei catapani del diritto di mostra in natura o in denaro una volta appreso che i ceci erano del vescovo; l’affermazione che era costume che si pagasse il diritto di mostra ed altre prestazioni sui prodotti della mensa vescovile e che così avevano fatto tutti i predecessori del vescovo Tedeschi.
 A leggere la risposta di Tesoriero e Cristò non può non emergere che il tentativo che si fa – e nemmeno tanto nascosto – è di fare apparire il vescovo non come colui che difende una prerogativa della sua diocesi sancita dalle consuetudini se non dalle leggi, ma come l’arbitrio di chi vuole imporre una norma nuova mai esistita e di volerla fare passare sulla pelle di due malcapitati che accetterebbero questa sopraffazione solo “per venerazione”. Cioè un vero e proprio capovolgimento delle ragioni e delle responsabilità. Infine, sembra di scorgere dell’ironia in quel: non c’è peccato e, non essendoci peccato, non ci può essere quindi scomunica. Un’ironia ed una impostazione che non poteva essere opera dei due catapani, modesti artigiani, ma svelava che vi era la mano sicuramente dei giurati che potevano avere, se non ideato, almeno cavalcata questa vicenda con l’obiettivo di colpire i privilegi della mensa e di costringere il vescovo, da quel momento in avanti, a sottostare agli obblighi fiscali comuni a tutti i cittadini.
A leggere la risposta di Tesoriero e Cristò non può non emergere che il tentativo che si fa – e nemmeno tanto nascosto – è di fare apparire il vescovo non come colui che difende una prerogativa della sua diocesi sancita dalle consuetudini se non dalle leggi, ma come l’arbitrio di chi vuole imporre una norma nuova mai esistita e di volerla fare passare sulla pelle di due malcapitati che accetterebbero questa sopraffazione solo “per venerazione”. Cioè un vero e proprio capovolgimento delle ragioni e delle responsabilità. Infine, sembra di scorgere dell’ironia in quel: non c’è peccato e, non essendoci peccato, non ci può essere quindi scomunica. Un’ironia ed una impostazione che non poteva essere opera dei due catapani, modesti artigiani, ma svelava che vi era la mano sicuramente dei giurati che potevano avere, se non ideato, almeno cavalcata questa vicenda con l’obiettivo di colpire i privilegi della mensa e di costringere il vescovo, da quel momento in avanti, a sottostare agli obblighi fiscali comuni a tutti i cittadini.
Le controdeduzioni della corte vescovile[8] arrivano a tamburo battente, lo stesso 27 gennaio. La supplica contiene – è detto – molte cose false o del tutto inconsistenti nella sostanza. Le cose false riguardano l’accaduto perché sono smentite dalle testimonianze; quelle inconsistenti riguardano le consuetudini a cui i catapani si appellano sostenendo che non è mai esistita una esenzione per i beni della mensa vescovile. “Nel caso che potesse pur esserci qualche normativa o una qualche pretesa consuetudine, i Giurati o i Magistrati locali sarebbero tenuti – sotto la medesima pena di Scomunica latae sententiae – ad abolire immediatamente o, quanto meno, a dichiarare che ne restano escluse le persone ecclesiastiche e le loro cose”.
Quanto all’ignoranza che i catapani chiamano in causa a propria discolpa “il Vescovo fa sapere ad essi ed ai loro conniventi che questa pretesa ignoranza non li favorisce in alcun modo. Infatti dal processo e dalle testimonianze risulta evidente che, se ignoranza ci fu, questa fu chiaramente un’ignoranza grossolana, premeditata, supinamente accettata e recitata, che non può assolutamente sottrarsi alla censura”.
La sentenza venne prorogata di tre giorni – come è detto nel comma conclusivo delle controdeduzioni - perchè, essendo giunta la notizia della vittoria dell'esercito di Filippo V, l'indomani si sarebbero tenute cerimonie pubbliche; inoltre perché il vescovo sperava ancora che gli accusati fossero in grado “ di addurre altri elementi più rilevanti senza che debbano essere ulteriormente ammoniti né ascoltati “.
Dei tentativi fatti dal vescovo per cercare di fare cambiare posizione ai catapani cercando di distaccarli dai loro “conniventi” se ne parla i in quel libretto anonimo – di cui abbiamo già fatto cenno – intitolato “Difesa della Verità a favore di Monsignor Tedeschi, Vescovo di Lipari” attribuito allo stesso vescovo. Un messaggero del vescovo andò dai catapani perché recedessero dalla loro posizione . Ma essi risposero che non potevano perché “li Giurati cel proibivano[9]”. Altrettanto inutile risultò il tentativo di un canonico della Cattedrale di fare intervenire il governatore sui giurati.
 Falliti questi tentativi, la mattina del 31 gennaio il vescovo fece suonare le campane a morto significando che era stata emesse la sentenza di scomunica “vitandi” contro i due catapani per avere “violato l'immunità e libertà ecclesiastica”. Questa sentenza – oltre che letta dal pulpito della Cattedrale in una chiesa gremita di folla curiosa -fu affissa, alla porta della stessa chiesa e della Madonna delle Grazie nella città alta e, nel borgo, alla porta di San Giuseppe e nella pubblica piazza di Marina San Giovanni. Era la più dura censura canonica che si potesse comminare ed escludeva, chi ne era colpito, dalla conversazione, dal consorzio e persino dal saluto degli altri cristiani. E per lo stesso suono delle campane la curia volle tutelarsi mettendo agli atti due dichiarazioni, di un frate cappuccino e del canonico sagrestano della Cattedrale, che il ricorso alle campane era usuale per annunciare una scomunica.
Falliti questi tentativi, la mattina del 31 gennaio il vescovo fece suonare le campane a morto significando che era stata emesse la sentenza di scomunica “vitandi” contro i due catapani per avere “violato l'immunità e libertà ecclesiastica”. Questa sentenza – oltre che letta dal pulpito della Cattedrale in una chiesa gremita di folla curiosa -fu affissa, alla porta della stessa chiesa e della Madonna delle Grazie nella città alta e, nel borgo, alla porta di San Giuseppe e nella pubblica piazza di Marina San Giovanni. Era la più dura censura canonica che si potesse comminare ed escludeva, chi ne era colpito, dalla conversazione, dal consorzio e persino dal saluto degli altri cristiani. E per lo stesso suono delle campane la curia volle tutelarsi mettendo agli atti due dichiarazioni, di un frate cappuccino e del canonico sagrestano della Cattedrale, che il ricorso alle campane era usuale per annunciare una scomunica.
La controversia dinnanzi al viceré ed a Roma
L'avvenimento ebbe grande ripercussione e clamore in tutta la Sicilia. Il giudice criminale d'intesa con il governatore e capitano d'armi ed i giurati – cioè tutte le autorità giudiziarie, militari e civili dell'isola – pensarono di ragguagliare subito il viceré don Carlo Antonio Spinola marchese di Balbasés. che, in quel tempo, risiedeva a Messina - accusando apertamente il vescovo di avere creato disordine nell'isola proprio in un momento così delicato giacché il regno era in guerra. Anche Mons. Tedeschi scriveva al viceré il 3 febbraio affermando che la scomunica non aveva creato il minimo disagio e rincarava le rimostranze nei confronti dei catapani e dei magistrati liparesi giudicati avversari della sua chiesa. Lo informava inoltre che avrebbe inviato don Giuseppe Todaro che, a voce, avrebbe meglio spiegato i fatti.
La risposta del viceré non si fece attendere: convocava il vescovo a Messina e autorizzava i catapani a ricorrere al Tribunale della Monarchia per farsi sciogliere dalla censura. Ma ancora prima che fossero giunte a destinazione queste disposizioni il can. Todaro si mobilita. Decide di partire per Messina la sera del 5 febbraio con un gruppo di preti e di chierici.

Messina, primi del Settecento
Siccome a Lipari – essendo periodo di guerra – c'è il coprifuoco e non si può lasciare l’isola di notte senza un permesso del capitano d'armi, i passeggeri si fanno passare per pescatori. Ma i magistrati di Lipari mangiarono la foglia e così quando il nostro canonico si presentò al viceré questi era già stato informato del suo comportamento e dopo averlo rimproverato lo fece mettere agli arresti nel carcere della cittadella di Messina. E’ la scena che Sciascia descrive nell’atto primo della sua Rappresentazione.
In carcere il can. Todaro ci rimase poco perchè fu subito scarcerato, non appena il vescovo Tedeschi andò a Messina ed ebbe modo di dimostrare al segretario del viceré che a Lipari era consuetudine che gli ecclesiastici potessero allontanarsi anche senza autorizzazione e d'altronde il canonico era andato a Messina per presentarsi al viceré, cosa che aveva fatto immediatamente . Così il vescovo convinse il segretario anche della inconsistenza di quelle accuse che sostenevano aver lui arrecato, con i suoi provvedimenti, disordine nell'isola e quindi pericolo per gli abitanti.
Ma se l'atmosfera fra Mons. Tedeschi e il Viceré si rasserenò, tanto che l'incontro che poco dopo avvenne si aprì in un clima di cordialità, questo non indusse il vescovo ad essere più morbido ed a fare un passo indietro sul tema della scomunica. Ed il viceré dovette contentarsi di lasciare il vescovo “nella sua ostinata durezza[10]”.
Intanto a Palermo il Giudice del Tribunale della Regia Monarchia, conte Francesco Miranda, il 6 marzo 1711, accogliendo il ricorso dei catapani, firmava un decreto assolutorio “ ad cautelam” in attesa della sentenza definitiva. Furono gli stessi catapani a recapitare questo decreto alla Gran Corte Vescovile di Lipari con l'ordine di rimettere a Palermo l'intero carteggio del processo. In assenza del vescovo il can. Emanuele Carnevale ritenne di dovere ottemperare alla richiesta. Bastò questo perchè Mons. Tedeschi lo sollevasse dall'incarico ed al suo posto nominasse il can. don Diego Hurtado.
Il vescovo respinse il decreto assolutorio considerandolo nullo ma non si appellò al Tribunale della Monarchia perchè lo riteneva illegittimo. Anzi, a suo avviso, l’assoluzione cautelare dei catapani da parte del Tribunale della Regia Monarchia rappresentava una ulteriore prevaricazione nei confronti della chiesa liparese perché ignorava o fingeva di ignorare che questa dipendeva direttamente ed esclusivamente dalla S.Sede.
Scrisse invece al papa ed al re di Spagna sperando in un intervento di sostegno e di difesa. Ma il tempo passava e risposte alle sue lettere non ne giungevano. Che non rispondesse il re poteva anche comprenderlo pensando che questi era stato informato già dal viceré e quindi non fosse ben disposto nei confronti delle sue ragioni. Ma il papa? Il papa che si era raccomandato con lui di non transigere sui diritti della Chiesa…. Sicuramente la lettera non gli era pervenuta.
E’ a questo punto Mons. Tedeschi fa due passi decisivi: prende contatti con gli altri vescovi della Sicilia per valutare insieme gli sviluppi futuri della vicenda; attende di ottenere un passaggio in nave per recarsi a Roma di persona dal papa. Ha così contatti epistolari con i vescovi di Girgenti, Mazara e Catania ed ai primi di giugno, col permesso del viceré, si imbarca su un galeone pontificio diretto a Civitavecchia.
Intanto il 31 maggio il Tribunale della Monarchia di Palermo aveva emesso la sentenza definitiva che aveva annullato la scomunica contro i due catapani e il 15 agosto, mons. Tedeschi, si fa rilasciare dalla S. Congregazione dell'Immunità ecclesiastica un rescritto di annullamento di questa sentenza “per difetto di giurisdizione”. Il rescritto va però oltre l'annullamento della sentenza ed afferma che “non è permesso né a Cardinali legati a latere, ne alli Arcivescovi, Vescovi, Ordinari de' luoghi, né a qualunque altro Tribunale... di concedere assoluzione alcuna, anche con reincidenza e a cautela, delle censure riservate al Sommo Pontefice”. In discussione non c’era più solo il caso di Lipari e lo speciale statuto di questa diocesi ma, di fatto, lo stesso Tribunale della Monarchia.
 La corte pontificia di Clemente XI
La corte pontificia di Clemente XI
Copia autentica del foglio venne spedita al canonico Hurtado a Lipari perchè l'affiggesse alla porta della Cattedrale e “ai cantoni soliti”. Il povero vicario capì subito quali sarebbero state le conseguenze e tentennò molto ad eseguire la disposizione. Finalmente si convinse la notte del 2 novembre 1711. L'affisse di notte ed al mattino non c'era più perchè il capitano d'arme lo fece ritirare osservando che era privo del regio “exequatur”. Ci riprovò il successivo 2 dicembre e non ebbe miglior successo.
Il 4 dicembre fece sospendere la celebrazione della Messa perchè in chiesa c'erano i due catapani scomunicati e la stessa cosa ripetè il 25 dicembre, giorno di Natale, facendo per giunta ammantare a lutto la porta di S. Maria delle Grazie.
Fino ad allora, tutto sommato, la sfida fra istituzioni era rimasta circoscritta alla diocesi di Lipari e fu per questo che a Palermo si pensò di recidere il male alla radice intervenendo drasticamente nell'isola. Il giudice della Monarchia inviò un suo delegato speciale, il canonico don Vincenzo Aucello col preciso mandato di procedere contro coloro che avevano violato “le Regalìe Sovrane e ...ridare la tranquillità seriamente turbata in quelle isole”e, quindi in pratica, dimostrare e convincere i liparesi che, con l’assoluzione del Tribunale della Monarchia, i catapani non erano più scomunicati.
Il 21 gennaio del 1712 Aucello giunge a Lipari e non essendo riuscito a trovare il can. Hurtado il giorno 24, seguito da famigli venuti con lui da Palermo e da una discreta folla di curiosi isolani, andò alla chiesa di S. Maria delle Grazie e vi celebrò messa alla presenza di Tesoriero e Cristò. Poi cominciò a fare pressioni sul clero. Il giorno dopo costrinse il guardiano dei cappuccini a celebrare messa nella stessa chiesa alla presenza ancora dei due catapani.[11] Ma la maggior parte del clero si mostrò fedele al vescovo.
E così a Lipari nacquero due partiti anche se c’è da dire che il popolo osservava questi eventi più con curiosità che con turbamento, ed anzi ci prendeva gusto al dissidio ed ironizzava su di esso. Chi stava col vescovo era chiamato – con convinzione, ironia o disprezzo a seconda di chi lo pronunciava - osservante, curialista o pontificio mentre chi stava con Palermo – e fra il clero erano pochissimi – inosservanti, o regalisti o patriottici.
Alla sfida di Aucello rispose Hurtado interdicendo la chiesa delle Grazie in attesa di altri provvedimenti che avrebbero preso il vescovo e Roma.


Chiesa della madonna delle Grazie al Castello
In quei giorni i Liparesi poterono assistere a sfide inconsuete fra l'Aucello e l'Hurtado che passavano per le strade di Lipari, ciascuno con un codazzo di sostenitori, preceduti ognuno da un mazziere in livrea che teneva in bella vista la mazza d'argento simbolo del potere.
[1] Di parte “regalista” abbiamo in particolare la già citata “Veridica Relatione e confronto de’ procedimenti delle due corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto del Tribunale della Monarchia”, pag. 7 e seguenti , e il manoscritto “Delle Vertenze fra la Corte di Roma ed il Governo della Sicilia” che si trova nella Biblioteca Universitaria di Messina e che parla del fatto di Lipari proprio all’inizio della Parte Seconda del Tomo Primo, pp.56 e seguenti.. Per la parte “curialista”, oltre al già citato libretto “Difesa della Verità…”, anonimo e senza luogo e data di pubblicazione ma attribuito a Mons. Tedeschi stesso, vi sono i documenti del processo che insieme al decreto assolutorio del conte Francesco Miranda, giudice del Tribunale della Regia Monarchia, si trovano nell’Archivio Vescovile di Lipari, Carpetta 25 Processi Civili.
[2] “Delle Vertenze fra la Corte di Roma et il Governo della Sicilia”, Tomo Primo Parte Seconda, pag.57. Anche “Veridica Relatione…”, pag. 7
[3] “Delle Vertenze...”, pag. 58-59.
[4] ”Veridica Relatione…” pag. 7
[5] L’originale del verbale di 12 fogli è conservato nell’Archivio Vescovile di Lipari, carpetta 25, Procedimenti Civili.
[6] Il monitorio presente nel verbale è in latino, noi abbiamo fatto riferimento ad una traduzione del prof. Giuseppe Iacolino nel dattiloscritto “La Chiesa cattedrale di Lipari” Quaderno IIIA. Da Mons. Tedeschi e la Controversia Liparitana fino alla morte di Mons. Platamone (1733), pag. 98g.
[7] Nel verbale dell’Archivio Vescovile manca l’originale di questa risposta ed essa risulta solo in copia priva di destinatario, di firma e di data.
[8] Le controdeduzioni nel verbale presente in Archivio vescovile sono presenti solo in minuta.
[9] Anonimo, Difesa della verità a favore di Monsig. Nicolà Maria Tedeschi, pp 11-12.
[10] Anonimo, Difesa della verità, op.cit., pp. 15-16.
[11] Vedi documento pontificio a stampa su un solo foglio del 18 giugno 1712. “Clemens Papa XI. Ad futuram rei memoria”, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St. St. D2 d bis.
La scomunica
La controversia liparitana: le premesse
Perché la “Controversia liparitana”?
Dipinto del 700 di Marina corta
Era la mattina del 22 gennaio 1711 quando nella piazzetta di Marina Corta di Lipari, che allora si chiamava di San Giovanni ed oggi Ugo di Santonofrio, due vigili annonari che allora erano detti “catapani” o “accatapani”, entrano nella bottega, che allora si chiamava “apoteca”, di Nicolò Buzzanca per verificare la merce in vendita e riscuotere il cosiddetto “diritto di mostra” cioè una piccola parte di ciascuna di esse al fine di testarne la qualità e fissarne il prezzo e garantire che la qualità non sarebbe stata adulterata nel corso della giornata. Poi, a fine giornata, questo “diritto di mostra” veniva diviso fra i catapani visto che il loro era un servizio volontario che si aggiungeva gratuitamente alla loro professione. Cose di tutti i giorni. Ma quella mattina fra le merci in vendita c’è anche una partita di ceci che veniva dalla mensa vescovile e che per prassi consolidata – così sosterrà la curia ma la cosa (come altre di questa vicenda) non sarà così pacifica – era esente da ogni tassa o balzello o diritto di mostra che fosse. I due catapani che fanno l’ispezione nella bottega di Buzzanca sono Battista Tesoriero e Jacopo Cristò , due artigiani, fabbro ferraio il primo e argentiere il secondo. Sapevano i due che si trattava di merce della mensa vescovile? E’ questo uno dei nodi della questione su cui si creano due schieramenti con posizioni contrapposte. Come emergono due verità contrapposte anche a proposito della restituzione da parte dei catapani al commerciante se non dei ceci almeno del loro prezzo una volta conosciuta la loro provenienza. Come si formano ancora schieramenti contrapposti a proposito dell’esistenza o meno sui beni della mensa vescovile di un diritto di esenzione. La tesi dei catapani come dei giurati – gli amministratori comunali di allora – e poi del Tribunale della Regia Monarchia di Palermo sarà a favore dei catapani: non sapevano, restituirono l’equivalente, non era mai esistito un diritto di esenzione. Del tutto opposto il giudizio del Tribunale della curia vescovile che aveva competenza su tutta una serie di questioni che in qualche modo toccassero la religione, la morale e le strutture ecclesiastiche, persone o beni che fossero. E sulla base di sette testimonianze scritte, i cui verbali si trovano ancora nell’Archivio della curia vescovile di Lipari, viene emesso prima un “monitorio” cioè una sorta di “avviso di garanzia” come si chiamerebbe oggi, ingiungendo ai due malcapitati di discolparsi e dopo alcuni giorni – giudicata inconsistente la risposta – la sanzione e cioè la scomunica che allora non era solo una pena di carattere religioso ma aveva rilevanza anche sociale perché di fatto tagliava fuori dalle pubbliche relazioni, in una società ancora non secolarizzata, chi ne fosse colpito.

Il palazzo vescovile nel borgo dove risiedeva il tribunale ecclesiastico.
Dal Tribunale della curia e dal Tribunale della Monarchia il conflitto investe direttamente il Vescovo e lo Stato di Sicilia che allora era governato da un viceré per conto del re Filippo V di Spagna. In questione non ci sono solo una partita di ceci e la situazione di due catapani ma molto di più. La Diocesi di Lipari era ritenuta, per un privilegio che veniva fatto risalire ad una bolla del Papa Urbano II del 1091, direttamente dipendente dalla Sede Apostolica per cui i giudizi del Vescovo, nelle questioni in cui aveva competenza,potevano essere sindacati solo dal Papa. Il Regno di Sicilia però poteva vantare un altro privilegio, sempre risalente ad Urbano II, ma di alcuni anni più giovane di quello di Lipari, e cioè del 1098, che riconosceva il Re di Sicilia legato apostolico del papa per diritto di nascita e quindi con competenza non solo a nominare i vescovi di Sicilia ma anche a decidere, in sede di appello, sui temi riservati al giudizio dei vescovi e questo attraverso un apposito organo che si chiamava appunto Tribunale della Monarchia. Ora avveniva che il Regno di Sicilia ignorava o fingeva di ignorare la particolare situazione di Lipari e pretendeva di trattare questa come una qualsiasi diocesi siciliana. Da parte sua la Santa Sede mal tollerava l’ingerenza del re e di un tribunale civile nelle sue competenze e, in particolare papa Clemente XI, aveva come obiettivo quello di abolire la Legazia Apostolica. Il caso dei ceci del vescovo di Lipari diventa quindi il detonare di un conflitto più ampio e più subdolo. Più ampio perché investe due stati: quello di Sicilia e quello Pontificio e tramite loro il delicato e complesso equilibrio degli stati europei praticamente sempre in guerra fra di loro ed impegnati in una sorta di partita a scacchi dove lo spostamento di una pedina aveva ripercussione su tutto lo scacchiere. Più subdolo perché investiva questioni di potere in una zona controversa dove la politica si intrecciava con la religione ed era difficile tracciare una chiara linea di laicità: laicità dello stato e libertà della chiesa.


Filippo V a sinistra. Vittorio Amedeo II di Savoia a destra.
E tanto è nodale questo conflitto che finisce con andare al di là degli stessi protagonisti infatti proseguirà anche quando il Regno di Sicilia passa da Filippo V a Vittorio Amedeo II di Savoia e poi ancora a Filippo e quindi agli Austriaci.
Un conflitto che da Lipari si estenderà a tutta la Sicilia dove lo stato combatte con le armi dell’espulsione e del carcere e la chiesa con quelle della scomunica e dell’interdetto. Lo sfratto colpirà innanzitutto i vescovi che continueranno a pubblicare e fare osservare le scomuniche e quindi saranno costretti all’esilio lanciando, prima di partire, non solo scomuniche, che sono sanzioni che toccano singoli cittadini, ma anche interdetti che investono l’intera comunità diocesana con diverse ripercussioni, anche qui, sul piano sociale come l’impossibilità di celebrare pubblicamente matrimoni, battesimi, funerali e seppellire i morti in terreno consacrato quali erano praticamente tutti i cimiteri nella Sicilia del settecento. Nell'anno 1717 nella sola Roma circolavano oltre millecinquecento sudditi siciliani perseguitati e sfrattati.
Tutto questo andrà avanti fino al 1719 quando a Palermo giungeranno gli Austriaci ed il papa applicherà quel “trattato di accomodamento” che aveva firmato qualche settimana prima con Filippo V.
Il privilegio della Diocesi di Lipari di fatto si estingue nel 1749 quando il re riconosce senza reazione alcuna, la competenza - per un ricorso contro una decisione del vescovo di Lipari - del Tribunale della Monarchia. Mentre la Legazia Apostolica si trascinò fino al 1871 quando finalmente anche il governo italiano rinunciava ai diritti che da essa derivavano in Sicilia, rendendosi conto che contrastavano nettamente con i principi del separatismo liberale.

Stampa della Palermo del 700
Il nodo della Legazia Apostolica
Uno dei punti della Controversia è l’istituto della Legazia Apostolica e se la Chiesa di Lipari facesse parte o meno di essa. La cosiddetta “Legazia Apostolica”[1], da cui discende il Tribunale della Monarchia, si vuole fare risalire a Urbano II che il 5 luglio del 1098 per ringraziare Ruggero d’Altavilla di aver sottratto l'isola agli arabi e di averla restituita al culto della Chiesa di Roma, emette la bolla Quia propter prudentiam tuam. In essa si afferma: “Noi non stabiliremo, nel territorio di vostra pertinenza, alcun legato della Chiesa di Roma senza il volere ed il consiglio vostro. Che anzi tutte le cose che Noi intendiamo fare tramite un legato vogliamo che siano fatte dalla vostra opera come vice legati quando dal Nostro lato le commetteremo a voi per la prosperità delle Chiese che sono sotto la vostra potestà, ad onore di San Pietro e della Santa sua Sede Apostolica alla quale sino ad ora tu hai fedelmente obbedito e che, nelle sue occorrenze, hai aiutato con valore e fedeltà”.
Fosse o meno nella volontà di Urbano II, Ruggero interpretò queste parole come il diritto di nominare e trasferire, a suo piacimento, vescovi e prelati nelle terre sottoposte al suo dominio cosa d’altronde che aveva già cominciato a fare anche prima del 5 luglio 1098 a cominciare dalla nomina del vescovo di Troina nel 1080 costringendo, prima Gregorio VII e poi Urbano II a dare il riconoscimento canonico alle sue decisioni[2]. Su questa linea il Gran Conte istituì il “Tribunale della Monarchia” cui attribuì l’esclusiva competenza a deliberare, senza appello o ingerenze della Curia romana, su tutte le questioni ecclesiastiche siciliane, con esclusione delle materie che riguardavano dogma o che afferivano la salute dell’anima.
 Conte Ruggero
Conte Ruggero
I contenuti e l’efficacia della bolla non rimase limitata a Ruggero di Altavilla, a cui il papa l’aveva indirizzata, ma venne ritenuta una prerogativa che si estendeva ai successori di Ruggero ed a tutti i sovrani di Sicilia, anche di diversa dinastia. Questi cercheranno di accrescere a loro vantaggio le implicazioni di questo documento definendosi “legati apostolici” per “nascita” mentre la Santa Sede farà di tutto per restringerne i termini e frenarne gli abusi, fino a definire falsa la bolla di Urbano II che invece era sostanzialmente vera.
Dopo il sec. XIII, in base alla documentazione nota, la politica ecclesiastica successiva alla dinastia normanna e fino al sec. XV pare sia stata determinata più dai tratti generali delle relazioni dei sovrani con il papato che dal privilegio della Legazia Apostolica[3] . Non scompare però l’ingerenza dei sovrani nella vita della Chiesa nei territori siciliani soggetti alla loro autorità.
Proprio sul finire del XV secolo viene introdotto in Sicilia il Tribunale dell’inquisizione spagnola con inquisitori nominati dal sovrano Ferdinando II il Cattolico re di Spagna, d’Aragona e, dal 1479 anche di Sicilia. Questo sovrano, oltre alla libertà di scelta degli inquisitori ottenne dalla Santa Sede la facoltà di nomina di vescovi e di prelati. Ed è in quegli anni che il giurista siciliano Giovan Luca Barberi, nella stesura del trattato De Regia Monarchia, riesuma la bolla di Urbano II[4] e con essa il privilegio della Legazia Apostolica – di fatto cadute nell’oblio[5] - affermando, sulla base di una artificiosa lettura della storia dell’isola, che non solo questo privilegio non era mai stato abolito dai pontefici, né vi avevano rinunciato i sovrani ma era stato sempre applicato e riconosciuto da tutti i successori di Urbano II[6]. E’ stato osservato che il Barberi diede al documento “nuova vita, creandogli attorno il grande edificio della Monarchia Sicula”[7].
L’avventurosa interpretazione del Barberi trovò numerose opposizioni e critiche soprattutto da parte della Santa Sede e fu allora che si tentò di accreditare la falsità della bolla attribuita ad Urbano. Comunque la tesi di Barberi si affermò e generò, fino all’Unità d’Italia, “uno stabile e singolare privilegio che ha determinato rapporti unici, intricati e litigiosi tra il potere statale e il potere ecclesiastico, con l’innegabile condizione di subordinazione del secondo al primo”[8]. In Sicilia, in forza del privilegio di Legazia, per nascita e non per nomina, perpetuo e irrevocabile e non a tempo definito, “il sovrano ha esercitato la giurisdizione civile iure proprio e la giurisdizione ecclesiastica e spirituale iure legationis”[9]. Era il giudice della Regia monarchia, le cui competenze erano stabilite unilateralmente dal sovrano, che aveva potestà sulle cause ecclesiastiche e sul controllo della vita della Chiesa siciliana. Un giudice che se inizialmente era un laico, nella seconda metà del Cinquecento divenne un ecclesiastico, con ufficio stabile e magistratura apposita chiamato Tribunale della Regia monarchia (1579). La finalità di questo Tribunale non era quella di contrapporsi alla Santa Sede affermando una propria ecclesiologia ma di tutelare delle prerogative locali.
L’istituto della Apostolica legazia andò, nel tempo, arricchendosi di competenze. Già sotto Carlo V fu istituito il visitatore regio che era un ecclesiastico che aveva la facoltà, tramite le sacre regie visite, di esaminare la lecita proprietà dei beni ecclesiastici e la loro corretta amministrazione, controllare gli arredi e le suppellettili sacre, vigilare sul servizio ecclesiastico in ciascuna diocesi.
Col moltiplicarsi di questi compiti all’interno della teoria legaziale si aveva una crescente ingerenza del potere laico esercitato dal viceré in nome del sovrano che incideva significativamente nella sfera di giurisdizione dei vescovi.
Deciso assertore della Legazia fu il viceré Giovanni de Vega che operò sotto il regno di Carlo V. La tesi del de Vega era che i vescovi erano feudatari del sovrano e dovevano comportarsi da buoni vassalli nel quadro della preminenza regia sull’isola che andava difesa e rispettata anche dai vescovi e da tutti gli ecclesiastici. Da qui il privilegio della Legazia inibiva al papa l’invio in Sicilia di legati apostolici con il potere di esercitare giurisdizione ecclesiastica ed obbligava i vescovi ad ottenere il regio placet e l’exequatur prima della pubblicazione ed esecuzione di documenti ecclesiastici prodotti in Sicilia, o provenienti dalla Curia romana[10].

Un quadro che raffigura una sessione del Concilio di Trento
Non è che questa ingerenza del potere regio nella sfera ecclesiastica fosse accettata di buon grado dai vescovi di Sicilia. Ed infatti la questione fu discussa al Concilio di Trento ( 1545- 1563) dove proprio sui canoni che prevedevano di demandare al pontefice l’esame e il giudizio delle cause criminali più gravi riguardanti i vescovi sottraendoli al potere regio, quale ne fosse l’origine, scoppiò uno scontro violentissimo in particolare fra vescovi francesi [11]che difendevano le prerogative regie ed i vescovi siciliani. Alla fine prevalse la posizione che sosteneva l’autonomia della Chiesa nei confronti della corona ma le decisioni del concilio tridentino ebbero scarsa efficacia in Sicilia dove fu dichiarato che la giurisdizione della Regia monarchia era superiore ai decreti tridentini[12]. Questa “prammatica” del re oltre a salvaguardare l’istituto della Legazia ebbe anche l’effetto di rendere più difficile in Sicilia la riforma della vita del clero e dei religiosi che era proprio l’obiettivo principale del Concilio e questo grazie al fatto che ogni ecclesiastico poteva ricorrere al giudice della Regia monarchia sfuggendo alla giurisdizione episcopale e dei legittimi superiori[13]. Unico effetto del Concilio fu che il sovrano Filippo II stabilì che il Tribunale della regia monarchia fosse un istituto stabile e che il giudice fosse un ecclesiastico costituito in dignità e non nominato dal vicerè caso per caso.
Comunque la polemica sulla Legazia continuò dopo il Concilio sotto i pontificati di Pio V e Gregorio XIII ma la corona spagnola rispose sempre con grande fermezza non manifestando, su di essa, nessun cedimento sostanziale ed il potere regio sulla vita della Chiesa siciliana andò sempre più consolidandosi e finì col manifestarsi anche plasticamente. Infatti in tutte le cattedrali siciliane fecero la comparsa due troni: a destra per il vescovo e a sinistra, in posizione più elevata, quello per il sovrano legato apostolico che, in quanto tale, riconosceva superiore a sé soltanto il pontefice[14]. Sul piano dei contenuti, oltre al diritto del sovrano di nominare i vescovi per ogni diocesi che lasciava al pontefice solo il compito di ratificare la nomina attraverso la consacrazione, si aveva – nel tempo – una crescita delle competenze del Tribunale della regia monarchia che si aggiudicò il diritto di assolvere dalle censure ecclesiastiche e di sospendere e dichiarare nulle le scomuniche. Il Tribunale inoltre mentre fungeva da appello per le sentenze emesse da vescovi ed arcivescovi relative ad ecclesiastici, nelle cause relative al matrimonio e per i cosiddetti reati di “misto foro”(usura, simonia, ecc.), impediva il ricorso alla Curia romana per la gran parte delle cause ecclesiastiche. In questo clima che perdurò per tutto il Seicento i conflitti di giurisdizione furono numerosi e la tensione fra Santa Sede e sovrano divenne esplosiva fino a culminare, nei primi anni del Settecento, nella cosiddetta “controversia liparitana”.


Pio V e Gregorio XIII
Una Diocesi tutta speciale
Come mai la periferica diocesi di Lipari diventa l’epicentro di uno scontro durissimo fra potere politico e potere religioso? Se il nodo era l’Apostolica Legazia non vi erano altri contenziosi di maggiore spessore che una disputa sui diritti nella vendita di una partita di ceci e diocesi di maggiore importanza e significato che non quella liparese? Il fatto è che la chiesa di Lipari, come abbiamo detto, riteneva di avere, sostenuta dalla Santa Sede, a proposito della Apostolica Legazia, uno statuto tutto particolare. La diocesi infatti vantava una particolare bolla, sempre di Urbano II, emessa il 3 giugno 1091, cioè sette anni prima di quella salernitana a cui si fa risalire la Legazia.
Il documento è rivolto all’abate Ambrogio che era sbarcato nell’isola qualche anno prima condottovi dai normanni ed aveva avuto, da Ruggero, la potestà politica e quella religiosa sull’arcipelago. In esso, il papa - dopo aver ricordato che tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San Pietro e ai suoi successori in forza del privilegio del pio Imperatore Costantino[15] ed aver riconosciuto il ruolo del monastero nel ripopolamento dell’isola - afferma che “questo monastero, cui la fraternità tua per volere del Signore, presiede, e che è intitolato a San Bartolomeo, noi lo prendiamo nel grembo della Sede Apostolica e intendiamo favorirlo con speciale protezione”.
La soggezione alla Santa Sede rimane in vigore anche dopo la bolla del 1098, tanto che l’antipapa Anacleto II quando nomina vescovo l’abate Giovanni con bolla del 14 settembre 1131, per venire incontro ad un desiderio dei re normanni, ribadisce che il monastero di Lipari, uno dei più grandi monasteri della Sicilia, “dipende dall’autorità della Chiesa Romana”anche se aggiunge che la diocesi di Lipari dipenderà dalla chiesa Messinese come propria chiesa Metropolitana, “fatte salve tutte le concessioni e i privilegi della Chiesa Romana elargiti al glorioso Nostro figlio Ruggero ed ai suoi eredi”. Comunque fino al vescovo Pietro ( 1171) i vescovi di Lipari venivano eletti dal capitolo del monastero ma non ratificati da Roma per cui nei documenti figurano non come episcopi ma come electi[16].
 All’interpretazione che viene data della bolla di Urbano del 1091 da parte degli abati benedettini di Lipari e poi dei vescovi della diocesi e ancor più negli anni di forte tensione e polemica a proposito della Legazia si aggiunge il fatto che le Eolie non sono sempre appartenute politicamente alla Sicilia. Tra il XIII ed l’inizio del XVI secolo esse cambieranno diverse volte appartenenza passando da Palermo a Napoli e viceversa. Certamente nei periodi in cui dipendevano da Napoli la Legazia non si applicava. Quando il 30 maggio1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandole dal Regno di Napoli cui erano appartenute fin dal 1458 e prima ancora dal 1357 al 1423, dal 1339 al 1347, dalla seconda metà del XIII al 1302, Filippo III lo fa venendo incontro ad una richiesta dei Liparesi che vedevano in questo passaggio un possibile incremento dei traffici e i vantaggi derivanti dall’avere una capitale più vicina. Ma se queste erano le motivazioni dei Liparesi e del loro vescovo che ne fu il più fiero propugnatore, il re Filippo ne aveva almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani – fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria – e ricondurre la Chiesa di Lipari, com’era per le altre chiese di Sicilia, nell’ambito della Legazia[17]. Probabilmente Filippo non conosce al Bolla del 1091 o non attribuisce particolare importanza a questa rivendicazione della diocesi liparese e della Santa Sede[18]. E come Filippo III, lo stesso faranno i suoi successori e questo spiega perché nel 1712 la Congregazione per l’Immunità si impegnerà a trovare le ragioni, il fondamento storico e il riconoscimento costante nel tempo di questa peculiarità della chiesa liparese in un documento inedito che pubblichiamo, corredato degli allegati, in appendice a questo libro[19].
All’interpretazione che viene data della bolla di Urbano del 1091 da parte degli abati benedettini di Lipari e poi dei vescovi della diocesi e ancor più negli anni di forte tensione e polemica a proposito della Legazia si aggiunge il fatto che le Eolie non sono sempre appartenute politicamente alla Sicilia. Tra il XIII ed l’inizio del XVI secolo esse cambieranno diverse volte appartenenza passando da Palermo a Napoli e viceversa. Certamente nei periodi in cui dipendevano da Napoli la Legazia non si applicava. Quando il 30 maggio1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandole dal Regno di Napoli cui erano appartenute fin dal 1458 e prima ancora dal 1357 al 1423, dal 1339 al 1347, dalla seconda metà del XIII al 1302, Filippo III lo fa venendo incontro ad una richiesta dei Liparesi che vedevano in questo passaggio un possibile incremento dei traffici e i vantaggi derivanti dall’avere una capitale più vicina. Ma se queste erano le motivazioni dei Liparesi e del loro vescovo che ne fu il più fiero propugnatore, il re Filippo ne aveva almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani – fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria – e ricondurre la Chiesa di Lipari, com’era per le altre chiese di Sicilia, nell’ambito della Legazia[17]. Probabilmente Filippo non conosce al Bolla del 1091 o non attribuisce particolare importanza a questa rivendicazione della diocesi liparese e della Santa Sede[18]. E come Filippo III, lo stesso faranno i suoi successori e questo spiega perché nel 1712 la Congregazione per l’Immunità si impegnerà a trovare le ragioni, il fondamento storico e il riconoscimento costante nel tempo di questa peculiarità della chiesa liparese in un documento inedito che pubblichiamo, corredato degli allegati, in appendice a questo libro[19].
Per tutto il corso del Sei e Settecento, la diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede” diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia, che sosterranno le loro prerogative anche sulla Chiesa Liparese, e i papi che le osteggeranno. E sarà allora che la vicenda registrerà i momenti di più drammatica conflittualità”.
La “controversia liparitana” nasce dal sequestro dei ceci ma lo scontro viene da lontano ed era stato voluto e preparato da tempo soprattutto dalla Santa Sede che voleva usare Lipari come un grimaldello per fare saltare tutto l’istituto della Apostolica Legazia, approfittando anche del fatto che la Spagna era impegnata in una difficile guerra per la successione (1700- 1713) nella quale avrebbe potuto soccombere e perdere quindi, come poi avvenne, il possesso della Sicilia.
Il primo scontro circa l’autonomia della diocesi di Lipari dalla Legazia avviene a pochi giorni dall’incorporazione e il pretesto è l’introduzione del Sant’Ufficio dipendente dalla Inquisizione spagnola, com’era d’uso in Sicilia, ed al deciso rifiuto del vescovo mons. Vidal forte, a questo proposito di una lettera del cardinale Gallo a nome del papa. E’ allora che scatta la minaccia della destituzione del prelato dalla dignità episcopale e della soppressione della sede Cattedrale[20].
Così per un intero secolo si sviluppa questo conflitto fra vescovato e curia romana da una parte e regno di Sicilia dall’altra dove tutto, anche le cose più banali, diventano occasione di contrasto giungendo perfino allo scontro fisico fra un vescovo ed un governatore durante il quale ci scappò il morto[21].
A dire il vero lo scontro non fu sempre così acceso e cruento. Vi furono vescovi che seppero destreggiarsi come mons. Giuseppe Candido ed altri che volendo essere ubbidienti a Roma e rispettosi verso il sovrano si trovarono tra due fuochi, come mons. Arata che per la sua intransigenza dovette patire anche il carcere a Palermo.
Il secolo XVIII in Sicilia si avviò con grandi mutazioni sul piano politico con il passaggio dell’isola dagli Spagnoli ai Savoia, agli Austriaci, ai Borboni mentre la Chiesa registrava una realtà tutto sommato vivace sul piano pastorale e spirituale anche se la società era flagellata da carestie, pestilenze, terremoti, guerre e tumulti popolari. Ma proprio questi gravi flagelli misero in risalto la nuova coscienza religiosa con la fondazione di un nugolo di opere pie a favore dei poveri, vecchi, ammalati, ragazze e bambini. Forse fu il contrasto fra questa nuova maturità pastorale e la debolezza del potere politico che rinvigorirono in alcuni prelati della chiesa siciliana, probabilmente sollecitati dalla Santa Sede, il desiderio di autonomia nel campo religioso.
 Clemente XI
Clemente XI
Infatti, all’inizio del XVIII secolo si vengono a trovare a capo delle diocesi di Catania e Girgenti vescovi che mal tolleravano l’ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano sempre pronti ad emettere scomuniche o a minacciarne. Così, quando la sede di Lipari diventa vacante, nella curia romana si pensa di nominarvi un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che, da una posizione tutta speciale, potesse opporsi alla Corte di Palermo, rivendicando l’autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese ma che si trovava a Roma priore del monastero di S.Paolo fuori le mura, cavaliere gerosolimitano.
Mons. Tedeschi viene nominato vescovo il 10 marzo 1710 con bolla di Clemente XI e, sembra, con la raccomandazione del papa di non permettere alcun abuso da parte della Monarchia[22].
E la prima occasione si presenta al vescovo non appena giunge a Lipari. Il Palazzo Vescovile, quello “ufficiale”, collocato nella città alta, a fianco alla Cattedrale, è occupato da una guarnigione di soldati franco-ispani. A Mons. Tedeschi non rimane che occupare la villa della città bassa che allora era praticamente in campagna, isolata dal centro abitato, e constava dei magazzini e una parte dell’attuale primo piano. Lo fa di malavoglia, lamentandosi col papa ed il papa a sua volta si rivolge a viceré lamentando che i soldati violano, “con non pochi scandali proprii della licenziosità soldatesca, il decoro e la sacralità del luogo, mentre il Vescovo, con suo grave incomodo e con maggiore affronto alla sua dignità, è costretto a risiedere altrove”[23]. Ma nemmeno le lamentele del papa ebbero effetto ed il vescovo dovette ingoiare questa “usurpazione”.
Come dovette accettare che fosse la giustizia dei giurati – e non quella ecclesiastica come lui sosteneva - a perseguire le frodi nei commerci dei Liparesi che danneggiavano la mensa vescovile ed il suo “jus dogane” fingendo di esportare, vini ed altre derrate prodotti nelle isole, in Sicilia dove vigeva la franchigia mentre, in realtà, questi raggiungevano località fuori del regno[24]. Mesi di arrabbiature e frustrazioni furono quindi per Mons. Tedeschi i primi del suo governo e probabilmente andava crescendo in lui la tensione ed il desiderio di rivalsa. E la causa scatenante non tardò a manifestarsi.
[1] Circa la disquisizione relativa all’autenticità dell’atto pontificio e sulla interpretazione da darvi si veda S. FODALE, L’Apostolica legazia e altri studi su stato e chiesa, Messina 1991;G.CATALANO, Strudi sulla Legazia Apostolica di Sicilia, Reggio Calabria, 1973; L. CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina, 2007..
[2] G. ZITO, Storia delle Chiese di Sicilia, Città del Vaticano, 2009, pag.43.
[3] G.ZITO, Storia delle Chiese, op.cit.,, pag. 46.
[4] S.FODALE,L’Apostolica legazia…, op. cit., pp.10-14. Secondo Salvatore Fodale il Barberi non avrebbe recuperato la bolla dagli archivi pontifici, né sarebbe venuto in possesso dell’originale o di un suo trascritto autenticato, bensì da un manoscritto del XIV secolo contenente la cronaca di Goffredo Malaterra o da un suo volgarizzamento redatto nel 1358 da Simone da Lentini.
[5] S. FODALE, op. cit., pag.13-14.
[6] Idem, pag. 57
[7] S. FODALE, op. cit., pag12.
[8] Idem, pag.58.
[9] Idem, pag.58
[10] Idem, pag.60; S.VACCA (a cura), La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medioevale e moderna, Caltanissetta- Roma 2000.
[11] L’interesse dei vescovi francesi nei confronti della Legazia derivava dal fatto che anche in Francia esisteva una sorta di privilegio dei regnanti nelle cose ecclesiastiche chiamato “gallicanesimo”.
[12]S.SARPI, Istoria del Concilio Tridentino, Torino 1974 ; G. MARTINA, La chiesa nell’età della riforma, Brescia 1988; M. VENARD, Il Concilio Lateranense V e il Tridentino, in Storia dei Concili Ecumenici, a cura di G. ALBERIGO, Brescia 1990 ; E. ISERLOH - J. GLAZIK - H. JEDIN, Riforma e Controriforma, vol. VI della Storia della Chiesa, Milano, 1975.
[13] L.LORENZINI,Catechismi e cultura nella Sicilia del Settecento, Soveria Mannelli, 1995;
[14] G. ZITO, op-cit. pag. 66.
[15] La “Donazione di Costantino” è il documento secondo il quale l’imperatore avrebbe donato a papa Silvestro la città di Roma e l'Occidente, spostando a Costantinopoli la sede del potere imperiale. In base a questa donazione i papi consideravano legittimo il loro potere temporale; non solo, pretendevano di avere autorità anche sui sovrani dell'Occidente. Nel XV secolo Nicola Cusano e Lorenzo Valla (De falso credita et ementita Constatini donatione declamatio) hanno dimostrato che la "Donazione" non poteva essere stata scritta all'epoca di Costantino, nel 313, ma alcuni secoli dopo; la dimostrazione di falsità si basava su argomenti di carattere storico e linguistico.
[16] L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina 2007
[17] M. GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, Marina di Patti, 2010, pag183; G. ARENA, Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610. Analisi, elaborazione statistica e sintesi dei riveli conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, Messina, 1992; G.ARENA, L’economia delle Isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina, 1982. C’è da dire a questo proposito che nella lettera che il Re di Spagna Filippo III scrive, il 22 novembre 1609 al viceré di Sicilia per comunicargli il passaggio della Città ed Isola di Lipari dal Regno di Napoli alla sua giurisdizione, non si fa alcun cenno alla condizione particolare della diocesi di Lipari, anzi si dice chiaramente che in detta isola valgano le disposizioni ed i costumi “ che si osservano alle altre Città, Isole, Luoghi Sudditi miei di questo detto Regno” anche per “le nomine di persone per gli offizij e cose Ecclesiastiche”. Inoltre quando il 10 maggio del 1610 questo passaggio è portato formalmente a conoscenza della autorità dell’isola – vescovo, giurati e governatore – il viceré di Sicilia è rappresentato proprio dal vescovo di Lipari, mons. Alfonso Vidal. Il testo della lettera di Filippo III e l’atto notarile della formalizzazione a Lipari del passaggio dell’isola al Regno di Sicilia si trovano nel documento manoscritto“Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,Allegato n. VII, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. D2 d bis. Ora in appendice di questo libro.
[18] La Bolla cui la S.Sede e i Vescovi di Lipari fanno riferimento è quella del 3 giugno 1091 scritta da Mileto e che confermerebbe un rescritto di Ruggero il normanno del 26 luglio 1088. Entrambi i documenti in latino in L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti…, op.cit., pagg.173-175.
[19] L’appunto manoscritto “Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,redatto per la Congregazione dell’Immunità di martedì 5 aprile 1712 e consultabile presso la Stanza Storica del Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ( ora in Appendice di questo libro), di ragioni ne elenca cinque corredate da 12 documenti a supporto. I primi due sono infatti il rescritto di Ruggero e la Bolla di Urbano II del 1091, emessa – come dice l’appunto – “ nove anni prima all’asserto privilegio della Monarchia”, cioè della Bolla del 1099 che riconosce al re normanno la apostolica legazia; v. anche. G. IACOLINO, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Il primo millennio…, pag.84.
[20] Archivio Vescovile di Lipari, carpetta Civili 7. Lettera del 7 maggio 1610 del Card.Gallo; M. GIACOMANTONIO, op.cit., pag. 191-192
[21] Il vescovo mons. Caccamo al culmine di una violenta discussione colpì con un coltello il governatore don Pedro Malpasso, ferendolo mortalmente. La notizia è riportata da diversi storici locali. Nell’Archivio Vescovile di Lipari esistono numerosi riferimenti a questo scontro fra il Vescovo e il Governatore in particolare nella busta denominata Processi criminali, n.3,1, carp. 33. f.408 e ss.; M. GIACOMANTONIO, op.cit, pp.194-197
[22] Nel libretto “Difesa della verità a favore di Monsig. Nicolò M.Tedeschi Vescovo di Lipari e della Libertà ed Esenzione della sua Chiesa contro le Calunnie e gl’Errori dell’Autore di una scrittura spagnola intitolata ‘Propugnacolo de la Real Jurisdicion etc”, anonimo, senza luogo di stampa e senza data di pubblicazione, dagli storici locali, sempre attribuito allo stesso Mons. Tedeschi, si dice che il papa “si degnò comandarli… che operasse viriliter, né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monaschia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima”(p.71). Una copia del libretto di Mons. Tedeschi si trova a Lipari nell’archivio personale del prof. Giuseppe Iacolino; M. GIACOMANTONIO, op. cit. pag. 232-237.
[23] La lettera è riportata nel libretto anonimo attribuito allo stesso Mons. Tedeschi a favore di Monsig. Nicolò Tedeschi, Vescovo di Lipari, senza data e senza luogo di stampa, pag. 87.
[24] “Delle vertenze fra la Corte di Roma e il Governo di Sicilia” manoscritto di autore anonimo presente presso la Biblioteca Universitaria di Messina, Tomo primo, Parte prima, pag.5.
Tribunale della Regia Monarchia
Un vescovo illuminato e una borghesia retriva
Una particolare attenzione alla condizione femminile
 Monumento funebre in Cattedrale del Mons. Coppola.
Monumento funebre in Cattedrale del Mons. Coppola.
Quando mons. Coppola arrivò a Lipari sul finire del gennaio del 1779 la prima impressione che ha della nuova diocesi è di forte delusione. Questa le apparve “come un quadro nel quale non si presentava alcunché di dipinto né alcunché di segnato” e lui si sentiva come un soldato disarmato o un artigiano senza gli attrezzi per lavorare[1]. Ma non per questo si abbatte. Individua immediatamente due punti forti per il suo programma: la formazione del clero, e “veggendo la deplorevole educazione delle donzelle e la sfrontata prostituzione delle donne di quella populazione che cagiona infiniti disordini[2]” l’educazione morale delle fanciulle perché diventino “ottime madri di famiglia” .
Sul primo punto comprese subito che a niente serviva ricorrere alle censure ed alle scomuniche perché non sarebbero servito ad altro che farli ricorrere al giudice della Monarchia che avrebbe concesso loro l’assoluzione e in attesa di creare quel Seminario che rimaneva l’obiettivo indispensabile, bisognava ricorrere al dialogo ed alla persuasione riproponendo quella disciplina, a cominciare dall’obbligo dell’abito talare ed al rispetto dei sacri canoni, a cui non erano più abituati[3]. Con questo scopo fondò la “Congregazione dei preti di Santa Maria del Fervore” che teneva raduni periodici sui temi della disciplina ecclesiastica e della liturgia, esercizi spirituali e dai cui dovevano uscire i predicatori, i catechisti ed i confessori della diocesi[4].
L’educazione delle fanciulle era, come si vide, il primo passo di una strategia più vasta nei confronti della condizione femminile. A questo scopo destinò il vecchio palazzo vescovile al Castello e fece venire dalla Sicilia della maestre che in quell’edificio presero alloggio ed, a titolo gratuito, dovevano insegnare alle ragazze “il timor di Dio, la sensibilità per i buoni costumi, il Catechismo e i lavori donneschi”[5] .
Una grande opera a cui mette mano è la costruzione, vicino al Palazzo vescovile del Borgo, di “un magnifico edificio per cui ha erogato molte migliaja di scudi[6]”, realizzato in tre elevazioni, tutto dedicato alle donne ma con tre distinte categorie di ospiti: le orfane, le donne che volontariamente “vogliono ritirarsi dal cattivo costume[7]” e che venivano allora chiamate “repentite” cioè’ “ree pentite” e le vere e proprie educande. A dirigere l’istituto – denominato Collegio di Maria o Conservatorio femminile - il vescovo chiamò alcune suore[8].
Un altro edificio che il Coppola realizzò per le donne inferme e l’infanzia abbandonata[9]fu l’”Ospedale femminile dell’Annunziata” riprendendo il nome del piccolo ospedale che era al Castello e che era ormai insufficiente e malandato[10].
Ancora, dedicate alle donne lavandaie, furono le cisterne, ciascuna con due lavatoi ai fianchi, che il vescovo fece costruire sulla Marina S. Nicolò per evitare che le massaie e le lavandaie di mestiere fossero costrette a fare il bucato sui sassi della riva e ,dovendosi alzare le gonne per non bagnarle, erano oggetto della morbosa curiosità dei giovani bellimbusti.
Una particolare attenzione il vescovo la dedicò alle “monache di casa”giudicandola una distorsione sia dal punto di vista sociale che religioso. Molte ragazze di famiglia agiata e benestante erano costrette a prendere il velo restando in famiglia di modo che non solo evitavano la dispersione del patrimonio, ma oltre ad assicurare il decoro della famiglia rappresentavano una garanzia per l’assistenza dei genitori in tarda età. “Le malelingue, – annota lo scrittore francese Jean Houel che visitò Lipari fra il 1778 e il 1780 - che in particolare si accaniscono contro le persone pie, non mancano di affermare che molte giovani donne prendono l’abito solo per godere di maggiore libertà. Il Vescovo ha pubblicato una pastorale per ovviare a questo abuso. Quando soggiornavo nell’isola, si diceva che volesse costruire un convento per farvi ritirare tutte quelle donne che sentissero un’autentica vocazione”[11]. Intanto mons. Coppola aveva emesso un decreto per regolamentare queste vocazioni richiedendo, a chi decideva di incamminarsi lungo questa strada, di dare buone referenze sulla propria vita, di essere dotate di un congruo patrimonio per evitare di rimanere sulla strada alla morte dei genitori, che a quarant’anni emettessero la “professione” e che si obbligassero a convivere con parenti di primo grado “ab omni suspicione alienis[12]” .
Toccò al suo successore, mons. Santacolomba chiudere definitivamente questo capitolo[13]
L’attenzione ai problemi sociali

L'edificio che Mons. Coppola dedicò alle donne.
Provvedimenti realizzati perché “della pudica modestia amatissimo[14] ” ma come aspetto di un più generale problema sociale di cui la moralità faceva parte. E fu per questo che si impegnò sul fronte della promozione culturale, dell’ammodernamento dell’agricoltura, dell’irrigazione e della fornitura di acqua potabile, del problema ospedaliero, dell’assistenza dei bambini abbandonati.
Quello dell’acqua è sempre stato un problema nodale per le isole ed è lo stesso Houel che ci racconta di avere assistito, durante il suo soggiorno, a due processioni con l’obiettivo di invocare la pioggia. “La prima processione era formata da una ventina di ragazzini, la testa cinta di una corona di spine e al collo una grossa corda che pendeva sino all’ombelico. Si flagellavano le spalle con aria divertita, e parevano più bambini che giocavano che piccoli santi che si mortificavano. Una ventina di preti, che cantavano le litanie, li seguivano stringendo con noncuranza una corda che di tanto in tanto si davano, con deboli colpi, sulle ampie spalle. I borghesi, i contadini e il popolo facevano seguito alla rinfusa, immersi nella preghiera con tutte le forze e con molta concentrazione…La pioggia non venne, fecero un’altra processione e a questa si partecipò con maggiore fanatismo; vi assistettero Cappuccini e Francescani, e la loro presenza accrebbe il fervore. Nove o dieci persone nude fino alla cintola si flagellavano duramente con catenelle di ferro dalle maglie sottili e taglienti, e il sangue scorreva sulla schiena e sui fianchi, tanto che il terreno ne era macchiato”[15].
Ma ad uno studioso di agricoltura come era mons. Coppola le processioni non potevano bastare e per questo “ordinò la costruzione di tre ampie e profonde gisterne; due avanti la gran porta del palazzo; l’altra innanzi la Chiesa del Rosario. Altre ne fece discavare sull’erta della Fossa Filici di Salina, ed in Filicudi ove stabilì un bel castagneto, come un grande oliveto piantò in Panarea[16].”
Lazzaro Spallanzani che visitò le Eolie fra dal 12 settembre al 17 ottobre del 1788 ed ebbe modo di conoscere il Coppola scrisse di lui “che parea nato fatto per ridur que’ Paesi, ancora mezzo salvatici, a stato migliore. E’ indicibile il numero degli olivi, che vi ha fatto piantare. Alla sola Panaria ve ne trovai più di tremila piedi. Vi ha pure introdutti i gelsi che assai bene vi allignano. Ne vidi uno nella sua bassa corte, piantatovi da otto anni che per la grossezza, e pel vigore non la cede punto a’ nostri di pari età, dove il terreno a tal pianta più si confà. I nominati fichi d’india portano il frutto, che sgusciato che sia, è giallognolo. Ha egli arricchita l’Isola d’una altra specie, fatta venir da Palermo, che li produce rossi, e che sono deliziosissimi[17]”.
Del programma sociale di questo vescovo faceva parte anche la cultura e così, nel 1782, trasferì nel borgo, “nel recinto del Vescovile Palazzo[18]”, il “Seminario delle Lettere” che i suoi predecessori avevano istituito sul Castello. Costruì cinque aule a piano terra – proprio di fronte al conservatorio delle donne - ed in esse fece altrettanti seminari di insegnamento aperti al pubblico. Si studiava – stando almeno alle intestazioni marmoree che ancora si scorgono all’esterno - grammatica, letteratura e retorica, filosofia tomistica e laica e, solo per i candidati al sacerdozio, teologia dogmatica, ma può darsi che in altri locali si insegnassero anche le scienze esatte. Oltre alla scuola aprì al pubblico la sua biblioteca con un bibliotecario e creò un “antiquarium” dove raccolse diversi reperti archeologici che aveva trovato negli scavi fatti per realizzare le aule del Seminario delle lettere: frantumi di statue di marmo, pavimenti a mosaico di pietre laviche, lapidi con iscrizioni greche[19].
“Io fui felice – scrive Houel - di scoprire, qui in mezzo ai rottami che andavo assiduamente rovistando, la statua di un console. Giaceva in terra, e il Vescovo ebbe la bontà di farla rizzare onde consentirmi che io potessi ritrarla. La sua grandezza è gigantesca, però le manca la testa ed è mutilata da tutte le parti[20]”.


I due grandi quadri di San Calogero e Sant'Agatone.
Dedicò anche attenzione e fondi alle chiese, al loro restauro ed al loro abbellimento. Nella Cattedrale in particolare diede gli ultimi ritocchi e sistemò alcuni altari e sistemò dei dipinti dei quali vogliamo ricordare i grandi quadri di S. Calogero e S. Agatone, realizzati nel 1779 da pittore palermitano Antonio Mercuri, che si trovano oggi su due altari delle navate laterali, ispirati a due episodi della nostra storia eoliana. Il primo con il santo che indica ai poveri malati che erano andati a curarsi alle terme il re Teodorico mentre – secondo quanto scrive il papa Gregorio magno nei Dialoghi - precipita nel cratere di Vulcano mentre, da una nuvola, il papa Giovanni I e il patrizio Simmaco, due sue vittime, lo osservano; il secondo ritrae il primo vescovo di Lipari che vestito dei paramenti pontificali indica alla gente in processione, prostrata a terra, la cassa di S. Bartolomeo a Portinenti.
Volle visitare tutte le isole. “Ho voluto rendermi conto di ogni cosa - annotava - senza risparmiare alle fatiche e ai disagi derivanti dal sito stesso, dall’angustia delle abitazioni e dalla povertà degli abitanti. Mosso appunto da cotanta miseria, ho attinto abbondantemente dalla Mensa, non ho dato neppure un soldo agli Assistenti che avevo portato con me e ai servitori che avevano qualche speranza, ma ho distribuito elemosine, proporzionatamente alle mie possibilità, sia alle Chiese che ai poveri, e ho fatto tenere tela e lino per vestire gli ignudi[21]”.
Il conflitto con i giurati
E fu proprio questo vasto programma sociale da una parte e dall’altra l’esigenza di dovere sostenere – integrando gli oboli raccolti fra i fedeli - le cappellanie in tutte le isole e le frazioni[22] - a fronte di una Mensa che non offriva più i guadagni di un tempo - che portò mons. Coppola a prospettare – a partire dal 1780 - all’Amministrazione locale, prima, l’esigenza di farsi carico dei bambini “projetti” e, poi, di concedere una sovvenzione pubblica per le chiese e le cappellanie a cominciare da quelle della città di Lipari.
Le richiesta del vescovo fece scalpore e non solo a Lipari ma anche a Palermo e Napoli e vennero ritenute quasi delle stranezze. In realtà dietro questa iniziativa di mons. Coppola – avanzata dopo lunga riflessione e consultazioni varie – vi era la riflessione che se la Real Monarchia avanzava nuove pretese sulla diocesi di Lipari negandole l’autonomia e la dipendenza diretta da Roma, doveva farsi carico anche di nuove incombenze a cominciare dalle attività sociali quali si potevano considerare l’assistenza dei bambini abbandonati e la cura d’anime. La sua prima richiesta che riguardava i “projetti” fu respinta sulla base di due sentenze del 1769 che facevano obbligo al vescovo di alimentare i bambini e di pagare le nutrici mentre ai giurati spettava solo il compito di cercare queste nutrici. Il vescovo certamente mal digerì questa decisione ma – dopo essersi consultato con i suoi esperti di Palermo – ritenne di non insistere oltre “prevedendo – come osserverà Giuseppe La Rosa che in questa vicende fungeva da consulente ordinario dei giurati e quindi aveva contrastato la legittimità della richiesta - il poco onore che si faceva a sé stesso in portare avanti tale indecorosa sua pretenzione”[23].
Comunque il vescovo reagisce male e risponde negando ai giurati alcune usanze di cerimoniale che danno luogo ad una nuova disputa e a nuove sentenze ancora una volta sfavorevoli al vescovo[24]. A questo punto mons. Coppola fa avanzare, nei primi mesi del 1782, dal vice parroco della cattedrale e dai cappellani curati della chiesa filiale di San Giuseppe, prendendo lo spunto dal fatto che era stata proibita la riscossione dei diritti mortuari che per il passato si era soliti pagare, la richiesta di “un congruo assegnamento annuale per cui potersi sostenere nel loro impiego Parrocchiale[25]”.
Il lungo memoriale che argomenta la posizione della civica amministrazione fu, ancora una volta, redatto da Giuseppe La Rosa. Esso concludeva sostenendo che il vescovo, essendo il parroco universale ed unico delle isole, dovesse sostenere con le entrate della “decimazione prediale[26]” il vice parroco della cattedrale e i cappellani della città e delle isole e quindi il loro ricorso dovesse essere rivolto al vescovo e “non mai essere tenuta questa università e suoi popoli a fare nuovo assegnamento di congrua prebenda a’ medesimi[27]”.
I giurati non si limitavano a respingere le richieste vescovili in punta di diritto ma tentavano di fargli i conti in tasca dicendo che dalle decime annualmente gli pervenivano “pinguissime somme” che nel 1782, annata sterile, erano di circa mille e cinquecento onze ma che nelle annate fertili si aggiravano sulle due mila onze. Contrapponevano così le pretese di un “Vescovo ricco” e la povertà di una Università costretta a litigare con lui per rintuzzare le sue pretese. Da parte sua il vescovo ribatteva che come i pubblicani del Vangelo i liparesi ed i loro amministratori civici erano avari ed ipocriti.

Disegno di Houel delle monache di casa di Lipari.
Il problema vero era che la borghesia e la nobiltà liparese non intendevano farsi carico dei bisogni dei ceti inferiori. Allora l’assistenza sociale e sanitaria come l’istruzione non era affidata alla pubblica amministrazione ma alla Chiesa e sostenere che il ricavato di millecinquecento o duemila onze fosse sufficiente per fare fronte alle esigenze sempre crescenti dei poveri era veramente incredibile. Inoltre Lipari proprio negli ultimi decenni del 700, oltre ai residenti, contava una guarnigione del presidio che fra soldati e loro familiari ammontava a circa tremila persone che aveva la funzione di controllare un numero consistente di “relegati provenienti dall’una e dall’altra Sicilia[28]”. E la presenza di una tale guarnigione e di così tanti “relegati” non doveva migliorare la condizione sociale soprattutto a Lipari[29].
Comunque, anche con tutte le difficoltà che dovette affrontare, rimane incredibile il volume di lavoro e di iniziativa che riuscì a realizzare mons. Coppola nei dieci anni che governò la diocesi. Come ci riuscì? Come riusciva a passare per un “Vescovo ricco” mentre le risorse della Mensa erano modeste? Ce lo spiega lui stesso in una nota alla S. Congregazione del Concilio del 24 settembre 1787: “Nell’assolvere a tutti questi impegni non ho potuto chiedere aiuto ai fondi della Mensa Vescovile che sono scarsi, bensì l’ho chiesto al poverissimo tenore di vita che mi sono imposto sin dal principio del mio Episcopato e che ancora, con l’assistenza di Dio, tengo”[30].
Nobili e personaggi eminenti della Lipari di fine secolo
Sul finire del settecento i borghesi che avevano fatto fortuna economicamente cercarono di consolidare la loro immagine col fregiarsi di un titolo nobiliare. Fu così che Giovanni Rodriquez, console di Francia, dopo aver acquistato terre ed essersi costruito una buona base economica, richiese ed ottenne, con decreto del 21 luglio 1784, dal re di Napoli il titolo di barone su una terra nel Vallone del Ponte[31]. Oltre al Rodriquez vi furono altre due famiglie borghesi, Monizio e Parisi, trapiantatesi nelle Eolie dove avevano acquisito poderi sia a Lipari che a Salina e avevano fatto fortuna col commercio dei cereali che chiesero ed ottennero da Ferdinando IV il titolo nobiliare. Don Francesco Monizio divenne così barone di Santa Marina e si costruì due dimore, una a Lipari nella campagna interna alla Marina di San Nicolò che da allora si chiamò “u Baruni” ed una a S. Marina nella zona che porta lo stesso toponimo. Don Domenico Parisi divenne invece barone di S. Bartolomeo e il 25 maggio del 1780 sposò Claudia, figlia del Monizio la loro abitazione era in un bel Palazzetto sopra la terra adiacente alla chiesa di S. Giuseppe[32]. A Lipari esisteva un’altra famiglia insignita del titolo baronale ed era la famiglia Tricoli che si era costruita una bella casa sul Timparozzo[33] .
Ma oltre ai nobili blasonati non dovevano mancare nella Lipari di fine settecento anche personaggi dotati nobiltà cultura e morale anche se, quelle di cui ci è arrivato a noi il ricordo sono pochi non solo rispetto alla realtà ma anche alle potenzialità. Infatti lo Spallanzani osserva che “qui i talenti non mancano, manca ad essi la coltivazione. I Liparesi sono in genere d’ingegno pronto e svegliato, presti nell’apprendere, acuti nel penetrare, e vogliosissimi di sapere. Quindi se qualche forestiero erudito approda alla lor terra, il domandano, lo interrogano, amano d’istruirsi. Prestansi volentieri a condurli ovunque più gli aggrada, gli mostrano con diletto le loro Stufe. I loro Bagni; né vi è alcuno che ignori, che quel Paese sia stato una volta prodotto dal fuoco”.
Comunque, fra le persone “coltivate” – oltre ai vescovi che provenivano però dall’eterno -, almeno due emergono dalle carte: un laico ed un prete. Il primo, lo abbiamo già incontrato. E’ Giuseppe La Rosa, avvocato, autore della “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole Eolie seu Lipari sacro” in quattro volumi di cui i primi due non ci sono pervenuti, il terzo raccoglie una serie di documenti relativi alla storia di Lipari, il quarto fa la storia cadenzandola sui vescovi da S. Agatone a mons. Coppola che governava la diocesi nel 1783 quando il manoscritto si ferma. La Rosa era un cristiano ma non un clericale. Un “cristiano adulto” diremmo oggi anche se era profondamente calato nel suo tempo e la sua religiosità era fortemente contraddistinta da atteggiamenti devozionali e credenze miracolistiche. Ma forse proprio per questo uno dei momenti di maggiore sofferenza nella propria esistenza fu quando, avendo dovuto difendere la civica amministrazione in qualità di consultore ordinario dei giurati e di avvocato dell’Università, vide che il vescovo – che nella disputa era la controparte – rimase irritato ed offeso nei suoi confronti. Non poteva darsi pace di questo, ripetendosi che un Prelato prudente avrebbe dovuto comprendere che non avrebbe potuto mancare al suo dovere professionale, inquinando così la sua onestà morale[34]. Eppure non per questo cambiò il suo giudizio su mons. Coppola e scrisse, a conclusione della sua opera, che “a se stesso niente pensa, sprezzante di ogni fasto mondano, e poca cura si piglia di sua salute, trattandosi di terminare l’opere da lui cominciate con il profitto di questo suo Gregge”[35].
Lazzaro Spallanzani
Un altro personaggio che spicca per le sue qualità e di cui ci parla Lazzaro Spallanzani, è l’abate Gaetano Maria Trovatini, uno dei centoquaranta o centocinquanta preti che vi erano a Lipari in quegli anni. Il Trovatini era medico[36] e coltivava le scienze. Di famiglia antica dove la ricerca era abitualmente di casa tanto che il padre Domenico aveva redatto una relazione “sopra i Bagni di S.Calogero nella Città di Lipari” ora andata perduta. Doveva essere nato nel 1752 il nostro abate, visto che era divenuto sacerdote nel 1752, quindi al tempo della visita di Spallanzani era ancora un giovane anche se non più giovanissimo. Comunque dovette fare una buona impressione sul grande naturalista che lo definisce “dotto” e ci informa che il Trovatini aveva redatto un lavoro di 72 pagine dal titolo “Dissertazione chimico-fisica sull’analisi dell’acqua minerale dell’Isola di Vulcano nel Porto di Levante detta volgarmente Acqua del Bagno” stampato a Napoli nel 1786. Quest’acqua sgorgava da una grotta ad un miglio dal Porto di Levante ed era, a parere del giovane ricercatore, importante ai fini medici ed a questo fine compilò anche un elenco”de’ morbi ne’ quali efficacissime si sperimentano le virtù della sorgente[37]”. Lo Spallanzani fu molto interessato da questa ricerca e portò con se, partendo, una riserva di questo liquido e sappiamo che continuò le ricerche sino al 1790. Non sappiamo però con quali risultati, inoltre di quella grotta oggi si è persa ogni traccia. Rimane il fatto che Trovatini, estraneo all’ambiente universitario e con pochi mezzi a disposizione abbia dimostrato, in quegli anni, una preparazione ed una sensibilità veramente apprezzabili[38]. Verso il 1788, ancora l’abate liparese venne nominato dal re, insieme al barone Bivona, soprintendente a lavori di scavo per individuare vene di zolfo e sorgive d’acqua entro la fossa del cratere di Vulcano. Si interessò anche di agricoltura e scrisse una dissertazione “Sulla maniera di coltivare le viti e il grano alla maniera del Sig.r Duhamel” che era un botanico francese famoso nel XVIII secolo.
Echi della rivoluzione francese
Pochi mesi dopo la morte di mons. Coppola a Parigi veniva presa la Bastiglia che è l’evento emblematico di quella rivoluzione francese che inciderà profondamente sulla storia del mondo. Ma ancora prima che scoppiasse questa rivoluzione fra il regno di Napoli e la Santa Sede si creò un duro braccio di ferro – che in qualche modo corrispondeva all’ostile isolamento praticamente nei confronti di tutti i sovrani europei - contro le prerogative e le ingerenze del papato e del clero in generale nella vita politica e nel’amministrazione dello Stato che qualche volta però sconfinava nell’invadere la sfera religiosa. A portare avanti questa lotta nel nome del re Ferdinando IV era soprattutto la regina Maria Carolina che si avvaleva dell’aiuto di alcuni ministri fra cui il viceré di Sicilia Caracciolo e più tardi l’amico sir John Francis Acton. Il papato – in una visione ispirata dalla massoneria che aveva a Napoli uno dei suoi punti di forza - fu visto come la causa di ogni arretratezza. Il principio della Apostolica Legazia che esisteva in Sicilia si volle estendere a tutto il regno e si voleva avere il diritto di presentare i vescovi da nominare. Aumentarono così le sedi vacanti. Ed anche Lipari subì questa sorte perché la S. Sede non voleva rinunciare a quella dipendenza diretta della diocesi da Roma che rappresentava l’unico punto di influenza diretta in Sicilia.
Tutti i nomi che Ferdinando proponeva il Papa li ricusava così il re si vide costretto a trovare una soluzione, in qualche modo transitoria, nominando, il 2 aprile del 1796, vicario capitolare mons. Carlo Santacolomba che era prelato ordinario di S. Lucia del Mela ed aveva il titolo di vescovo di Anemuria[39] .
 Mons.Carlo Santacolomba
Mons.Carlo Santacolomba
Quando giunse questa nomina non solo la rivoluzione aveva dispiegato i suoi effetti e vi erano state le esecuzioni di Luigi XVI e di Maria Antonietta che era sorella di Maria Carolina, ma Napoleone si apprestava a scendere in Italia. Il re cercava ora di arginare il potere della massoneria perché aveva compreso come i nemici della S. Sede stavano divenendo anche i suoi nemici[40] e si stava entrando ormai in anni di grandi turbolenza.
Santacolomba[41] non era un personaggio qualsiasi. Uomo di cultura avvertiva il clima di cambiamento che maturava in quegli anni nella società e lui stesso lo aveva in qualche modo interpretato celebrando nella primavera del 1783 nel duomo di S. Lucia del Mela, i funerali solenni, insieme all’intero capitolo, di un povero, umile, onesto, laborioso contadino pubblicando l’elogio pubblico[42] che aveva letto dal pulpito contrapponendolo ai ricchi possidenti, ingordi, oziosi, sfruttatori e sprezzanti. Queste sue idee,che gli erano valse l’accusa di “giacobino[43]”, dovette proclamarle anche a Lipari nelle sue prediche in Cattedrale e va sicuramente in questa direzione anche il decreto riguardante le “monache di casa” di cui abbiamo detto.
Ma più che impegnato a divulgare queste idee di rinnovamento e di innovazione sociale il vescovo dovette dedicarsi, come ogni altro vescovo del regno, negli ultimi mesi del 1796, a fare incetta di oro e di argento[44] per finanziare la guerra contro Napoleone che avanzava sul territorio italiano e presto una repubblica autonoma sarebbe sorta anche a Napoli e il re costretto a rifugiarsi in Sicilia chiedendo protezione agli inglesi e facendo ricorso a contribuzioni straordinarie. Anche nelle Eolie le chiese e i conventi furono spogliati di tutto quanto potesse avere un valore mentre venivano requisite per le truppe le chiese di S. Caterina e S. Maria delli Bianchi.
E dopo gli ori e gli argenti fu la volta anche dei metalli vili e persino delle coperte da letto dei due monasteri. Ma questa volta il guardiano dei Minori Osservanti protestò. Questa è una comunità poverissima, disse, e abbiamo solo i mantelli per coprirci. Ma è proprio vero che il re vuole fare morire di freddo noi poveri religiosi? “Se però il Sovrano la comanda così stracciosa come si trova, tutti i miei religiosi saranno pronti ubbidire”.[45]
Nel giugno del 1799 il re torna a impossessarsi di Napoli e la reazione contro i giacobini sarà durissima in tutto il regno. Anche mons. Santacolomba viene fatto oggetto di critiche e sospetti ricordando l’omelia per la morte del contadino a S. Lucia del Mela. Forse per reagire a queste voci, forse sollecitato dal governo di Napoli, forse anche perché se anche odiava lo sfruttamento e l’arroganza della nobiltà non per questo condivideva le idee e soprattutto gli eccessi dei repubblicani e dei rivoluzionari, mons. Santacolomba scrisse una lettera pastorale, di una sessantina di pagine, dal titolo :”Istruzione Pastorale sulla divina origine della Sovranità in questa terra, diretta agli Ecclesiastici delle due Diocesi di S.Lucia e di Lipari in Sicilia da Carlo Santacolomba Vescovo d’Anemuria”.
La società ed il suo sistema civile – afferma il Prelato – non si fonda, come sostiene Rousseau, sul contratto sociale ma prendono impulso da una disposizione divina. Il potere non deriva da un patto fra il sovrano e i sudditi ma da un espresso mandato divino. “Istruite i popoli, alzate al par di tromba la voce, - esorta concludendo rivolto agli ecclesiastici – e fate conoscere agli ignoranti il sacro glutino che stringe in vincolo di unione divina l’Ara ed il Soglio, il Vangelo e la Maestà. Con le dottrine che vi ho proposto si sciolgono e si dileguano, qual nebbia al sole, i due incantatori vocaboli di Liberté ed Egalité”.
[1] ASV. Cass. 456 B, f. 166v.
[2] Memoria per l’Università dell’Isole di Lipari,p.61 cita, da G. Iacolino, manoscritto cit, Quaderno V, pag. 337.
[3] G. La Rosa, op. cit. ,vol.I, pag. 303
[4] ASV. Cass. 456 B, f. 165.
[5] ASV. Cass. 456 B, f. 162 v.
[6] G. La Rosa, op. cit. vol. I. Oggi questo edificio, che verrà inaugurato nel 1787, e si trova all’inizio, sulla destra, del Viale mons. Bernardino Re è chiamato Seminario o anche “centro sociale”.
[7] Memoria per l’Università… op.cit.
[8] G. Iacolino , manoscritto cit., Quaderno V, pag. 237
[9] I “projetti” erano i bambini abbandonato di cui a Lipari si curava solo la Chiesa.
[10] Ricordiamo che a Lipari esisteva un altro ospedale dedicato agli uomini, chiamato di S. Bartolomeo a Marina S. Nicolò che però in quel tempo era molto malandato e stava per chiudere i battenti.
[11] J.Houel, op. cit.
[12] “Lontani da ogni sospetto”. ASV. Cass. 456 B , f. 163.
[13] Mons. Carlo Santacolomba, vescovo di Anemuria e abate di S.Lucia del Mela gestì la “sede vacante” di Lipari dopo la morte di mons. Coppola, col titolo di vicario del Capitolo di Lipari. In una lettera dell’1 maggio 1797 diretta a don Giuseppe Moscuzza, canonico della Regia Cattedrale di S. Lucia “Travai qui [in Lipari] uno stuolo innumerevole di donzelle, che senza i canonici requisiti prescritti dalle leggi di S.Chiesa vestivan l’abito religioso di terziarie Pinzochere, ed in sostanza erano vere laiche perché di laica convivenza ed alla potestà secolare immediatamente soggette. La maggior parte di freschissima età e di vistoso aspetto compariva di questa maschera; giacché maschera può chiamarsi l’indossare una veste che mostri al di fuori diversa persona di quel che sia nell’interno, anzi potea chiamarsi una rea profanazione dell’abito religioso. Queste poi vagavan sole per la Città portando il costume che le ragazze così velate non avessero più bisogno di compagnia, ed era volgare adagio che ‘legavano il capo e scioglievano il piede’. I rispettivi lor padri godevano di questa sacra comparsa delle figliuole, ed imprimevan loro la falsa idea che un tal travestimento fosse già una stabile situazione per così allontanarle dallo stato coniugale, risparmiarne le doti ed impinguare i primogeniti. Crescevano le fanciulle, si sviluppavan naturalmente le lor macchine: avrebbero desiderato cambiare e vesti e professione, ma non potendo resistere al paterno reverenzial timore, non avendo il coraggio di vincere il rossor proprio del sesso per svelar il natural desiderio di andare a marito, e trovando qualche fanatico direttor di coscienza che faceva veder loro chiuso il Paradiso e aperto l’Inferno qualora abbandonassero l’intrapresa carriera, seguivane che marcivano, invecchiavano, ed internamente costernate sacrificavano loro stesse ad uno stato di violenza. Si aggiunga ancor un più maturo politico riflesso di buon governo che il Superiore ecclesiastico non dee trascurare. E’ questo un picciol paese, ha un territorio di vasti poderi non coltivati per mancanza di agricoltori; abbonda il ceto nobile e contadino; mancan gli artisti e i villani che sono i principali costituenti di una popolazione ben ordinata; ed ecco l’origine della pubblica povertà che, nascendo dalla scarsezza de’ prodotti e delle manifatture, produce un pernicioso languore in tutto il corpo dell’inferma società. Come por rimedio ad un tal male se non facilitando con i maritaggi l’accrescimento delle braccia alienate dalle campagne e dalle arti? E come facilitarlo se non con l’esterminio di tante beatine che tutte sarebbero per diventar madri feconde di numerosa figliolanza? Credetemi, o caro Amico, mi sarei recato a coscienza di gravissima colpa se, dietro a tutte le esposte riflessioni da me seriamente meditate, avessi lasciato correre un disordine sì mostruoso. Grazie alla carità dell’Altissimo lo riparai. Pubblicai l’editto proibitivo delle Pizzochere ed ordinavo di svestire le attuali. Per maggiormente avvalorarlo, implorai l’autorità del Governo, e (…) fu comunicato al mio editto il valore di legge perpetua con Viceregio Biglietto, ond’è che sono già cinque anni che rimangon libere tante in felicissime prigioniere. Porzion di loro, quelle cioè che volesser restar Vergini nelle paterne lor case, vivon più santamente in abito secolare che non vivan sotto le prime mentite bende consacrando al Signore il lor candore elettivo da libere e non da schiave; e le altre, che formano il maggior numero, fra le quali coloro che forse men si credevano, oggi son mogli e madri, e benedicono quelle mani che impiegarono a sciogliere le lor crudeli catene” G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno V, pp 249 a,b,c
[14] C. Rodriquez, Breve cenno sulla Chiesa liparese, Palermo 1841, p.47.
[15] J. Houel, op.cit.
[16] C. Rodriquez, op. cit., pp.46-47. Oggi di queste tre cisterne è rimasta solo quella della Chiesa del Pozzo che è conglobata nella sacrestia, mentre quelle di fronte al cancello del viale vescovile rimasero fin verso il 1960.
[17] L. Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari 1993, p.380.
[18] C. Rodriquez, op. cit., pag.46.
[19] C. Rodriquez. Breve cenno storico sull’isola di Lipari, Palermo 1841, p.11.Corpus Inscriptionum graecarum, Berolini 1853, p. 683, n. 5757.
[20] J. Houel, op.cit.
[21] ASV. Cass. 456 B. f. 161 v.
[22] Al tempo di mons. Coppola a Filicudi vi erano due cappellani ( uno a carico della Mensa), a Salina vi erano sette chiese , una per frazione, con sette cappellani; a Stromboli tre ( S. Vincenzo, S. Bartolomeo e Ginostra) con tre cappellani, una chiesa e un cappellano ad Alicudi. A Panarea vi era una chiesa ma senza cappellano perché la popolazione non poteva mantenerlo.
[23] G. La Rosa, op. cit., vol. I. pag. 303-306.
[24] G- La Rosa. Op.cit., vol. I, pag. 347-348
[25] Idem, pag. 349.
[26] Sarà lo stesso La Rosa a spiegare che per decime prediali si intendono quelle che derivano per i frutti ed i proventi della terra che si producono annualmente ed in ogni stagione indifferentemente da qualsiasi podere sia di campagna che urbano. Esse si distinguono dalle decime personali e da quelle miste. Le personali sono quelle che prima si pagavano con l’ingegno e la fatica delle persone ( commercio, pesca, caccia ecc.).Infine le miste sono quelle che partecipano delle prediali che del lavoro delle persone come la lana, il latte, i parti delle pecore e delle mucche (op. cit. pp.370-371).
[27] Idem, pp. 349-364. Buona parte del materiale dell’Antiquarium di mons. Coppola fu recuperata o acquistata tra il 1878 e il 1879 da James Stevenson che lasciò alla sua morte i reperti al Museo di Glasgow.
[28] Da una lettera di mons. Coppola. ASV. Cass. 456 B, f. 163 .
[29] Nel 1788 un prete medico che aveva assistito per dieci anni gratuitamente i militari e le loro famiglie scrive al re chiedendo di potere avere un pezzo di terreno a Vulcano dove fare delle sperimentazioni agrarie che se dessero frutto potrebbe aiutarlo a vivere avendo tre sorelle a carico. La lettera di don Giuseppe Cubeta è in Archivio Vescovile di Lipari. Car. Capitolo Cattedrale 1772-1972.
[30] ASV. Cass. 456 B ff. 165v -166.
[31] Registri del Protonotario del Regno, vol. 914, 1783-84, ff.57 e ss. Arch. Di Stato di Palermo, sez. II.
[32] Oggi sede dell’Hotel Meligunis.
[33] Era un edificio ad angolo fra le attuali via Garibaldi e via Umberto I che, divenuto di proprietà dell’Amministrazione comunale, intorno al 1965 fu demolita e ricostruita senza alcun pregio divenendo sede della Pretura ed oggi di alcuni uffici comunali.
[34] G. La Rosa, op. cit., vol.I, pag. 364
[35] G.La Rosa, op. cit., vol.I, pag. 297.
[36] A metà del settecento a Lipari su sei medici quattro erano sacerdoti. G.Iacolino, Il settecento liparitano, in L: Spallanzani, Destinazione Eolie, op. cit., pag. 429.
[37] G: Iacolino, idem, pag. 436.
[38] P. Manzini, Lazzaro Spallanzani, Gaetano M. Trovatini e l’analisi dell’acqua dell’isola di Vulcano” in “Bollettino Storico Reggiano”, a. XIII, vol. XLIV, 1980, pp 15-26. citato in G.Iacolino, idem, pag.436.
[39] Antica città nella Cilicia i cui vescovi venivano nominati in partibus infidelium.
[40] L. Von Pastor, Storia dei Papi, Roma, 1955, vol.XVI, parte III, p.97 si veda anche G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno V pp.244-246-
[41] Carlo Santacolomba era nato a Palermo intorno a 1728. Aveva ottenuto la prelatura ordinaria di S.Lucia del Mela nel 1780 ed il 2 aprile del 1786 era stato consacrato vescovo di Aremuria. Morirà a Lipari il 14 luglio del 1801.
[42] “Ne’ solenni funerali di Marco Trifirò vecchio contadino celebrati da Monsignor vescovo d’Anemuria Carlo Santacolomba. Omelia da lui recitata nella sua regia cattedrale”, Siracusa, 1787.
[43] A.Di Giovanni, La vita e le opere di Giovanni Meli, Firenze 1938, p. 233.
[44] Gli inventari della Chiesa di S. Bartolomeo in contrada Lingua di Salina, della Chiesa di S. Giuseppe in Lipari, e quello complessivo della diocesi in G. Iacolino, manoscritto cit., quaderno V, pp.251-253.
[45] La lettera di fra Giacomantonio da Lipari, guardiano dei Minori Ossservanti rivolta al Vescovo si trova in G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno V, pp.253-254. Questa come una lettera simile del guardiano dei Cappuccini, e gli inventari della diocesi e delle chiese in, Archivio Vescovile, Scritture varie e visite date. Miscellanea, vol.9 rispettivamente ai ff.11,22,31 e 7.
La Rosa e Trovatin
Un vescovo caritatevole e lo scontro su Vulcano
A Lipari, la città bassa prende forma

Il settecento in Sicilia prende il via fra repentini cambiamenti politici che rendevano ancora più precario uno scenario fatto di povertà e di guerre vicine e lontane. Come abbiamo visto nel 1713 gli spagnoli furono sostituiti da Vittorio Amedeo II di Savoia, nel 1720 fu la volta degli austriaci, nel 1735 arrivarono i Borboni che rimasero fino al 1860 quando prima Garibaldi e poi i piemontesi di Vittorio Emanuele II li scacciarono per costituire il Regno d’Italia.
Durante uno di questi passaggi, ai primi di ottobre del 1718, Lipari fu coinvolta in un episodio di guerra. Mentre una flottiglia inglese, venuta in appoggio agli austriaci, percorreva la rotta da Napoli a Messina per dare l’assedio a questa città, i liparesi intercettarono due grosse tartane cariche di vettovaglie e se ne impossessarono. La cosa non piacque agli inglesi che inviarono un battello con l’ambasciata che o Lipari prestava omaggio all’Arciduca o sarebbe stata bombardata. La risposta fu pronta :”Lipari aveva giurato fedeltà a Filippo V e non avrebbe tradito. Piuttosto avrebbero combattuto”. Gli inglesi cominciarono così a bombardare la città ma i liparesi risposero per le rime. Questo scontro durò poche ore durante le quali mentre i danni subìti dalla città furono minimi e senza morti, le navi inglesi che scortavano la Palandra che bombardava furono costrette ad allontanarsi lasciando questa isolata. Immediatamente i liparesi ,armate delle feluche, corsero verso questo battello per catturarlo. Vista la manovra gli inglesi mandano un lancia per difendere la Palandra, ma anch’essa fu catturata. Mentre i liparesi trainavano i due battelli in porto, le navi nemiche puntarono su di esse e così si dovette abbandonare la Palandra che aveva la poppa fracassata e si faceva fatica a portarsela dietro. Comunque i liparesi tornarono in porto avendo sequestrato la lancia e fatto prigionieri gli uomini, mentre gli inglesi andarono via scornati avendo perso le bombe ed una lancia con gli uomini a bordo.[1]

Le case sotto le mura del castello disegnata da Luigi Salvatore d'Austria
Lipari intanto, via via che andava diminuendo la paura delle incursione barbaresche, andava espandendosi fuori dalle mura del Castello. Cominciarono gli strati sociali più poveri che non trovavano spazio nella città alta a costruire le loro case, per lo più anguste, di uno o due vani, realizzate con materiale economico e quindi per lo più scadenti, con una piccola cisterna e prive di servizi igienici con pavimenti sconnessi per lo più di semplice battuto,le une accostate alle altre disegnandolo vicoli strettissimi in terra battuta perennemente sporchi e maleodoranti perché vi si vuotava di tutto persino i pitali con le orine e gli escrementi della notte.
La borghesia si trasferisce alla Marina S.Giovanni

Marina corta vista da Veuiller
Poi fu la volta delle famiglie borghesi che cominciarono ad avvertire gli effetti di una globalizzazione crescente dei commerci e delle idee e che, oltre ad un benessere crescente, si traducevano in una evoluzione nei gusti e nelle esigenze. Così cominciarono a trovare troppo anguste le abitazioni al Castello e non potendole ampliare – introducendovi i servizi igienici e i nuovi spazi di convivialità e di rappresentanza - pensarono di costruire nella città bassa. Soprattutto i commercianti e gli armatori avvertirono la necessità di risiedere nei pressi della marina mentre la nobiltà terriera ed altri borghesi sperimentarono l’importanza di potere disporre, dietro la loro abitazione, di uno spiazzo di terreno da destinare ad orto e a giardino con un pergolato sotto il quale passeggiare e sostare all’ombra per conversare .
Realizzarono così le loro abitazioni, anche su due piani, nella Marina di San Giovanni proprio di fronte al mare, sul lato destro della salita di S. Giuseppe, lungo il Timparozzo, nella strada di S. Pietro che si chiama oggi via Maurolico, lungo la strada dei Bottài , oggi via Roma, e qualcuna più in su nel vallone Ponte. Abitazioni – annota Iacolino – dai “caratteristici prospetti ad intonaco colorato, spezzati da bianchi rifasci orizzontali, i sobrii cornicioni correnti alla sommità, i portali ad arco, di pietra, i balconi, anch’essi di pietra, con ringhiere a ‘petto d’oca’ onde consentire alle donne di affacciarsi agevolmente sulla via nonostante indossassero le ingombranti crinoline a campana”[2].
La Marina di San Giovanni che arrivava fin dove oggi c’è il vicolo di Sant’Antonio e l’omonima chiesetta dominava la spianata e il mare, venne ridotta dalle costruzioni delle famiglie La Rosa, De Pasquale, Carnevale.
L’odierno corso Vittorio Emanuele, che si chiamava strada del Pozzo, era il greto di un torrente su cui si aprivano orti e botteghe di artigiani. Lungo l’attuale Marina lunga che allora si chiamava Marina San Nicolò, vi erano poche casupole di pescatori con le loro barche tirate a secco dinnanzi, ed in fondo, un po’ distaccata dal resto la chiesetta di San Francesco di Paola che verrà poi rinominata Maria SS.di Porto Salvo con a fianco l’ospedale di San Bartolomeo per soli uomini che aveva voluto il facoltoso commerciante don Bartolomeo Russo morto nel 1712[3]. L’ospedale di S. Bartolomeo sorse intorno al 1730 mentre un altro ospedale, quello dell’Annunciata, era al Castello[4].
Nel 1737 Lipari fu inclusa fra le cento città di Sicilia che ebbero le prime “officine postali” segno che i rapporti di scambio dovevano essere abbastanza rilevanti[5].

Mons. Platamone
Ancora nel terzo decennio del secolo, al vescovo Platamone la massa dei poveri appariva grande rispetto alle risorse della Mensa vescovile che probabilmente per la lunga vacanza vescovile e per le vicende della “controversia”, mancando un attento e continuo controllo sulla produzione dei campi e della pesca, si era di molto contratta. Tremila scudi, è quanto il vescovo dichiara che aveva riscosso l’anno precedente e desunte tutte le spese dovute rimanevano a disposizione solo 1.685 scudi con i quali doveva fare fronte ai poveri ed allo “stato di bisogno della Chiesa”[6]. Con questi fondi, ma anche con risorse proprie, Platamone doveva rendere agibile la residenza di villeggiatura ospitando anche la curia ed il tribunale ecclesiastico giacchè il Palazzo vescovile vicino alla Cattedrale era “quasi del tutto crollato, a causa della recente guerra di Sicilia, non è in atto abitabile[7]”. Oltre alla sopraelevazione del primo piano ricavandone sei vani, egli realizzò un bel vialetto colonnato, ombreggiato da viti che andava verso la via di S. Lucia[8].
Anche vescovo e municipio lasciano il Castello
Così intorno al 1725 il vescovo andrà ad abitare nel palazzo di villeggiatura a Diana[9] mentre il “Tocco”, cioè la sede municipale, dovette allora essere trasferita sul Timparozzo che col tempo fu chiamata strada del Municipio. Sempre dalle relazioni di mons. Platamone riusciamo ad avere anche informazioni sulle altre isole. Certamente la più popolata è Salina che conta ben sei chiese distribuite a S.Marina, Lingua, Capo dei Fichi, Malfa, Pollara e Val di Chiesa. Anzi è la prima volta che nella relazione di un vescovo si parla del “miracolo”[10] . Delle altre isole si parla solo della chiesa di S. Stefano a Filicudi e di quella di S.Pietro a Panarea; ma nel 1730 sorgerà la chiesa di S. Vincenzo a Stromboli.

S. Marina con la sua chiesa che svetta sulla cittadina.
Nelle nuove abitazioni, soprattutto della nobiltà terriera ma non solo, non era difficile trovare una stanza dedicata a cappella giacchè , in queste famiglie, vi era sempre un ecclesiastico come non mancavano una o due figlie che prendevano il velo in privato. Soprattutto per le donne, le cosiddette “monache di casa”, la ragione era quella di evitare la frantumazione della proprietà mantenendola concentrata in una ristretta cerchia di eredi, per i maschi che intraprendevano la carriera ecclesiastica vi era anche – in particolare nella borghesia che aspirava ad entrare nel giro dei “gentiluomini” – la propensione ad una promozione sociale per sé e per la propria famiglia.
Numerosi erano divenuti gli ecclesiastici che vivevano nelle Eolie: 95 sacerdoti, 8 diaconi, 5 suddiaconi, 5 accoliti e due lettori. Venti - venticinque erano i frati che risiedevano nei due conventi dei Minori e dei Cappuccini [11]. Ma per la maggior parte si trattava di un clero culturalmente povero tanto che il vescovo dovette fare venire da fuori il suo vicario generale. E questo anche perché , durante il tempo della “controversia”, nel Seminario delle lettere le lezioni non si tennero più con continuità ed alcune cattedre, come quelle di filosofia e teologia, rimasero vacanti. Per rimediare il vescovo obbligò tutto il clero a frequentare corsi tenuti da un suo confratello domenicano.
Comunque nel 1754 il vescovo De Francisco annota che i preti della Cattedrale e di San Giuseppe attendono scrupolosamente ai loro doveri “come pure anche gli altri Cappellani nelle Isole, dove risiedono, impartiscono con buon esito i rudimenti della Fede ai fanciulli”[12].
La paura della peste e la contesa su Vulcano
Nel giugno del 1739 una grande allarme si diffuse per le isole. Si era saputo che nei Balcani si erano verificati casi di peste e siccome le isole erano territorio aperto, sul transito di tante barche e vascelli, appena si seppe di questo pericolo subito la fibrillazione salì alle stelle. Già vi era stato un allarme ed una mobilitazione nel 1720 quando si era parlato di casi di contagio a Marsiglia, ora il problema si ripresentava. I giurati subito si mobilitarono e con i deputati di sanità tennero un pubblico consiglio. All’ordine del giorno le precauzioni da prendere negli scali delle isole. E come diciannove anni prima si decise di fare presidiare notte e giorno tutti gli scali dalla gente delle isole, dando loro le stesse istruzioni di allora.
Il governatore fu però di diverso avviso. D’accordo sul presidio notte e giorno ma in tutte le isole si dovevano mandare gente di Lipari, probabilmente perché ritenuta più affidabile. Incurante delle proteste dei giurati che reclamavano che non si potevano ignorare le risoluzioni ufficialmente già adottate, il governatore ordinò subito al Capitano dei quartieri delle milizie urbane di recarsi a Salina con 20 uomini da collocare nei vari scali, all’alfiere delle stesse milizie di prendere altri dieci liparesi e di recarsi a Stromboli ed al governatore del porto di Lipari di individuare altre 30 persone per gli scali dell’isola principale. Naturalmente tutte queste persone che erano comandate non erano militari ma gente del popolo che aveva un lavoro a cui accudire e tutti si lamentarono con i giurati perché queste decisioni recavano loro un grave danno visto, per di più, che non si sapeva quanto tempo sarebbe durata la mobilitazione.
Così i giurati si appellarono al viceré ed il viceré diede loro ragione affermando che fossero essi investiti dei più ampi poteri per l’emergenza predisponendo le guardie per le isole, procedendo alle ispezioni sanitarie a bordo dei bastimenti in arrivo, ordinando le opportune quarantene per gli equipaggi e quant’altro occorresse con l’obbligo di coinvolgere il vescovo nelle decisioni “per maggior accerto della comun salute[13]”.
Per fortuna il contagio non raggiunse le isole ma lo stato di allarme durò a lungo, almeno sei mesi. La paura della peste però non abbandonò le Eolie. Solo quattro anni dopo, nel 1743 essa esplose a Messina e in 3-4 mesi si contarono ben 40 mila vittime. Si mise in atto uno stretto cordone di vigilanza intorno alla città e si impedì che il contagio si propagasse nel circondario. Probabilmente misure di sicurezza scattarono nuovamente nelle Eolie ma per quello che se ne sa anche le isole non furono immuni dall’infezione di questo male anche se probabilmente in misura non allarmante. A Val di Chiesa ( Salina) vi è infatti una lapide che ricorda questo evento[14]
Difficilmente il vescovo partecipò con i giurati alla valutazione dei provvedimenti sanitari da prendere come voleva il viceré perché proprio in quel tempo era scoppiata una controversia fra i giurati ed il presule a proposito delle competenze di giurisdizione nel concedere autorizzazioni o proibire l’estrazione dello zolfo e dell’allume. Si ripeteva cioè quanto era accaduto al tempo del vescovo Ventimiglia, solo che, questa volta, furono i giurati a compiere il primo passo.

Huel, Vulcano visto da Lipari
Si sapeva che di notte, di nascosto della gente di Lipari senza lavoro e per cercare di racimolare qualche soldo si recava a Vulcano dove, scavando, raccoglieva zolfo e allume che poi vendeva a forestieri. Protestarono di questo fatto i benestanti di Lipari proprietari di terre sostenendo che le esalazioni di questi scavi danneggiava i loro campi e le loro culture e chiesero ai giurati di intervenire. Il vescovo si sentì toccato nelle sue prerogative e prevenendo i civici amministratori emise lui l’ordinanza di divieto. Scoppiò un forte dissidio e i giurati ricorsero al viceré. La sentenza del Tribunale del Patrimonio fu molto dura per il vescovo. Richiamandosi a quanto accaduto al vescovo Ventimiglia sentenziò che l’isola di Vulcano, come le altre isole dell’Arcipelago eoliano erano di pertinenza del dominio del re, per cui il vescovo era invitato a revocare subito il suo editto[15].
Un vescovo caritatevole
Il vescovo se la prese e quando si accorse che i giurati avevano rinnovato il panno rosso del loro scranno in Cattedrale avendolo realizzato “di scelto damasco con un suo guarnimento all’intorno di una frinzettina d’oro e seta” andò su tutte le furie.
“Troppo superbo, lo bollò, e più eccellente, e ricco del suo baldacchino Vescovile”. Il vescovo proibì che si collocasse questo drappo in Cattedrale e la questione fu portata a Palermo dove si discusse per oltre un anno. Alla fine mons. Beamonte, prevedendo che il risultato della sentenza non gli sarebbe stato favorevole, desistette dal suo divieto e la controversia si compose[16].
Questi episodi potrebbero fornire una immagine errata di questo vescovo che invece ci viene tramandato come fortemente caritatevole verso i poveri della diocesi, “eccedendo le sue elemosine oltremisura, né vi era mai bastante denaro, che potean dare le entrate annuali di sua Azienda vescovile, per saziare le calde brame della sua carità” . Proprio per questa sua prodigalità gli amministratori della Mensa dovettero tagliargli i fondi e gli impedirono di ingerirsi nella gestione finanziaria. Così per fare beneficenza egli ricorreva a vari sotterfugi.
Quando rimaneva senza denari e non riusciva a corrispondere alla richieste di un povero, si rinchiudeva nel suo ufficio si toglieva la tonaca del suo ordine e si liberava dei vestiti che portava di sotto quindi si rimetteva la tonaca sulla biancheria intima mentre i vestiti li consegnava al poveretto dicendo “ Pigliate queste vestimenta, andate a venderle e servitevene per i vostri bisogni, mentre io non tengo denaro pronto per soccorrervi, ma guardate di farvi vedere con queste robbe dai miei familiari, ne dite cosa a nessuno che l’avete ricevute da me”. Il prelato rimaneva così per diversi giorni senza abiti sotto la tonaca fino a che non veniva scoperto dai suoi familiari che provvedevano a rifornirlo di nuovi vestiti.
“Altre volte arrivò di notte tempo, a segno di gettare dà balconi del suo appaltamento, che corrispondevano in strada, li matarazzi dove egli soleva dormire dandoli a qualche povera donna, che li ricorreva per bisogno di non poter maritare qualche figlia per mancanza di matarazzi. Onde la mattina poi veniva trovato dà suoi familiari coricato sopra le nude tavole del letto; e bisognava provederlo di nuovi matarazzi”[17].
Comunque al di là della carità spicciola un segno importante sul piano sociale il Beamonte riuscì a dare agli eoliani, infatti, riuscì a dare vita a quello che era stato il sogno di mons. Arata e di altri vescovi: la creazione di un Monte di Pietà che potesse finanziare le attività economiche del popolo ed in particolare i contadini ed i pescatori[18].
Vulcano non si tocca

I terreni ed i giacimenti di Vulcano che erano stati oggetto di contesa al tempo di Ventimiglia e di Beamonte, tornarono a creare problemi al successore di questi, mons. Francesco Maria Miceli[19]. Anche Miceli si chiese come si poteva venire incontro alla massa dei poveri che viveva a Lipari. I terreni a Lipari e Salina erano tutti occupati e coltivati, delle altre isole minori – Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli – diceva che “non sono altro che montagne scoscese protette da dirupi inaccessibili; non abbondano di comodità, né sono fertili di granaglie; in esse molti conducono una vita stentata”[20] . Così puntò gli occhi su Vulcano e andò di persona a vedere che cosa era possibile fare e si convinse che buona parte di essa poteva essere coltivata.
Reso edotto dei problemi che avevano bloccato i suoi predecessori pensò che fosse prudente coinvolgere nell’iniziativa i maggior enti dell’isola e così, nei primi mesi del 1748, ne parlò col governatore e i giurati. Li trovò d’accordo tutti tranne un giurato, Giacomo Bonanno ma probabilmente si pensò che prima o poi anche lui si sarebbe convinto e così fu dato il via all’operazione mandando i contadini a “dar principio allo scampamento”.
Invece il Bonanno – che, per disposizione governativa, aveva il compito di badare a che non si producessero zolfo e allume nell’isola di Vulcano[21] - non si convinse ma riuscì a portare dalla sua altri liparesi che non volevano che la lottizzazione compromettesse l’antico diritto di pascere e di legnare e ricorsero al viceré[22].
E il 10 maggio arrivò la risposta , direttamente al vescovo, che era decisamente negativa. L’idea di mandare gente a Vulcano a zappare e seminare le terre era di impedimento a chi voleva andarvi per pascolare o per fare legna, ma era anche di grave pregiudizio “alla reale giurisdizione di S. Maestà, a cui unicamente appartiene detta isola, ne già mai si potea un tal permesso di scampare e seminare dette terre accordare né dalli riferiti Giurati”. Il vescovo viene diffidato dal compiere qualsiasi passo in quella direzione, “ne ingerivi per l’avvenire in cosa alcuna, attinente a detta isola di Vulcano[23]”.
Nessuno disse allora che lo “jus pascendi” e lo “jus legnandi” consistevano in una aggressione selvaggia al manto boschivo dell’isola che nel giro di qualche decennio lo distruggerà irrimediabilmente.
Si costruisce l'Immacolata

La Chiesa dell'Immacolata
E’ nel periodo in cui mons. Miceli regge la diocesi che si realizza la costruzione di quel gioiello che è la chiesa dell’Immacolata al Castello ad opera della confraternita che portava questo nome. La confraternita si riuniva in una chiesina che si trovava assieme ad altre due piccole cappelle nel sito dove ora sorge l’Addolorata. Quando fu realizzata l’Addolorata le cappelle vennero incorporate e scomparvero e la confraternita fece capo ad una chiesetta, all’entrata del Castello, subito dopo il corpo di guardia che era detta della Concezioncella ma che tutti chiamavano di S. Caterina. Ora erano trascorsi cento anni da quando era stata restaurata, vi pioveva dentro e spesso dal soffitto si staccavano dei calcinacci. Per questo la confraternita ,che vantava un patrimonio ragguardevole, chiese al vescovo di potere realizzare una sua chiesa, grande e spaziosa, nel terreno fra la Cattedrale e la chiesa dell’Addolorata dove vi erano vecchie casupole che si erano liberate perché chi vi viveva era andato ad abitare nella città bassa.
Vi era anche un’altra ragione non dichiarata per cui la confraternita desiderava costruire una bella e grande chiesa al Castello e questa stava nella competizione che si era venuta sviluppando fra confraternita dell’Addolorata e confraternita dell’Immacolata.. La prima infatti raccoglieva la nobiltà terriera sempre più insofferente verso il diritto del vescovo di riscuotere censi e decime e gli ufficiali del presidio militare che nel tempo avevano avuto spesso degli attriti con il vescovo ed avevano fatto della confraternita e della chiesa un centro autonomo di culto posta sotto il Regio Patronato per cui il rettore non veniva nominato dal vescovo ma da Palermo; nella seconda confraternita confluivano invece la borghesia agiata formata da padroni di barche, mercanti, bottegai ed artigiani ed erano devotissimi al vescovo.
La richiesta di autorizzazione al vescovo è della fine di dicembre del 1746 e nell’arco di pochi giorni mons. Miceli ordina che si proceda allo studio della questione con gli esperti, esamina le relazioni e rilascia il suo benestare. Occorsero sette anni per realizzare l'opera e nel 1754 la chiesa, benchè non rifinita in ogni sua parte, venne aperta al culto[24].
La colonizzazione di Ustica e le difficoltà economiche
Si è detto come via via che ci si inoltra i questo secolo i segni di benessere e le esigenze di qualità della vita vanno crescendo nelle due classi benestanti dell’isola: la nobiltà terriera e la borghesia mercantile. Questo a fronte di una condizione della grande maggioranza della popolazione che doveva faticare per vivere. Eppure non è corretto descrivere la situazione sociale delle Eolie come fortemente polarizzata: i benestanti da una parte i poveri e gli emarginati dall’altra. Fra la gente che ogni giorno doveva porsi il problema della sopravvivenza propria e della famiglia vi era indubbiamente chi, come i contadini, i pescatori proprietari di una piccola barca e gli artigiani, che avevano un mestiere che in qualche modo – a meno di disgrazie improvvise - rappresentava una garanzia per l’esistenza; vi era invece chi e forse erano la maggioranza viveva nella precarietà andando a giornata a lavorare nei campi o offrendosi sempre a giornata nei lavori servili, facendo il facchino o lo sguattero, arrangiandosi a raccogliere pomice, legna da ardere, vendendo i pochi pesci che riusciva a pescare, ecc.; ed infine c’era anche chi non poteva contare sulla proprie braccia e viveva praticamente solo di elemosina. Può stupire che i tentativi di vescovi come Ventimiglia e Beamonte di valorizzare le terre o i giacimenti di Vulcano per cercare di offrire lavoro a chi a Lipari non ne aveva, vengono contrastati in nome proprio dei “poveri mendichi, i quali con l’uso quotidiano di far legni secchi si procacciano il miserabile vitto”[25]. Ed è questo che convince come alla base di questa opposizione non ci sia un intento sociale ma piuttosto l’egoistica posizione di chi vuole garantirsi un mercato di braccia a basso costo.
E che questo problema esista lo dimostra l’esodo per popolare Ustica che si verificò fra il 1762 ed il 1764. Il 4 aprile del 1759 il re Carlo di Borbone autorizzava la colonizzazione dell’isola ed agli immigrati venivano promesse due salme di terra - circa 5 ettari - per ogni famiglia di 5 individui e l’esenzione delle imposte per 10 anni. L’idea di avere un proprio pezzo di terra fu il motivo che convinse una sessantina di capi famiglia eoliani – di Salina e Filicudi in particolar modo – a salpare – nel 1762 probabilmente nel mese di giugno - con quattro barche dette “paranzelle” rifornite di commestibili e piccoli cannoni “senza che si fosse ancora provvisto a quanto il Tribunale di Commercio stabilito aveva per la difesa dell’isola e per il comodo dei nuovi coloni”[26]. Tutto andò bene nel viaggio e giunti all’isola subito i nuovi immigrati cominciarono a costruire baracche per ripararsi e probabilmente provvidero a fare arrivare anche altri membri delle proprie famiglie. Ma dopo qualche tempo si fanno vivi i pirati turchi che i liparesi però riescono a respingere decimandoli. Purtroppo nella notte dell’8 dicembre i pirati ritornano con cinque galere ed ebbero ragione dei nuovi coloni: le baracche furono bruciate, molti furono uccisi, settanta furono portati via come schiavi e solo pochi riuscirono a nascondersi su una barca e, non visti, giunsero a Palermo. Dopo che a Ustica furono fatte le fortificazioni, si organizzò una nuova spedizione, quasi tutta di eoliani, questa volta di 85 famiglie per circa 399 persone, marinai e contadini, nell’ottobre del 1763, portando con loro pecore, asini, buoi, vanghe zappe e rastelli, arnesi per pescare, masserizie d’ogni sorta, commestibili e vestiti[27].
Si trattò indubbiamente di un viaggio della speranza come quello che decenni dopo, altri eoliani affrontarono verso l’America. Un viaggio dettato dalla precarietà della situazione e dalle condizioni di vita difficili. Tanto difficili, da fare accettare i disagi di una destinazione disabitata e selvaggia. con la difficoltà aggiuntiva di dover superare la paura per nuovi attacchi dei pirati.
Certo i pirati non erano una novità per i liparesi ed anche a Lipari avevano, come abbiamo visto, spesso a che fare con loro anche se negli ultimi decenni sempre meno. E qualche volta, spinti dalla necessità, anche i liparesi dovettero ricorrere alla forza ed all’epediente della pirateria per cercare di procurarsi il necessario per vivere.

L'isola di Ustica vista dall'aereo
Quegli anni, in cui emigrarono per Ustica un buon numero di eoliani ed altri si apprestavano a partire, la carestia imperversava in tutto il regno ed in Europa e frequentemente giungevano notizie di gente, che nelle città, moriva di fame. Per fortuna non era questa la situazione delle isole dove se non si arrivava col lavoro a provvedere a tutti ci pensava la carità del vescovato. Ma comunque non era una situazione facile per cui, quando in un giorno di forte tempesta, una grossa nave carica di frumento proveniente da levante e diretta a Palermo, entrò nel porto per ripararsi ed attraccò al molo subito i deputati della sanità, alcuni magistrati e lo stesso vescovo si recarono dal capitano pregandolo di sbarcare una parte di grano perché la popolazione ne aveva bisogno. Ma il capitano non voleva saperne e a nulla valse nemmeno il fatto che il vescovo gli si mettesse dinnanzi in ginocchio scongiurandolo con pianti e preghiere. Ad un certo punto, visto tutto inutile i soldati della guarnigione si disposero sulla banchina con i fucili puntati mentre altre imbarcazioni impedivano alla nave di prendere il largo. Vedendosi imprigionato il capitano “ fu costretto a dare forzosamente il frumento che con preghiere non aveva voluto cedere[28]”.
[1] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale di Lipari, manoscritto cit., Quaderno IIIA, pp. 138 a,b,c. da un foglio a stampa il cui originale è conservato presso la Biblioteca Ursino di Catania ed intitolato” Distinta relazione dell’attentato de’ Vascelli Inglesi contro la Città di Lipari, e del Fedele, Magnanimo, e Vittorioso Operato di quei Cittadini nella lor difesa”, Palermo 1718.
[2] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale.., manoscritto cit., Quaderno IV, pag. 171.
[3] Queste notizie sulla nuova topografia di Lipari sono tratte dal saggio di G.Iacolino, Il settecento liparitano, in L. Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari, 1993, pp 407-453.
[4] “Qui c’è un ospedale di cui non ci pesa tenere l’amministrazione. Raramente vi si ricoverano degli infermi, sebbene esso non difetti di tutto il necessario per la salute dell’anima e del corpo”, così scriveva nel 1722 il vescovo Platamone alla S.Sede, per cui giudicava inutile un secondo ospedale e avrebbe preferito devolvere il lascito di Russo alla costruzione di un Seminario.(ASV, Cass. 456 B f.36v e 33v). Ma malgrado il Platamone chiedesse l’autorizzazione per effettuare questo storno dopo qualche anno l’ospedale di S.Bartolomeo si realizzò. Comunque si cercarono di differenziare i due nosocomi indirizzando quello di Marina S.Nicolò per malati forestieri, di sesso maschile che soffrissero di febbre persistente e quindi con possibili malattie endemiche. In seguito fu destinato ad ospizio per soldati veterani poveri e soli. Infine tornerà ad essere adibito a nosocomio generico per uomini e donne e tale resterà per tutto l’ottocento circa. (G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno III A pag. 146 e). Nel 1755 il vescovo De Francisco dava però un ritratto della situazione sanitaria preoccupante: il vecchio ospedaletto dell’Annunciata era cadente e inagibile e l’ospedale San Bartolomeo non accettava altri degenti se non fossero “malati di febbre”.( G. Iacolino,manoscritto cit. Quaderno IV, pag. 106 a2.
[5] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale di Lipari, manoscritto, Quaderno IV, pp. 162- 162 a.
[6] Relazione ad Limina del 15 marzo 1723, ASV, Cass. 456 B, ff.31v-32.
[7] ASV. Cass. 456 B, f. 31v.
[8] Secondo lo spirito del settecento il vescovo amava la convivialità sposata con conversazioni erudite come appare da questa pagina di G.La Rosa:”Voleva il Prelato che ogni giorno i Gentil’Uomini, li Sacerdoti cospicui nel decoro e Canonici del suo Capitolo avessero frequentato la loro conversazione nel suo palazzo Vescovale e nel suo appaltamento ove s’intratteneva a circolo con tuti piacevolmente, senza perdere la sua naturale sostenutezza, discorrendo di cose erudite; e si significavano le notizie che percorrevano dell’affari del gran Mondo e delle guerre d’Europa. Volendo uscirer a fare qualche caminata per esèlo e divertimento, era associato col séquito di tutta la Conversazione…; intratteneva al pranzo della sua tavola, quasi ogni giorno, quattro sogetti, cioè due Ecclesiastici e due Gentil’Uomini, che invitava a circolo, di quei che frequentavano la sua Conversazione, e nelle giornate solenni dava pasti molto esquisiti con invito di moti Canonici e Gentil’Uomini principali della Città”(op.cit. vol. I, pp.269-270). Questi modi cordiali e conviviali non evitavano che qualche volta il vescovo assumesse delle posizioni estreme nei confronti di chi lo contrariava o non gli pareva sufficientemente raffinato. Un esempio del primo tipo l’abbiamo già verificato quando si scontrò con il canonico Diego Hurtado e stava facendo riesplodere una nuova controversia liparitana. Un esempio del secondo tipo ce lo fornisce Giuseppe Iacolino ( La chiesa cattedrale di Lipari, manoscritto, cit. Quaderno IIIA, pag. 152) e riguarda un suo servente di Bronte, Ignazio Capizzi, che nel 1726 venne a Lipari a lavorare nella casa del vescovo e contemporaneamente voleva studiare per diventare prete. Era un giovane che si applicava negli studi e qui a Lipari imparò latino, filosofia, teologia ma, malgrado questo non riusciva a superare –come riconoscerà lui stesso - una “natural ruvidezza, rusticità e tratto villano” che non si conciliavano con la raffinatezza del Platamone che lo apostrofava dandogli del villano e chiamandolo “testa d’asino”. Per questo nel 1731 lo licenziò. Il poveretto accettò di fare lo sguattero presso l’ospedale di Palermo ma continuò a studiare e divenne medico nel 1734 e prete nel 1737. Si distinse per la sua cultura e la sua carità e Pio IX lo definì nel 1858 il S.Filippo Neri della Sicilia avviando il processo per la canonizzazione. Mons. Platamone morirà il 12 febbraio 1733 all’età di 66 anni.
[9] Ma non sarà una scelta stabile perché il suo successore, mon. Beamonte, quando nel settembre del 1736 prese possesso – a tre anni dalla nomina – della diocesi – tornò ad abitare al Castello anche se il palazzo era malandato.
[10] Descrivendo la Chiesa il vescovo arriva a parlare della cappella che contiene il quadro della Beata Vergine Maria. “Circa questa Cappella si tramanda che accadde un fatto straordinario. Si racconta che un abitante, di nome Alfonso Mercorella, mentre tagliava alberi per dare spazio alla coltivazione, nel fitto del bosco udì con suo gran stupore il suono di una campana. Direttosi, benché intimorito, verso quel richiamo, in un tempietto diruto e coperto di rovi e sterpaglie vide, con la guida della campana che Ella teneva in mano, l’immagine della Beata Maria sempre Vergine. Questo fatto infiammò soprattutto gli abitanti alla devozione della Beata Maria Vergine, e in quel luogo poi fu eretta per venerazione la Chiesa di cui qui si parla.”( Visita Pastorale di mons. P.V. Platamone del 1722, in Archivio Vescovile di Lipari ff. 22-22v)
[11] L’elenco di tutti gli ecclesiastici si trova nell’Archivio Vescovile di Lipari nella cartella “Visita Pastorale di mons. V.P. Platamone del 1722, primi f.f. non numerati).
[12] ASV, Cass. 456 B, f. 94. In questa epoca tutte le isole dovevano avere una loro chiesa ed un loro cappellano.
[13] Libro delle Corrie, foglio 226.
[14] “In perpetuam saevissimae pestis memoriam / anni 1743/ sodalitas nativitatis B.V. / Mariae/ novum hoc monumentum posuit”in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IV, pag. 169 ( nota a margine in rosso).
[15] G.La Rosa, op.cit., vol I, pp. 276-277
[16] Purtroppo di queste controversie ne risentì il fisico del vescovo che si ammalò e gli fu consigliato di andare a Palermo dove probabilmente l’aria natia gli avrebbe giovato. Ma ormai il suo fisico era minato ed il 19 luglio del 1742 spirò.
[17] G. La Rosa, op.cit., vol. I , pp. 274-276.
[18] C.Eubel, Hierachia Catholica etc, vol.VI, Padova 1958, p.263, in nota:
[19] Mons. Francesco Maria Miceli, messinese, fu nominato vescovo di Lipari l’11 marzo 1743 a 65 anni di età. Ma siccome a Messina c’era la peste e la città era isolata, poté prendere possesso della diocesi solo negli ultimi mesi del 1744. e morì il 2 gennaio del 1753.
[20] ASV, Cass. 456 B, f. 82v.
[21] G.A.M.Arena, L’economia delle isole Eolie dal 1544 al 1951, op.cit. pag. 29 nota 77. v. anche Genuardi, Siciliano, Scaduto e Garufi, “Il dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’isola di Lipari” Acireale 1912.
[22] Il procuratore del vescovo nel processo sostenne che il giurato Bonanno, definito “torbido ed insolente” aveva concesso a tale Francesco Berrio un “pezzo di terra” nell’isola di Vulcano e costui aveva fatto “scampare detto pezzo di terra di detta isola”, seminandovi orzo.
[23] G. La Rosa, op. cit. vol. I pp 282-283. Comunque la sentenza del tribunale che giunse un anno dopo (Archivio di Stato di Palermo, Corte del Tribunale del Real Patriomio, anno 1749 v. G.A.M. Arena, op. cit. pp29-30) fu meno drastica: essa riconobbe l’isola di Vulcano e le altre isole dell’arcipelago di pertinenza della Mensa vescovile unicamente sulla base dei documenti esibitigli dal vescovo, peraltro non contestati dai giurati; lasciò all’Università la possibilità di opporsi alla contribuzione di censi e decime, cioè la possibilità di dimostrare che le isole non erano di proprietà della Mensa vescovile. Concretamente a Vulcano non si poteva fabbricare zolfo ( e quindi il Bonanno doveva continuare a sovrintendere che questo non avvenisse) mentre doveva continuare ad essere permesso ai singoli di raccogliere legna e quindi praticamente il terreno non poteva essere dissodato e coltivato.
[24] Gradatamente si fecero eseguire le tele dipinte e le statue e, infine, intorno al 1790-92, giunsero i marmi della balaustra, dell'altare maggiore e del pavimento. Nell'aula centrale, vicino al coro, i membri della confraternita si fecero scavare l'ipogeo per le loro sepolture. L'organo, della fabbrica Mancini, fu collocato in cantoria nel 1792.
Comunque nel 1755 il fatto che non si sia riusciti a realizzare anche le rifiniture sembra dovuta a due problemi convergenti. La prima : “la mala cautela avuto nel concerto dell’opera marmorea tra i Rettori della Congregazione dell’Immacolata con Mastro Santo d’Antoni e Mastro Pietro Muscarella”; la seconda: “sebbene li suddetti già decaduti Rettori con efimeri pretesti non intendessero rilasciare sudetta amministrazione, forse per essere scoverti di quelle positive mancanze”(Archivio Vescovile, Visite delle Chiese fatte da mons. Bon. Attanasio, 1851- 1859, ff. 439-440).Sul fatto che nel 1754 la chiesa venne aperta al culto esistono dei dubbi giacchè nel 1755 il vescovo Gerolamo Giovanni De Francisco - palermitano, dell’ordine dei Dominicani, eletto vescovo il 9 aprile del 1753 – in uno scritto alla S.Sede dice che, dentro le mura della città, oltre a quattro grandi chiese (la Cattedrale, la Concezioncella, delle Grazie e della Purificazione o S. Maria delli Bianchi), si “ha inoltre un’altra Chiesa , incominciata, sotto il medesimo titolo della Concezione, che per la sua imponenza e per la scarsezza dei suoi proventi sino ad ora non è stata portata a compimento.” in ASV, Cass. 456 B, f. 92 v..
[25] Dalla comparsa del Giurato Giacomo Bonanno in G.A.M. Arena, op. cit., pag.30 in nota.
[26] G: Tranchina, L’isola di Ustica, Palermo 1982, pag. 26.
[27] Più tardi sembra che altri eoliani siano partiti per Ustica e Arena dice che in totale si trattò di seicento persone. Iacolino da una cifra superiore.
[28] G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno IV pag. 186 a 5. Questi come altri episodi Iacolino li ha ricavati da un manoscritto, anonimo, di proprietà della famiglia del dott. Luigi Mancuso . Il manoscritto per la prima parte ripropone l’opera del Campis ed invece nella seconda parte contiene una documentazione originale.

Mons. Platamone
I vescovi alle prese con i problemi sociali
Riesplodono i conflitti sopìti

Vulcano con i suoi fenomeni geologici: le fumarole e il mare che bolle.
Potrebbe sembrare che quelli di mons. Castillo e mons. Ventimiglia siano due episcopati tranquilli, privi di conflitti, sia per mancanza di contenzioso, sia per capacità e prudenza dei presuli. Eppure nel periodo di mons. Castillo per quanto breve e fortemente caratterizzato dal terremoto, qualche problema di giurisdizione con i giurati si era pure presentato per la proibizione di “vendere le cose commestibili innanti alla chiesa cathedrali in tempo che si celebra la messa cantata” e soprattutto circa la competenza di dare permessi per raccogliere legna – jus lignandi – e pascolare – jus pascendi – nell’isola di Vulcano che il vescovo riteneva fosse sua giacché del vescovo era la potestà sull’isola mentre i giurati la rivendicavano asserendo che l’isola era nel dominio del re. Problemi che si erano sorti quando il 26 febbraio ed il 9 marzo del 1693 il vescovo aveva emesso gli editti. Così i giurati erano ricorsi al vicerè che li aveva affidati al Real Patrimonio. La sentenza di questo Tribunale del 3 novembre 1693 lodava il vescovo per avere difeso il “decoro divino” mentre per lo jus lignandi e jus pascendi affermava che non potevano regolarlo né il vescovo né i giurati ma che dovesse – a determinate condizioni – rimanere libero[1].
Al verdetto di Tribunale di Palermo mons. Castillo non replica non sappiamo se perché gliene fosse mancato il tempo o perché avesse ritenuto che non valeva la pena aprire un conflitto per una cosa di scarsa rilevanza.
Quanto a mons. Ventimiglia abbiamo visto come è lui steso a toglier l’occasione quando sorge un conflitto sull’industrializzazione di Vulcano.
Ma una vicenda insidiosa è quella provocata dall’arcivescovo di Messina mons. Giuseppe Migliaccio che ha l’obiettivo di mettere in cattiva luce mons. Ventimiglia alla corte di Spagna. Il Migliaccio scrive una lettera al re dove accusa il Ventimiglia di volersi abusivamente affrancare dalla suffraganeità a Messina e di essere un perturbatore della Regia Giurisdizione perché costringeva gli appellanti di Lipari a rivolgersi alla curia romana come se la diocesi di Lipari fosse esente dalla Giurisdizione di Messina e soggetta immediatamente alla S. Sede.
Questa lettera doveva essere del settembre del 1699 ma mons. Ventimiglia ne viene a conoscenza solo dopo la Pasqua del 1700 quando finalmente riesce ad andar a Palermo ad incontrare il viceré che gli aveva chiesto un colloquio già dall’autunno precedente. Non è difficile per il Ventimiglia discolparsi: l’arcivescovo di Messina non aveva mai convocato nessun sinodo al quale sarebbe dovuto intervenire il vescovo di Lipari e nessun liparese aveva mai fatto appello alla curia di Messina perché a Lipari tutti conoscevano la bolla di Urbano VIII che esentava la loro diocesi in perpetuo da ogni Giudice Metropolitano. E qui il vescovo ricordò la vicenda di mons. Arata, suo predecessore.

Questa vicenda si concludeva qui perché il vicerè rispondeva al re che “l’Arcivescovo senza ragione alcuna andava seminando zizzania tra il Papa e il Re, giacché spetta al Romano Pontefice dare leggi ai Metropolitani e ai Suffraganei, e far sottostare questi ultimi ed esimerli da qualsivoglia giurisdizione, come è avvenuto per la Chiesa di Lipari nei confronti di quella Messinese, mentre i diritti del Re, che sono di altra natura, restano salvi”.
Ventimiglia assicurava la S. Sede che la grave offesa arrecatagli l’avrebbe ignorata in nome della carità cristiana ma sarebbe stato bene che, per evitare in futuro questioni di questo genere magari con un diverso vicerè meno comprensivo, si intervenisse per chiarire la vicenda. Inoltre ogni anno alla vigilia dell’Assunta l’arcivescovo chiama all’appello il vescovo di Lipari e mancando questo, gli applica una multa. Si potrebbe chiedergli – suggerisce mons. Ventimiglia – sulla base di qual diritto egli si comporta in questo modo e, sulla base della sua risposta “si potrebbero adottare una volta per tutti gli opportuni rimedi[2]”.
Ben più grave è invece quanto accade nel 1709. Nel 1700 era morto il re di Spagna Carlo II d’Asburgo che non aveva eredi. Il trono se lo contesero il re di Francia Luigi XIV in favore del nipote Filippo e l’imperatore d’Austria Leopoldo I in nome del figlio Carlo. Il trono andò a Filippo che fu chiamato Filippo V ma scoppiò una guerra fra la Spagna da una parte e l’impero asburgico, l’Inghilterra, l’Olanda e il Piemonte di Vittorio Amedeo II dall’altra. Nel 1709 gli austro-inglesi avevano occupato il milanese, la Sardegna , il napoletano e la Calabria e puntavano alla Sicilia.
 Filippo V e la sua famiglia
Filippo V e la sua famiglia
Il rigore verso gli amici dell'Austria
La Sicilia gravata da una pressione fiscale atroce e stremata dalla fame, fu invasa da soldataglie franco-spagnole con lo scopo di presidiare le piazzeforti temendo attacchi nemici. Anche Lipari ebbe le sue guarnigioni franco-spagnole che occuparono case e chiese al Castello, deturparono la Cattedrale e si comportavano con arroganza.
Il governo di Palermo era diventato estremamente diffidente e puniva con grande rigore tutti quelli su cui cadeva il sospetto che parteggiassero per l’Austria[3]. E siccome si sapevano i rapporti che il Ventimiglia manteneva con Vienna e probabilmente anche il fatto che nutriva simpatia per una amministrazione che promuoveva le riforme e lo sviluppo economico dei territori che gli erano soggetti, qualche nobile o borghese che, nella sua miopia, non aveva dimenticato la vicenda di Vulcano pensò che era venuto il momento di prendersi una rivincita. Partì quindi l’accusa che il vescovo trattava col generale delle forze austriache in Calabria. Così la sera del 10 settembre arrivò a Lipari una feluca con un capitano e venti soldati che alle tre della notte ( le 21 attuali) circondarono il Palazzo vescovile. Il capitano fece irruzione nel gabinetto del vescovo, gli intimò l’abbandono entro 24 ore dell’isola e del regno di Sicilia e sequestrò tutte le carte.
Mons. Ventimiglia non si scompose ma chiese solo il tempo per riuscire a procurarsi un po’ di quattrini per il viaggio visto che le sue casse erano a secco. Riuscì ad ottenere “sforzatamente” un prestito di onze cinquanta dal suo vicario e l’indomani mattina partì accompagnato solo da un sacerdote. Salendo a bordo del bastimento, si rivolse a chi era sulla banchina e lo guardava con compassione, sorridendo disse : “Amato mio gregge, addio. Questa ti sia l’ultima mia benedizione. Non ci vedremo più”. E così dicendo, benedisse tutti[4]. Morì a Roma il 17 dicembre del 1709, aveva sessantacinque anni.
La ricerca di un vescovo da battaglia

A Roma, nelle Congregazioni Pontificie ed in particolare in quelle dei Vescovi e dell'Immunità ecclesiastica, la politica del Ventimiglia era stata giudicata troppo tollerante ed arrendevole nei confronti delle gerarchie civili locali e nazionali, ben diversa da quella dei Vescovi di Catania e di Girgenti che non tolleravano alcuna interferenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano pronti a sfoderare scomuniche o minacce di scomuniche.
Per questo, alla sua morte, si pensò di trovare un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che - da una posizione tutta speciale quale era appunto la Diocesi di Lipari immediatamente soggetta alla Sede Apostolica – potesse opporsi alla Corte di Palermo rivendicando l'autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese, che si trovava proprio a Roma, priore del Monastero Cassinese di San Paolo fuori le mura, Cavaliere Gerosolimitano. Nicolò Maria Tedeschi era un nobile che era fuggito di casa per farsi benedettino, si laureò in teologia e insegnò a Catania fino a quando nel 1693 il suo monastero non fu distrutto da un terremoto. Promosso abate, fu destinato prima al Monastero di San Martino delle Scale a Palermo e poi a Roma dove oltre a fare l'abate ebbe ruoli di consultore del S. Uffizio e di teologo per la Congregazione dei riti, l'esame dei Vescovi, dell'Indice e delle Indulgenze.
Nominato vescovo il 10 marzo del 1710 con bolla di Clemente XI – e pare con la raccomandazione dello stesso Papa di non permettere alcun abuso da parte della Monarchia [6] - appena giunto a Lipari, come vedremo più avanti. cominciò subito a tener fede al mandato ricevuto.
La controversia liparitana
Sotto il nome di "controversia liparitana" va una vicenda apparentemente banale (la vendita di 800 grammi di ceci) che coinvolge tutta la Sicilia e la Santa Sede e mobilita tutte le più grandi potenze europee oltre a creare problemi a tanta genete, compreso esili e carceri. Una vicenda che dura circa dieci anni e che comunque si trascinerà, in qualche modo ancora nel secolo successivo. Ad essa quindi dedichiamo una parte specifica dell'Archivio.
[1] G. La Rosa, op. cit. vol. I, pp. 246-248.
[2] ASV, Cass. 456 ff2v-4.
[3] G.E. Di Blasi, Storia cronologica de’ vicerè di Sicilia, tomo IV, Palermo 1975, p.59..
[4] G. La Rosa, op. cit. vol I, pag. 260.
[5] in “La Chiesa Cattedrale di Lipari”, manoscritto inedito, Quaderno III A
[6] Nell’opuscolo “Difesa della verità a favore di Mons. Nicolò M. Tedeschi, vescovo di Lipari”, anonimo,( 1713?) a lui stesso attribuito è detto che il papa “ si degnò comandarli…che operasse viriliter, Né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monarchia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima”( pag. 71).
Nicolò Maria Tedeschi
Il XVIII secolo: fra progetti di sviluppo e carità cristiana
L’economia eoliana nel 700

Allo sguardo ampio dello studioso[1] l’economia eoliana nel XVIII secolo può apparire in lenta ma progressiva ripresa a cominciare da alcuni segni esteriori come la città che continuava decisamente ad allargarsi nelle zone circostanti del Castello; il disboscamento e la messa a coltura di ampie zone di Flicudi, Salina ed Alicudi; un naviglio che percorreva tutte le rotte del basso Tirreno malgrado il pericolo dei pirati; l’amalgama della popolazione gli “oriundi” ed gli immigrati del dopo “ruina”; un buon numero di artigiani; una borghesia sempre più padrona dei processi economici dell’arcipelago.
E sull’onda della crescita dell’economia cresceva anche la popolazione, anche se non con il ritmo[2] del secolo precedente. Nel 1789, data del primo censimento ufficiale, risultò essere di 12.482 abitanti[3]. Ormai le borgate sono diventate una realtà per l’isola di Lipari ed a metà del secolo abbiamo Canneto, Acquacalda, Quatttropani, Lami e Pianoconte. Mentre nelle isole Stromboli aveva raggiunto i 700-800 abitanti, circa 600 Filicudi, 1500 Salina mentre pochissimi erano i residenti ad Alicudi e Panarea quasi tutti contadini e pescatori. La borghesia continuava a risiedere a Lipari. Un discorso a parte deve farsi per Vulcano che continuava a rimanere disabitata. La gente andava a lavorare di giorno, nei campi, ma preferiva tornare a Lipari all’imbrunire suggestionata dalle storie che volevano il cratere grande come la bocca dell’inferno da cui la notte uscivano gli spiriti maligni ed imperversavano sull’isola.
Nei campi eoliani crescevano fichi d’India, fichi, gelsi, capperi soprattutto ma anche ulivi, castagni, agrumi, susini; si coltivavano le viti, i legumi, gli ortaggi dai pomodori, ai cavoli, ai carciofi, ai peperoni; si allevava il bestiame. Dei prodotti della terra si esportavano uva passa, capperi, fichi secchi e vino a cominciare dalla malvasia sulle rotte di Napoli e Venezia. E’ in questo secolo che diventa una voce importante della esportazione la pomice – da 500 a 700 tonnellate l’anno - tanto che quando arriverà a Lipari Jean Houel nel 1771 andrà ad abitare dal console di Francia, don Giovanni Rodriquez, che si interessava soprattutto della pomice che si estraeva a Canneto ed Acquacalda[4].
Si importava invece il grano, utensili vari, panni e stoffe e il sale in grande quantità che serviva per la conservazione dei pesci e dei capperi.
Una carpenteria per costruzione dei vascelli si trovava a Marina S.Giovanni ed alimentava la marineria di Lipari che contava 150 e più feluche che sostenevano il traffico con la Calabria ed il regno di Napoli[5].
 Marina S. Giovanni
Marina S. Giovanni
Dal punto di vista sociale, all'inizio del 700 – sostiene Arena – accanto ad una massa di gente per un verso o per l'altro ben sistemata, risiedeva nelle Eolie un'altra massa di persone che aveva una vita alquanto tribolata, per poche possibilità di lavoro e insufficienti mezzi di sussistenza. Si può ipotizzare che gli indigenti raggiungessero le mille unità[6].
Ma quanti sono i poveri?
Una lettura diversa invece proprio della realtà sociale di Lipari ci è fornita dal vescovo Girolamo Ventimiglia in una lettera al papa in occasione della visita “ad Limina” del 1696: “Il numero degli abitanti nella città e nel Suburbio ammonta a circa diecimila, ma quanto grande sia la povertà di cui essi soffrono non si hanno sufficienti parole per dirlo; basti pensare che soltanto due volte la settimana – e talora una sola volta – si macella un bue o una vacca per una così numerosa popolazione che, per l'estrema povertà in cui versa si nutre di frutta, di legumi e di pesce, e non raramente senzapane”.Le abitazioni, continua il vescovo, sono anguste, speso attendamenti e tuguri coperti di canne e di paglia che sono alla base di tutta una serie di violenze domestiche e di problemi morali. “Una gran massa di fanciulli e fanciulle ogni giorno assediano il Vescovo chiedendo pane, ma non c'è chi lo spezzi loro, benchè giornalmente ai più si dia uno scudo... Io tremo e mi rattristo vedendo più di seimila perone affamate e nude”.
Quindi non mille su una popolazione di 10 mila sarebbero gli indigenti ma la grande maggioranza. Certo questa è la percezione di chi giunge nelle Eolie e trova una realtà più critica di quella che si era immaginata. Di più, siccome la lettera ha lo scopo di sollecitare il papa ad una maggiore considerazione della realtà delle isole cominciando, per esempio, a sgravare la Mensa vescovile dell’obbligo di versare annualmente una pensione di 500 scudi per un cardinale, potrebbe darsi che in mons. Ventimiglia la verve del predicatore abbia avuto la meglio sulla serenità dello studioso, ma comunque il malessere sociale doveva essere più profondo di quanto le considerazioni economiche lascerebbero ipotizzare.

Vecchia Salina e Stromboli
Guardando alle isole minori alle considerazioni sociali si aggiungono quelle morali e pastorali ed il ritratto d el presule diventa più cupo. “Ci sono abitanti in ognuna di queste isole ma, all’infuori di Salina, tutte le altre non hanno né Chiesa né Sacerdote né Messa né Sacramenti, cosiché queste isole e queste genti odono da lontano la Buona Novella di Cristo e il Suo insegnamento e, cosa che è assai dolorosa a dirsi, in mezzo a questi gruppi permangono ancora tracce di incivile superstizione mentre non vi si scorge segno alcuno della Religione Cristiana, tranne che a Filicudi dove c’è una Cappella non ancora portata a compimento”. Il vescovo riconosce che sarebbe suo obbligo andare nelle isole, predicare, portare con sè dei collaboratori. Ma a che servirebbe se non ci sono i mezzi per edificare una chiesa e per mantenervi un sacerdote? La mensa vescovile vive dei frutti delle isole e del mare che le circonda. In passato queste entrate arrivavano fino a sei- settemila scudi ora però la situazione è peggiorata. Si sono esauriti i banchi di corallo ed il mare è divenuto più avaro per cui i pescatori sono costretti a spingersi nell’Adriatico o sino in Sardegna; mentre per quanto riguarda la terra le viti sono invecchiate e non danno più vino come un tempo e dai 30 mila del passato si è arrivati a 10 mila dello scorso anno. Anche le altre entrate sono state colpite. Le esportazioni dalla guerra[7] e dal timore dei pirati; i censi per via della riduzione delle aliquote praticate dal regno di Sicilia che dal 8-10 per cento le ha portate al 5. Ma se una volta la Mensa rendeva 6-7 mila scudi, quanto pensa mons. Ventimiglia che possa rendere ora? Il suo predecessore aveva appaltato il servizio di raccolta a 5 mila scudi ma fu costretto a scendere a 4.100 scudi, mentre ora non è riuscito a trovare appaltatori nemmeno per 3.500 scudi. Con ogni probabilità si otterranno solo 3 mila scudi che corrispondono, osserva, a 2.600 in moneta romana.
Rimane il fatto che questa somma la si introita per lo più in natura ed in natura vengono pagate le pensioni dei canonici, il maestro dei chierici, il cappellano di Salina, il parroco della Cattedrale e l’uomo di vedetta su Monte Guardia, cioè tutti i carichi della mensa. E poi ci sono altre spese – olio, cera, predicatori, musica, ecc.- per il servizio della cattedrale ai quali deve praticamente provvedere il vescovo[8].
Inoltre, come il suo predecessore mons. Arena, anche il Ventimiglia era un vescovo prodigo con i poveri ed i bisognosi in genere[9].
Le iniziative di valorizzazione e sviluppo
Ma dove trovare i denari, visto che oltre alla costruzione di cappelle nelle isole si riprometteva di realizzarne anche a Lipari a cominciare dalla Cattedrale che quando la vide le parve più “una spelonca di ladri che una casa della preghiera”[10]?
Visto che noi nostri mari , per la sconfitta che avevano subito i turchi a Zenta nel 1697, si era alquanto attenuato il pericolo corsaro mons. Ventimiglia sollecitò i liparesi a colonizzare le isole minori anche Stromboli e Alicudi che erano le più lontane. A Stromboli i primi coloni giunsero nel 1702 e si stabilirono a Ginostra che era una località meno esposta ad eventuali incursioni. Anche ad Alicudi inizialmente l’abitato sorse sul pendìo della montagna.
I risultati si fanno subito vedere e nella relazione del 15 marzo 1705 il vescovo dà notizia che il gettito della mensa è cresciuto di 300 scudi all’anno e già pensa di investirli nella realizzazione del seminario e nella costruzione di una chiesa a Stromboli dove “la fertilità del suolo, che ben si adatta alle culture, a poco a poco va allettando gli abitatori, e la posizione dell’isola, che è come una stazione obbligata di transito, richiama un gran numero di marinai e di viaggiatori”[11]. Inoltre la Santa Sede gli è venuta incontro è dopo l’abolizione di una pensione già concessa all’inizio del suo mandato, ora nel 1700 ha ridotto a solo 300 scudi la seconda pensione e duecento “sono stati assegnati a beneficio delle Isole”[12].


In alto contadini di Stromboli . Sopra, antico disegno di Vulcano
Dopo la colonizzazione di Alicudi e Stromboli il vescovo pensa a valorizzare anche Vulcano. Le risorse dello zolfo, dell’allume e del boro, se estratti con sistemi razionali ed efficienti, avrebbero potuto creare occupazione e altre risorse per la Mensa.
Così nel 1696 il Ventimiglia aprì le concessioni – gli “arbitrati” si chiamavano - per lo sfruttamento dello zolfo e dell’allume e immediatamente molte persone di Lipari scelsero di andare ad operare. Ma la cosa non piacque ai nobili ed alla borghesia locale che paventavano che questa nuova occasione di lavoro facesse lievitare i salari dei lavoratori che coltivavano le loro terre a Lipari e Salina ma anche nella stessa Vulcano. La motivazione che addussero per contrastare l’iniziativa fu che i fumi emanati dalle officine per la raffinazione di prodotti danneggiavano le coltivazioni non solo dell’isola ma giungevano fino a Lipari e Salina e producevano danni soprattutto alle viti.
Si creò quindi un influente partito contrario all’iniziativa che polemizzò col vescovo e spinse i giurati ed il giudice civile di Lipari a emettere un bando che vietava di “arbitrare” nell’isola di Vulcano. Il vescovo vide in questo provvedimento una ingerenza nel patrimonio ecclesiastico e scomunicò giurati e giudice. Questi ricorsero sia al Tribunale della Regia Monarchia per essere liberati dalla scomunica ed al viceré perché sospendesse l’impresa avviata dal vescovo giudicata dannosa per l’ambiente e l’agricoltura.
Se si poteva pensare che il Tribunale avrebbe assolto i giurati riaprendo così la questione annosa dell’autonomia del vescovo e della sua dipendenza solo da Roma, più complesso era il discorso dell’inquinamento giacché l’apposita commissione di esperti che era stata istituita a Palermo per valutare il problema, a gran maggioranza negava che l’industrializzazione di Vulcano potesse produrre i danni paventati.
Ma mentre si attendevano i responsi per i due ricorsi fu lo steso mons. Ventimiglia che chiuse la partita. Assolse giurati e giudice e ritirò le concessioni date a Vulcano. La ragione? Con ogni probabilità il Ventimiglia valutò che il rischio di riaprire la controversia sulla competenza del foro di appello non valeva la partita. Lo sfruttamento industriale di Vulcano era una grande idea ma per il momento andava rimandata.
Comunque la vicenda aveva lasciato da una parte e dall’altra diffidenze e prevenzioni e certamente nella borghesia liparese, miope nelle sue vedute e dalla mentalità angusta, vi era chi pensava che questo vescovo fosse pericoloso e bisognava aspettare l’occasione buona per liberarsene.
Chi era mons. Ventimiglia
Ma chi era mons. Ventimiglia? Chi era questo vescovo che univa carità cristiana e progetti ambiziosi di sviluppo? Famoso a Roma e nelle grandi capitali del mondo, come erudito, diplomatico e grande predicatore, aveva insegnato a Parigi e tenuto conferenze a Madrid, Vienna[13] ed in numerose città d’Italia, quando venne nominato vescovo di Lipari, don Gerolamo dei Principi di Ventimiglia, era un perfetto sconosciuto proprio nell’arcipelago.
A mons. Ventimiglia si era pensato come vescovo di Lipari anche prima della nomina di mons. Castillo ma sempre aveva rifiutato. Quando accettò, volle fare il vescovo con scrupolo e si documentò coscienziosamente sulla diocesi che andava a governare. Presentò a Innocenzo II una sorta di promemoria programma dove si mettevano in risalto: la grave situazione sociale (fame e miseria) delle isole; la grave situazione ecclesiastica ( il capitolo non aveva plebenda fissa, mancava il seminario, la Cattedrale abbisogna di urgenti restauri); occorreva una piccola banca di prestito (Monte di Pietà) a favore dei contadini per sostenerli nell’acquisto delle sementi e degli strumenti di lavoro[14].
Il papa si mostrò disponibile ed immediatamente abolì - visto che il cardinale che ne beneficiava era morto – l’obbligo di versare a Roma ogni anno una delle due pensioni che erano a carico della mensa vescovile di Lipari. Cinquecento scudi che furono destinati, per esplicita volontà del papa, alle necessità più urgenti delle isole[15]. Oltre a questi, con preciso riferimento ai punti che il nuovo vescovo aveva evidenziato, il papa garantiva un assegno annuo di 294 ducati d’oro e due giulii.
Era passato un anno intero dalla sua nomina ma, con questi risultati, il Ventimiglia arrivò a Lipari il 17 luglio del 1695.



La volta della Cattedrale con i dipinti voluti da mon s. Ventimiglia
L’impegno più importante a favore delle chiese il vescovo lo riversò nella Cattedrale creando un ampio sagrato[16], rinnovando la facciata che con tre porte dava l’impressione delle tre navate, rifatto il pavimento in marmo rosso e così il coro e l’altare maggiore, realizzata una cantorìa pensile al di sopra della porta centrale e vi installò un nuovo organo. Ma sicuramente il contributo più suggestivo all’abbellimento di questa chiesa fu l’affresco della volta cinquecentesca con sedici scene bibliche realizzato fra il 1705 ed il 1708.
Questo impegno per la Cattedrale creò una spinta di emulazione che portò le confraternite ad impegnarsi nel rifacimento di altre chiese come la Chiese della Madonne delle Grazie, un gioiello di architettura barocca realizzato in soli otto anni dal 1700 al 1708[17]e la chiesa di S.Pietro nel Suburbio[18].


La Chiesa della Madonna delle Grazie. A sinistra la facciata. A destra, l'artistico coro ormai pericolante da tre anni nell'incuria generale.
Ma il suo pensiero costante – lo scrive il 20 ottobre del 1696 - è la mancanza di un Seminario per garantire una adeguata formazione del clero giacché “quasi tutti gli ecclesiastici sono cresciuti e crescono senza una soda preparazione culturale e spirituale, mentre l’indole del popolo è portata alle pratiche devote ed è aperta all’apprendimento così come lo è per la vita libertina e poco operosa”.
Le uniche due chiese che in Lipari funzionano dal punto di vista pastorale sono la Cattedrale e San Giuseppe dove “ogni domenica si spiega ai fanciulli la Dottrina Cristiana”.
Pessimo è invece il giudizio sulle altre chiese della città e fuori le mura specialmente quelle cappelle che stanno a due e tre miglia fuori, sopra le montagne o in fondo alle valli. Sono in tutto quattordici e benché “risultino erette dalla grande devozione popolare, tuttavia sono sedi di una religiosità rozza e irriguardosa” dove i canonici nelle feste dei Santi titolari arrivano correndo a dorso d’asino o in barca “ per buscarsi i legati di due scudi (talvolta anche meno)”, cantano i vespri e le messe e poi , con la stessa precipitazione ritornano di corsa in Cattedrale “per non perdere le distribuzioni corali”. Talvolta in queste chiese si cantano in fretta e furia tre o quattro messe. “Questa vergogna che non si addice affatto alla dignità capitolare, non è possibile eliminarla a causa della estrema povertà che grava sul Clero”.
Fuori della città si distinguono per vivacità e bellezza le chiese dei francescani osservanti e dei cappuccini. Ma mentre i cappuccini, pur essendo pochi, si distinguono per esemplarità di vita e cultura, i francescani non brillano per serietà di costumi e dottrina. Di più, pur essendo calabresi, per eludere l’interdetto emesso nei loro confronti dalla Curia Vescovile si sono rivolti al Tribunale della Monarchia creando problemi di competenza per cui subito il vescovo ha dovuto informare a Roma la Congregazione dell’Immunità[19].
Per rimediare alle carenze del clero il Ventimiglia teneva dei corsi di aggiornamento per gli ecclesiastici, la sera nel coro della Cattedrale. Poi, verso il 1704 decise di rilanciare e riqualificare la “Scuola di grammatica” che era stata istituita da Mons. Arata, introducendo nuove discipline ed affidando l’insegnamento a frati fatti venire da fuori. Cambiò il nome alla scuola e la chiamò “Seminario delle Lettere” o “Ginnasio” lasciandola aperta a tutti i giovani fossero chierici o laici.
Impegnato su più fronti il vescovo non trascurava i suoi contatti col mondo esterno e spesso si recava a Palermo, dove aveva un rapporto di familiarità col viceré, e a Roma dove spesso predicava i quaresimali nella basilica di S. Andrea della Valle.
Ed era proprio a Roma, in visita “ad Limina” quando il 27 settembre del 1700 muore Innocenzo XII. Ed è Mons. Ventimiglia che viene chiamato all’inaugurazione del conclave, il 9 ottobre, a parlare ai cardinali.
[1] G.A.M. Arena, L’economia delle isole eolie dal 1544 al 1961, op.cit., cap.III, pp.25- 36.
[2] Le tappe di questa crescita per il 600 si possono così stimare: 4.566 nel 1630, 6000 nel 1651, 10.000 nel 1693
[3] Nel 1761 gli eoliani, soprattutto originari di Salina e Filicudi, contribuiscono al popolamento di Ustica con duemila(dice Iacolino, invece 600 dice Arena) persone.
[4] J.Houel, Viaggio pittoresco alle isole Eolie, Lipari 2003.
[5] G. A.M. Arena, op.cit., pag. 27; G.Iacolino, note a P.Campis, op.cit., nota 32 p. 454.; Libro delle Corrie, f. 185.
[6] Idem, pag. 32.
[7] E’ la guerra della Lega di Augusta che dal 1688 è durata sino al 1697.
[8] ASV, Cass. 456A, ff. 265v-269 in G.. Iacolino, manoscritto cit., Quadermo III, pp.77a-g.
[9] G.La Rosa, op.cit., vol.I, pp 250-251.
[10] ASV. Cass.456B,f.1. Della Cattedrale mons. Ventimiglia ne parla in due relazioni “ad Limina”. Quella del 1696 dove e quelle del 1700. G. Iacolino, idem.
[11] ASV, Cass. 456B, ff.10,10v.
[12] ASV, Cass, 456 B, ff 2, 2v.
[13] Nella capitale austriaca erano circolati due libretti dedicati a Mons. Ventimiglia scritti da vari poeti e dallo stesso imperatore in cui si elogiava “l’opere ammirande e chiare/ di sua eloquenza, onde l’Italia e ‘l mondo/ stupinne”.
[14] G.M. Cottone, De Scriptoribus Domus S. Joseph, Palermo 1733, pag. 156.
[15] ASV, Cass, 456 A, ff. 266v-267.
[16] Acquistando alcune aree e radendo al suolo alcune abitazioni.
[17] Purtroppo per la realizzazione di questa chiesa dovette sacrificare la chiesetta medioevale che ricadeva nella stessa area.
[18] Un ingrandimento della chiesetta che si era realizzata all’indomani della “ruina”. Questa chiesa di S.Pietro rimarrà fino al 1929 quando verrà abbattuta per fare posto all’attuale struttura.
[19] ASV, Cass. 456 A, ff. 264-265v .
mons. Girolamo Ventimiglia
"San Bartolo ha salvato Lipari"
La protezione dei liparesi fuori Lipari

Secondo il Campis la protezione di S.Bartolomeo ai liparesi dalle conseguenze di quel terribile terremoto, non si limitò a chi era nelle isole ma operò a favore di ogni liparese “che disperso si trovava…nel tempo di tanta ruina e stragge”[1].E ci dà qualche esempio.
Era partito da Malta con la sua feluca per tornare a Lipari, sua patria, il padron Giovanni Lambrosa con i suoi compagni e due cavalieri gerosolimitani. La notte del 9 gennaio, circa l’ore cinque, tutte si trovavano nel porto d’Augusta quando si sentono furiosamente sbattere da insoliti colpi di mare, mentre si sentono dalla città venire gridi, gemiti e rumori di rovine come se tutto stesse diroccando. Immediatamente, padrone ed equipaggio, invocano la protezione di S. Bartolomeo e confidando del suo aiuto mettono mano ai remi e, senza sapere come, in un momento si trovano al largo, fuori da ogni pericolo e senza alcun danno. Proseguirono così il loro viaggio e la domenica 11 gennaio giunsero a Catania. Padron Lambosa con i suoi compagni vollero andare a fare un giro in città pensando di trovare un buon posto dove pranzare. Ma non avendone trovati di loro gradimento decidono di tornare in barca. Ma avevano appena messo piede a bordo che sentono e vedono un disastro apocalittico. Catania in poco tempo si disfa in polvere, il mare freme ed urla e si ritira velocemente dal porto. I liparesi si appellano ancora una volta al loro Santo protettore e mentre vedono otto feluche affondare essi si abbandonano alla corrente. Una corrente tanto impetuosa che sembrava, ad ogni istante , doverli inghiottire. E invece miracolosamente si salvarono e, tornati a Lipari, poterono contare fra le lacrime, quanto era loro accaduto.

Catania e il suo porto nel 1693
Sempre da Malta ritornava a Lipari, con la sua feluca, padron Giovanni Mangano. Giunto sotto il castello di Scicli, in località detta Mazzarelli, la sera stessa di venerdì 9 gennaio, con i suoi marinati, sbarcarono ed andarono in città per cenare. Ma improvvisamente , “toccati interiormente da tacito impulso” , lasciarono la casa in cui avevano deciso di cenare e si diressero al Convento del Carmine per cenare con i religiosi e pernottare. I dieci liparesi, si erano già ritirati nella cella che era stata loro assegnata quando sopraggiunse il terremoto. L’alloggio dove erano prima andati per cenare e dormire la notte viene raso completamente al suolo e tutti quelli che ci erano dentro trovarono la morte. Anche quattro celle del Monastero crollarono, ma quella in cui erano alloggiati i liparesi non subì il minimo danno. Di più, questi si erano appena alzati ed usciti che tutto il convento, compresa la loro cella, andò in rovina. Padron Mangano con i suoi marinai si ritirò sulla sua feluca a Mazzarelli e lavorarono per caricare la barca di mercanzie per partire. Domenica mattina il Mangano si accorse che per finire di portare il carico a bordo gli occorreva l’aiuto di un cavallo e mandò due marinai a cercarlo in città. Erano questi appena usciti dalla città e stavano tornando alla barca seguiti da un uomo col suo cavallo quando sentirono delle forti scosse ed il terreno si aprì dietro di loro inghiottendo l’uomo col cavallo. I due marinai illesi, videro Scicli andare in rovina dinnanzi ai loro occhi. Corsero verso la barca e videro che sulla spiaggia c’era il Mangano con gli altri marinai illesi. Il risucchio del mare e la successiva ondata danneggiarono la barca ma non la distrussero. S. Bartolomeo, raccontarono, a cui si erano affidati, li aveva protetti.
I Liparesi a Messina

Altri due episodi riguardano liparesi che si trovarono a Messina la domenica 11 gennaio. Un padre osservante doveva partire da Messina per andare a predicare. Volle pertanto quella mattina, prima di lasciare la città, andare a salutare alcuni suoi devoti. Si prese per compagno il padre Serafino da Lipari ed entrarono in un palazzo. Ma padre Serafino non volle salire sopra, sebbene pregato disse che avrebbe aspettato nel cortile. Mentre il padre osservante è sopra a chiacchierare con l’amico giunge il terremoto che scuote tutto il palazzo. La parte di fabbrica dove si trovava il predicatore crollò e questi rimase coinvolto nelle rovine e morì. Si salvò invece padre Serafino.
La stessa cosa accadde ad una donna di Lipari che si trovava in una casa di Messina con altre due donne. Quando giunse il terremoto lei invocò la protezione di S. Bartolomeo e rimase illesa mentre le sue ospiti morirono nella rovina della casa.
Conclude il Campis questo escursus , affermando che “né si sa che in tante e sì grande rovine accadute nel Regno di Sicilia per causa di questi fieri tremoti vi sia rimasto morto o in qualche modo offeso alcun liparoto, onde pare che il Glorioso Bartolomeo potesse dire , in quelle sciagure, al Signore Dio: - Di quanti havete posto sotto la mia tutela ‘non perdidi ex eis quemquam’ (Giovanni XVIII,9) ”[2].
La riconoscenza dei liparesi al Santo patrono
I giorni che seguirono il terremoto, mentre arrivavano le notizie dei lutti e delle rovine dalla Sicilia e si moltiplicavano i racconti dei liparesi che tornavano a casa felici di essere scampati al disastro, certo uno degli argomenti più sentiti era come avrebbe potuto la città e l’isola esprimere la propria riconoscenza al Santo Patrono.
E la prima idea che venne in mente a tutti fu quella di dedicargli una nuova festa di precetto: la quarta dopo quella canonica del 24 agosto, il 13 febbraio quando ricorreva l’invenzione delle reliquie del corpo, il 17 giugno introdotta per aver preservato Lipari dalla peste quel giorno del 1541.
I giurati con la partecipazione del governatore convocarono il consiglio che all’unanimità deliberò che “a gloria di S. Bartolomeo si festeggiasse in perpetuo, e con tutta la divotione e pompa possibile, l’undicesimo del mese di Gennaro, giorno anniversario della grazia ricevuta”[3]. Inoltre l’atto pubblico sottoscritto dal notaio prevedeva anche che la vigilia fosse giorno di digiuno e lo stesso doveva avvenire per la vigilia delle altre tre feste del Santo. Il Tribunale del Real Patrimonio il 2 luglio, confermò questa delibera ed autorizzò la spesa per i festeggiamenti[4].
Un secondo provvedimento fu quello di costituire una confraternita dedicata al Santo che aggregasse solo nobili. Ancora il vescovo stabilì che il giorno 11 di ogni mese fosse esposto in Cattedrale alla pubblica venerazione la reliquia di S.Bartolomeo e che egli stesso avrebbe celebrato la Messa alla presenza della reliquia. Inoltre decise che tutti giorni, all’ora 21 che era quella del terremoto, ognuno smettesse la propria attività e recitasse un atto di dolore per i peccati commessi.

L'altare di San Bartolomeo nella Cattedrale di Lipari
Al Santo fu anche promesso che si sarebbe fatto un altare nuovo in Cattedrale, che gli sarebbe stata dedicata una statua ad altezza naturale tutta in argento e che sarebbe stata riparata la chiesa madre che pure aveva accusato le scosse del terremoto.
Ma mentre le prime decisioni diventarono subito esecutive, questi altri tre proponimenti impiegarono del tempo a realizzarsi. In particolare la statua in argento e l’altare in legno forte intagliato ed ornato di fregi d'oro zecchino, richiedevano molti fondi e la ricerca di questi procedeva con estrema lentezza. Forse fu necessaria la forte scossa tellurica dell’1 settembre 1726 perché improvvisamente si ebbe una grande accelerazione e, nel giro di due anni, dal 1727 al 1728, tutto fu commissionato, improntato e posto in opera. Alla testa dell’operazione si misero i giurati Nicolò Antonino Rossi, Francesco Policastro e Girolamo Pisano facendo ricorso a fondi pubblici locali e contribuzioni di privati[5]. E fu da quel momento che le processioni del Santo, fino ad allora circoscritte nel Castello cominciano a snodarsi anche per la città bassa. Si trattava spesso di un lungo serpentone umano formato da oltre cento fra preti, frati e chierici, ben otto confraternite – San Bartolomeo, Immacolata Concezione, Maria S.S. Della Grazie, Addolorata, San Giuseppe, San Pietro, Sant'Antonio Abate, S. Francesco di Paola, e le Anime Sante del Purgatorio – e poi tutto il popolo.
Ma rimaniamo al 1693. Quell’anno, ci dicono i cronisti dell’epoca, il carnevale fu “consegrato alla modestia, alla computione ed alla integrità de’ costumi”[6].
Così il giovedì grasso, che cadeva il 29 gennaio, parve il giorno “più santo dell’anno”. La gente numerosissima si confessò e fece la comunione riempiendo la Cattedrale e disertando le piazze. In Cattedrale sopraggiunsero anche le confraternite ed i frati e si diede luogo ad una solennissima processione col vescovo che portava il santissimo e l’arcidiacono il braccio d’argento con la reliquia del dito pollice. Il baldacchino era sostenuto dai rappresentanti della città. L’interminabile sequela di gente uscì dalla città alta e si portò prima a San Giuseppe, poi alla cappella di S.Barolomeo a Portinenti, finalmente – compiendo un ampio giro – giunse alla chiesa di S. Pietro e da qui si fece ritorno alla Cattedrale dove il vescovo tenne un discorso annunziando, fra l’altro, che da venerdì a lunedì, la reliquia del santo sarebbe stata esposta alla venerazione dei fedeli, mentre martedì 3 febbraio, giornata del carnevale, sarebbe stata santificata con l’esposizione del Santissimo e l’adorazione dei fedeli. Così, senza intermezzo, si sarebbe entrati nella quaresima.
 Statua in argento di San Bartolomeo
Statua in argento di San Bartolomeo
Intanto si approssimava il 13 febbraio, ricorrenza dell’arrivo a Lipari del corpo del Santo e si pensò quell’anno di celebrarla con particolare solennità. Si cominciò con l’esporre, tre giorni prima dell’evento, a sera, la reliquia e “si cantarono in musica le laudi”. Quando poi si era fatto buio in ogni parte della città, del borgo e della campagna si accesero dei grandi falò. La mattina del 13 ci fu il pontificale del vescovo con un panegirico rivolto al Santo. Alla fine della messa si portò, in processione - vescovo, canonici, clero, frati e confraternite, autorità e popolo - la reliquia alla chiesetta del Santo extra moenia . E per la prima volta da oltre un mese si vide la gente sorridere ed anche i canti non era più quelli della mestizia ma della gioia. La cerimonia si concluse in Cattedrale dove si intonò il Te Deum[7].
La morte del vescovo
Il personaggio che era emerso con forte spicco da questa vicenda del terremoto era sicuramente mons. Castillo che aveva interpretato, più di chiunque altro, il sentimento popolare ed intorno al quale si era stretto tutto il popolo ma anche le autorità ed i nobili cittadini. Tutti parlavano bene di lui nelle isole e si presagiva un futuro importante per la chiesa di Lipari vista anche la giovane età del prelato. Ma le cose dovevano andare diversamente.
Si era nella quaresima del 1694 ed era trascorso più di anno dal terremoto. Il papa Innocenzo XII aveva indetto un Giubileo e il vescovo volle che il popolo fosse preparato a questo evento religioso. Così affidò ad un predicatore, in Cattedrale, l’illustrazione del suo significato e l’importanza di prepararsi ad accogliere questo evento che era segno di riconciliazione e di remissione ei peccati. Lui stesso il venerdì 19 marzo , come usava fare tutti i venerdì di quaresima, volle prendere la parola ed, oltre a parlare della passione del Signore, affrontò il tema del Giubileo e degli effetti di santificazione che provocava nelle anime preparate a riceverlo. E poi preso dalla passione, nel fervore del discorso, ripeté più volte: “Beato quello a cui Dio concedesse di morire domenica prossima subito dopo aver ricevuto il Giubileo! Oh se fossi io questo fortunato!”.
La gente fu colpita dall’impeto del discorso e lo stesso presule finì, spossato, la celebrazione tanto che, contrariamente al suo solito, dovette mettersi a letto per riposare. Lui stesso ebbe a confidare nella stessa giornata che quello che gli era successo non gli era mai accaduto prima. La grande stanchezza dopo il discorso ma più ancora, un forte impulso interiore, mentre parlava, e l’impossibilità di trattenere le parole che uscivano da sole e le lacrime.
Il 21 marzo era il giorno in cui a Lipari si celebrava il Giubileo e alla funzione religiosa partecipò un gran numero di persone che si accostarono alla confessione ed alla comunione. Nel pomeriggio – dopo essere stato in chiesa a pregare – il vescovo salì con suo cognato, che era il governatore di Lipari, su un terrazzo per respirare l’aria del mare e passeggiare un po’. Passeggiando volle andare da un terrazzo ad un altro per mezzo di una scaletta di pietra senza appoggio. Probabilmente scendendo si impiglio nella veste, perse l’equilibrio e cadde nel terrazzo sottostante e batté con la testa nella parte destra. Subito perdette conoscenza e rimase in uno stato di letargo fino alla mattina di lunedì quando morì. Aveva 35 anni.
[1] Ibidem, pag. 362.
[2] P.Campis, pp. 362-365.
[3] P. Campis, op.cit., pag. 358.
[4] G.La Rosa, op.cit. vol I, pp.240-242.
[5] Per la verità le 750 onze che costarono i due manufatti, statua ed altare, furono raccolte fra la popolazione mentre il municipio offrì l’avantialtare d’argento e si fece carico della cappellina erogando, previa autorizzazione del viceré, prima 50 onze il 16 gennaio 1733 e poi altre 35 onse il 15 novembre dello stesso anno. Libro delle corrie,ff.171, 174, 174v.
[6] P. Campis, op.cit., pag. 359.
[7] Idem, pp. 359-262.
La morte del vescovo
Il terremoto del 1693
Il terremoto in Sicilia
“All’unnici di Jinnaru a vintin’ura
a Jacu senza sonu s’abballava
cui sutta li petri e cui sutta li mura
e cui a misericordia chiamava”
“L’undici di gennaio alle ore ventuno
ad Acireale senza musica si ballava
chi sotto le pietre e chi sotto le mura
e chi invocava la misericordia divina”
(detto popolare siciliano)

Una stampa tedesca sulla eruzione del 1693 in Val di Noto
La prima scossa avvenne nella notte - “nell’ora quinta[1]” - del 9 gennaio ma non furono in molti a sentirla perché i più dormivano e probabilmente a Lipari non dovette essere particolarmente forte. La seconda arrivò nel pomeriggio dell’11 gennaio, domenica, alle 13- 13,30 corrispondenti alle 21 siciliane dell’epoca, e questa volta la percepirono tutti, così riferiscono gli storici liparesi.[2]
Ma prima di parlare di quali furono le reazioni dei liparesi, cerchiamo di capire , anche alla luce delle ricerche moderne, la natura di questo evento sismico.
“Il terremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale – osserva uno studio del dipartimento di fisica dell’Università di Bologna[3] – è l’evento di più elevata magnitudo[4] della storia sismica italiana. Ad esso fu associato un maremoto catastrofico, osservato lungo tutta la costa orientale della Sicilia e più a sud fino all’arcipelago maltese”. Questo terremoto ha provocato distruzione completa in molte città delle attuali province di Catania, Siracusa e Ragusa e gravi danni fino a Palermo e Messina . Lo tsunami che ha colpito l’intera costa ionica aveva onde fino ad 8 metri.[5]. I morti furono da 60 mila a 93.000[6]. A Catania morirono 16 mila persone su 20 mila abitanti che contava allora la città; 5 mila su 9.950 a Ragusa; 4 mila su 10 mila a Lentini; 4 mila su 15.339 a Siracusa. La prima scossa arrivò la sera del venerdì 9 gennaio alle 21 circa[7], crollarono numerosi edifici e vi furono vittime, altri edifici furono seriamente lesionati. Il sabato passò senza forti scosse mentre la mattina di domenica alle ore 9 si ebbe una forte scossa e un’altra circa un’ora dopo. Ma l’evento principale, la scossa di 7,4° Richter, arrivò alle 13 e 30 provocando l’immane distruzione e l’innesco del successivo maremoto. Lo sciame sismico con le scosse di assestamento, anche forti, si protrasse ancora per circa due anni con un numero elevatissimo di repliche. Ne vengono stimate circa 1500 di varia intensità e a volte, come quella dell’1 aprile, provocarono altri danni[8]. L’area di avvertibilità è stata molto vasta e si è estesa dalla costa africana alla Calabria settentrionale. “Il terremoto ha raggiunto un’intensità del 6° grado nelle isole Eolie, ed ha provocato danni abbastanza gravi nell’isola di Malta (8°), ma la parte più colpita è stata la Sicilia meridionale con un’area di circa 5600 kmq in cui il terremoto ha raggiunto un’intensità di almeno 9°”. L’area mesosismica, cioè quella dei massimi effetti, la cui intensità è stata valutata dell’11°, copre una superficie di circa 550 kmq e mostra una direzione di allungamento verso nord-est e verso sud-ovest, cioè verso Messina e Malta dove, in entrambe, il sisma è stato dell’8° e che sono poste rispettivamente ad una distanza di circa 180 e 110km dall’area dell’epicentro. Mentre sulla direttrice perpendicolare, si ha una forte attenuazione e l’8° è raggiunto fra i 20 e 40 km dall’epicentro. Questo spiega perché alle Eolie che si trovano proprio sulla direttrice verticale il sisma è stato di 6° ben due in meno di Messina[9].

Un dipinto siull'eruzione del 1693
Ma dov’era l’epicentro? Oggi la tesi più accreditata sulla sorgente di quel sisma indica la scarpata ibleo-maltese che si trova sul mare proprio di fronte alla costa ionica della Sicilia e più precisamente al largo della costa fra Augusta e Catania. E spiegherebbe anche uno tzunami di quella portata[10]. La profondità risulterebbe circa di 20 km.
Messina subisce danni assai gravi. “I magnifici palazzi di Messina, dalle facciate imponenti e ornamentali, ma strutturalmente inadeguati a sostenere i movimenti tellurici dell’isola, furono scossi fin dalle fondamenta”.[11] Ma, visto come andò per Catania, Ragusa e altri centri della Sicilia orientale si può ben dire che essa sia stata risparmiata come, per la gran parte dei paesi della costa tirrenica e le stesse isole Eolie.


Sopra una mappa della sicilia con segnati i paesi colpiti dal sisma e sotto l'elenco delle città evidenziate nella mappa.
Il terremoto a Lipari
Il racconto di come avvenne il terremoto a Lipari lo si deve a Pietro Campis[12]che non si limita a dare informazioni sulle giornate del terremoto ma anche sulle manifestazioni di pietà religiosa che seguirono ai fatti e altre vicende che sono ad essi connessi. Siccome ci sembra che delineano un quadro suggestivo della Lipari del tempo e della sua cultura, anche noi attingeremo ampiamente a questa cronaca riportandola ad un linguaggio più accessibile al lettore di oggi. Va detto subito che il Campis, come d’altronde i liparesi suoi contemporanei, vede in questo evento che risparmiò non solo Lipari ma i liparesi ovunque si trovassero, la grandezza “del Patrocinio di S.Bartolomeo Apostolo sopra la Città di Lipari e i suoi Cittadini in occasione che la divina Giustizia provocata dalle colpe dei mortali usò la forza del suo giustissimo sdegno sopra la vicina Sicilia con spaventosi e replicati terremoti, i quali scotendola dai fondamenti, tolsero la stabilità alla terra, la fermezza alle fabbriche, la vita a più di cento quarantamila persone”[13]. Ed è proprio per fare comprendere “come per li meriti ed intercessione del Santo Apostolo sia stata preservata la Città di Lipari con i suoi abitanti da quello universale flagello[14]”ma anche per dimostrare il “grande amore del novello pastore verso le sue pecorelle”che lo storico che scrisse probabilmente un anno dopo gli eventi ci fornisce una narrazione dettagliata.
La cronaca del terremoto ha un antefatto. Tre mesi prima, l’8 ottobre del 1692 circa 21 ora, improvvisamente si annuvolò il cielo e si oscurò come se volesse piovere, e improvvisamente si scatenò sull’isola una furiosa tempesta come di grandine ma i chicchi erano grossi e pesanti fino a cinque libre[15], avevano una forma triangolare con tre punte lunghe ed al centro come la figura di un occhio che risaltava perché più chiaro. Questa burrasca sorvolò l’isola con un forte frastuono e si scaricò a mare, senza colpire nessuna persona ma solo alcuni animali che morirono.
Naturalmente questo evento, ripensato con quanto accadde dopo, nel successivo gennaio, apparve come un segnale divino a non peccare per non “sogiacere all’acuti strali dell’Irata Giustizia”.
 Licodia Eubea, il castello Santapau distrutto dal sisma del 1693
Licodia Eubea, il castello Santapau distrutto dal sisma del 1693
La prima scossa del terremoto a Lipari si avverte il 9 gennaio alle “ore cinque di notte” che dovrebbero essere le 22 di oggi, ma siccome i più dormivano e non procurò alcun danno, passò per lo più inosservata. Ma, qualche giorno dopo, la domenica 11, circa l’ora 21, mentre in Cattedrale il vescovo stava amministrando la cresima, per cui la chiesa era affollata, si avvertono tre terribili scosse. Ogni cosa vacilla, gli edifici oscillano, le strade sembrano sfuggire sotto i piedi. Dove andare? Verso dove scappare per salvarsi la vita? Sono domande che ognuno si pone mentre si cerca di capire che cosa è successo, spaventati, instupiditi.
Quelli che sono in chiesa corrono verso l’altare dove si conserva la reliquia del pollice chiedendo misericordia, pietà perdono, invocando l’aiuto del Santo. Quelle scosse durarono a lungo, un tempo infinito. Ma come era venuto il tremore finì.
Durante quelle scosse vi erano a Vulcano dei liparesi che erano andati a lavorare nei campi. Anch’essi avvertirono le forti ed interminabili scosse ma ciò che li terrorizzava era vedere l’isola di Lipari, dove avevano casa e famiglia, come una piccola barca agitata da una furiosa tempesta e sballottata tanto da parere che da un momento all’altro dovesse inabissarsi. Ma poi improvvisamente anche questo fenomeno cessò e Lipari tornò ad essere ferma e stabile.
Il Campis, a questo punto, passa in rassegna le città e i paesi colpiti dal sisma cominciando con la Val di Noto e via enumerando fino a Catania.
Palermo, Messina e le altre città, terre villaggi della Sicilia “ se non caddero a quelle scosse, furono con tutto ciò sì maltrattate che non si reggono in piedi e, bisognose di sostengo per non cadere, hanno mendicato dalle selve l’appoggio affidando a’ legni le vacillanti e cadenti loro membra[16]”.
Solo Lipari, sostiene il Campis, nella sciagura e desolazione universale, non patì il minimo danno né nelle persone,né negli edifici. E non ha il minimo dubbio, il Campis, che il merito sia solo di S. Bartolomeo: “se l’invocato Santo Bartolomeo non si fusse subitamente interposto appresso la Divina Giustizia per il populo supplichevole, non haverebbe avuto Lipari miglior sorte di quella che incontrarono tante e tante famose Città della Sicilia”.


Sopra un dipinto dell'epoca di Catania. Sotto le rovine di Noto antica.
Una lunga penitenza
Comunque è questo il sentimento della grande maggioranza di liparesi in quel giorno tremendo. Finite le scosse, il vescovo che è mons. Castillo – che era andato a vivere nel Palazzo accanto alla Cattedrale, probabilmente in qualche modo riparato – va nella Cattedrale che è piena di popolo e fa esporre la reliquia del pollice, lascia quindi che la gente si sfoghi per qualche tempo con pianti e preghiere e quindi, chiesto di fare silenzio, prende la parola ed esorta tutti alla penitenza.
E subito, esposto il SS.Sacramento, annuncia che sarebbe rimasto all’adorazione dei fedeli per le prossime quarant’ore, notte e giorno comandando ai canonici che tutti facessero turni di due ore. E lui stesso diede l’esempio scegliendo per se il turno della mezzanotte.
Quella notte la maggior parte dei liparesi la passò in Cattedrale, alternando la paura alla speranza, e ritenendo che, se era destino che dovessero morire, meglio era morire in chiesa in ginocchio dinnanzi al Santissimo.
Ma la notte passò senza nessuna replica del terremoto per quanto leggera.

Una ipigrafe a Catania ricorda la ruina
Il lunedì il vescovo preceduto dal clero e assistito dal governatore e dai giurati portò in processione il Santissimo dalla Cattedrale al Borgo e quindi per tutta la città invocando Dio che preservasse le persone e le isole dal ripetersi di eventuali dissesti. Alla processione il popolo partecipò numerosissimo e, tornata in Cattedrale la processione, il vescovo esortò tutti a prepararsi ad una comunione generale per il prossimo mercoledì mentre il martedì sarebbe stato dedicato alle confessioni.
E così passò il martedì col vescovo che partecipò direttamente alle confessioni mentre ognuno viveva nel raccoglimento e nella preghiera.
Arrivò il mercoledì 14 e per tempo la mattina arrivarono alla Cattedrale in processione le varie confraternite con i loro abiti penitenziali e intonando canti di penitenza. Dopo la comunione si formò una processione che dalla cattedrale, attraverso il borgo, si diresse alla chiesa di San Bartolomeo extra moenia sempre con il clero, il vescovo e le autorità in testa portando la reliquia del pollice. Lì giunti fu chiesto al Santo di confermare il proprio patrocinio e quindi tornarono alla Cattedrale.
Ma la giornata non poteva dirsi ancora conclusa. Nel pomeriggio, quando scadevano le quaranta ore di adorazione, di nuovo le confraternite si diressero alla chiesa madre e questa volta tutti i confrati avevano una corona di spine in testa e una grossa e rozza fune al collo.
Anche i frati Osservanti ed i Cappuccini intervennero con la corona di spine in testa e scalzi e ciascuno portava uno specifico strumento di penitenza: chi si era caricato una grande e pesantissima croce, chi si trascinava al piede una lunga e massiccia catena, chi aveva sulle spalle un pesante macigno, chi con strumenti a punta si colpiva il volto che aveva tutto coperto di sangue. Anche il clero sopraggiunse con il capo cinto di spine.

La processione, con alla testa il vescovo, che mostrava il Santissimo, e le autorità cittadine – anch’essi cinti di corone di spine -, dalla Cattedrale si diresse verso la chiesa di San Giuseppe nel Borgo seguita da un a folla numerosa, tutti con in capo una corona di spine. In questo lungo corteo non mancava chi con flagelli si sferzava le spalle, o si era fasciato le carni nude con l’ortica, o chi si piagava il petto mentre il clero con voce flebile intonava preghiere. Quindi la precessione fece ritorno alla cattedrale dove il vescovo, con un breve discorso, accomiatò tutti.
La congregazione dell’Immacolata chiese al vescovo che si prolungasse di altre quaranta ore e ad essa si unirono le altre congregazioni. Così fu deciso che l’indomani mattina, 15 gennaio, il Sacramento venisse esposto nella chiesa di San Giuseppe e poi a turno si sarebbe portato nelle altre chiese e conventi – e durante il giorno oltre alle preghiere ci sarebbero stati esortazioni spirituali di canonici, padri regolari e dello stesso vescovo nel pomeriggio – e questo fino alla Domenica.
La domenica 18 il vescovo era nuovamente in cattedrale in abito penitenziale e nel pomeriggio, arrivati anche i monaci e il clero con gli stessi segni penitenziali del giorno 14, con la reliquia del Santo la processione si diresse verso la chiesetta di San Bartolo extra moenia. Vi erano anche il governatore ed i giurati anch’essi cinti di spine e con al collo una corda di canapa e così tutto il popolo che seguiva silenzioso e penitente.
E’ fra la sera della domenica e la mattina del lunedì che finalmente giungono a Lipari notizie dalla Sicilia. E ciò che colpisce di più è il sapere che lì alle fortissime scosse dell’11 ne erano seguite diverse altre, “minacciandone un totale sterminio”.
La mattina del lunedì Lipari è tutto un pianto. Nella case, nelle chiese, nelle piazze, nelle strade sono solo suppliche e gemiti. E non si capisce se questi sono per la commiserazione della rovina che è toccata a tanta gente o per il riconoscimento di esserne stati preservati. “La verità si è che – commenta il Campis – dall’uno e l’altro motivo il tutto s’originava nel cuore dei Liparoti”[17].
A questo punto la sequela penitenziale riprende con maggior convinzione e vigore. “Affronte di tante calamità partorite dal tremoto in Sicilia più spicca la gratia fatta alla Città di Lipari, che, sbattuta gagliardamente, fu sostenuta, e, già cadente, fu fermata senza minomissimo detrimento”[18].
Lipari come Ninive penitente
Il vescovo scende in Cattedrale con la corona di spine in testa e scalzo, si prostra in preghiera di ringraziamento dinnanzi alla reliquia dell’Apostolo e poi, sempre scalzo, si reca alla chiesa della Madonna delle Grazie , che si trova ad un centinaio di metri dalla Cattedrale, dove era esposto il Santissimo. Qui lo raggiungono i canonici del capitolo anch’essi incoronati di spine e scalzi. E quando si sparse la voce nella città che il vescovo è con i canonici in preghiera e scalzo, tutti corrono alla Madonna delle Grazie. Tutti scalzi, tutti col capo coperto di spine, anche il governatore ed i giurati, tutti senza eccezione alcuna incuranti del fatto che era inverno, che faceva freddo, che le strade erano pozzanghere fangose. Tutti anche le signore, le donne di ogni ceto, scarmigliate, con croci e flagelli, battendosi il petto, piangendo, invocando pietà. Tutti anche le ragazze, i giovani, i bambini graffiandosi la faccia. Percotendosi il petto con sassi, battendosi le spalle con corde impeciate, tutti implorando misericordia e perdono, “vedevasi una divotione confusa et una confusione devota[19]”.
“Chi non vidde Ninive penitente poteva quella mattina raffigurarla in Lipari[20]”!


Sopra una antica rapprersentazione di Ninive e sotto il profeta Giona che predica la penitenza.
E questa contrizione non si trattò di un fuoco fatuo. Il martedì, il mercoledì e il giovedì furono giorni totalmente consacrati al pianto, al pentimento, alla confessione ed alla comunione, ad atti di penitenza “che ognuno a suo talento esercitava” , di giorno per le strade e nelle chiese e di notte dinnanzi alle porte chiuse di queste giacchè si temevano ancora rovine e stragi.
Le notizie che erano arrivate dalla Sicilia sembravano avere tolto senno e sonno alle persone. Non si dormiva più di notte e di giorno si camminava per le strade “insensate e stolide”, meste e taciturne. Non si vedevano più per le strade e per le piazze il formarsi di circoli per chiacchierare, anzi appena si scambiavano saluti muti fra amici e parenti. Diversi pensavano di abbandonare la città e il borgo e di rifugiarsi in campagna come se anche qui non si fossero potuti aprire delle voragini.
Di questo sentimento popolare di depressione ne fu turbato il vescovo che pensò che fosse giunto il momento di porre fine a questa lunga penitenza ch era durata per più di dieci giorni.
Così giovedì 22 gennaio era l’ultimo giorno in cui il Santissimo stava esposto nella Chiesa delle Grazie. Il vescovo, alla 21 ora (ore 14?), preceduto dal capitolo e seguito dai rappresentanti la città, si soffermò in preghiera dinnanzi all’ostensorio poi presolo in mano si portò alla porta della chiesa perché potesse essere ascoltato da quelli che erano dentro la chiesa e dai moltissimi che non erano riusciti ad entrare e stavano in ginocchio nella piazzetta dinnanzi. Nel suo discorso partì dalla grazia che Lipari ed i liparesi avevano ricevuto per i meriti di S. Bartolomeo ma, parte nuova del suo discorso, si disse sicuro che l’isola e la città non sarebbero più stati soggetti a cataclismi e scosse di terremoto e questo proprio per la tutela del santo. E disse questo senza alcuna esitazione sereno in volto ma con voce ispirata. E lo ripeté più volte alzando l’ostensorio. Grazie a S. Bartolomeo il pericolo era cessato.
 La Cattedrale dove accorrono i liparesi quando incombe il pericolo.
La Cattedrale dove accorrono i liparesi quando incombe il pericolo.
Un discorso breve ma di grande efficacia. E la gente gli credette ed immediatamente tutti si rasserenarono. Così accompagnarono vescovo e ostensorio in processione ancora una volta per la città e ritornati alla Chiesa delle Grazie il vescovo volle rassicurare ancora i cittadini: “Non bisognava avere più paura che tremi la terra. Dio per i meriti del suo Apostolo ci ha preservati da questo tragedia e così sarà per l’avvenire”. Quindi mons. Castillo impartì la benedizione e rimandò la gente alle proprie case.
Nei giorni seguenti si seppe che proprio nella giornata di giovedì, “alle 22 ore sonate”, mentre il vescovo parlava rassicurando tutti, a Messina ed in altre città la terra fu scossa da forti tremori. Ma a Lipari non ci fu più alcun sommovimento, ne allora nei mesi seguenti, dice il Campis, che finiva di scrivere il 10 agosto di quello stesso anno[21].
[1] Le ore si contavano a partire dall’Ave Maria che però cambiava da stagione a stagione perché corrispondeva all’imbrunire. Se a gennaio il sole tramonta alle 17 si può pensare che l’ora quinta siano le 22 e che le 21 della domenica erano le 13. Un calcolo diverso degli orari viene fatto da M.S. Barbaro e M. Cosentino (Il terremoto siciliano dell’11 gennaio 1693, Rend.Soc. Geol.It, 4 (1981), pp- 517-522): il 9 gennaio la scossa si sarebbe verificata alle ore 4,30 del tempo corrispondente alle 21,07 di oggi; il terremoto dell’11 gennaio sarebbe avvenuto alle ore 21 del tempo allora in uso corrispondente alle 14.09 del tempo odierno. Ma se il terremoto a Lipari giunse durante la cerimonia in Cattedrale è difficile che questa fosse ancora in corso alle 14.09. Più probabilmente la scossa che colse la gente in cattedrale fu quella delle 16 tempo di allora corrispondente alle ore 9. 23 di oggi e che vi sia stata confusione fra le due scosse.
[2] G.La Rosa, op.cit., voll. I, pp232-241,
[3] S. Tinti, A.Armigliato e R.Tonini, Studio delle possibili sorgenti del maremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale mediante modellazione numerica, Convegno GNDT 2004.
[4] M=7,4 secondo Gruppo di Lavoro CPTI, 2004.
[5] Dal sito www.socgeol.it , vol.128(2009) f.1.
[6] M.S. Barbano, M. Cosentino, art. cit., pag. 521. I dati e le notizie riportati dalle cronache o da descrizioni del terremoto si rivelano spesso contraddittori. Risulta perciò importante confrontare più documenti, possibilmente atti ufficiali. Riguardo, ad esempio, alle vittime del terremoto le notizie sono estremamente discordanti; per la Relazione dei Senatori di Siracusa ... , cit., i morti sono 93.000, secondo il manoscritto anonimo Il gran terremoto del 1693 in Siracusa sarebbero 26.000: L. Trigilia, Siracusa ... , cit., pp. 116-117, cfr. a p. 82. F. Aprile, Della cronologia ... , cit., riportando gli «Estinti nelle rovine del terremoto», osserva: «rapporterò qui la strage delle persone quasi d'ogni popolazione per potersene conietturare ancora le rovine degli edifici; avvegnaché non sia in tutte argomento infallibile, poiché in alcune fu grande il danno delle fabbriche, minore, e non corrispondente la perdita degli uomini, che con maggiore accorgimento si sottrassero al pericolo dopo il terremoto del venerdì .. ».
[7] La prima scossa si fece sentire “per lo spazio di due pater noster”, quella dell’11 gennaio (alle 15 o alle 13.30), fu avvertita per il tempo di “una litania cantata”. ( Da una lettera del conte Domenico Lacorcia scritta da Mazzarino il 13 gennaio ad Antonio Bulifon in L.Trigilia, La ricostruzione necessaria, Centro Internazionale di Studi sul Barocco.)
[8] M.S.Barbano e M. Cosentino, art. cit., pag. 519.
[9] Idem, 519-521.
[10] M. Stucchi, F.Albini, A.Moroni, I. Leshiutta, C.Mirto e G.Morelli, Il terremoto del 9 gennaio 1693 in (a cura di) G.Giarrizzo, La Sicilia dei terremoti lunga durata e dinamiche sociali, Catania 1886.
[11] S.Greco, Messina medievale e moderna, op.cit., pag. 332.
[12] P.Campis, op.cit., pp.345-366. E la cronaca del Campis riprende ampiamente Giuseppe La Rosa, op.cit., vol I,pp.232-241. Noi seguiremo la narrazione del Campis integrandola, dove ci sembra più chiara e puntuale sotto l’aspetto narrativo, con quella del LaRosa, che in qualche punto se ne discosta.
[13] P. Campis, op.cit., pag. 345.
[14] Idem, pag. 345.
[15] La libra siciliana doveva essere di poco superiore ai 3 etti e quindi questi chicchi di grandine sarebbero arrivati pesare sino ad un chilo e mezzo.
[16] P.Campis, op, cit., pag.350.
[17] P. Campis, op. cit., pag. 354.
[18] Idem, pag. 354.
[19] P. Campis, op. cit., p.355.
[20] Ibidem, pag. 355.
[21] Ibidem pag. 358.
Lipari penitente come Ninive
Mons. Arata, un grande vescovo santo
La paziente intransigenza di mons. Arata
 Le antiche porte di Palermo
Le antiche porte di Palermo
Tensioni con il Tribunale della Real Monarchia dovette sperimentarle anche mons. Francesco Arata[1], malgrado i propositi con cui era giunto a Lipari nel gennaio del 1664. Il suo fermo intento era quello di liberare la diocesi dalla presenza del commissario del Tribunale della Real Monarchia di Palermo ma agendo con tatto e diplomazia e senza lasciarsi sviare da altri problemi. Invece improvvisamente, ad un anno dal suo arrivo, si trovò nel bel mezzo della mischia con il governatore delle isole e capitano d’arme. Una contesa partita da un problema eminentemente giuridico e cioè se l’istituto del “privilegio del foro” – che permetteva al vescovo di far giudicare dal tribunale ecclesiastico di sua competenza gli ecclesiastici ed i familiari di Curia – che era stato abrogato nel 1635 dal re di Spagna, si applicava ugualmente a Lipari visto che la diocesi – già prima di quel tempo - dipendeva direttamente dalla Santa Sede[2]. Ma la vicenda degenera in un conflitto col capitano d’arme che viene scomunicato dal vescovo e col commissario del Tribunale della Real Monarchia. Inoltre mons. Arata deve anche trascorrere tre mesi nella prigione di Palermo dove lo rinchiude, nella primavera del 1667, il viceré. Il vescovo non si dà per sconfitto ed approfitta di questi mesi per avere un chiarimento, a conclusione del quale torna a Lipari con la promessa che sarebbe stato allontanato il capitano d’arme e rimosso il commissario. Ma se viene mantenuta, “a stento[3]” , la prima promessa la seconda viene dilazionata nel tempo fino a quando nel 1668 non scoppia un altro caso. Anche qui il commissario impugna una sentenza del vescovo ed il vescovo lo minaccia di scomunica. A questo punto il commissario si dimette e chiede di riconciliarsi col vescovo. Il Tribunale di Palermo non nominò un successore ma il nuovo viceré volle incontrare, come aveva richiesto il suo predecessore il vescovo. Mons. Arata accettò prontamente e annunciò alla S.Sede che chiedeva una dispensa dalla residenza di sei mesi, mettendo in conto che anche questo viceré , come il predecessore, avrebbe approfittato di averlo a Palermo per segregarlo in carcere. Invece questa volta si trattò di un confronto in piena libertà dove ognuno espresse le sue ragioni ma il vescovo rimase fermo sulle sue posizioni e se ne tornò a Lipari di fatto vittorioso anche se non volle ammettere che di una vittoria si era trattato.
Mons. Arata deve nominare il vicario di Messina
Non purtroppo una vittoria definitiva perché scoppia un altro caso, sempre per l’applicazione del “privilegio del foro”, probabilmente nel 1675 o poco prima perché di esso mons. Arata parla in una relazione , appunto del 1675, alla Sacra Congregazione del Concilio. Il caso riguarda il capo dei gendarmi della Curia vescovile che da dieci mesi è in carcere per un alterco col giudice del Tribunale laico. Il vescovo scomunica il giudice e questo si appella al Tribunale della Monarchia. Il vescovo resiste all’ingiunzione di trasmettere ad essa gli atti del procedimento per l’appello e viene convocato alla corte del viceré che allora risiedeva a Milazzo. Dopo due ore di rimostranze che mons. Arata dovette subire improvvisamente il suo interlocutore fu colto da un terribile mal di testa che non accennava a placarsi nemmeno dopo giorni, e così se ne dovette tornare a Palermo.
Ma il caso più clamoroso doveva accadere l’anno successivo, in seguito alla morte dell’arcivescovo di Messina che avvenne il 22 marzo 1676. In quel tempo Messina si era ribellata agli spagnoli ed era temporaneamente occupata dai francesi. Nell’attesa che fosse designato il nuovo arcivescovo il capitolo nominò il vicario nella persona del canonico Benedetto Dini, ma la decisione non piacque al Tribunale della Real Monarchia.
Messina, si eccepì, anche se occupata dai francesi appartiene al regno di Spagna ed al regno di Spagna appartiene gran parte del territorio diocesano. Inoltre si fece appello ad uno dei canoni del Concilio Tridentino che stabiliva che in una diocesi metropolitana con sede vicaria, la nomina del vicario spettava al vescovo della diocesi suffraganea più antica. Cioè, in questo caso, il vescovo di Lipari. Questi, che si trovava in quel periodo a Palermo, acconsentì e nominò un ecclesiastico messinese di sua conoscenza, don Francesco Tanzi che, saputo della nomina, fuggì da Messina e si stabilì a Milazzo per esercitare, libero dal controllo francese, la sua funzione. E così Messina ebbe due vicari, il Dini e il Tanzi. Il primo che esercitava sulla città e sulla parte della diocesi sotto il controllo francese, e l’altro sulla parte della diocesi sotto il controllo spagnolo.
La decisione di mons. Arata di nominare lui il vicario non piacque alla S. Congregazione del Concilio che temeva insidiata la dipendenza diretta della diocesi di Lipari dalla Santa Sede ed il rischio del suo rientro nell’alveo della Legazia Apostolica. Mons. Arata , saputo di queste critiche, cercò di spiegare ai membri della S. Congregazione i motivi del suo comportamento e come, consultando l’archivio diocesano, si era potuto rendere conto che i suoi predecessori per più di sessant’ anni, senza interruzione, avevano accettato di essere suffraganei della sede Metropolitana di Messina. Comunque, conclude assicurando, che è pronto a rimettersi alle loro decisioni.[4].
Prima che la lettera arrivi alla Congregazione questa ha già disposto. Valeva – si conferma - il decreto di Urbano VIII del 1627 che dichiarava esente la chiese di Lipari da qualsiasi dipendenza che non fosse quella della S. Sede quindi l’Arata veniva invitato ad annullare il suo atto, mentre il Tanzi, che non doveva tenere in alcun conto la designazione del vescovo di Lipari doveva comunque rimanere nella carica di vicario generale perché a questo incarico veniva destinato direttamente dalla Congregazione.
Un braccio di ferro fra Roma e Palermo sulla pelle del vescovo
Il vescovo di Lipari ubbidì prontamente e lo comunicò a Roma per dimostrare la sua buona fede. Il Tanzi invece non potè accogliere la disposizione della S. Sede perché viveva in regime di Legazia Apostolica e non poteva accettare ordini superiori che non passassero o fossero approvati dal Tribunale della Monarchia. Inoltre se si applicava il Concilio di Trento, una volta esclusa la diocesi di Lipari il diritto-dovere della nomina passava alle altre diocesi suffraganee che erano Cefalù e Patti e non alla S. Sede.
Ma la S. Congregazione non si dà per vinta. Rimbrotta aspramente il vescovo di Lipari accusandolo “di essersi comportato da spergiuro con determinata volontà e di avere, in piena consapevolezza, contrastato ad un preciso decreto della S.Sede”[5]; e riguardo al Tanzi coglie al volo la circostanza che un suo membro, il card. Ludovico Emanuele Fernandez de Portocarrero era stato designato dalla corte di Madrid a governare l’isola per chiedergli di avallare la nomina della S.Congregazione alla cui decisione lui stesso aveva concorso.
 Il Cardinale Portocarrero
Il Cardinale Portocarrero
Questa mossa metteva in imbarazzo il cardinale Portocarrero che si vide nel mezzo di un conflitto di interesse e non potè fare altro che passare la lettera al giudice del Tribunale della Regia Monarchia. Il giudice – comprendendo benissimo che la richiesta della S. Congregazione minava l’istituto della Legazia Apostolica – respinse la richiesta e censurò l’operato del vescovo di Lipari.
Per circa un anno le cose andarono avanti nella confusione. Il Tanzi continuò ad operare come vicario in base alla nomina del vescovo di Lipari per il Tribunale della Regia Monarchia ed in base alla propria designazione per la S. Sede. La diocesi di Lipari rimase suffraganea di Messina per il Tribunale ed invece soggetta unicamente alla S. Sede per la S. Congregazione. E il povero vescovo di Lipari? Rimaneva nelle ambasce e aspettava chiarimenti da Roma che non arrivavano.
Questa era la situazione quando nel maggio del 1678, in ordine ad una causa della vendita di un podere di Salina avvenuta 35 anni prima, ci si appella all’arcivescovo di Messina e questo richiede gli atti alla curia di Lipari. Che fare? Il vescovo scrive all’arcivescovo esprimendogli tutto il proprio imbarazzo, gli chiede di aver pazienza e di attendere, perché spera in un chiarimento da parte della S. Congregazione del Concilio[6]. Ma Roma taceva malgrado le sollecitazioni ed intanto si aveva sentore che a Palermo la situazione andava aggravandosi perché l’arcivescovo di Messina non aveva mantenuto il silenzio dopo la lettera di Mons. Arata, ma aveva informato il viceré che aveva informato il re.
Il 17 ottobre del 1678 la consulta dei ministri di Stato emette una sentenza che riafferma la suffraganeità della diocesi di Lipari rispetto a Messina e si suggerisce al vicerè di convocare a Palermo il vescovo di Lipari per dar conto della sua condotta presente e passata.
E mons. Arata parte per Palermo alla fine di giugno del 1679 ed a Palermo vi rimarrà per circa un anno, fino al giugno del 1680, trascorso in incontri e interrogatori e per lo più in stato di detenzione con lo scopo di farlo desistere dalla posizione di ritenersi dipendente solo da Roma. Durante questo periodo più volte scrive alla S. Congregazione chiedendo lumi su come comportarsi ma senza ricevere sostegno ed appoggio alcuno. Al vicerè il povero vescovo continua a rispondere che lui aveva cercato di adeguarsi alla volontà del re e di comportarsi come suffraganeo del metropolitano di Messina ma questa condotta non mi fu più possibile tenerla per un esplicito intervento del papa. “Quel che avrei dovuto fare me lo suggerisca, di grazia, Eccellentissimo Viceré, la Sua ben nota e decantata pietà e saggezza. Avrei potuto io, in tutta coscienza, avrei potuto io, in tutta coscienza, non ubbidire ad un così esplicito ordine del Sommo Pontefice che è l’immediato ed unico superiore dei Vescovi?... se ad un suddito vengono impartiti da due Superiori diversi ordini contrastanti fra loro, ben si sa che tutti i Teologi suggeriscono che è doveroso obbedire a quel superiore che è di grado più elevato, e non all’altro”.[7]
Mentre a Palermo mons. Arata si mostrava risoluto sulla sua posizione, a Roma l’ambasciatore di Spagna aveva aperto estenuanti quanto inutili trattative con la curia giacchè il papa era più risoluto di Mons. Arata. Intanto a Messina si raccoglievano documenti e testimonianze per testimoniare quanto la suffraganeità di Lipari fosse antica e costante. Tutto però dimostrava che la questione andava per le lunghe per cui sul finire dell’inverno del 1680 il vicerè chiede al re il permesso di potere rimandare a Lipari l’Arata che si era dimostrato un soggetto troppo difficile da trattare e per di più la diocesi lamentava la mancanza del suo vescovo.
Così, probabilmente, nel giugno dello stesso anno mons. Arata tornava alla sua sede. Intanto nel marzo del 1678 era stato nominato il nuovo arcivescovo e quindi il problema della nomina del vicario si era risolta di per sé. Rimaneva il problema della dipendenza della chiesa di Lipari. Questa si risolvette in qualche modo il 9 febbraio del 1691 quando, morto mons. Arata, venne nominato vescovo di Lipari mons. Gaetano Castillo[8] ed il papa, nella bolla di nomina, ribadì l’esenzione della chiesa di Lipari da ogni sudditanza esclusa quella con Roma. Ed essendo questa bolla stata sottoposta dal nuovo vescovo all’exequatur del governo siciliano la questione veniva risolta con una vittoria piena della Santa Sede[9].
Gli anni ’70 non sono solo quelli, come abbiamo visto, del braccio di ferro fra Roma e Palermo giocata sulla pelle di mons. Arata ma sono anche anni di carestia e di guerre che investono le Eolie come la Sicilia ed altre realtà del Mediterraneo.
Carestia allora significava crudamente mancanza di pane. La raccolta del 1671 era stata poverissima. I contadini protestavano con i proprietari terrieri accusandoli di vendere ai cittadini tutto il grano prodotto per ricavare maggiori guadagni e abbandonavano le campagne affollando le città sperando di trovare qui il benessere. In realtà trovavano miseria e morte. Nel corso del 1672 a Palermo morirono di fame oltre cinquantamila persone, a Messina ventimila, quindicimila a Catania e Siracusa[10]. I messinesi armarono cinque vascelli e con essi cominciarono a dare la caccia alle navi cariche di mercanzie che attraversavano lo Stretto o veleggiavano nelle vicinanze[11]. E siccome questa pratica si era diffusa nelle zone costiere, il viceré intervenne per dichiararla inammissibile, chiedendo la punizione dei magistrati che li avevano avallato ed ordinando la restituzione dei grani derubati. Ma era tutto inutile perché la situazione, in particolare nel messinese, era ogni giorno di più fuori controllo[12] .
Il "miracolo" del Vascelluzzo
E a Lipari? La situazione non era certo migliore che altrove. E’ proprio in questa circostanza il vescovo Arata, che già si era fatto apprezzare per il suo spirito di carità verso i poveri, “faceva distribuire ai bisognosi ogni mattina alla porta del suo Palazzo – annota il Campis[13] -o leumi cotti o riso, e non in scarsa misura”.Ma malgrado l’impegno del vescovo la situazione andava precipitando fino a quando, nella prima decade di febbraio del 1672, erano terminate le scorte di grano e non si aveva speranza che ne potesse arrivare dalla Sicilia perché per parecchi giorni di seguito vi erano furiose tempeste che non permettevano a nessun vascello di accostarsi.
 Il Vascelluzzo
Il Vascelluzzo
Il 13 febbraio era la ricorrenza dell’arrivo a Lipari delle spoglie di S.Bartolomeo e la gente, come sempre nelle situazioni di pericolo, si affidava al patrono aumentando le invocazioni e le preghiere. Ed è proprio il 12 febbraio, vigilia della ricorrenza, si vide apparire all’improvviso dinnanzi all’isola “una gran nave, la quale, quantunque combattuta da ogni parte dalli venti infuriati e flagellata dall’onde, non però cedeva punto allo sdegno degli elementi”[14]. Il Campis descrive come il comandante cercasse in tutti i modi di indirizzare il vascello verso Milazzo o una spiaggia della costa tirrenica, ma inutilmente. Il vento consentì una sola manovra, quella di approdare nel porto di Lipari. Qui si scopre che era una tartana francese, denominata S. Bartolomeo, carica di frumento, diretta a Messina. E quando si seppe che Bartolomeo era anche il nome del proprietario, subito si gridò al miracolo e comprato tutto il grano, “si rimediò alle communi miserie per qualche tempo”[15].
E si tratta, questo del vascello pieno di grano, del miracolo più popolare fra gli eoliani assieme a quello dell’arrivo delle reliquie del Santo. A memoria di esso nel 1930 i liparesi fecero realizzare il cosiddetto “vascelluzzo” in oro ed argento, un reliquiario che conserva un lembo di pelle del Santo[16].
Ma non sono solo la carestia e la miseria a travagliare in questi anni la vita degli eoliani, vi sono i navigli dei saraceni che rifanno la loro comparsa, ma soprattutto ricompaiono nei nostri mari le navi da guerra, che per qualche tempo, non si erano più viste e le isole tornano ad essere teatro di scontri.
Il motivo per cui gli scontri navali riprendono a verificarsi nel basso tirreno è legato in particolare alle vicende di Messina. Qui la carestia ha dato origine a forti sommosse popolari[17] e ad una sorta di guerra civile che ha portato Messina a scacciare gli spagnoli e a chiedere l’appoggio dei Francesi ed a dichiararsi indipendente dalla Spagna ( 1674-1678).
Tutto questo per i liparesi – che si mantennero fedeli al re di Spagna con in testa i loro giurati ed il loro vescovo - voleva dire maggiori restrizioni nelle navigazioni giacchè c’era il pericolo di imbattersi in navigli francesi. Per il popolo voleva dire anche lavoro straordinario e gratuito nelle opere di difesa, requisizione ed ammasso nei magazzini del Castello del poco grano che i contadini conservavano per le emergenze. Una squadra francese piuttosto consistente operava nei mari delle Eolie nel febbraio del 1675 . Lo scontro con gli spagnoli avvenne tra Panarea e Stromboli e la vittoria arrise ai francesi tanto che il comandante della flotta, sbarcato a Messina, si dichiarò viceré di Sicilia. Un altro scontro, questa volta fra francesi e gli olandesi venuti a dare man forte agli spagnoli e dall’esito dubbio, si ebbe a largo di Alicudi l’8 gennaio del 1676. Dopo lo scontro entrambi i contendenti vennero a sostare nelle baie di Lipari tenendosi a rispettosa distanza. Si studiarono per due giorni con qualche scaramuccia, poi i francesi si mossero verso Messina mentre gli olandesi buttarono le ancore a Milazzo. Dopo le operazioni navali si spostarono sulle coste della Sicilia orientale.
Gli scontri finirono nel 1678 con la pace di Nimega e la Spagna riebbe indietro Messina e gli altri territori occupati in Sicilia[18].
 Messina, antica fortezza
Messina, antica fortezza
Un grande e santo vescovo
La carità di mons. Arata verso i poveri non si limitò solo al periodo della carestia ma fu un carattere distintivo di tutto il suo ministero[19]. E visto che gli introiti della Mensa non erano più abbondanti come un tempo, giacchè la carestia e la limitatezza dei commerci aveva ridotto le entrate a 3 mila scudi l’anno mentre la popolazione era arrivata a 5.500 abitanti – di cui tre mila nella città alta – e da questi introiti bisognava decurtare diverse somme[20] fra cui quelle per l’ospedale dell’Annunciata che si trovava al Castello, vi rimediava con le sue risorse personali e con i contributi dei benefattori[21] che continuamente sollecitava. Per recuperare le risorse per i poveri mons. Arata arrivò a vendere i materassi e le coperte del suo letto. Il Campis racconta che “tutte le limosine che distribuiva voleva passassero per mano non sua, ma d’altri. Anzi mai esso tenne denaro sopra di sé, e richiesto un giorno da persona confidente perché così praticasse, rispose: ?Se io vedessi con i miei occhi il denaro, che sa se io me l’affetionassi e mi paresse più duro il darlo come devo. L’argento e l’oro rubbano i cuori per menzo dell’occhio, onde per guardarci da essi non dobbiam guardarli”[22].
La sua attività caritativa aveva ottenuto dei buoni successi se poteva scrivere nel 1665 – naturalmente prima della carestia - che “in mezzo a questo piccolo gregge non c’è una sola pecorella alla quale manchino gli alimenti per il suo quotidiano sostentamento”.[23]
Ma la carità non era l’unico valore all’attenzione del vescovo Arata, aveva anche – ed è forse il suo tratto più interessante – una concezione dell’evangelizzazione che modernamente si sposava con la promozione umana. Anch’egli, come i suoi predecessori, si rende conto che la religiosità degli eoliani é molto carente, fortemente inquinata da una ignoranza – a cominciare dal non sapere leggere e scrivere, peculiarità che non era solo del popolo ma anche della classe media e dei ceti privilegiati[24] - che li portava a viverla intrisa di superstizione e paganesimo.. Ma, al contrario di essi, non si limita a condannare queste deviazioni ma andava alle sue cause. E le cause stavano nel clero secolare e nei religiosi che non erano meno ignoranti del popolo che era loro affidato. I primi perché la loro formazione era approssimativa e abborracciata[25], i secondi perché come scriverà lo stesso vescovo in una relazione “ad Limina” del 19 gennaio 1668 – “qui per lo più vengono inviati come a luogo di confino e al fine di far penitenza taluni frati che si allontanano dalla disciplina religiosa e sono rilassati nello spirito” per cui “con la loro condotta essi fanno più male che bene, e che con la loro licenziosità e dissolutezza danno occasione a fatti scandalosi”[26].
Per i frati chiede ed ottiene la collaborazione dei superiori. Ed infatti, già nel 1672, in una lettera alla S. Congregazione del Concilio riferisce che la situazione è del tutto mutata sia per quanto riguarda i cappuccini sia per i minori osservanti. Per quanto riguarda, invece, il clero secolare e il popolo mette in campo una strategia ad ampio raggio. Fa venire da fuori sette sacerdoti che dovranno collaborare nella sua opera pastorale a cominciare dal vicario generale; tenta di portare a Lipari – ma l’operazione non va in porto - i frati Scolopi, specializzati nella promozione della cultura popolare, ed arriva ad offrire loro il convento sulla Civita dei minori osservanti; promuove un Sinodo diocesano per il 1666 con l’obiettivo di verificare lo stato disciplinare della sua chiesa;[27] istituisce in Lipari di un parroco stabile perpetuo che svolga con continuità la cura d’anime senza essere distolto- come accade per il vescovo – da attività di governo; invita puntualmente predicatori gesuiti a parlare in Cattedrale ed a tenere “i quaresimali”[28]; infine, ma sicuramente l’iniziativa più importante, promuove l’apertura di una “scuola di grammatica”, gratuita ed aperta a tutti, ai chierici che volevano prepararsi al sacerdozio ma anche i ragazzi poveri che volevano darsi una cultura di base. In questa scuola si dovevano insegnare “la grammatica ed i rudimenti della fede”[29].
 La “scuola di grammatica” promossa da mons. Arata sarà il primo strumento di istruzione pubblica delle Eolie. Proprio in quegli anni Lipari apriva due biblioteche – sempre sovvenzionate dal vescovo - una presso il monastero dei Minori Osservanti ed una presso i Cappuccini mentre lo stesso vescovo, presso il suo palazzo, aveva un’altra buona dotazione di libri.
La “scuola di grammatica” promossa da mons. Arata sarà il primo strumento di istruzione pubblica delle Eolie. Proprio in quegli anni Lipari apriva due biblioteche – sempre sovvenzionate dal vescovo - una presso il monastero dei Minori Osservanti ed una presso i Cappuccini mentre lo stesso vescovo, presso il suo palazzo, aveva un’altra buona dotazione di libri.
Col tempo anche le forme di espressività religiosa durante le processioni si erano purificate e non vi erano più le manifestazioni esagitate che tanto negativamente avevano colpito mons. Vidal.
Si era fortemente affezionato a Lipari Mons. Arata e quando, morto l’arcivescovo di Catania, il 27 settembre 1686, lo stesso Carlo II lo proporrà per governare quella diocesi, egli rifiutò per non abbandonare quella che Dio gli aveva “data per sposa” [30]. Ci si è chiesti se quello del re fosse un riconoscimento per un prelato che nella difficile vicenda della ribellione di Messina si era mantenuto fedele alla monarchia spagnola oppure un ennesimo tentativo di riaprire in qualche modo la vicenda dell’autonomia della diocesi liparese liberandosi di un vescovo irriducibile dalla consegna avuta dal papa. Ma se veramente questo proposito stava in cima ai pensieri della Spagna non si sarebbe dovuta prestare più attenzione alla bolla di nomina del suo successore quando fu sottoposta all’exequatur?
Comunque passarono meno di quattro anni ed il 25 maggio 1690 mons. Arata morì compiendo l’ultimo atto di umiltà della sua vita. Chiedendo, cioè, - come racconta il Campis – di essere sepolto nella Cattedrale, ai piedi dei gradini dell’entrata , dalla parte interna della chiesa, in modo da “esser calpestato da tutti quelli che entrassero”[31]
[1] Dopo i problemi vissuti da mons. Gentile la Santa Sede tornò a promuovere su Lipari vescovi siciliani capaci di trovare un modus vivendi con la Real Monarchia siciliana e la scelta cadde su mons. Francesco Arata, appartenente ad una influente famiglia di Palermo. Venne nominato vescovo di Lipari il 13 agosto del 1663 e giunse a Lipari nel gennaio del 1664 con il fermo proposito di tenersi lontano da ogni competizione.
[2] La vicenda la si ritrova nei documenti dell’Archivio Segreto del Vaticano, Sacra Congreg. Concilio R., cass. 456°, ff.147 e 147v e anche i G. La Rosa,op.cit., vol.I , pag. 205 e ss.. Si veda G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IID, pag.57 b1,2,c
[3] ASV,SCCR, Cass.456 A f.178v.
[4] Archivio Segreto Vaticano, SCCR, Cass. 456°, ff.173-173v. La lettera del vescovo Arata è del 10 aprile 1677.
[5] G.Oliva, op.cit. doc.IV, p.36.
[6] La documentazione in ASV, SCCR, Csss. 456°, ff.300-300v.
[7] Lettera del 10 novembre 1679 in ASV, SCCR, Cass.456°, ,f.330.
[8] Mons. Gaetano Castillo, nato a Termini Imerese, teatino, eletto vescovo di Lipari l’8 gennaio 1691all’età di trentatrè anni. Morirà il 22 marzo del 1694 cadendo da una scaletta sul tetto del Palazzo Vescovile.
.[9] Iacolino ritiene che l’accettazione dell’autonomia di Lipari da Messina non sia stato un atto voluto del Tribunale di Palermo ma piuttosto una disattenzione giacchè l’arcivescovo di Messina continuò a ritenere la diocesi di Lipari sua suffraganea ed a chiamare all’appello il vescovo di Lipari il 14 agosto, la vigilia dell’Assunta. Naturalmente questi risultava assente e veniva puntualmente multato ma la multa non veniva mai riscossa. (G:Iacolino, manoscritto, cit. Quaderno IID, pag. 72 a,b.). Comunque dopo il successo del 1691 la Curia romana continuerà a ribadire l’autonomia di Lipari da Messina fino al 1826 quando tornò a considerare i vescovi di Lipari suffraganei di Messina anche se ormai si trattava di un atto formale. La suffraganeità viene definitivamente meno quando nel 1976 la diocesi di Lipari verrà incorporata nell’Arcidiocesi di Messina.
[10] S.Greco, Messina Medioevale e moderna. Dai Normanni ai Borboni, Messina 1998, pag. 285.
[11] Idem, pag. 283.
[12] G.E. Di Blasi, Storia cronologica de’Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1974, vol.III, pag.243-245.
[13] É.Campis, op.cit., pag.338.
[14] Idem, pag. 339.
[15] Idem, p.340.
[16] Quello dell’arrivo miracoloso di vascelli carichi di grano nei porti di città o paesi marinari in quei giorni della grande carestia, non furono rari. Un simile caso, imputato ad un miracolo della Beata Vergine, successe anche a Messina negli stessi giorni ed anche a Messina si fece un vascello d’oro per ricordare l’evento. V. F.Pergolizzi, “Quel famigerato viceré della Sicilia”, in Gazzetta del Sud, 1 aprile 1992. Certo la coincidenza degli arrivi miracolosi e della denuncia dei furti di nave non può non insospettire. Inoltre, al di là del fatto specifico, c’è da chiedersi quanto i liparesi che avevano la fama di sapersi destreggiare nel campo della pirateria marittima fossero rimasti inoperosi in una situazione così confusa e drammatica. Su questi dubbi si veda anche G.Iacolino “E’ arrivato un vascello carico di…” in Gente alle Eolie, Lipari 1994, pp.207-210.
[17] Uno degli episodi che fu all’origine delle sommosse messinesi riguarda un argentiere Giuseppe Martines la cui moglie aveva da poco partorito e lui andava alla ricerca di un pane. Ma in Sicilia, per decreto del viceré, al popolo non poteva esser venduto pane fresco (che invece era privilegio solo dei baroni), ma quello del giorno precedente perché si era convinti – vista la carestia - che dovendo mangiare pane duro se ne limitasse il consumo. Il Martines a cui era stato rifiutato un pane si vide sfilare sotto gli occhi una cesta di quello appena sfornato destinato ai nobili. Infuriato picchiò il garzone e rubò un pane. Sul posto si raccolse una piccola folla che cominciò ad inveire contro il Senato. Accorsero altra gente ed anche alcuni nobili e nel tafferuglio che seguì il Maertines ferì un nobile e si dette alla fuga. L’episodio mette in evidenza il dualismo che si andava formando in città: i nobili e il senato da una parte denominati Malvizzi ed il popolo dall’altra denominati Merli. E siccome con questi si schierò lo stradigoto, i Merli furono intesi come filo spagnoli e i Malvizzi invece come fauturi dell’indipendenza dagli spagnoli. Nell’estate del 1674 i Malvizzi fecero strage di popolani, scacciarono lo stradigoto e fecero allontanare a cannonate il viceré che voleva entrare in porto. Era l’avvio dell’indipendenza della Spagna e per garantirla i messinesi si appellarono ai francesi e furono ben felici di intervenire con le loro navi. Essi fecero la comparsa nei nostri mari il 28 settembre del 1674. (S.Greco, Messina mediovale e moderna, op.cit,. pp.283-300.
[18] Dura fu la vendetta degli spagnoli contro Messina che uscì da questa esperienza distrutta: il Palazzo municipale venne abbattuto e le macerie cosparse di sale; il senato elettivo fu abolito; l’Università e la Zecca chiuse; le campane del Duomo vennero fuse e se ne ricavò una statua equestre raffigurante re Carlo II che schiacciava l’idra della rivoluzione; l’Archivio distrutto e disperso; i cittadini più compromessi fuggirono e la città si ridusse a quasi la metà con non più di 50 mila abitanti.
[19] Campis racconta che fra l’altro il vescovo tutti i giorni aveva un povero a pranzo come commensale ed alla fine del pasto, che condivideva con lui, gli dava anche una elemosina in denaro. I poveri diventavano più d’uno nelle solennità.
[20] Ricordiamo che a carico della Mensa oltre all’ospedale vi erano le spese correnti della Cattedrale; gli stipendi per i cappellani, i canonici, i procuratori legali e gli impiegati delle corti vescovili; le pensioni annuali per i porporati romani; le guardie per mare e sulle alture (Stromboli, Alicudi, Monte Guardia); l’integrazione dei legati per le fanciulle povere da marito, ecc.
[21] Fra questi benefattori il più generoso e assiduo fu Bartolo Russo “il quale quotidianamente lo provedeva di quanto vi fu bisogno sino all’ultimo de’ di lui giorni”(Campis).
[22] P.Campis, pag. 340-341.
[23] ASV, Cass.456 A f. 163.
[24] Vi erano “cerusici” che per rilasciare un certificato di malattia dovevano ricorrere al notaio che sotto il referto faceva apporre un segno di croce attestando che questo apparteneva al “professionista”(G. Iacolino, manoscritto cit. Quaderno IID, pag. 58).
[25] Se un giovane voleva farsi prete chiedeva l’autorizzazione al vescovo che gli indicava alcuni sacerdoti anziani che davano un po’ di rudimenti per una decina d’anni. Di tanto in tanto venivano sottoposti a degli esami e quando erano ritenuti idonei ricevevano gli ordini sacri.
[26] ASV,SCCR,Cass. 456°, ff.179v-180.
[27] E’ singolare che all’annuncio del Sinodo le autorità laiche ed il popolo si appellano al viceré ed al Tribunale della Monarchia ritenendolo “contro il bene comune”. Per fortuna il vicerè e i Tribunale furono di tutt’altro avviso e stigmatizzarono le autorità locali per avere “osato iterferire nella sfera ecclesiastica” (ASV,SCCR, Cass, 456A, f. 177).
[28] La preparazione alla Pasqua durante i quaranta giorni della quaresima.
[29] G. La Rosa, op.cit., Vol.I, pp 211-216.
[30] G.La Rosa, op.cit., Vol.I, pag.220.
[31] P.Campis, op.cit., pag. 344.
Mons. Gaetano Castillo
Il vescovato di Lipari sempre al centro di tensioni
La pratica dello "spoglio" ridesta il conflitto
 Innocenzo X
Innocenzo X
Se durante il vescovato di mons. Giuseppe Candido la tensione pubblica fra il vescovo e le autorità di governo sembra assopirsi essa riprende di nuovo fuoco improvvisamente – segno che la situazione era tutt’altro che tranquillizzata – con il suo successore che era anche suo cugino, mons. Agostino Candido[1]. A dar fuoco alla miccia è la decisione della Nunziatura Apostolica di Napoli di praticare lo “spoglio” in seguito alla morte del predecessore sospettando il lascito di un ingente capitale liquido. Il capitale non si trova ma scoppia un conflitto che si allarga a macchia d’olio chiamando in causa prima il vescovo, che pure aveva tentato di tenersi in disparte, poi i giurati e quindi anche i referenti esterni a cominciare dal viceré di Sicilia sollecitato dai giurati che avevano preso le parti del vescovo, e del Nunzio di Napoli che inviò un suo rappresentante il quale si appellò al capitano d’arme. Infine la vicenda viene portata per ben due volte alla Santa Sede, la prima dal vescovo che era stato sospeso da un procuratore del Nunzio di Napoli, la seconda dai suoi avversari che avevano accusato Mons. Candito di avere ceduto alla Real Monarchia di Sicilia mettendo in discussione il diritto del Pontefice. Ed è nel corso di questo viaggio, dopo aver chiarita la situazione col papa, che mons. Candido muore, nel luglio del 1650, colpito dalle febbri delle paludi romane[2].
Alla fine lo “spoglio” si fece malgrado il nuovo vescovo, mons. Geraci, avesse preso posizione contraria. Questi però seppe trarre insegnamento dalla vicenda e curò, durante il suo governo, di depositare periodicamente presso il banco del Vaticano – garantendone la disponibilità per la chiesa liparese – le somme eccedenti della sua amministrazione.[3]
Comunque la chiesa liparese – al di là di momentanei chiarimenti - continuò a vivere in un intreccio di tensioni e di ambiguità fra Santa Sede, Nunziatura Apostolica di Napoli e Tribunale della Regia Monarchia di Palermo. E che a queste tensioni contribuivano anche gli uffici vaticani lo mette in risalto la lettera che il 19 dicembre 1650 – in occasione della nomina del nuovo vescovo mons. Benedetto Geraci[4] – a nome del papa Innocenzo X veniva inviata all’arcivescovo di Messina. In essa si ripristinava il suo ruolo di metropolita nei confronti del vescovo di Lipari, in aperta contraddizione di quanto aveva disposto Urbano VIII nel 1627 e quindi si ridava fiato alle mire di Palermo di interferire nella diocesi di Lipari. Comunque quest’atto, qualunque ne sia stata la ragione e la causa, rimarrà isolato e la S.Congregazione del Concilio, in futuro, farà sempre riferimento alla bolla di Urbano VIII.[5].
E fu proprio mons. Geraci che sperimentò direttamente come fra la prepotenza della Real Monarchia e le ambiguità e la lontananza della Santa Sede, spazio al vescovo per difendere l’autonomia della sua diocesi ne rimaneva ben poca. Così dovette piegare la testa sulla vicenda dello “spoglio”, ma in qualche modo dovette subire – malgrado le riconferme formali del vaticano della particolare condizione della diocesi nei confronti del regno di Sicilia - anche l’ingerenza del Tribunale della Real Monarchia che nominò un suo commissario a Lipari, ed infine ebbe partita persa nella difesa del “diritto d’asilo” che cercò di far rispettare nelle chiese della sua diocesi ma ricevendo i rimbrotti del viceré[6].
Ma qual è la rendita annua della Mensa vescovile?
 Prima di partire per Roma per effettuare la sua visita “ad Limina”, fissata per i primi mesi del 1660, Mons. Geraci scrive una sua relazione alla Sacra Congregazione del Concilio[7] dove fa il punto sulla situazione economica e finanziaria della diocesi. Egli sostiene che i proventi annui della mensa sono di circa 3 mila ducati di moneta d’argento siciliana quindi ben 1.500 in meno degli introiti dichiarati da mons. Candido. Se poi si pensa che da questi 3000 bisogna sottrarne 1.500 per le pensioni romane[8] e rimanevano da pagare gli stipendi ai due collettori delle decime, i contributi per il mantenimento delle guardie diurne e notturne della Città e delle isole, le elemosine da erogare ai poveri della città alta – dove risiedevano 3 mila abitanti - che erano molti, e a quelli del borgo – che contava 2 mila anime – che erano ancora di più, si poteva capire che le risorse a disposizione del vescovo fossero veramente poche e da qui le lamentele per non potere riparare la cattedrale che mostrava segni di decadimento.
Prima di partire per Roma per effettuare la sua visita “ad Limina”, fissata per i primi mesi del 1660, Mons. Geraci scrive una sua relazione alla Sacra Congregazione del Concilio[7] dove fa il punto sulla situazione economica e finanziaria della diocesi. Egli sostiene che i proventi annui della mensa sono di circa 3 mila ducati di moneta d’argento siciliana quindi ben 1.500 in meno degli introiti dichiarati da mons. Candido. Se poi si pensa che da questi 3000 bisogna sottrarne 1.500 per le pensioni romane[8] e rimanevano da pagare gli stipendi ai due collettori delle decime, i contributi per il mantenimento delle guardie diurne e notturne della Città e delle isole, le elemosine da erogare ai poveri della città alta – dove risiedevano 3 mila abitanti - che erano molti, e a quelli del borgo – che contava 2 mila anime – che erano ancora di più, si poteva capire che le risorse a disposizione del vescovo fossero veramente poche e da qui le lamentele per non potere riparare la cattedrale che mostrava segni di decadimento.
Ma se questo si diceva nella relazione, la realtà doveva essere ben diversa perché risulta che egli avesse messo da parte ben quattordicimila scudi d’oro con i quali intendeva creare un fondo per costituire a Lipari un “monte di Pietà per beneficio delli Popoli di questa Città”. E contava proprio di approfittare della vista “ad limina” per versarlo in una qualche banca romana. E non ne aveva parlato nella relazione perché reso edotto delle travesìe subite al suo insediamento non voleva che questa somma finisse nello “spoglio[9]”.
Purtroppo il viaggio per Roma fu avventuroso e durò un paio di mesi passando per tempeste spaventose. A Roma, qualche mese dopo il vescovo morì e dei quattordicimila scudi d’oro, che era riuscito a salvare dalla tempesta, non si riuscì a sapere che fine avessero fatti[10].
Basiluzzo fa parte delle Eolie?
 L'isolotto di Basiluzzo
L'isolotto di Basiluzzo
Comunque che il vescovo avesse messo da parte una somma cospicua si doveva essere diffusa la voce perché subito , questa volta, partì l’operazione di “spoglio” avallata dal nuovo vescovo, mons. Adamo Gentile[11], che era un napoletano. Ma delle somme sperate non si trovò nulla e si dette sfogo ad una caccia alle streghe con incriminazione di furto ed arresto nei confronti di un povero prete e quindi reazioni delle autorità civili e quindi del viceré di Palermo che mal sopportavano l’accondiscendenza del vescovo allo “spoglio”[12]. Il vescovato di Lipari rimaneva così al centro di tensioni e turbolenze. Anzi mons. Gentile nel poco tempo che fu alla guida della diocesi, riuscì ad unificare contro di sé giurati, governatore, nobili e capitolo della Cattedrale. Sull’onda della vicenda dello “spoglio” l’attenzione del vescovo fu attratta dal cercare di capire dove erano andati a finire i 4.600 scudi annui che dovevano avanzare, fatte tutte le detrazioni, visto che la Mensa percepiva ben 6.600 scudi e non 3.000 come asseriva il suo predecessore. E quindi il prelato era divenuto sospettoso di tutti e pronto a entrare in lite con chi scopriva evadere i censi e le decime. In particolare la sua attenzione si appuntò sui possessori di terreni di Basiluzzo, ricchi borghesi ed ecclesiastici che vivevano a Lipari e nulla pagavano alla diocesi. Il vescovo li diffidò e costoro ricorsero al Tribunale della Regia Monarchia. Ed il tribunale candidamente sentenziò che Basiluzzo non faceva parte del lascito di Ruggero Normanno perché nell’elenco delle isole da questo fatto nel documento, Basiluzzo non compariva. Era chiaramente un dispetto fatto al vescovo liparese giacchè era naturale che Basiluzzo non fosse presente nell’elenco visto che era considerato poco più di uno scoglio e quindi nelle pertinenze di Panarea[13].
[1] Mons. Agostino Candido divenne vescovo il 12 giugno del 1645. E’ sotto il suo governo che ufficialmente tornano i cappuccini a Lipari (anche se probabilmente la decisione era già stata presa l’anno precedente) e si stabiliscono dove ora c’è il cimitero comunale ottenendo il terreno per il convento dal vicario episcopale don Benedetto Gualtieri.
[2] La narrazione puntuale di questo conflitto si trova in G. La Rosa, Pyrologia Topistorigrafica dell’Isole di Lipari, Lipari 1997, Primo volume, pp 186 – 191.
[3] G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IIC, pag. 43.
[4] Mons. Benedetto Geraci venne nominato vescovo di Lipari il 19 dicembre 1650 e morì a Roma , dove era andato in visita ad limina il 13 agosto 1660.
[5] La lettera di Innocenzo X all’arcivescovo di Messina in G.Oliva, Le contese giurisdizionali della Chiesa liparese nei sec. XVII e XVIII, Messina 1905, doc. III, pag.36. In G.Iacolino, manoscritto cit, Quaderno II C, pag 42g,h.i.
[6] Sull’indipendenza della Diocesi si veda G. Oliva, op.cit., pp.97-98 e G. Iacolino, manoscritto cit., pag.43, a, b..Per quanto riguarda il diritto d’asilo si veda G.La Rosa, op.cit. vol.II, pag.110-111. Migliore successo ebbe invece mons. Geraci nel promuovere iniziative devozionali come la nomina di Sant’Agatone a copatrono della diocesi e la Vergine Immacolata a patrona universale delle Eolie. Fece anche consacrare la Chiesa Cattedrale anche se non mancava chi sosteneva che questa fosse già stata consacrata quando fu rimessa in piedi dopo la ruina. Il 28 maggio del 1651 emise un severo “Editto per le magàre” rivelando come i liparesi mischiassero nella loro pietà la devozione dei santi con pratiche di esorcismo e di stregoneria.
[7] Relazione di Mons. Geraci alla S,Congregazione del Concilio del 1659, in Archivio Segreto del Vaticano. Cass. 456 A, ff.133-135,
[8] A carico della diocesi di Lipari che era ritenuta una delle più ricche della Sicilia ogni anno, da oltre un secolo, pendeva l’obbligo di rimettere alla Santa Sede sotto la voce “pensionamento” o stipendio per un paio di cardinali millecinquecento o duemila scudi.
[9] Su queste vicende si vedano i documenti in Archivio Vescovile Lipari, Civili,9. G.Iacolino, Manoscritto cit., pagg. 46 b3,c,d.
[10] G. Iacolino, Gente alle Eolie, Lipari 1994, p.160; G. Iacolino, manoscritto cit.,pag. 46d,47,47°.Mons. Geraci a Roma andava ad abitare presso un amico medico, Terenzio Tornatore, e fu questi che si incaricò delle esequie e su cui si appuntarono molti sospetti per la perdita degli scudi d’oro.
[11] Mons. Adamo Gentile, di Caserta, nominato il 15 novembre del 1660, giunge a Li pari nel maggio del 1661 muore 18 mesi dopo la sua elezione.
[12] G.La Rosa, op.cit., vol.I97-203, vol. II pag. 113-114.
[13] G.La Rosa, op.cit., vol I pag.203, vol.II pag.115-116. La polemica con i canonici si sviluppò a partire dalla richiesta di questi di aumentare la loro prebenda e di regolarizzare il servizio in Cattedrale che lasciava molto a desiderare specie nei confronti delle chiese conventuali. Si discusse anche come reperire i fondi visto che la Cattedrale pretendeva anche lavori di restauro e si arrivò così col parlare degli introiti della Mensa e qui scoppiò il dissidio. I canonici scrivono due lunghe lettre di reclamo – una al viceré e una al Tribunale della Regia Monarchia – dove fra l’altro si accusava il presule di non curarsi del culto divino e del bene spirituale della diocesi e di lasciar deperire la Cattedrale. La risposta del vicerè, comunicata al vescovo e a lui giunta il 7 giugno del 1662, è una dura reprimenda soprattutto per la condizione della cattedrale. Il vescovo – letto il dispaccio – “divenne una vipera che si avventava contro chiunque se li parava d’innanzi, di modo che, non potendo sfogare la sua còlera, se la volle pigliare contro il nostro Glorioso Protettore Apostolo S.Bartolomeo” ed abolì la festa del 17 giugno che scadeva pochi giorni dopo. Ci si immagini la reazione della cittadinanza a cominciare dai giurati. Così quando a metà di novembre mons. Gentile si ammalò e, nel giro di pochi giorni, il 28 novembre morì a solo quarantaquattro anni di età, il giudizio popolare non potè non attribuire questa ad una punizione del Santo.
Mons. Adamo Gentile
Un vescovo diplomatico in un mare di maldicenze
Mons Candido un vescovo che sa destreggiarsi

Urbano VIII
Per evitare gli eccessi di mons. Caccamo, nella scelta del successore la Santa Sede si muove con molta prudenza e preferisce puntare su un siciliano di Siracusa che però aveva studiato e risiedeva a Roma presso il papa - era maestro del Sacro Palazzo Apostolico - di cui spesso condivideva la mensa. Quindi un uomo di tutta fiducia per cercare di portare in porto l’obiettivo che ha in mente la Santa Sede, rendere la diocesi di Lipari autonoma, dipendente unicamente da Roma e potere da lì sferrare l’attacco alla Legazia Apostolica, ma operando in questa prospettiva con grande prudenza senza perdersi in scontri personali e di sapore locale come era accaduto al Caccamo. Era questi mons. Giuseppe Candido che il 29 novembre del 1627, quando è nominato vescovo di Lipari, ha appena trantacinque anni. Il nuovo vescovo arriva a Lipari con due bolle in tasca: quella di nomina che prudentemente – anche lui come il suo predecessore – sottopone all’exequatur del viceré di Palermo ed un’altra, del dicembre 1627, che doveva tenere segreta e conteneva la dichiarazione di Urbano VIII che la Chiesa di Lipari era immediatamente dipendente dalla Sede Apostolica e quindi libera da ogni autorità e giurisdizione compresa quella del metropolitano di Messina[1]. Segreta doveva essere la bolla per tutti ma non per l’Arcivescovo di Messina che ne era stato messo a conoscenza dallo stesso pontefice. Purtroppo dopo circa un anno anche questa bolla diventa pubblica in seguito ad un incidente. Un soldato, colpito da scomunica da parte del vescovo, ricorre in appello e la causa viene inoltrata a Messina ma l’Arcivescovo, con riferimento alla bolla, si dichiara incompetente. La notizia scatena non poche polemiche. Il re ed i loro funzionari si sentono colpiti nelle loro prerogative giacchè a questo punto tutte le cause giudicate dal Vescovo in appello devono andare direttamente a Roma Ma protestano anche i liparesi per cui questa scelta provocava “tanti dispendij e lungarìe” per cui mandano a Madrid un loro incaricato, designato dai giurati, don Tommaso Policastro a perorare la loro causa[2]. Ma le proteste del re e l’impegno dell’ambasciatore spagnolo non ebbero alcun effetto e con due rescritti del 9 novembre 1631 e del 21 dicembre 1635 la Sacra Congregazione confemava che “Liparensem Episcopum Sedi Apostolicae subiectun”.
 Luigi Guglielmo Moncada viceré di Sicilia
Luigi Guglielmo Moncada viceré di Sicilia
Quindi al povero vescovo veniva lasciata una difficile incombenza, quella di rimanere fermo sul principio e nell’ubbidienza alla Santa Sede ma al tempo stesso sapersi muovere con prudenza e diplomazia. E dovette farlo molto bene mons. Candido da ottenere, allo stesso tempo, lode ed approvazione dalla Real Corte e dal papa[3].
Comunque se riesce a destreggiarsi bene con i militari e le autorità di Palermo e di Lipari, Mons. Candido non riesce ad evitare il vezzo - che era un po’ generalizzato, ma nelle isole trovava maggior diffusione forse a causa dell’isolamento e della limitatezza dell’ambiente che finiva con l’enfatizzare luci ed ombre e spesso le ombre più delle luci – della maldicenza e della denigrazione affidata ad una lettera. Mons. Candido fu preso di mira da un gruppo di professionisti e comunque di gente in vista della città che, a partire dal 1639, cominciarono a divulgare sul suo conto critiche e calunnie portandole a conoscenza del viceré e poi anche a Roma alla Sacra Congregazione del Concilio. Fra le altre accuse vi era quella di aver utilizzato a proprio vantaggio il lascito di Mons Vidal, di cui abbiamo detto, per regalare ogni anno il vestiario a persone bisognose dell’uno o della’altro sesso avendo ecceduto nel protagonismo sia pretendendo che o poveri andassero a farsi misurare i vestiti in Palazzo vescovile in sua presenza, sia che poi – una volta ultimati- andassero a ritirarli dalle sue mani mentre se ne stava sulla sedia gestatoria. Una prassi che i delatori giudicavano la causa per cui “molte persone vergognose e meritevoli, essendo di famiglie onorate e bennate, lassano di piglare il detto legato per non comparire pubblicamente e pigliare detta elemosina”[4].
A tutte le accuse il Candido risponde serenamente e puntualmente, ma oltre a lui lo fanno ben venticinque canonici liparesi con una dichiarazione del 15 aprile 1642 che più che una difesa è una attestazione di affetto e di stima per il loro vescovo. E certamente non aveva bisogno di essere difeso a Roma dove era conosciuto e stimato tanto che quando il 15 settembre 1644 viene eletto papa il prefetto della S.Congregazione del Concilio il card. Giambattista Pamphili col nome di Innocenzo X non meraviglia che questi volle mons. Candido a suo fianco a Roma e lo nominò governatore della città[5].
Durante il suo governo che durò dal 1627 al 1644 mons. Candido si distinse per aver ulteriormente migliorato le entrate della diocesi che dai 3 mila scudi del 1626 arrivarono sino a 4.500 scudi. E fu proprio grazie a queste entrate che riuscì – malgrado le dicerìe dei detrattori - a finanziare diverse opere a cominciare dalla Cattedrale dove, per prima cosa, provvide a ricollocare il soglio vescovile all’interno del coro dove era prima dell’intervento di mons. Caccamo. Ma non si limitò certamente a questo: “La Chiesa cattedrale che era vecchia e brutta e che minacciava di andare in pezzi, è stata da me consolidata, interamente biancheggiata, fornita di finestre di vetro e arricchita di nuove cappelle[6]”. E fra l’altro si deve a lui la creazione della cappella del battistero con un artistico fonte battesimale.
Gli anni della carestia e dei tumulti

Innocenzo X
In quegli anni Lipari era cresciuta e contava complessivamente 5 mila abitanti di cui settecento risiedevano permanentemente nel borgo. Questo numero però aumentava di molto durante l’estate quando la gente abbandonava la città alta perché vi faceva troppo caldo e cercava refrigerio in ville e casalini fuori dalle mura. C’era quindi bisogno che si costituisse “una filiale sacramentale” della cattedrale anche perché le porte della città alta chiudevano al tramonto e diveniva impossibile accedervi. Così fu scelta la chiesetta di San Giuseppe di cui fu iniziato l’ampliamento e dove , dal 1929 in poi, si poterono celebrare tutti i sacramenti escluso i battesimi.
Il buon andamento delle finanze della diocesi certamente dovette influire positivamente anche sulle vocazioni perché se nel 1610 i preti, compreso i canonici, erano 28, con 3 diaconi, un suddiacono e 12 chierici, nel 1642 erano divenuti 44 con 4 diaconi , 3 suddiaconi e 17 chierici ed ogni anno vi erano lasciti per la celebrazione di più di 7 mila messe quasi tutte da farsi in Cattedrale, cioè una media di ben venti messe al giorno e si può quindi capire come mai il vescovo si lamentasse che “il solenne sacrificio della Messa viene celebrato precipitosamente, disordinatamente e con grandissimo scandalo”[7].
Comunque non erano tempi facili quelli per i liparesi in genere perché non era raro che nelle isole venissero a mancare le derrate alimentari. Il grande terrore oltre ai pirati era quello della peste. Bastava che si diffondesse la voce che in qualche parte del Mediterraneo fosse scoppiata una pestilenza perché i porti dei regni di Napoli e di Sicilia si chiudessero all’approdo alle navi che non offrivano garanzie. I commerci si bloccavano e con i commerci non circolavano più i grani che era la derrata alimentale fondamentale. Che voleva dire offrire garanzie? Le navi dovevano munirsi di certificati rilasciati dagli ammiragliati che attestavano lo stato di sanità della nave e dei paesi da cui provenivano. Ma non sempre questi certificati erano accettati come attendibili nei porti di arrivo.
I LIparesi contro Masaniello e fedeli alla monarchia


A sinistra, i tumulti a Napoli capeggiati da Tommaso Aniello. A destra, Masaniello arringa la folla
Nel 1647 a causa di una ostinata siccità che provocò mancanza di frumento, si ebbero tumulti e ribellione a Napoli e Palermo con richieste che assunsero un significato politico perché chiedevano l'abolizione della gabelle e la partecipazione del popolo alle municipalità. I rivoltosi di Palermo e di Napoli – questi ultimi guidati da un certo Tommaso Aiello meglio conosciuto come Masaniello - si collegarono fra di loro e si scambiavano informazioni tramite navigli che passavano per le Eolie. L’obiettivo dei rivoltosi palermitani era quello di liberare la Sicilia dal dominio spagnolo e proclamare la repubblica. In questa occasione i liparesi rimasero fedeli alla monarchia spagnola e riuscirono diverse volte a bloccare questi collegamenti trasmettendo i messaggi dei rivoltosi ai Vicerè di Napoli e della Sicilia. Fra l’altro i navigli liparesi catturarono una feluca che da Napoli si dirigeva a Palermo con la quale i ribelli di Napoli segnalavano di fermare sei vascelli carichi di grano per evitare che cadessero nelle mani degli spagnoli che avevano bloccato il porto di Napoli.
Don Giovanni d’Austria, figlio del re Filippo IV che comandava l’armata navale spagnola inviò al capitano d’arme ed ai giurati di Lipari il 26 ottobre 1647 una lettera di plauso.
La carestia continuò per parecchio tempo, fino al 1648, e don Giovanni d’Austria assunse la carica di viceré di Sicilia. Se ne avvantaggiarono i liparesi che il 12 maggio del 1649 ottennero la diminuzione della tassa del censo.

Don Giovanni d'Austria al centro.
[1] Ughelli, Italia sacra, tomo I, foglio 784, in L. Zagami, op.cit., pag. 242.
[2] G. Oliva, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese, Messina 1905, doc.I, pag. 33. G. Iacolino, manoscritto cit, pag.38b.; L. Zagami, op.cit., pag, 242-3.
[3] G. Iacolino, manoscritto cit., pag. 38c.
[4] La documentazione di questa vicenda comprendente le lettere dei delatori e le risposte del vescovo e la lunga nota dei canonici a sostegno del vescovo, si trovano in Archivio Segreto Vaticano, Sacra Congr. Cons. Relat., Carp. Liparen., 456°, ff.99 e ss.; G.. Iacolino. manoscritto cit., pag. 40 g-o.
[5] Purtroppo Mons. Candido morì il 9 dicembre del 1644 a Roma dove si era trasferito da poche settimane affrontando in autunno il viaggio per mare che poco sopportava tanto che negli ultimi sedici anni non si era mai mosso da Lipari nemmeno per le visite “ad limina” al papa che i vescovi devono fare ogni tre anni.
[6] Arch.Segreto del Vaticano, Cass. 456 A, f. 93v), G. Iacolino, manoscritto. Cit., pag. 39 b.
[7] Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456°, ff. 54v e53. G. Iacolino, manoscritto. Cit., pag. 39.
Tommaso Aiello
La devozione alla Madonna del Terzito
La madonna del Terzito
 Nel periodo in cui Mons. Caccamo era vescovo di Lipari, il 23 luglio del 1622, a Salina, quell’Alfonso Mercorella che abbiamo già conosciuto, mentre era impegnato a disboscare il pianoro che collega Malfa a Leni per poter mettere i terreni a coltura, giunto ai piedi del Monte dei Porri sente un misterioso suono di campanella che si ripete tre volte e che lo porta a scoprire il rudere di un’antichissima chiesetta che risaliva al VII secolo, dedicata, come abbiamo già visto, alla Vergine Maria[1].
Nel periodo in cui Mons. Caccamo era vescovo di Lipari, il 23 luglio del 1622, a Salina, quell’Alfonso Mercorella che abbiamo già conosciuto, mentre era impegnato a disboscare il pianoro che collega Malfa a Leni per poter mettere i terreni a coltura, giunto ai piedi del Monte dei Porri sente un misterioso suono di campanella che si ripete tre volte e che lo porta a scoprire il rudere di un’antichissima chiesetta che risaliva al VII secolo, dedicata, come abbiamo già visto, alla Vergine Maria[1].
Col tempo la fantasia popolare amplificò questo fatto del ritrovamento dei ruderi e si disse che il Mercorella non avrebbe solo sentito il campanello ma anche visto “una bellissima Donna vestita di color azolo, con un velo bianco sul capo, e con un campanello nella mano destra, che fissamente lo mirava”, si parlò di una lampada che rimase accesa per ben tredici anni senza che le fosse somministrato olio, di un giovane cieco dalla nascita che facendo visita al santuario acquistò la vista[2]. Lo stesso Campis, parlando dell’episodio, fa propria un’altra voce nata dalla fantasia popolare, che il Marcorella insieme ai ruderi avrebbe trovato anche un vecchissimo quadro della Vergine che fu fatto a pezzi dalla devozione popolare “trasportata da eccessivo affetto” per farne reliquie[3]e, rifacendosi al Campis, la versione del ritrovamento dell’immagine, è riportata nella lapide che nel 1901 fu posta nel vestibolo del Santuario. .
In realtà, come fa notare Giuseppe Iacolino, Rocco Pirri[4] che scrive prima del Campis, nel 1640 dice chiaramente che fu nel VII secolo che “per divina ispirazione, fu trovata la celebre immagine di Maria”, e ciò apparirebbe da antichissimo documenti che si conservano presso alcuni cittadini di Lipari appassionati di antichità.
Più che ad un miracolo si pensa a valorizzare i terreni
 E’ un fatto che nell’immediato non dovette fare molto scalpore questo episodio del Terzito riproposto dal Mercorella nel 1622 visto che mons. Caccamo non ne parla nei suoi scritti, né si soffermano su questo episodio altri storici della chiesa liparese[5]. Il Mercorella, che come abbiamo visto era impegnato a titolo proprio ed anche per conto del vescovo, nella valorizzazione di quei terreni fu il promotore della ricostruzione della chiesa[6] . Era quello il tempo, dopo il concilio tridentino, di un forte rilancio e sviluppo della devozione per i santi ed in particolare la devozione mariana. In Sicilia culti legati ad apparizioni o eventi miracolosi si sviluppavano a Tindari, Caltagirone, Capo d’Orlando, Palermo. Nella stessa Lipari erano arrivati i culti della Madonna di Loreto a Quattropani, del Nome di Maria a Pirrera, dell’Assunta a Serra. E col tempo anche la madonna di Tindari si impose all’attenzione ed alla devozione degli eoliani.
E’ un fatto che nell’immediato non dovette fare molto scalpore questo episodio del Terzito riproposto dal Mercorella nel 1622 visto che mons. Caccamo non ne parla nei suoi scritti, né si soffermano su questo episodio altri storici della chiesa liparese[5]. Il Mercorella, che come abbiamo visto era impegnato a titolo proprio ed anche per conto del vescovo, nella valorizzazione di quei terreni fu il promotore della ricostruzione della chiesa[6] . Era quello il tempo, dopo il concilio tridentino, di un forte rilancio e sviluppo della devozione per i santi ed in particolare la devozione mariana. In Sicilia culti legati ad apparizioni o eventi miracolosi si sviluppavano a Tindari, Caltagirone, Capo d’Orlando, Palermo. Nella stessa Lipari erano arrivati i culti della Madonna di Loreto a Quattropani, del Nome di Maria a Pirrera, dell’Assunta a Serra. E col tempo anche la madonna di Tindari si impose all’attenzione ed alla devozione degli eoliani.
[1] Quella del 1622 viene intesa come la terza ricostruzione del Santuario. La prima cappellina risale al V secolo quando un santo monaco eremita, anche per contrastare il culto di Demetra che continuava a sopravvivere fra i contadini che lavoravano a Salina ed in particolare in quel fertilissimo pianoro, volle edificare questo punto di richiamo religioso e dipinse o disegnò anche una immagine della vergine. La cappellina andò in rovina e venne ricostruita nel VII secolo e fu allora che venne riscoperta l’immagine della madonna che il monaco aveva dipinta.
[2] Alcuni di questi episodi ed altri ancora sono raccolti in fascicoletti devozionali circolati nel secolo scorso come “Breve storia del Santuario della Madonna del Terzito che si venera a Val di Chiesa (Salina), a cura del Cappellano Curato Sac. D. Francesco Costa, Messina 1924.
[3] P.Campis, op.cit., pp 66-67.
[4] R.Pirri, Sicilia Sacra, Liparensis Ecclesiae Notitia VIII, p.951.
[5] Iacolino fa notare che all’episodio del 1622 non danno alcun risalto né il Pirri, né La Rosa, né Rodriquez. In “La Chiesa Cattredrale…, manoscritto cit. Quaderno IIB, pp.33-39.
[6] Su dove ricostruire la chiesa, se nel luogo indicato dal Mercorella o a quota più bassa, sul ciglio del sentiero che percorreva il fondovalle come voleva qualcun altro che affermava di avere trovato lì i veri ruderi della antica chiesetta, ci fu a suo tempo discussione ma prevalse la tesi del Mercorella, mentre il suo contestatore fece erigere una edicola nel luogo da lui indicato ( G.Iacolino, op,cit., pag. 34).
Un'icona del VII secolo
Il vescovo che uccise il capitano d'arme
Mons. Caccamo, un vescovo prevenuto

Lo scranno (come appare oggi) che scatenò le ire di Mons. Caccamo
Che la ragione di scegliere come successore di mons. Vidal un domenicano di Palermo, teologo e consultore dell’Inquisizione, segnalato alla S.Sede dal viceré di Sicilia don Francesco di Castro che lo conosceva e lo stimava perché confessore della suocera, fosse quella di stemperare il clima e di andare su una personalità gradita al regno di Palermo, è più che probabile. Ed infatti il primo atto del nuovo vescovo fu proprio un atto di deferenza verso il viceré sottoponendo la bolla della sua nomina alla visione del Tribunale della Regia Monarchia che concesse l’exequatur cioè il gradimento. Nominato il 2 aprile del 1618 il Caccamo prede possesso della diocesi tramite un suo procuratore, Alfonso Mercorella, mentre giunge a Lipari solo in estate.
Che non fosse venuto a sedare gli animi ed promuovere la pace lo si comprese subito dal suo primo atto. La prima cosa che vide entrando in cattedrale – tre giorni dopo il suo arrivo - fu lo scanno delle autorità laiche, spazioso e imponente, che attirava gioco forza l’attenzione dei fedeli mentre il soglio vescovile era relegato dentro il recinto del coro. E così immediatamente decide di dare lo sfratto ai giurati e al capitano d’arme, “ruppìo pezzi pezzi detta seggia”, e colloca al posto del loro scranno “una seggia altissima di sei scaloni per sedere lo stesso Vescovo”[1].
Comunque nei giorni seguenti, venuto a più miti consigli, mons. Caccamo fa ricostruire il seggio giuratorio ma colloca, di fronte a questo, un proprio seggio anch’esso di legno creando in una chiesa che aveva allora solo la navata centrale una strozzatura che intralciava le funzioni.
Questo atteggiamento risentito nei confronti delle autorità dell’isola che ebbe sfogo contro lo scranno in Cattedrale probabilmente fu originato dal fatto che trovò il Palazzo Vescovile per gran parte inabitabile e per l’altra parte occupato da uffici del municipio e dai soldati per cui era stato costretto a prendere alloggio nel casalino fuori città “con evidente pericolo di cadere in mano ai privati”, come egli stesso ebbe a scrivere.[2] .
 Il vecchio Palazzo Vescovile oggi sede del Museo Archeologico
Il vecchio Palazzo Vescovile oggi sede del Museo Archeologico
Comunque che nell’animo di mons.Caccamo non ci fosse solo un risentimento nei confronti delle autorità locali ma la convinzione profonda che a lui toccasse combattere una santa battaglia contro le ingerenze dei laici e la riaffermazione della preminenza del vescovo sulla città e le isole, lo si vide dagli atti conseguenti a cominciare dai tentativi –non riusciti – di sganciarsi dalla suffraganeità verso l’Arcidiocesi di Messina. Trovata sbarrata questa strada anche per l’intervento del viceré, l’azione del vescovo si concentrò nel resistere alle richieste della Regia Monarchia a cominciare dal rifiutarsi di trasmettere gli atti dei processi tenuti a Lipari[3] perché si potessero celebrare, presso il Tribunale di Palermo, i giudizi d’appello. In questa resistenza la Corte di Lipari trovò alleata la Corte arcivescovile di Messina che o non dava corso al processo di revisione o si muoveva con lentezza eccessiva, tanto che il governo di Sicilia col consenso del re decise di inviare a Lipari quello che oggi si chiamerebbe un “ispettore”, cioè un delegato dal giudice della Monarchia, l’abate Rocco Pirri, dottore in teologia e diritto, che nel 1647 sarebbe divenuto famoso pubblicando “Sicilia Sacra”, la storia della chiesa nella regione.
L'ispezione del Pirri
Il Pirri arriva a Lipari con una lettera delegatoria e per giorni e giorni - anche grazie all’assenza del vescovo che si trovava a Roma - può operare nella Curia, interrogare persone, eliminare editti e carte che contenevano anatemi contro l’istituto della Regia Monarchia. Certamente incontrò anche il Capitano d’arme a cui raccomandò che nelle isole si rispettassero gli ordini della regia Monarchia e del suo tribunale.
Non sembra però che il risultato di questa ispezione abbia influito sul comportamento di mons. Caccamo che continuerà a restare fermo nella sua posizione intransigente sull’immunità e’indipendenza della sua diocesi. Aumenterà però la vigilanza dei Capitani d’arme nei confronti del Prelato e questo renderà i rapporti ancora più esasperati.
 Una nedaglia dedicata all'abate Rocco Pirri.
Una nedaglia dedicata all'abate Rocco Pirri.
Intanto il vescovo pensa anche alle finanze della diocesi e parte col rivendicare il diritto del vescovo ad autorizzare chi vuole andare nelle isole per coltivarle, cacciare, prelevare frutti e legna e ricordando che al vescovo spetta, in tutte le isole, una imposta chiamata “laudemio” - dal latino laudare cioè approvare –consistente in una percentuale sui trasferimenti che avvengono da una persona all’altra. Una particolare attenzione il vescovo dedica all’isola di Salina per valorizzare circa metà del territorio a ridosso del Monte delle Felci, verso ponente, che dovrà essere disboscato e destinato a colture redditizie attraverso contratti di enfiteusi. E’ nella redazione di questi contratti che emerge, come testimone di molti di essi, un personaggio, Alfonso Mercorella, che abbiamo incontrato come procuratore del vescovo nel suo insediamento a Lipari e che diventerà uno dei più facoltosi possidenti di Salina.
Il vescovo si scontra con i possidenti
Nel procedere in questa operazione dei nuovi contratti di enfiteusi il vescovo si imbatté in numerose persone che risultavano senza titolo nel possesso del terreno e non pagavano il censo alla chiesa e siccome egli partiva dal presupposto che Salina, come tutte le isole, fosse di proprietà della chiesa ritenne che si trattasse di abusivi e intimò loro l’esibizione dei documenti pena l’esproprio. La decisione scatenò forti proteste e molti di questi proprietari veri o presunti, quasi tutti residenti a Lipari, ricorsero avanzando due obiezioni: i titoli non esistono perché con la “ruina” sono andati persi o negli incendi o nella deportazione inoltre se il vescovo rivendica la proprietà di tutte le isole come mai allora di Lipari possiede solo alcuni terreni e la gran parte hanno invece dei proprietari? Per questo si chiede di fare a Roma delle verifica negli uffici degli “spogli” per trovare qualche inventario antico e comunque verificare cosa percepivano di censo i vescovi prima della “ruina”[4].
Il ricorso contiene inoltre tutta una serie di notizie - alcune forse veritiere ma diverse probabilmente esagerate o false perché contraddittorie - sull’operato del vescovo col chiaro intento di metterlo in cattiva luce come persona avida, poco attenta al bene delle anime, che trascura i luoghi di culto.
Non si hanno riscontri sull’esito di questa protesta in ordine ai terreni di Salina ma il fatto è che Caccamo continuò a stipulare contratti aumentando il numero dei residenti e triplicando le entrate della Mensa.
Ed è grazie a queste entrate che egli può mettere mano al casale di Lipari che ormai è divenuta la sua sede, restaurandola ed ampliandola, promuovere lavori nella Cattedrale e procede all’erezione o ampliamenti di chiese ed oratori nella stessa isola di Salina.
La colonizzazione di Salina scatena un conflitto fra i poteri locali
 Ma proprio la colonizzazione di Salina diventa causa di attrito del vescovo col capitano d’arme Pedro Jurato, tipo borioso ed esibizionista, che voleva intromettersi nel progetto di valorizzazione forse per perseguire qualche utile personale. Il fatto è che le pretese del capitano dovettero farsi molto insistenti tanto che Caccamo perse la pazienza e si rivolse al viceré che intervenne ordinando al capitano di “non molestare li beni della Chiesa”[5] Cosa che Pedro Jurato non dovette accettare di buon grado e così la tensione fra il vescovo e i militari aumentò e questo anche quando cambiò il capitano d’arme e a don Pedro Jurato successe don Pedro Manpasso.
Ma proprio la colonizzazione di Salina diventa causa di attrito del vescovo col capitano d’arme Pedro Jurato, tipo borioso ed esibizionista, che voleva intromettersi nel progetto di valorizzazione forse per perseguire qualche utile personale. Il fatto è che le pretese del capitano dovettero farsi molto insistenti tanto che Caccamo perse la pazienza e si rivolse al viceré che intervenne ordinando al capitano di “non molestare li beni della Chiesa”[5] Cosa che Pedro Jurato non dovette accettare di buon grado e così la tensione fra il vescovo e i militari aumentò e questo anche quando cambiò il capitano d’arme e a don Pedro Jurato successe don Pedro Manpasso.
Si sviluppano così una serie di episodi che trasformano l’animosità in fatti incresciosi dove, pur nel contrasto delle diverse versioni, è possibile comprendere che si fronteggiano l’arroganza e la prepotenza del capitano d’arme e della guarnigione militare da una parte e la superbia ostinata - a cui si aggiungeva un temperamento impulsivo che arrivava fino alla perdita di controllo sui propri comportamenti - di un vescovo che si riteneva il signore a cui doveva essere riconosciuto il “diretto Dominio e Patroneggio delle isole” e bollava come “figlioli de iniquità[6]”coloro che abusavano del patrimonio terriero della diocesi e non versavano né censi né decime.
Ed è proprio nell’estate del 1623 che si verificano una serie di fatti dove entrano in conflitto le competenze di due autorità, il vescovo e il capitano d’arme, in campo giudiziario ma che finiscono coll’essere così sproporzionati e spropositati che si possono spiegare solo con i particolari temperamenti dei due personaggi. Il capitano d’arme, don Pedro Manpasso - per perseguire dei servi del vescovato, in un crescendo di reazioni e controreazioni - arriva a mettere in stato d’assedio la città alta impedendo di fatto a Mons. Caccamo di abbandonarla per tornare alla sua abitazione, minacciando di arrestare ecclesiastici e laici che lo accompagnavano.. Il vescovo di fronte alla violazione delle proprie competenze e ad azioni che giudica gravissime sopraffazioni, reagisce non soltanto con la scomunica ma col vietare agli ecclesiastici di confessare e di assolvere i militari, persino in “articulo mortis” e privando il cappellano del presidio della possibilità di amministrare i sacramenti[7] .
Indubbiamente questi episodi si ritorcono in modo particolare contro il vescovo che è sempre più isolato e inviso non solo ai militari ma anche ai nobili ed alle autorità civili, e gli uni e gli altri, inviano “informative” al re ed al papa. E le proteste dovettero andare a buon fine perché il papa Urbano VIII lo richiamò a Roma. Mons. Caccamo che negli ultimi tempi era divenuto sempre più permaloso ed irascibile reagì malamente a quest’ordine e ritenendo che la responsabilità del suo allontanamento fosse soprattutto del capitano d’arme, lo fece convocare ed al culmine di una violenta discussione lo colpì con un coltello ferendolo mortalmente[8]. A Roma il papa lo fece confinare in carcere dove morì il 9 agosto del 1627.
[1] Da un esposto di liparesi al Santo Padre, in Arch. Vesc. Di Lipari, Carp. Civili 7. il documento che contiene altre lamentele ha per titolo “Li pretendentij del Vescovo Caccamo contro questa Città de Lipare”. La versione del vescovo è in Archivio Segreto Vaticano, Relazione di mons. Caccamo del 1631 circa, Cass. 456 A, f. 46v; in G. Iacolino, La Chiesa Cattedrale, manoscritto cit., Quaderno IIB pag. 37 d,e,f.
[2] ASV; Relazione di mons. Caccamo, cit. A proposito del Palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale al tempo del vescovo Vidal il Campis scrive che era “ridotto il tutto in frantume di fabrica non abitabile, sol poche stanze restano ad uso del Prelato, e queste esposte nell’estate al caldo intollerabile”(op.cit, p.324). Probabilmente erano quelle poche stanze che negli unici mesi di assenza del vescovo, erano state occupate dai funzionari del municipio e dalle guardie.
[3] Fra gli atti processuali di quegli anni che la Corte vescovile di Lipari si rifiutava di trasmettere a Palermo per l’appello vi era il ricorso contro la scomunica inflitta dal vescovo a Giovanni Maria Israeli che aveva avuto la colpa di avere preso le parti del proprio fratello, il prete don Tommaso, mentre veniva arrestato nella Cattedrale per ordine dello stesso vescovo giacchè, don Tommaso, subcollettore del legato pontificio di Napoli , aveva avuto l’ardire di richiedere 2000 scudi da devolvere al Nunzio e alla camera Apostolica per lo”spoglio” successivo alla morte di mons. Vidal. Era, quello dello spoglio, una antichissima consuetudine per cui i vescovi non potevano disporre, per testamento, del superfluo dei loro redditi beneficiali. Questo superfluo, all’atto della morte del presule, doveva essere individuato e quindi devoluto alla Camera Apostolica. A chi spettava questo compito? In Sicilia, eccetto Lipari fino a prima dell’unione, era il viceré o il giudice della monarchia di Palermo che, per mezzo di suoi emissari, compiva questa operazione per conto della Santa Sede mentre nelle diocesi dipendenti dal viceré di Napoli era il legato pontificio di Napoli che mandava funzionari di sua fiducia. Anche se i beni andavano sempre alla Santa Sede l’importanza di chi materialmente compiva l’operazione stava nel fatto che a questi – e quindi allo Stato per cui operava ed a tutta una catena di funzionari - andava un largo margine di utile. E non si trattava di utili di poco conto perché quando ( si trattava di un diritto non sempre esercitato) lo “spoglio” veniva fatto esso era così meticoloso e fiscale che prosciugava i fondi delle mense vescovili.
Quindi si trattava di una operazione che in loco non veniva vista di buon occhio e suscitava sempre molte critiche e rancori sia da parte del clero locale che del vescovo di nuova nomina che la vivevano come una aggressione alle proprie risorse. E siccome, per l’esecuzione di questo istituto, Lipari continuò a dipendere da Napoli e il legato pontificio di Napoli, per questo “spoglio” aveva nominato come suo delegato, sub collettore si diceva, un prete liparese, don Tommaso Israeli. Su di lui si scatenò l’ira del vescovo che fu arrestato, maltrattato e sbattuto in un “damuso obscuro”appena finita la messa cantata con ancora indosso tutti i paramenti. Parimenti l’arresto ma con sequestro di beni e scomunica toccò a Giovanni Maria che aveva cercato di difendere il fratello protestandone l’ innocenza. (Archivio Vescovile di Lipari, Esposto di Giovanni Maria Israeli carp. 7 civili. In G:Iacolino, La Chiesa Cattedrale, manoscritto cit. Quaderno IIB, pag.13).
[4] Archivio Vescovile di Lipari, Carp. Civili 7; v. G.. Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, Quaderno IIB, manoscritto, cit. pp 21-23.
[5] L.Genuardi e L.Siciliano, Il Dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’isola di Lipari, Acireale 1912,p.81, in G.Iacolino, manoscritto cit., pag. 27.
[6] Archivio.Vesc. di Lipari,Editto del 1624, Carp. Civili 7.
[7] In quella estate del 1623 dovettero verificarsi due diversi episodi che fecero scoppiare il conflitto di interessi fra il vescovo ed il capitano d’arme. Il primo, sul finire dell’estate, in cui un isolano invasato aggredisce prima degli ecclesiastici e poi il capitano d’arme. In quale prigione doveva essere rinchiuso questo soggetto? Nelle carceri del vescovo o in quelle del presidio militare? Qui la relazione al re di un tale Gilberto funzionario di Milazzo parla di una reazione inconsulta del vescovo che in abiti pontificali e accompagnato dai canonici con i paramenti della messa scomunicò il capitano e andò in processione per la città alta “con atti e con parole ingiuriose maltrattò il detto Capitano”.Sempre secondo Gilberto il Capitano avrebbe scongiurato il vescovo in ginocchio di evitare lo scandalo ma il vescovo in sovrappiù, tolse alla guarnigione la possibilità di accedere ai sacramenti. Relazione di Gilberto di Milazzo al re del 6 settembre 1623.( Archivio Generale di Simanca, Legajo 1895, n.23. in G. Iacolino, La Chiesa cattedrale, manoscritto cit., pag. 40). Non mettiamo in dubbio che ci sia stato anche questo episodio, ma i documenti che si conservano nel vescovato di Lipari si riferiscono ad un episodio accaduto il 27 luglio sempre del 1623 il cui abnorme appare soprattutto il comportamento del capitano d’arme. A scatenare il conflitto sarebbe una partenza dei servi del vescovato da Lipari, per degli acquisti in Sicilia, senza “licenza ‘uscita” contando sulla consuetudine che i famigli del vescovo ne erano esentati. Il capitano giudica la trasgressione gravissima e persegue uno dei due servi fino dentro la Cattedrale violando il diritto d’asilo che vigeva per i luoghi sacri. E’ a questo punto che Mons. Caccamo vuole fare valere la sua autorità scatenando reazioni durissime e impensabili fino a isolare il vescovo, gli ecclesiastici ed i famigli in cattedrale e negli alloggi dissestati del Palazzo Vescovile. Infatti il capitano ordinerà ai suoi soldati di guardia che se il vescovo voleva andar via era libero di farlo ma preti e servi sarebbero stati arrestati ed inviati a Palermo in catene. A questa dichiarazione, il vescovo che vestito dei paramenti, in processione con il clero e i servi era giunto al posto di guardia grida ad alta voce “ Siatemi testimonij che lo Capitan d’arme mi tiene carcerato con i miei creati et clero dentro la Città et non mi lassa andare al mio palazzo fuori Città” . E fatto dietro front se ne tornò processionalmente alla Cattedrale.( La documentazione di questo episodio con ben 14 testimonianze si trova nell’Archivio Vescovile di Lipari, Processi criminali, busta n. 3,1, carp. 33, f. 408 e ss). Con ogni probabilità, il divieto di prestare i sacramenti alla guarnigione, dovette avvenire dopo questo episodio che non sappiamo se sia giunto e come a conoscenza del re del papa.
[8] L. Zagami, op.cit., pag. 241-2.
L'abate Rocco Pirri
Il nodo della Legazia Apostolica
Lipari nella Legazia Apostolica
 Filippo III di Spagna
Filippo III di Spagna
Uno degli obiettivi del re Filippo III nell’aggregare le Eolie alla Sicilia distaccandole dal regno di Napoli – abbiamo detto - era quello di ricondurle nell’alveo della Legazia Apostolica di cui godeva il regno di Sicilia.
Era la Legazia Apostolica un istituto che risaliva a papa Urbano II ed alla bolla Quia propter prudentiam tuam del 5 luglio 1098. In essa si diceva: “Noi non stabiliremo, nel territorio di vostra pertinenza, alcun legato della Chiesa di Roma senza il volere ed il consiglio vostro. Che anzi tutte le cose che Noi intendiamo fare tramite un legato vogliamo che siano fatte dalla vostra opera come vice legati quando dal Nostro lato le commetteremo a voi per la prosperità delle Chiese che sono sotto la vostra potestà, ad onore di San Pietro e della Santa sua Sede Apostolica alla quale sino ad ora tu hai fedelmente obbedito e che, nelle sue occorrenze, hai aiutato con valore e fedeltà”. E questo per ringraziare Ruggero di aver sottratto l'isola agli arabi e di averla restituita al culto della Chiesa di Roma. Il problema era che lo stesso Urbano II , qualche anno prima, con bolla del 3 giugno 1091 aveva concesso all’Abate Ambrogio la piena potestà sulle Eolie affermando che queste sarebbero dipese direttamente dalla Santa Sede.
Con l'andar degli anni i sovrani di Sicilia, anche di diversa dinastia, accresceranno a loro vantaggio i contenuti e l'efficacia della bolla e, ad un certo momento, si autodefiniranno legati apostolici mentre la Santa Sede farà di tutto per restringerne i termini e frenarne gli abusi, fino a definire falsa la bolla di Urbano II che invece era sostanzialmente vera.
Il concetto di Legazia Apostolica si affermerà con maggior consapevolezza tra i secoli XIV e XV e assumerà forme più decise di invadenza a cominciare dal Cinquecento. Per tutto il corso del 1600 e 1700 la diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede” diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia e la Santa Sede. Sarò' allora, con inizio nel 1711, che esploderà la famosa “controversia Liparitana”, di cui parleremo più avanti.
La Chiesa sulla difensiva
Per ora, nel 1610, siamo ai prolegomeni. Se Filippo III pensa quindi di ricondurre le Eolie sotto la sua piena autorità, politica e religiosa, il papa Paolo V non solo è deciso ad opporvisi ma probabilmente pensa di utilizzare le Eolie come un grimaldello per scardinare questo istituto e, in questo disegno la diocesi di Lipari doveva essere quella in cui il potere del papa si esercitava in maniera piena e senza nessuna remora. Quindi niente applicazione della Legazia Apostolica ma anche niente più subordinazione di Lipari alla sede metropolitana di Messina che fino ad allora era stata sempre riconosciuta dai vescovi liparesi anche quando Lipari faceva parte del reame di Napoli[1].

Papa Paolo V
Comincia così una corrispondenza fra il cardinale Gallo a nome del papa ed il vescovo di Lipari in cui si raccomanda a mons.Vidal di non permettere che “per causa di detta unione venga fatta alcuna novità intorno alle Cose Ecclesiastiche così in materia di Giurisditione come di Collatione di Beneficij o qualsivoglia altra cosa, ma , pretendendosi qualche Innovatione, faccia che si ricorra prima a Sua Beatitudine a cui deve spettare sopra di ciò la totale diliberazione” [2]. La prima lettera della Santa Sede è del 6 maggio cioè ci si muove per tempo prima della formalizzazione dell’incorporazione che avverrà il 30 maggio.
Non sono passati che pochi giorni da questa data che viene preteso dai Ministri del regno di introdurre nella diocesi di Lipari il Sant’Uffizio dipendente dall’Inquisizione spagnola come era d’uso in Sicilia. E così il 16 aprile del 1611 il Cardinale Gallo a nome del papa riscrive a Mons. Vidal raccomandandogli di non permettere assolutamente questa intromissione. Se i ministri palermitani dovessero insistere il vescovo mostri pure la lettera scritta a nome del papa e comunque non si faccia alcuna innovazione senza prima trattare col pontefice. Mons. Vidal è convinto e determinato in questa resistenza e lo fa opponendosi energicamente “non senza – dirà il suo successore mons. Caccamo – gravissimo percolo della sua vita”[3]. I regi ministri minacciarono allora e continueranno a farlo in seguito “la destituzione dalla dignità episcopale e la soppressione della Sede –Cattedrale”[4].
Il vescovo di Lipari, per antica consuetudine proprio perché si riteneva il proprietario delle isole e dipendeva direttamente da Roma, godeva di specialissime immunità e prerogative ed era esente dai tributi imposti dallo Stato. Questa situazione, proprio negli ambienti politici ed amministrativi di Palermo, era mal tollerata mentre lo stesso vescovo non era ben visto perché giudicato inaffidabile ed un evasore di fatto, e quindi, appena possibile, osteggiato.
Le tensioni fra le confraternite
Queste tensioni, alcune anche di scarso rilievo ed effimere, si riflettevano nel microcosmo eoliano facendone un vero e proprio covo di vipere. Prima la guarnigione militare e poi anche le autorità civili e la nobiltà terriera e armatoriale, che mal subivano il pagamento dei censi e delle decime, cominciarono a percepire la figura del vescovo con fastidio e insofferenza, fino, qualche volta, a sfociare in gesti di aperta ostilità, a cui facevano riscontro reazioni durissime col solito ricorso a severissime scomuniche.

Confraternite di Lipari
E non deve destare meraviglia se proprio la cerimonie religiose divennero il terreno più proficuo in cui questi sentimenti e queste tensioni presero a manifestarsi. Così da una parte i militari ed i nobili fecero della confraternita dell’Addolorata - che aveva sede nella chiesetta che si chiamava allora della Soledad, nel luogo dove sorge ora la chiesa dell’Addolorata – il loro luogo di incontro e tendevano a manifestare con cerimonie sfarzose il loro potere contrapponendosi a quelle che il vescovo officiava in Cattedrale. In particolare le cerimonie della Settimana Santa diventarono occasione di confronto e di competizione tanto da costringere il vescovo ad intervenire per porre un freno. Per tutta risposta la confraternita si adoperò perché la loro chiesa forse promossa a Cappella di Regio patronato con cappellano indipendente dal vescovo e sottoposto direttamente alla Legazia Apostolica di Palermo. Fu quello il momento di una ricca fioritura di confraternite molte sorte in contrapposizione a quella dell’Addolorata ed in solidarietà col vescovo come la confraternita[5] del S. Crocifisso o dei SS.Sette Dolori che si radunava ogni venerdì nella cappella della Concezione in Cattedrale mentre, sempre in Cattedrale, venne eretto un altare detto dei SS.Sette Dolori.

Anche le situazioni più banali divennero occasione di conflitto e di scontro come l’uso del “chiomazzo”, un cuscino ricamato che metteva il vescovo sotto le ginocchia durante le celebrazioni, divenne occasione di contesa col capitano d’arme che se n’era fatto fare uno simile; oppure il colore del drappo sullo scranno del municipio in Cattedrale che i girati vollero rosso paonazzo mentre il vescovo riteneva che questo colore fosse distintivo degli abiti dei prelati; o la consuetudine che i pubblici ufficiali, nelle feste solenni, accompagnassero il vescovo dalla soglia del palazzo vescovile alla Cattedrale e viceversa, alla fine delle funzioni, che divenne occasione di dispetti e quindi di processi che si imbastivano dinnanzi al Tribunale civile del vescovo[6]. Beghe paesane, frizioni locali che però si inserivano e acquisivano spessore nel più grande conflitto che si andava approfondendo quello cioè dello schierarsi con Palermo o con Roma, con lo Stato o con i vescovo.
la sofferenza di mons. Vidal
Il monumento a mons. Vidal nella Vaddedrale di Lipari
Questa situazione di tensione e di contrasti doveva essere subìta con sofferenza da un vescovo come Vidal che, come abbiamo visto, proprio in nome della buona convivenza aveva esentato dai tributi alla chiesa i nove decimi dei possessori dei terreni in enfiteusi ed aveva donato al Municipio diversi beni. Così a partire dal 1613, sentendosi logorato e con una piaga nella gamba che lo inficiava negli spostamenti, pur avendo solo 66 anni, declinò di andare a Roma per la consueta visita “ad limina” e cominciò a pensare alla propria morte. Fece costruire il suo sepolcro che volle in Cattedrale interrompendo l’antica tradizione di seppellire i vescovi nell’ipogeo che si apriva sotto il coro[7] ma soprattutto, uomo sensibile ai problemi della povera gente, volle creare, il 19 giugno del 1617, un fondo perpetuo che permettesse, con i proventi ricavati, ogni anno di dotare di un corredo di vestiario una trentina di persone: dodici uomini al 24 di agosto, festa ufficiale di S. Bartolomeo, e un certo numero di donne al 13 febbraio, ricorrenza, secondo la tradizione, dell’arrivo della cassa di S.Bartolomeo a Lipari, giorno che era comunemente detto della “festa della cascia”. Infine, nella festa del 17 giugno – anche questa dedicata a S.Bartolomeo - dovevano essere consegnate onze 10 “in sussidio di maritaggio d’una povera zitella”[8].
Mons. Vidal moriva il 17 settembre del 1617 a settanti anni di età, colpito da apoplessia. Oltre che, come abbiamo visto, dotato di abilità diplomatica, ed attento alle esigenze della comunità a cominciare dai più poveri, fu anche un vescovo di grande sensibilità pastorale. Indefesso nel somministrare i sacramenti “ si faceva udire frequentemente – ci informa il Campis – predicando nelle Chiese, o , nel conffessionario, ascoltando, consolando et istruendo i penitenti, oltre il tacito esortare che facevano le sue virtù delle quali era a meraviglia dotato” [9].
Particolare del monumento a mons. Vidal
[1] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto citato, pag. 33°. Il rapporto di “suffrageneità” di una diocesi ad un’altra si esprimeva soprattutto nella funzione di corte d’appello che il vescovo metropolita esercitava nei processi ecclesiastici ed anche in alcuni gesti formali di riconoscimento di questa dipendenza durante particolari funzioni religiose come il 15 agosto a Messina, in occasione della festività della Madonna della Lettera, patrona della città, quando nel corso della funzione solenne i vescovi di Lipari, Patti e Cefalù dovevano rispondere alla chiamata del vescovo di Messina pena la commissione di una multa che il più delle volte però non si faceva pagare.
[2] Archivio Vescovile di Lipari – Carpetta Civili 7 “Documenti ritrovati nell’Archivio della Chiesa di Lipari…” in G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto cit., pag. 33°1. Lettera del 7 maggio 1610.
[3] Relazione di mons. A. Caccamo alla S.Congregazione del Concilio, del 1621 circa, in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 A,f.46.
[4] Idem.
[5] Sulla storia delle confraternite nelle Eolie vedi G.Iacolino, Confraternite e Pie Associazioni laiche nell’Arcipelago delle Lipari, Lipari 2005.
[6] Su tutti questi avvenimenti si veda G.Iacolino, L Chiesa Catttedrale..,, manoscritto citato pag.33-34; vedi anche Archivio vescovile di Lipari, criminale, anni 1622 e ss.
[7] Nell’ipogeo mons. Vidal stabilì invece che si deponessero i cadaveri dei canonici capitolari, opportunamente essiccati e poi rivestiti dei loro abiti di cerimonia, ciascuno collocato in una propria nicchia verticale, in posizione eretta. Le nicchie non superavano la quindicina. Un minuscolo locale adiacente era destinato ad essiccatoio e colatoio. Vi era uno speciale sistema di trattamento dei cadaveri. Ventiquattr’ore dopo il decesso, il cadavere, senz’altra preparazione, veniva chiuso nel colatoio, adagiato sul coricatoio a grata. L’ingresso veniva poi murato perfettamente con malta per schiudersi allo scadere di almeno un anno. Alla riapertura del colatoio, essendo prosciugato il cadavere, questo veniva rivestito con gli abita da cerimonia. L’aria non lo distruggeva, né c’era più da temere alcuna nociva influenza sulla pubblica igiene. G.. Iacolino, La Chiesa cattedrale…, manoscritto cit., pag. 32b; per il sistema di trattamento dei cadaveri v. una lettera del 9 ottobre 1881, indirizzata al Sig, Soprintendente dell’Ufficio del patrimonio e Beneficenza, n. 5791, pubblicata ida Pierre Thomas in G. De Maupassant, Viaggio in Sicilia, Palermo 1977, pag. 45, in nota.
[8] Archivio Stato Vaticano, Cassetta 456 A, ff.41v-42v. Atto del notaio Alfonso Ferrazzano. G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…., op.cit.pag. 32 e,f ,g. Questa pratica alimentata dal fondo istituito da mons. Vidal era ancora operante nel 1841.
[9] P.Campis, op.cit., pag. 317-318. Stranamente il Campis afferma che mons. Vidal morì ad 82 anni di età (pag. 324), e sulla sua scia l’informazione viene ripresa da altri storici. Ma è lo stesso mons. Vidal che il 3 gennaio del 1613 scrivendo a un dignitario della curia pontificia per scusarsi che le condizioni di salute non gli permettono di andare a Roma per la visita “ad limina” per cui manda al suo posto il canonico La Noara, suo procuratore, afferma di avere, a quella data, 66 anni.
Confraternita dei S.S. Sette Dolori(Archivio Storico Eoliano.it)
Popolazione, economia e tributi
I conti con il vescovo e con lo Stato

La chiesa era a Lipari proprietaria di gran parte delle terre e di molti immobili e questo creava molte tensioni con gli enfiteuti di più antica data che mal sopportavano di dover pagare i censi alla Mensa vescovile sia con il municipio che, dopo la “ruina”, si era appropriato di alcuni fabbricati compreso una parte del Palazzo Vescovile e la casa del Tocco, che era la sede dei giurati, e non voleva restituirli. Così il 14 aprile del 1610 Mons.Vidal, con atto pubblico, esentò dai tributi ecclesiastici la maggior parte dei proprietari delle terre coltivate di Lipari e rinunciò a favore dell’autorità civile a gran parte degli edifici occupati. E questo “per vivere la città con il suo Prelato, ed i Prelato con il suo gregge, in pace come si conviene”. Rimanevano al vescovo il possesso di oltre un decimo dei terreni agricoli dell’isola fra cui, nei pressi della città, l’area che andava dai piedi del Castello sin oltre l’attuale corso Vittorio Emanuele che era allora una sorta di torrente intransitabile nelle giornate piovose e delimitata ai lati dal Vallone del Ponte e da via XXIV maggio che veniva chiamata Calata del Castello. Quest’area, che rappresenta il centro storico odierno, comprendeva orti e vigneti con una ventina di pozzi di acqua salmastra. Nella parte meridionale vi erano delle piccole abitazioni che rappresentavano la periferia di Sopra la Terra per il resto vi erano terreni dati a coltura punteggiati qua e la da rustici “casalini”che,via via, saranno oggetto di cessioni censuarie ai privati permettendo così l’espansione del Borgo e contravvenendo alle disposizioni dell’autorità spagnole.
Oltre il torrente, dove ora c’è il corso Vittorio Emanuele, vi era, sempre di proprietà del vescovo, una grande vigna che era stata rinnovata verso il 1595 dove proprio mons. Vidal fece sorgere “un casalino di villa” quello che ora è il palazzo vescovile. La costruzione era sobria e consisteva in due vani terreni con sopra due o tre stanze munite di baglio e pergolato ad essa si accedeva per un viottolo che collegava il casalino con il torrente che era allora corso Vittorio Emanuele[1].
Già nel 1608 il vescovo aveva condonato, a favore dell’Università, alcune terre boschive del Castellaro con alcune modeste condizioni.
Le Eolie nel Regno di Sicilia
Intanto il 30 maggio del 1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandosi dal regno di Napoli a cui erano appartenute fin dal 1548. Si trattava di una antica aspirazione dei liparesi che vedevano in questo passaggio sia un possibile incremento dei loro traffici, sia il beneficio di avere una capitale più vicina importante ai fini delle pratiche amministrative e giudiziarie. E per questo si era speso, mettendo in campo le sue virtù diplomatiche., il vescovo Vidal con numerosi viaggi fatti a Napoli e Messina.
 Filippo III
Filippo III
Ma se questi erano gli obiettivi dei liparesi e del loro vescovo per cui avevano chiesto l’incorporazione alla Sicilia, fra quelli del re Filippo III ve ne erano almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria e ricondurre la Chiesa di Lipari nell’ambito della Legazia Apostolica di Sicilia.
Ed è proprio questo passaggio amministrativo a far scattare l’”operazione reveli”[2] cioè il censimento delle persone e dei beni che aveva come finalità quella di stabilire la base impositiva per il pagamento dei tributi. La cosa non fu presa bene dagli abitanti perchè questo obbligo amministrativo contrastava palesemente con i privilegi di cui essi godevano da vario tempo ed anche la gente che si era riversata a Lipari dopo il “sacco” l'aveva fatto a patto di dover godere, tra l'altro, dell'esenzione dalle imposte statali. Da qui l’inizio di una dura contestazione per fare valere i privilegi contro una burocrazia palermitana che li riteneva tacitamente abrogati.
“I Liparoti comunque – osserva Arena - non poterono sottrarsi all'ordine che veniva da Palermo, ordine che il loro vescovo ribadiva con proprio bando e doveva far rispettare. Sicché l'operazione riveli si portò a compimento in tempi brevissimi e nel rispetto delle formalità stabilite”[3]. Essi non ebbero seguito perché il Tribunale del Real Patrimonio, riconoscendo i diritti acquisiti. scongiurò che essi potessero avere effetti fiscali per cui le carte del censimento andarono a finire direttamente nell’archivio del Tribunale.
Le proprietà del Vescovo e quelle del Comune
Innanzitutto i riveli ci dicono che i residenti a Lipari sono 1281 maschi e 1103 femmine quindi, in totale 2.384. Vi sono inoltre 256 persone del presidio militare fra soldati e famiglie e 38 schiavi. In totale 2.678 di cui 86 sono ecclesiastici[4] mentre 40 residenti risultano temporaneamente assenti. L’età media dei maschi residenti è di 22 anni visto l’alto numero di bambini sotto i nove anni (383) mentre i fuochi familiari sono 576 con un’ampiezza media delle famiglie di 4,05.
I rilevi permettono di ricavare informazioni non solo riguardo alla popolazione, ma anche all'economia. In ordine alle proprietà dai “riveli” risulta che l'Università possedeva “la casa del Tocco”, sede del Municipio( gravata di censo enfiteutico da corrispondere al vescovo), due case adibite a deposito di armi e munizioni, un magazzino adibito a deposito di grano, terreno di 18 salme circa in località Castellaro e molti altri terreni boscosi ed incolti in diverse parti dell'isola che non davano nessun reddito perchè erano a disposizione dei cittadini per raccogliere legna da ardere e pascolare il bestiame.
 Castellaro
Castellaro
La Chiesa possedeva vari fabbricati ( chiese, palazzo vescovile e qualche casetta) dentro la città e aveva la piena proprietà in molte contrade di Lipari ( Acquacalda, Annunziata-Chiusa, Canneto-Calandra, Capistello-San Nicola, Caravezza, Castagna, Monte Pelato, Pianoconte, Pianogreca-Ficuzza, Pirrera, Sant'Angelo, Salvatore,ecc.) e la proprietà praticamente di tutte le isole minori.
Vi erano in quella data anche un Monte di Pietà ed un Ospedale, entrambi amministrati dalla Chiesa ed una Confraternita di San Nicola proprietaria di un terreno in località Valle de Imbroga. L'Ospedale aveva diversi lotti di terreno ceduti in enfiteusi (Annunziata, Barisana, Collo, Cappello, Cugni, Ponte, S. Caterina, S. Lucia, S. Margherita...).
Una proprietà immobiliare diffusa fra i privati
Quanto ai privati bisogna osservare che c'era a Lipari una proprietà immobiliare piuttosto diffusa anche se va osservato che c'era chi possedeva una casa, mezza casa, un terzo di casa e chi possedeva più case; c'era chi possedeva un pezzo di terreno improduttivo e chi possedeva diversi terreni redditizi. Comunque senz'altro notevole era il numero di coloro che godevano di redditi non di lavoro. Tuttavia se si considera che per il vitto di una persona abbisognava una somma all'incirca pari a 12 onze d'oro l'anno, e che questa spesa aumentava adeguatamente secondo che si trattasse di famiglie di 2,3 o più componenti e se contemporaneamente si tiene presente che su un totale di 577 rivelanti abitanti a Lipari, solo 62 ( il 15,94%) avevano una rendita annua netta superiore a 12 onze, 62 (10,74%) una rendita annua superiore a 18 onze, 31( 5,37%) una rendita superiore a 30 onze e solo 16 ( 2,77%) andavano oltre le 40 onze di rendita netta annua, di certo non si può pensare che fossero molte le famiglie liparesi che potevano vivere esclusivamente di rendita.
Bisogna quindi capire che cosa offriva l'agricoltura, la pesca, il commercio, ecc. La poca disponibilità di acqua per l'irrigazione condizionava fortemente l'agricoltura eoliana del primo seicento. Di fatto a Lipari, alle poche colture orticole si contrapponevano massicciamente il fico, il cappero, le terre coltivate a grano e altri cereali, e soprattutto la vite. C'erano poi alcuni canneti, qualche gelso e, sparsi qua e là, vari altri alberi da frutto.

Una cisterna d'acqua ora scomparsa
Niente i riveli ci dicono sugli animali da cortile, quanto agli altri tipi, nell'isola c'erano 169 asini, 92 bovini, 1632 caprini, 38 muli, 12 cavalli e 1 maiale. Perciò la carne, il latte, il formaggio e persino le pelli, non mancavano. Di mulini ce n'erano 27 per cui si può ricavare che la farina si produceva sul posto sia macinando il grano locale che quello importato.
La flotta si componeva di 4 barchette (gozzi), 3 speronare( bastimenti con 2 o 3 alberi a vele latine e capienza di 20-30 tonnellate) e 4 feluche ( bastimenti con 1-2 alberi inclinati a vele latine e capienza di 30-50 t.). Diffuse erano le imbarcazioni in comproprietà.
Notevole doveva essere il commercio nell'isola e quello con piazze siciliane e calabresi ( Messina, Milazzo, Palermo, Ficarra, Tropea, Militello, Monteleone) o estere. Si commerciava grano, olio, vino, uva passa, capperi, fichi secchi, formaggio, spezie, pani. La presenza a Lipari di alcuni possidenti genovesi lascia capire che i rapporti si spingessero oltre il Tirrreno.
Nonostante il forte sviluppo delle attività economiche c'erano a Lipari persone che per vari motivi ( infermità, vecchiaia, ecc.) non erano in grado di procurarsi nemmeno un piccolo reddito di lavoro su cui contare. Ai bisognosi comunque non mancavano né l'aiuto della Chiesa, né quello dei privati, sicché non è nemmeno immaginabile che la condizione dei poveri a Lipari fosse identica a quella dei mendicanti presenti in quasi tutte le parti d'Europa.
Le entrate della chiesa e l'attività caritativa
Varia era l'attività che la Chiesa svolgeva a favore delle persone bisognose. Essa si estendeva dalle sovvenzioni alle concessioni di aree fabbricabili, dalla concessione di piccoli lotti di terre coltivabile, alle elemosine, dalla formazione della dote per le giovani povere che andavano in spose alla tutela dei minori ( il Campis informa che a Lipari la Chiesa amministrava anche un brefotrofio), e riusciva ad evitare forti disagi.
“ Se è vero – commenta Giuseppe Arena – che i vescovi di Lipari, male interpretando le concessioni normanne del 1088 e del 1134, pretesero per lungo tempo di essere proprietari delle Isole Eolie, è anche vero che con la distribuzione di terre in enfiteusi o altra forma crearono una grossa massa di piccoli coltivatori e proprietari, che altrimenti non ci sarebbe mai stata; se è vero che gli stessi vescovi incassarono per lungo tempo censi che in termini di diritto loro non spettavano, è anche incontrovertibile che quasi tutto il denaro da essi percepito venne riversato nelle Eolie, per costruzioni e a sostegno del Seminario, del Monte di Pietà, dell'Ospedale, dei poveri, degli orfanelli, ecc. E quindi, se sul piano giuridico non si può dire che l’Università di Lipari non sia stata privata per tanto tempo di molta parte del suo demanio, sul piano del realismo più crudo sembra proprio che la storia debba riconoscere che ciò fu più un bene che un male per le Eolie, tanto per i risultati diretti quanto per quelli indiretti”[5].
Sempre nella seconda metà del 600 il vescovo procedette a far disboscare vaste zone dell'arcipelago aumentando così i posti di lavoro e permettendo una distribuzione più razionale della popolazione nelle isole e la messa a coltura di molte terre. Queste terre procuravano al vescovo nuove entrate perchè venivano date in enfiteusi o in affitto dietro il pagamento di censi e decime. Di queste terre certo non ne beneficiò il popolo minuto ma le famiglie benestanti, gli ecclesiastici, loro parenti e comunque coloro che avevano delle risorse, classi sociali che nel tempo cominciarono a lamentarsi sempre più per questi balzelli che dovevano pagare[6].

Il cancello che portava al palazzo vescovile. Subito a destra l'edificio del 600 per le donne
Ma malgrado le lamentele per i censi e per le decime, le incursioni dei pirati lungo tutto il corso del secolo, la vita economica dell'arcipelago andò migliorando al riparo, com'era, dalle rivolte e dalle guerre. Erano in molti a darsi all'attività della pesca, alla caccia dei conigli, delle quaglie e delle tortore all'allevamento del bestiame e soprattutto di capre che circolavano libere nelle terre comuni e qualche volta sconfinando e danneggiavano i poderi coltivati.
Si raccoglieva e si esportava in Toscana, Campania, a Marsiglia anche la pomice: circa 500 tonnellate l'anno. Per molte di queste attività – pesca, caccia, allevamento , raccolta della pomice – i liparesi qualche volta riuscivano ad eludere le gabelle e la gente poteva arrotondare i propri redditi. Ancora nel corso della seconda metà di questo secolo un'altra fonte di entrata fu rappresentata, come abbiamo visto, dalla lotta ai pirati turchi che una volta catturati venivano venduti come schiavi, per esempio a Trapani dove si svolgevano libere vendite all'asta.
[1] Un primo ampliamento il casalino lo ebbe nel 1620 a cura del vescovo Candido, un altro intervento ci fu nel 1725 il vescovo Platamone che diede alla costruzione un aspetto più decoroso, ma fu il vescovo Attanasio che tra il 1845 e il 1856 diede al Palazzo l’aspetto che oggi conserva. Tra il 1911 e il 1928 il Palazzo rimase disabitato e andò degradandosi. Fu mons. Re che nel 1928 mise in atto un generale restauro del fabbricato. Nel 1965 Mons. Nicolosi mise in vendita quasi per intero la vigna venendo incontro al desiderio dell’Amministrazione comunale di tracciare nuove strade ed acquisire terreni per l’espansione urbana.( G.Iacolino, La chiesa cattedrale.., manoscritto cit., pag. 31 e,f,g.
[2] G. Arena “Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610 “Analisi, elaborazione statistica e sintesi dei riveli di Lipari conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, Messina 1992, pag.7 e ss.
[3] G.Arena, op.cit., pag. 10.
[4] Fra cui 1 vescovo, 12 canonici, 16 preti semplici, 18 fra diaconi, subdiaconi e chierici, 8 frati, 18 monache professe e 13 terziarie francescane
[5] G.A.M. Arena, Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610, op.cit.,pag.75.
[6] G. A.M. Arena, L’Economia delle isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina, 1982, pp20-21.
(Archivio Storico Eoliano.it)
La cura d’anime e il lento ripopolamento del territorio
Morale della gente e involuzione religiosa

Abbiamo segnalato che nel periodo che precede la “ruina”, per la maggior parte i vescovi venivano eletti e consacrati ma non raggiungevano la diocesi per cui quello di vescovo di Lipari era di fatto divenuto un titolo onorifico e si governava tramite un proprio vicario. Così aveva fatto il vescovo Ubaldo Ferratino ed anche i suoi tre predecessori. Quanto ai successori[1] – visto che per lo più erano siciliani - può darsi che abbiano deciso di vivere nell’isola e si sa che sotto il loro governo avvenne, come vedremo, l’apertura di chiesette e cappelle[2], ma se per loro iniziativa o su insistenza della gente questo non sapremmo dire, comunque, quello che è certo, è che non dovettero avere molta cura pastorale della Diocesi se, chi verrà dopo, troverà una situazione molto deteriorata. Questi successori, non solo si impegneranno a riportare a Lipari i frati cappuccini, come farà mons. Paolo Bellardito che probabilmente dovette giudicare insufficiente l’opera dei preti secolari, o metteranno mano alla ricostruzione del capitolo come fecero mons. Martino d’Acugna[3] - che fu il prelato che ricondusse , come abbiamo visto, in Cattedrale la reliquia del dito di S.Bartolomeo – e mons. Giovanni Gonzales da Mendoza[4], ma ciò che più dovette preoccupare questi vescovi a cominciare da Mons. Bellardito – di cui il Campis ci dice che governò la Chiesa di Lipari “con somma pietà e zelo come dimostrano le ordinazioni e costituzioni da lui fatte per la riforma dei costumi”[5] - era proprio la situazione morale della gente e lo stato di involuzione a cui era giunta la pietà religiosa.
E’ un editto di Mons. Antonio Vidal - che succederà nel 1598 a mons. Gonzales de Mendoza – che apre uno squarcio sul tipo di religiosità che era divenuta abituale fra le donne dell’isola. L’editto è del 16 giungo 1609, quindi ben dieci anni dall’insediamento di questo vescovo[6], e indubbiamente parla di situazioni che doveva conoscere molto bene e di pratiche che risultano ostiche ad estirparsi. Mons. Vidal, si richiama ai tre predecessori mons. Bellardito, mons. D’Acugna e mons. di Mendoza che come lui ogni anno, sotto pena di scomunica ed altre pene, avevano proibito alle donne di Lipari in occasione della morte di un loro congiunto o nelle ricorrenze di questa, di lasciarsi andare a pianti, grida, urli, balli disordinati ed altri comportamenti scomposti “all’usanza di barbari”.[7] Lo stesso editto denuncia poi che nelle solennità e durante le processioni, ancora le donne, si fanno notare con pianti “ad alti voci parendo volersela pigliare con nostro Signore Dio”.E visto che la minaccia di scomunica, da sola, non raggiunge alcun effetto, il vescovo annuncia che la disubbidienza verrà anche multata col pagamento di tre onze a ciascuna persona da devolvere ad opere pie[8].
Ma la trasformazione delle processioni e dei funerali in sceneggiate intollerabili – che tanto scandalizzavano e irritavano presuli di grande cultura religiosa e di ampie visioni cosmopolite - era solo la superficie di un disordine morale più profondo e così. con fogli che faceva affiggere sulla porta della Cattedrale, il vescovo Vidal bollava il concubinato, il meretricio, le magarìe, le invocazioni diaboliche,ecc[9]. Ed è perché preoccupato della cura d’anime che quando nel 1599 andarono via i Cappuccini[10], mons. Vidal, d’accordo con i giurati, fece venire dalla Calabria i Minori osservanti assegnando ad essi la chiesa ed il convento dei Cappuccini che era, come abbiamo detto, sulla Civita. I frati osservanti prendono consegna dei locali nell’aprile del 1600 ed il mese dopo viene stipulato l’atto notarile.

Disegno di Salvatore d'Austria di Piazza Mazzini con la Chiesa di Sant'Antonio
Il ripoipolamento delle campagne
E non era solo la situazione morale e religiosa che lasciava a desiderare a Lipari ma anche quella delle condizioni igieniche soprattutto in una realtà così ristretta come era il Castello. Erano poche le case che avevano una latrina o un pozzo nero per cui rifiuti di ogni genere, solidi e liquidi, gli avanzi dei cibi misti ad escrementi ed orina, si riversavano per le strade e persino “a lato la chiesa cattedrale, altre chiese et palazzo vescovale”[11]. Il vescovo lamentava Vidal , oltre a questo, lamentava che nella città e a fianco alle chiese si tenevano gli “animali attaccati” e ci si servisse dei tetti delle chiese per stendervi il grano ad asciugare “et altri servicj indicenti farsi in lochi sacri”.
I giurati nelle loro ordinanze si limitavano a chiedere che il sabato e nelle vigilie delle feste comandate, ogni famiglia provvedesse a pulire di fronte alla soglia delle loro abitazioni mentre si raccomandava che i rifiuti non si buttassero per strada, né dagli spalti che davano sul Borgo, ma da quelli del lato del mare. E se la situazione morale, religiosa e umana di Lipari appariva ai vescovi così critica ancora di più doveva sembrare quella delle contrade dell’isola principale e delle isole minori.
Dopo la “ruina” per alcuni anni la popolazione visse concentrata nella città alta e nel borgo e nelle contrade si andava solo, come nelle isole, a lavorare la terra ed infatti l’attenzione alla realizzazione di chiesette e cappelle rimane qui circoscritta. Ma col passare degli anni, lentamente riprendono a formarsi anche nella campagne delle piccole comunità. Ed il nascere di chiesette e cappelle fuori di Lipari è un segnale della creazione di nuovi insediamenti anche per lo stimolo dei deliberati del Concilio di Trento,. Così mentre il vescovo Lanza (1554-1564) porta a compimento la costruzione delle chiese nella città alta; il suo successore mons. Giustiniani (1564-1571) si spinge Sopra la terra e nel 1569 fa costruire la chiesa di S. Anna. Ma è mons. Cavalieri ( 1571-1580) che va fuori dal borgo di Lipari e fa riparare l’antica chiesa dell’Annunziata, poi quella di S. Margherita e quindi quella della Serra dedicata all’Assunta. Mons. Bellardito (1580-1585) ricostruisce e amplia l’antica chiesa di S. Nicola e ne realizza una alla Cicirata dedicata all’Assunta. Fa costruire nel 1583 una edicola rifugio su monte S.Angelo dedicandola a S. Michele Arcangelo ma sicuramente si tratta di un richiamo devozionale piuttosto che un luogo di culto al servizio di una comunità. Mons. d’Acugna realizza una cappella dedicata a S.Giorgio sulla sponda sinistra del Vallone del Ponte, la chiesa a Quattropani dedicata a Maria SS.di Loreto, quella a Pirrera al SS Nome di Maria, a S.Salvatore , a S.Leonardo, a Pianoconte nel 1593 la chiesina dedicata a Santa Croce dinnanzi alla nuova chiesa.

PIanoconte, la chiesa vecchia oggi un magazzino
A questo punto dobbiamo affermare che oltre a chi vive nella città alta e nel borgo ci sono almeno una decina e più di piccoli nuclei abitati nelle campagne e nelle contrade che si spingono fino a Quattropani e la Cicirata ma a nord dell’isola non vanno oltre Pirrera. Tutta la zona al di là di Monte Rosa fino ad Acquacalda, probabilmente perché giudicata poco fertile e troppo scoscesa anche per la presenza dei giacimenti di pomice, di forre e profondi calanchi, è come se non esistesse.
Il difficile ripopolamento della zona nord di Lipari
Ci penserà il vescovo Gonzales de Mendoza (1593-1598), un vescovo che amava le sfide e l’avventura dato che finirà la sua esistenza in America, a cercare di forzare questa sorta di confino. Così pensò innanzitutto a quella gente che era andata a vivere a Canneto dentro - per dedicarsi allo scavo della pomice che cominciava ad essere adoperata nell’edilizia anche in Sicilia - edificando la chiesetta di S.Vincenzo Ferreri, quindi fece costruire una cappelletta a Pignataro dove una volta c’era la lanterna dedicandola a S. Giacomo Maggiore, quindi punta su Canneto in quella che allora si chiamava la baia della Calandra e, nel bel mezzo di questa baia, edifica una cappella dedicata a S.Cristoforo forse un incoraggiamento a chi scavare la pomice a raccogliersi in comunità e non vivere dispersi e nascosti fra le montagne per paura dei pirati. Comunque dovette passare molto tempo perché questo avvenisse se Lazzaro Spallanzani nel 1788 dice che a Canneto sono edificati “rari tuguri, dove vivono a stento pochi Isolani[12]”
Acquacalda, la vecchia chiesa di San Gaetano
Ad Acquacalda, sul finire del 500, non vi era ancora nessun insediamento perché era una realtà troppo lontana, isolata ed indifesa. Vi erano un paio di persone che coltivavano un po’ di terra e forse scavavano anche la pomice nei pressi della Castagna ma si guardavano bene dal pernottarvi per timore dei pirati turchi. Comunque col riprendere della vita a Salina anche Acquacalda riceve maggiore attenzione prima come luogo di sosta ma già ai primi del 600 sul timpone di San Gaetano dovettero sorgere una decina di “tuguri” e magari una piccola cappella dedicata proprio a S.Gaetano[13].
Il ripopolamento delle isole minori
Ufficialmente le isole minori dovevano essere disabitate e incolte per non offrire punti di appoggio ai pirati turchi o a navigli nemici visto che le guerre non mancavano, malgrado ciò abusivamente tutte le isole, di fatto, erano abitate: non molti a Salina, alcune decine a Stromboli e Panarea, un po’ di più a Filicudi. Alcuni erano venuti da Lipari, altri dal continente spesso fin dalla fine del secolo precedente. Se gli abitanti di Lipari ponevano diversi problemi di morale lassa e di religiosità deviata, nelle isole, che vivevano, nell’abbandono totale dove la violenza per sopravvivere era esperienza quotidiana, questi problemi non erano certo minori. Dovevano vivere in capanne di frasche coltivando pezzi di terra detenuti illegalmente perché di proprietà della Mensa vescovile , in condizioni miserevoli se non subumane, con relazioni improntate all’ individualismo ed alla sopraffazione ed una religiosità fortemente intrisa di pratiche superstiziose. Il loro isolamento fu per decenni quasi assoluto salvo le puntate che stagionalmente vi facevano pescatori e contadini di Lipari che riuscivano ad ottenere – dietro il rilascio, come abbiamo visto, di una tangente in natura - la “licenza d’uscita” dal capitano d’arme. Contadini che andavano nelle isole per raccogliere uve passe e malvasia, fichi e capperi barattandoli magari dai residenti in cambio di mercanzie di cui i locali erano completamente sprovvisti.

Ai divieti del comandante, a cominciare dal 1603 fino al 1917, si aggiunsero quelli di Mons, Vidal che proibì di andare nelle isole “senza licenza in scriptis di esso Monsignore” pena la scomunica. Una ordinanza affissa e proclamata ogni anno il giovedì santo nella chiesa Cattedrale durante la messa solenne[14]. Ma l’attenzione del vescovo per le isole non era solo connessa all’esigenza di fare rispettare il pagamento delle decime ma anche di procedere al recupero della gente sia alla vita organizzata sia alla fede ed alla morale cattolica. E questo a cominciare da Salina dove, proprio agli inizi del 600, si avvertivano chiari e manifesti segni di risveglio di vita e di attività agricola. Rari insediamenti stabili di pastori e contadini mezzadri dovevano esserci nelle zone interne e un certo numero di produttori di sale avevano fissato la loro dimora nel tratto costiero tra Lingua e Santa Marina. E come pensa a questo recupero mons. Vidal? Creando dei luoghi di culto dove la gente possa raccogliersi per pregare, accostarsi ai sacramenti ma anche ascoltare qualche insegnamento morale e religioso. Così, nel 1602, abbiamo il primo oratorio in una zona elevata della baia di Arenella, la Rinella di oggi, dedicata a S.Gaetano dove viveva un gruppo di boscaioli e contadini le cui abitazioni si assiepavano nel primo tratto del Vallone boscoso ; due anni appresso, nel 1605 sul fertile pianoro di Capo dove fra rigogliosi vigneti e alberi di fichi insieme a povere abitazioni, per la gran parte capanne, viene costruita la primitiva cappella in onore di S.Anna e della Natività di Maria ; nel 1612 sorge una chiesetta anche a Lingua, in località piuttosto discosta dal mare, intitolata a S. Bartolomeo al servizio di gente che si adattava alla pesca ed all’agricoltura, alla produzione di sale e al lavoro di carpenteria per piccole imbarcazioni; quindi ne 1622 dedicato alla vergine S.Marina. venne recuperata ed ampliata una antica struttura nella zona che prende il nome dalla chiesa dove dei contadini si dedicavano al trasporto a Lipari di derrate alimentari.
Il ripopolamento di Salina
Al ripopolamento di Salina, secondo Iacolino, concorsero in maniera significativa, un qualche gruppo di coloni proveniente dall’area di influenza veneta ed in particolare dalle isole Cicladi, Nasso, Scio, Cipro e Creta. Da terre cioè dove si producevano, in particolare, uve da tavola e da vino. Fra queste vi era una isoletta che si chiamava Monembasìa dove confluivano moltissimi vini dell’area e prima di prendere la strada dell’Europa, venivano ulteriormente curati e miscelati. Questi vini, a cominciare dal quattrocento, presero il nome dell’isoletta e si chiamarono “malvasie”. Quando a cominciare dal 1540 le isole caddero in mano dei Turchi e col tempo entrò in crisi anche Venezia come potenza marinara, cominciò la trasmigrazione dei coloni in varie regioni d’Italia fra cui la Sicilia. Ed anche nelle Eolie e principalmente a Salina a cominciare dal 1561 giunsero gruppi di questi portandosi i vitigni che avevano selezionato con tanta cura e trapiantandoli da noi[15] assieme alla loro esperienza di viticoltori. Fra questi immigrati probabilmente doveva esservi anche gente che aveva avuto a Cipro esperienze di saline e rimisero a cultura la piccola salina di Lingua. Ed è per questo che sul finire del 500 con riferimento all’isola non si parlò più di Didime ma di Salina che era già in uso nel XII secolo.

Stromboli. Ginostra
Sicuramente, continua Iacolino, si deve a questi coloni veneti l’introduzione a Salina del culto di Santa Marina . Una santa che nel 1512 era divenuta conpatrona di Venezia[16].
Una piccolissima cappella nel 1615 il vescovo Vidal la fa erigere anche a Stromboli e la dedica a S.Vincenzo Ferreri ma sarà una costruzione che deperirà presto perché l’isola era poco frequentata e spesso insidiata dai pirati turchi.
[1] Il Campis ( op.cit., pp.307-317) mette in risalto alcune contraddizioni fra due fonti entrambe solitamente bene informate: l’abate Ughelli che si rifà agli atti concistoriali e l’abate Pirri che, come abbiamo visto e stato anche a Lipari per documentarsi. L’Ughelli pone come successore di Ferratine, Annibale Spadafora , di Messina che rimarrà vescovo di Lipari fino alla sua morte e cioè per un anno dal 1553 al 1554; gli succede Filippo Lancia o Lanza, di Catania, dal 13 aprile 1554 al 1564; poi Antonio Giustiniani da Chio dal 12 maggio 1564 al 1571 che era già stato arcivescovo di Naxos ed aveva dato un significativo contributo teologico al Concilio di Trento; alla sua morte gli succede Pietro Cancellieri dal 3 ottobre 1571 alla sua morte nel 1580; gli succede Paolo Bellardito di Lentini dal 17 ottobre 1580 al 1585 quando rinunciò; quindi Martino d’Acugna da Siviglia dal 21 dicembre 1585 al 1593 e quindi Giovanni Gonzales da Mendoza, spagnolo dal 1593 al 1595; gli succede nel 1593 Alfonso Vidal anche lui spagnolo. Il Pirri disconosce questa successione e al Ferratino nel 1584 fa succedere un certo Giovanni, il quinto vescovo liparese con questo nome, dei minori osservanti che avrebbe portato a conclusione la fabbrica della Cattedrale ed avrebbe fatto venire dalla Sicilia i frati cappuccini affidando loro il convento che era stato dei frati osservanti sulla Civita. Sempre secondo il Pirri Giovanni V morì nel 1584 e fu sepolto in Cattedrale presso l’altare del SS.Sacramento. Il Pirri salta Spadafora, Lancia, Giustiniani e Cancellieri e fa succedere a Giovanni V, Bellardito ma non il 1580 bensì il 1584 per cui questo vescovo avrebbe governato solo un anno. Dopo di che la chiesa di Lipari sarebbe rimasta vacante sette o otto anni perché non nomina nemmeno il d’Acugna. Ma al di là delle contraddizioni fra la versione dell’Ughelli e del Pirri, dei quattro vescovi che seguirono il Ferratino sappiamo poco . Sicuramente risedettero a Lipari Mons. Bellardito e il d’Acugna . Anche a Lipari venne ad abitare Gonzales da Mendoza ma vi rimase solo due anni dopo di che nominò suo vicario l’arcidiacono e se ne partì per l’ America dove gli fu assegnata la diocesi di Chiapas nel Messico.
[2] Vedi G. Iacolino, Acquacalda di Lipari. Il territorio, la comunità umana, la chiesa, Lipari 2003, pp. 25-28.
[3] Martino d’Acugna, carmelitano come S.Teresa d’Avila e S:Giovanni della Croce dei quali era contemporaneo, predicatore,autore di un trattato su De arte Divini Amoris,e quindi studioso del misticismo.
[4] Giovanni Gonzales da Mendoza, agostiniano, aveva vissuto a lungo nel Messico e poi probabilmente andò anche in estremo oriente giacchè pubblicò una Historia de las cosas màs notables, ritos y costumbres del gran Reino de la China con allegato un Itinerario del Nuovo Mundo. Più tardi pubblicò anche Informe à Felipe II sobre la conservacion de las Indias e entrò a far parte dell’Accademia di Spagna.
[5] P. Campis, op. cit., pag.311.
[6] Mons. Alfonso Vidal viene nominato il 23 novembre 1599 ma raggiungerà Lipari solo il 20 aprile dell’anno successivo perché preferì passare a Roma l’inverno.
[7] “..ballari, triscare o alzarsi alla dritta, raffugnarsi o xipparsi li capelli o battersi in qualsivoglia parte del corpo, reputare o far reputare, sbattere la persona o fare strepito con porte o fenestre o far gesto di donna poco saggia gridando e saltando all’usanza dei barbari”.
[8] G.Iacolino, La Chiesa cattedrale di Lipari sotto il titolo di S.Bartolomeo, manoscritto citato, quaderno IIA, pag. 27-29.
[9] Idem, 27
[10] Il Convento dei Cappuccini di Lipari fu fondato nel 1584 ed edificato “tutto a lamia e damuso in quadro secondo il modello allora moderno innante la porta dell’entrata nella città, in buon sito e sopra l’antiche muraglie del palazzo del re Liparo”come è scritto nel manoscritto di P. Bonaventura Seminara da Troina, Libro primo, op.cit. pag. 140-141. Fu chiuso nel 1599 su iniziativa di un frate visitatore con la motivazione che i frati avevano violato la “regula della santa Poverà”.( Manoscritto di P.Bonaventura, op.cit., libro III). Iacolino, analizzando l’inventario dei beni lasciati dai Cappuccini nel monastero, afferma di avere individuato in che cosa consisteva questa violazione della regola: i frati si erano dati al commercio dell’uva passa. Infatti fra la roba trovata ci erano “trenta tri barilotti” che contenevano tredici cantàra ( un cantàro oscillava dagli 80 ai 100kg) e dieci rotoli uva passa, cioè oltre una tonnellata di merce pregiata. Inoltre nel monastero furono trovati anche sei archibugi con sei fiaschette per la polvere da sparo, una difesa contro eventuali assalti notturni da parte dei pirati visto che il convento si ergeva, allora, su una zona isolata a ridosso dell’approdo. (G. Iacolino, manoscritto, op.cit., pag. 30l).
[11] Archivio vescovile, Visita di Mons. D.Giovanni Mendozza, dal 1593 al 1626, f. 300; in G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto cit, pag. 32°.
[12] L.Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari 1993, pag. 214; G.Iacolino, Acquacalda di Lipari, op.cit., pag.33.
[13] G.Iacolino, Acquacalda di Lipari, op.cit., pp.33-38.
[14] L.Genuardi e L. Siciliano, Il Dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’Isola di Lipari, Acireale 1912, pg. 83, nn. 8 e 10 dove è riportato l’atto di Notar Verderami Voi del 1623. In manoscritto di G.Iacolino, La cattedrale…, op.cit., pag. 29 b.
[15] Si ricordi che nel 1564 viene trasferito a Lipari il vescovo Antonio Giustiniani, di famiglia genovese, che era nato a Scio ed era stato vescovo di Nasso.
[16] Queste informazioni sono ricavate dal manoscritto di G.Iacolino, La chiesa cattedrale…, op.cit., pag. 29f-i2. Sempre dallo stesso manoscritto – che si rifà, per lo più, all’Archivio Vescovile – derivano le notizie che seguono.(Archivio Storico Eoliano.it)
Antonio Vidal
La pratica della pirateria e il commercio degli schiavi

La battaghlia di Lepanto diede un duro colpo alla piratertia ma non la debellò.
Una pirateria legalizzata
Già da alcuni accenni si evidenzia il fatto che, col tempo, va diminuendo la paura del “turco alla marina” aumenta invece la capacità predatoria dei liparesi sino a diventare essi stessi mercanti di schiavi.
La pirateria era considerata una vera e propria attività nel 400 e nel 500. E mentre in altre parti del mondo si va distinguendo fra corsari e pirati - i primi autorizzati e legalizzati, i secondi dei veri e propri banditi senza regole e senza vincoli - in Sicilia tutti erano pirati anche se quelli patentati si dicevano affidati ad pyraticam exercendam”[1]. La legalizzazione di questa attività nasceva dal fatto che il re con le sue navi non riusciva a difendere territorio e popolazione dalle incursioni che, quando si realizzavano ad opera dei pirati, erano caratterizzate da scorribande senza avvisaglia alcuna e richiedevano un continuo stato di allerta. Per questo già nel 1446 il re Alfonso aveva concesso ai siciliani facoltà di difendersi e persino “manu armata offendere” quando si imbattevano in navi che li aggredivano[2]. Il problema più dibattuto non era quello dell’esercizio di questa pratica come professione ma la divisione del bottino che i privati reclamavano tutto per intero sottolineando i rischi che correvano e il servizio che recavano al regno, mentre gli Ammiragliati, che rilasciavano le patenti, ne rivendicavano un parte[3]. Nel tempo si va affermando il concetto - formalizzato in una presa di posizione del Parlamento siciliano nel 1523 – che, visto il servizio reso alla comunità, nessun compenso dovesse spettare alla Regia Corte ed all’Ammiragliato ma il bottino doveva essere “di quelli che li pigliranno” se questo avveniva per mare. Nel caso invece che l’imbarcazione venisse catturata mentre si dirigeva verso terra doveva essere diviso a metà con coloro che erano a terra.
Una professione quella, della pirateria , molto lucrosa - soprattutto perché era collegata direttamente al commercio degli schivi - a cui non sdegnavano di prendere parte anche i vicerè, i loro familiari e funzionari governativi in un intreccio di ruoli pubblici e speculazioni private. “Le carte notarili di piazze come Trapani, Messina, Siracusa, […] ci hanno lasciato memoria interessante di contratti di società finalizzate all’esercizio della pirateria. Si trattava infatti di un’attività come un’altra , per la quale i notai fissavano in atti pubblici le condizioni e i patti a cui i soci dovevano sottostare[4]”.
Il commercio degli schiavi
 L’aspetto economico più rilevante e quindi lo scopo principale dell’attività di pirateria era costituito dal lucro ottenuto dalla vendita degli schiavi catturati. Un commercio per trovare braccia per il lavoro ma anche un commercio per riscattare chi era caduto in cattività. Il riscatto era infatti l’obiettivo della pirateria barbaresca mentre invece era più raro il riscatto per i mori caduti in cattività .
L’aspetto economico più rilevante e quindi lo scopo principale dell’attività di pirateria era costituito dal lucro ottenuto dalla vendita degli schiavi catturati. Un commercio per trovare braccia per il lavoro ma anche un commercio per riscattare chi era caduto in cattività. Il riscatto era infatti l’obiettivo della pirateria barbaresca mentre invece era più raro il riscatto per i mori caduti in cattività .
Abbiamo parlato delle condizioni in cui i deportati da Lipari fecero il viaggio verso oriente nel 1544. Possiamo dire, in genere, che i viaggi dei pirati che commerciavano in schiavi non doveva essere una crociera anche se c’era una bella differenza fra le condizioni di viaggio dei mercanti, dei proprietari degli schiavi e quello degli stessi schiavi costretti in catene, ferri e cippi giacchè il pericolo che potessero fuggire durante il viaggio era elevato e, in tal caso, né il locatore né tantomeno i proprietari degli schiavi, erano tenuti a pagare il nolo[5].
Come abbiamo avuto modo di accennare la pirateria si praticava anche da parte dei liparesi autorizzata e abusiva.
Nell’estate del 1571, prima della battaglia di Lepanto, fra Vulcano e Lipari si svolge l’assalto ad una fusta turca da parte di due galee genovesi che si contendono il bottino del naviglio mentre l’equipaggio turco che si era dato alla fuga per l’isola viene scovato dai liparesi che, ucciso un turco, ne fanno prigionieri altri undici e li consegnano ai genovesi ricevendo in pagamento cinquecento zecchini d’oro. In quell’occasione vengono liberati diversi schiavi cristiani che si trovavano nella stiva della nave turca incatenati[6].
I corsari berberi
Due documenti del fine secolo parlano invece di contadini eoliani che a Stromboli, Panarea e anche a Lipari sulla marina di San Nicolò, l’attuale Marina Lunga, vengono rapiti da equipaggi barbareschi e deportati in terre lontane[7]
Pietro Campis ci informa che intorno al 1580 continuano i corsari berberi ad imperversare nel mare di Lipari impedendo la navigazione e persino facendo incursione nei campi rubando i frutti della terra e facendo schiavi quanti vi ci trovavano. Per reagire a questi fatti alcuni liparesi - Bartolomeo Carnovale, Nicolao Altiri e Francesco Di Franco - armarono due brigantini ed una galeotta e si misero a contrastare i turchi impedendo loro altre scorrerie ed anche liberando una gran quantità di schiavi che si trovavano sui loro navigli. Poi, presa la mano, i nostri liparesi decisero di spingersi a levante esercitando loro la pirateria e tornando a casa con “prede considerabili e numerose turbe di Turchi in catene”[8]. Lo stesso Bartolo Carnovale nel 1584 chiede che gli vengano restituiti 17 turchi che gli erano stati requisiti dall’autorità dell’isola[9] mentre, sempre nel 1584, i liparesi si lamentano che viene loro impedito di recarsi a vendere al mercato degli schiavi i turchi catturati[10].

I turchi residenti a Lipari e chi tornava dalla schiavitù
Diversi turchi vivevano anche a Lipari e non erano poche le famiglie borghesi che fra i loro schiavi non contassero anche un moro ed una mora. Erano tempi quelli in cui la discriminazione razziale e religiosa esisteva in maniera sensibile. Nel 1664 il vescovo di Lipari, che era mons. Francesco Arata – un pastore, come vedremo, dotato di grande pietà e carità -fece affiggere alle porte della cattedrale un editto che ribadiva alcune norme comportamentali fra i cristiani e “li turchi mori et altri infideli” a cominciare dal fatto che, per distinguersi, quest’ultimi dovessero portare “il cerro di capelli in testa” pena dieci anni di galera e nella stessa pena sarebbero incorsi se fossero stati trovati in case di meretrici o avessero avuto rapporti con donne cristiane. Quest’ultime, a discrezione del vescovo, sarebbero state condannate invece o al carcere o alla frusta. Inoltre schiavi infedeli e schiavi cristiani dovevano pernottare in stanze separate e non dovevano mangiare insieme, “particolarmente in tempo in cui venghino proibiti i latticinij”. Per evitare “ogni occasione di male che potrebbe succedere” i cristiani non devono abitare con gli infedeli, né andare ai loro conviti, né invitarli ai propri, né mangiare insieme a casa propria o altrui, né possono ricevere da loro alcun medicamento e nemmeno andare da loro per curarsi delle infermità, né abbiano con loro cose in comune “ma, quanto far si può, da tutto lor commercio e pratica si astenghino”[11].
Un atteggiamento discriminatorio e vessatorio veniva tenuto anche nei confronti di chi tornava o fuggiva dalla schiavitù fino a quando non si accertava che era rimasto cristiano o che volesse sinceramente riconciliarsi con la Chiesa. E’ il caso di un tedesco fatto schiavo dai turchi e fuggito – nell’ottobre del 1583 - durante una sosta a Salina della nave dove era messo ai remi. Da Salina, dopo ventidue giorni di latitanza, riesce ad avere un passaggio per Lipari e si consegna alle autorità. E qui comincia un nuovo calvario del poveretto che viene messo in carcere in attesa che il vescovo accerti – sulla base di testimonianze – la sua vera identità, se era fuggito di sua volontà o se era un “turcho nato”, se avesse rinnegato la sua fede e in questo caso se lo avesse fatto di propria volontà o se costretto. Fortuna volle che qualche mese dopo, nel marzo del 1584, a Vulcano venne catturato un vascello marocchino dove, nell’equipaggio, vi erano persone che l’avevano conosciuto o avevano sentito parlare di lui e della sua fuga a Salina. Tutto a posto? Purtroppo non ancora. Il malcapitato doveva subire l’iter della “sollenne riconciliazione con la Chiesa”, una dura cerimonia penitenziale[12].
I vescovi pretendono le decime sugli schiavi
Ma l’attenzione dei vescovi e della curia alla liberazione degli schiavi non era sempre solo dettata da motivi religiosi per quanto rigidi ed inumani, ma anche da interessi materiali e cioè la decima sugli schiavi che spesso veniva reclamata sotto pena di scomunica. Infatti il 17 ottobre 1580 di scomunica viene colpito Bartolomeo Carnavale perché “degli schiavi liparesi da lui presi non aveva pagato la decima[13]”.
Le cose cominciano a cambiare il 20 luglio 1612 quando il vicerè di Sicilia dichiarerà che i liparesi per le loro azioni di pirateria autorizzata nulla dovranno dare al re ed all’Ammiraglio. I vescovi oppongono a questa decisione un “distinguo”, la norma non può valere anche per i turchi che venivano presi a terra perché, essendo essi gli unici ed assoluti proprietari delle isole, come si doveva la decima per i frutti del suolo così era per i prigionieri fatti a terra. Ma ai primi di ottobre del 1693 di quell’anno, proprio ad Alicudi, si ha un episodio di una certa importanza che porta alla liberazione di ventidue cristiani ed alla cattura di centocinquanta infedeli di cui tre agguantati sull’isola. Il vescovo rivendica per questi le decime dietro minaccia di scomunica. Gli armatori si oppongono e si va dinanzi al Tribunale della Regia Monarchia che li assolve dalla scomunica sentenziando che le decime non erano dovute perché le nostre sono “Isole che non producono turchi”[14].
La pirateria dei liparesi continuò ancora per qualche tempo. C’è un documento del napoletano del 1710 che parla dei “liparoti che infestano questo mare impedendo il commercio[15]” e proprio nel primo scorcio del 700 il nome dei liparesi era temuto sulle coste fra Reggio Calabria e il Golfo di Gaeta mentre gli isolotti di Ventotene, Palmarola e Zannone era loro zona di operazione dove sequestravano e poi chiedevano il riscatto di barcaioli del luogo usciti per la pesca. Poveri che derubavano altri poveri e giustamente Iacolino parla di “briganti marini di mezza tacca”[16].

Isole Pontine
I costi per la sicurezza
Col passare degli anni dalla “ruina”, abbiamo visto, la paura dei turchi va diminuendo. Ed anche se di tanto in tanto compaiono nelle nostre acque vascelli barbareschi la gente di Lipari comincia a lamentarsi del costo della sicurezza e chiede che vengano ridotte le incombenze e le spese. Si comincia nel 1633 quando i giurati di Lipari protestano col viceré e la spuntano, perché il Capitano d’armi ha ordinato che le guardie che si era soliti fare, ogni notte, con pattuglie di nove persone, nel periodo estivo da agosto ad ottobre nella marina di San Giovanni, nella spiaggia di Portinente e “in un posto ditto Gattarelli” siano estese per tutto l’anno e siano a carico delle persone che abitano nel borgo[17].Nel 1635 una lettera del vicerè ridimensiona le spese per le guardie e la difesa cominciando dalla “guardia del Monte”, per la barca di guardia all’isola di Vulcano, e per le guardie nell’isola di Salina, Stromboli e Filicudi. Un anno dopo i giurati riescono a liberare l’ università del costo del “capitan d’arme pratico ed esperto alla guerra”– onze otto al mese – che veniva inviato nell’isola per cinque mesi nella prospettiva di una guerra. Nel 1657 una nuova protesta per essere esentati dalla spesa di 40 onze al mese per la paga delle guardie ritenendo che la vigilanza contro i corsari e le imbarcazioni nemiche può essere fatta dalla gente che va al pascolo[18].
Non deve meravigliare questa richiesta dei liparesi di ridurre i costi per la sicurezza giacchè sulle mercanzie dei pescatori, dei contadini e dei commercianti già pesavano le decime ed i censi della Mensa vescovile. E se si aggiungevano le angherie del capitano d’armi e dei soldati si comprende che il peso dei prelievi diveniva insopportabile.
[1] A. Italia, La Sicilia feudale, Milano 1940, pag. 363; R. Cancila, Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna, op.cit. pag, 363.
[2] F. Testa, Capituli Rengi Siciliae, Palermo 1741, p.352, v. R. Cancila, op.cit., pag. 364.
[3] R. Cancila, op.cit., pag. 256.
[4] Idem, pag. 369.
[5] Idemm, pag, 373-4.
[6] G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., pp. 207-209.
[7] Idem, 209 e 218-9.
[8] P.Campis, op.cit., pag. 312.
[9] Libro delle Corrie, f. 4v e 5.
[10] Idem, f.6.
[11] Archiovio vescovile di Lipari, Editto generale di Mons. Francesco Arata, carp. 16.Civili, in G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., pag. 210-211.
[12] Anche per questa vicenda i documenti originali si trovano nell’Archivio Vescovile di Lipari, Civile, carp. 2 e riprotati in G. Iacolino, op.cit., pp2111-213 e 222-226.
[13] G.Iacolino, idem pag. 214.
[14] Sulla vicenda si veda P. Campis, op.cit., pag. 58-60; G.Iacolino,op.cit., pag.213-214, 226-229; Archivio Vescovile, Carpetta Criminali 12.
[15] Si tratta di un documento del Banco di Santa Maria del popolo del 27 maggio del 1710 ora in Archivio del Banco di Napoli, cit. da G: Iacolino, op.cit., pag.215, 219.
[16] G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit.,pag. 215-216
[17] A.Raffa, op.cit., pag. 101.
[18] Idem, pag. 102.(Archivio Storico Eoliano.it)
Francesco Arata
La difficile ripresa
Un ripopolamento alla "Far West"

All’indomani del sacco, Lipari riprende lentamente la sua vita. Ha due grossi problemi da affrontare: il ripopolamento e la ricostruzione e cioè riparazione del castello e espansione della città.
Il re – che, come abbiamo visto, è stato pronto nella risposta anche su sollecitazione del marchese di Terranova - manda, di concerto col viceré di Napoli, il Comandante Consalvo de Armella , che si fermerà a Lipari dieci anni dal 1544 al 1554. Il comandante avrà ”ampla potestate et autoritate di far quello che li piacesse circa la rehabitazione di deta cità[1]”.
Già nel 1545 giunge anche una guarnigione spagnola – che nel 1544 è di cinquanta uomini ma al censimento del 1610 conterà, nell’insieme, comprese le famiglie, più di 250 persone - che risiederà stabilmente al Castello. Inoltre il Viceré di Napoli, il 21 gennaio del 1546, per aiutare il ripopolamento dell’isola, confermava, a nome del re, a chi fosse andato ad abitare a Lipari i privilegi, le grazie le franchigie e le immunità che in passato erano state concesse all’isola e questo favorì l’immigrazione dalla Sicilia, dalla Calabria e anche da diverse città italiane[2].Di più fu garantito anche il non luogo a procedere per chi aveva conti in sospeso con la giustizia[3].
Si tratta di un chiaro contributo ad un ripopolamento realizzato senza andare troppo per il sottile e quindi a una sorta di Far West, come è stato detto. Un notevole flusso migratorio quindi si concentra su Lipari per far fronte al vuoto creato dalla deportazione. Il movimento vorticoso durò circa un secolo e mezzo e attrasse genti dalle località più vicine, ma anche da territori più lontani. Nel 1693 Pietro Campis afferma che gli abitanti erano giunti a circa diecimila e “alla giornata si va sempre accrescendo”[4].
Le fonti liparesi danno molte informazioni sulla “qualità” degli immigrati. Molti sono mascalzoni, molti fuggono da situazioni tragiche, ma c’è anche gente intraprendente che spera in una promozione sociale.
“Lipari all'indomani del sacco e dello svuotamento si presenta come una terra delle opportunità, ma non soltanto da chi fugge da condizioni di non sufficiente garanzia di sopravvivenza, come pure è facilmente presumibile nella Sicilia del 500. Spesso si tratta di singoli o di famiglie che , cercando fortuna altrove e avendo una “preparazione” emigrano definitivamente a Lipari, dove trovano spazio per la qualificazione del loro mestiere”[5]. Così ai superstiti, via via si aggiunsero famiglie siciliane, calabresi, campane e la colonia di spagnoli rappresentata dai militari e dai loro familiari e che spesso crea dei problemi di conflitto con le autorità ed i comuni cittadini[6]. Molti di questi si sposano con eoliane ed una volta terminato il servizio rimangono nell’isola dando origine a quei cognomi chiaramente spagnoli che ritroviamo ancora oggi[7]
Ripopolamento forte ma non stravolgente
Il primo censimento compiuto dopo la “ruina”, come vedremo nel 1610, dice che gli abitanti residenti nelle Eolie, compresi gli ecclesiastici, sono 2384. Sono passati sessantacinque anni dalla grande tragedia e quindi hanno fatto a tempo a nascere i figli dei figli, e gli “oriundi”, cioè persone che o erano di Lipari o avevano anche un genitore che lo era, assommavano a 1200. “Nel ripopolamento di Lipari, dopo il sacco del 1544, vi fu, quindi, - commenta Angelo Raffa[8] - un profondo rinnovamento di stirpi, ma esso si innestò su un ceppo principale indigeno, che costituisce ancora elemento forte di continuità con la storia demografica isolana”. Il ripopolamento, quindi, fu forte ma non stravolgente.
I lavori per riparare e potenziare il castello cominciarono nel 1547 ma durarono a lungo anche se il grosso fu realizzato in due anni su progetto di Iacopo Malerba e la direzione dei lavori di Giovanni Andrea di Ferrara. Nel 1634 non erano ancora ultimati, tanto che il vicerè di Palermo, chiede al nuovo direttore dei lavori, Vincenzo Tudeschi, di ultimarli con urgenza perché la struttura minaccia di rovinare “per aversi differito tanto tempo a dar principio a ditta fortificazione”[9].

La chiesa di San Francesco detta di Sant'Antonio
Abbiamo detto che una delle prime cose che Carlo V decise e che il capitano Gonzalo de Armella realizzò, insieme alla riparazione delle mura, fu quello fu di “spianare tutto il borgo cosiché le mura potessero dominare scopertamente la campagna[10]”. E questo perché non era solo considerato insicuro e pericoloso per abitarvi ma rappresentava anche un pericolo perché si poteva dare riparo ad eventuali attaccanti, come era avvenuto per il Barbarossa. Ma dove mandare ad abitare la gente di Lipari? Probabilmente per i primissimi tempi, fin quando la popolazione fu sotto i duemila abitanti, la questione non si pose, ma via via che l’opera di ripopolamento andava avanti non era pensabile che tutti potessero risiedere dentro le mura del castello. Ha inizio così un braccio di ferro fra le disposizioni delle autorità regie ed i comportamenti della gente spesso col beneplacito delle autorità cittadine. Da una parte si continua a ribadire il divieto - “non ardisca ne presuma piantare vite, ne fabbricare in modo alcuno in lo burgo in fronte la chiesa di S.to Petro in contro allo spontone né in altra parte intorno alla muraglia di questa città”[11] - e dall’altro lo si contravviene. E non giovano nemmeno le sanzioni che vengono poste come nel 1606 “sotto pena, per i nobili, di cinque anni di esilio dall’Isola e onze cinquanta da pagarsi per la regia fabrica, e, per i non nobili, sei anni al remo sulle galere” [12], o nel 1647 quando si vuole privare - chi abita fuori della mura - del diritto di voto e dei privilegi[13] o di nuovo si ribadisce, nel 1687, il pagamento di 50 onze di multa a chi vi abita senza permesso[14]. Così nel censimento del 1653 su 4480 abitanti ben 2406 abitavano “nel burgo e nelle marine”[15]. Nel 1653 però apprendiamo che nel borgo operano sei mulini e se ne autorizzano altri quattro, mentre alle due botteghe di alimentari se ne aggiungono altre due [16]. Eppure nel 1685 prima e nel 1687 ancora, il conte di Santisteban esprime grande meraviglia e chiede come sia possibile che. “senza espresso ordine nostro” , sorgano fuori dalle mura tante costruzioni[17]. Segno questo che qualche volta le autorità locali – come si è accennato - si mostravano comprensive. Daltronde come avrebbero dovuto fare i liparesi?
 Duca d'Alcalà
Duca d'Alcalà
Nel 1634 tramite i giurati avevano ripescato l’antico progetto di costruire sulla Civita, giudicato luogo più atto e sicuro da abitare, ed i giurati avevano inviato una supplica al duca di Alcalà.[18] Il consenso è ottenuto ma questo non blocca le costruzioni nella marina di San Giovanni che finisce col rappresentare il collegamento fra la Maddalena ed il quartiere di S.Pietro. Infatti proprio in quello stesso anno i giurati chiedono l’autorizzazione al duca di usare del patrimonio civico per completare il terrapieno del bastione che porta questo nome[19].
Abbiamo detto dell’attenzione del papa e del vescovo Baldo Ferratino – che pur continuava a vivere a Roma - per la riedificazione delle chiese subito dopo la “ruina” ed infatti già a partire dal 1545 vengono costruite le chiese di San Giuseppe, di San Pietro, delle Anime Purganti a Marina Corta ed iniziano i lavori per la Cattedrale che fu completata negli anni successivi. Si mise mano anche alla ricostruzione del palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale. Il Campis osserva che la Cattedrale – grazie alla vigilanza e sollecitudine del vescovo - “ è riuscita più nobile che prima fosse, imperciò che quel tempio non è [più] coperto di tavole, ma d’una bellissima volta”[20]. E se i francescani che avevano avuto in custodia la chiesa di San Bartolomeo alla Maddalena vanno via subito dopo il sacco[21], dopo qualche anno, nel 1584, arriveranno i cappuccini che daranno inizio alla costruzione del convento e della chiesa di S. Francesco sulla Civita e cioè all’attuale Municipio ed a quella che oggi si chiama chiesa di S. Antonio[22].
Il riconoscimento e l’applicazione dei privilegi
Carlo V ed il viceré di Napoli, come abbiamo visto, avevano riconfermato tutti gli antichi privilegi oltre alle norme per ripopolare la città, ma questa direttiva doveva essere disattesa molto spesso dal comandante della città e dai suoi funzionari, perché i liparesi nel 1574 sono costretti a esprimere una protesta molto forte dichiarando che se la loro richiesta dovesse continuare ad essere ignorata si troveranno costretti a “disabitar dita città” [23]. Ma ancora nel 1598 deve intervenire il conte di Miranda per ordinare al capitano che si rispettino i privilegi e le consuetudini[24].
Non si tratta solo di rispetto dei privilegi, il fatto è che la guarnigione vuole le tangenti per consentire ai liparesi quello che è loro diritto. Come nel caso dei permessi per recarsi nelle isole minori a lavorare. Queste infatti erano ufficialmente disabitate e tali si voleva che rimanessero sia per pericolo degli agguati della pirateria turca, sia, in  caso di guerra, temendo la presenza di vascelli nemici e sia per evitare il contagio dalle ricorrenti pestilenze. Così il Capitan d’armi e governatore di Lipari era tenuto ad impedirvi, in genere, l’accesso. Ai lavoratori in proprio o per conto terzi, escluse le donne e gli uomini sotto i 18 anni e sopra i 60, soleva rilasciarsi un permesso d’uscita a tempo determinato, cioè per la durata dei lavori stagionali. Ma ottenere il regolare permesso d’uscita non era cosa facile, giacché il Governatore ed i suoi ufficiali frapponevano una infinità di ostacoli, a meno che il richiedente non accondiscendesse a pagare una sostanziosa tangente in natura[25].
caso di guerra, temendo la presenza di vascelli nemici e sia per evitare il contagio dalle ricorrenti pestilenze. Così il Capitan d’armi e governatore di Lipari era tenuto ad impedirvi, in genere, l’accesso. Ai lavoratori in proprio o per conto terzi, escluse le donne e gli uomini sotto i 18 anni e sopra i 60, soleva rilasciarsi un permesso d’uscita a tempo determinato, cioè per la durata dei lavori stagionali. Ma ottenere il regolare permesso d’uscita non era cosa facile, giacché il Governatore ed i suoi ufficiali frapponevano una infinità di ostacoli, a meno che il richiedente non accondiscendesse a pagare una sostanziosa tangente in natura[25].
Conte di Miranda
Conflitti con la guarnigione del Castello
Ancora, nel 1588 i liparesi si lamentano che il Capitano della città non permette loro di pescare di notte né nella loro isola né in quelle vicine a meno che non diano a lui una parte del pescato e cioè la quota di un pescatore: un grande danno. Il 12 dicembre 1588 il Conte di Miranda accoglie la petizione ed ordina al Capitano di non molestare i liparesi che possono andare a pescare di giorno e di notte senza dovergli dare niente. Invece i pescatori dovranno versare ai giurati un carlino per ogni barile di pescato che dovrà servire a pagare le guardie che fanno il servizio di controllo intorno all’isola[26].
Lo stesso problema lo pongono altri tipi di pescatori che non vanno in cerca di pesci ma di schiavi. Anche i padroni di barche che volevano uscire in mare a fare una retata o andare in Sicilia a vendere gli infedeli che gli era capitato di far schiavi, lamentano di dover pagare grosse tangenti occulte.
E’ superfluo dire che per tutti questi arbitri e abusi i liparoti si lagnarono più volte con le autorità superiori – generalmente il vicerè di Napoli e di Palermo, - ma con esito non sempre favorevole.
 Esito favorevole invece ha la petizione che nel 1595 i liparesi rivolgono al re Filippo II perché i loro privilegi siano applicati anche nei rapporti commerciali con la Sicilia[27]. Così anche nel 1618 lo stesso re conferma il diritto dei padroni di barche di tenere per se tutta la preda di schiavi senza dovere niente al regio fisco[28].
Esito favorevole invece ha la petizione che nel 1595 i liparesi rivolgono al re Filippo II perché i loro privilegi siano applicati anche nei rapporti commerciali con la Sicilia[27]. Così anche nel 1618 lo stesso re conferma il diritto dei padroni di barche di tenere per se tutta la preda di schiavi senza dovere niente al regio fisco[28].
[1] G.Retifo, “Un drammatico sradicamento e un convulso ripopolamento. Lipari dopo il 1544” in Atlante dei beni etno-antropologici eoliani, Messina 1955., pag.48.
[2] P.Campis, op.cit., pag. 307-8.
[3] Idem, pag. 48.
[4] P.Campis, op.cit., pag. 308. G.Restifo, op.cit. pag. 52.
[5] Idem, pag. 53.
[6] Idem, pag. 49. F. Vergara, Società e giustizia nelle Isole Eolie (sec. XVI-XVIII). I processi penali della Curia Vescovile di Lipari, Soveria Mannelli, 1994, pag. 16. G.Restifo, op.cit., pag. 53.
[7] I Rodriquez, i Lopes, i De Losa, i Mirabito, ecc.
[8] A, Raffa, op.cit., pag. 103
[9] A. Raffa, op. cit. , pag. 100.
[10] Lettera di Baldassar Calderon del 30 ottobre 1606 nel Libro delle Corrie, ff. 12-12v anche in G. Iacolino, I turchi…, op.cit., pag. 198-201. Il Calderon dice che nel 1594 il vescovo Mendoza aveva dato in affitto alcune parti del borgo per fabbricarvi o coltivare ma l’anno successivo il Capitano don Basco de Peralta “emanò un bando secondo il quale nessuna persona osasse fabbricare o piantare alberi, sia piccoli che grandi, in detto borgo senza ordine di sua Eccellenza, sotto pena di cinquanta onze”.
[11] Libro delle corrie, 1606,f.12 v.
[12] Idem.
[13] Libro rosso, foglio 172 v. in A.Raffa, op.cit. pag. 99.
[14] Idem, foglio 311 r:.
[15] Idem, f.186,v.
[16] Idem, f.221 r, 222r, 258 r ev.
[17] Idem, f. 311 r.
[18] Idem, f.106 r e v.
[19] Idem, f..107 v.
[20] P.Campis, op.cit., pag.308.
[21] Nel 1559 viene venduto all’asta il loro convento alla Maddalena e lo comperano Gioannello Mercurella e la moglie Pina. “La chiesa francescana di S.Bartolomeo alla Maddalena, benché assai malconcia a seguito dell’incendio turchesco, restò adibita al culto finché non fu abbattuta. Al suo posto – e a semplice titolo di ricordo -, i fedeli liparoti del ‘600 vollero erigere qualla cappellina quadrata, con campanile, che ancora sussiste. E’ interessante sapere che al decadimento della quattrocentesca chiesa di S. Bartolomeo ebbero un qualche interesse i vescovi i quali mal tolleravano che la devozione al Santo Protettore non fosse interamente accentrata nella Cattedrale. Tant’è che essi, i vescovi, nelle vicinanze della chiesa francescana favorirono l’erezione di un nuovo sacello dedicato a S.Giuseppe.” ( G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., p.197-198.
[22] Il manoscritto di P.Bonaventura da Troina (+1704) ( a cura di Giuseppe Lipari).Libro I, Messina 1999, pag. 140. I cappuccini lasciano Lipari nel 1599 e nelle loro strutture verranno ad insediarsi, verso il 1600 i Minori. I cappuccini torneranno ancora una volta a Lipari nel 1650 e costruiranno convento e chiesa nella zona attuale del cimitero. G.Iacolino. I turchi alla marina, op.cit., pag. 194-198.
[23] Libro delle Corrie, f.1 e 1v.
[24] Libro delle Corrie, 16 gennaio 1589, f.3 v.
[25] G.Iacolino, manoscritto, La chiesa cattedrale di Lipari sotto il titolo di S.Bartolomeo, Quaderno II A.
[26] Libro delle corrie, foglio 2 v..
[27] P.Campis, op.cit., pag. 316.
[28] Libro rosso, f. 228 r; A. Raffa, op.cit., pag. 104.(Archivio Storico Eoliano.it)
Si ricostruiscono le chiese
La riedificazione di Lipari dopo la “ruina”
L'attenzione dell'imperatore e del Papa


L'imperatore Carlo V e il Papa Paolo III
La “ruina” di Lipari, abbiamo detto, colpì notevolmente la mente, il cuore, la fantasia della cristianità di allora e Carlo V ed il Papa Paolo III fecero a gara per cercare di riedificare Lipari e di ripopolarla. Carlo V era stato sensibilizzato sulla situazione anche da una lettera, come abbiamo visto, del marchese di Terranova dell’8 settembre 1544 che temeva che un’isola strategicamente così importante, sia per il regno di Napoli che per il regno di Sicilia, se fosse rimasta disabitata avrebbe rappresentato una “gran commodità de’ corsali[1]”. Per questo concesse ai Liparesi ampi privilegi, immunità ed esenzioni. Inviò anche una colonia di tecnici e di maestranze con il compito di restaurare il Castello e di renderlo più forte di prima munendolo di nuovi bastioni e di muraglie inespugnabili e fece demolire le case del Borgo[2]. Il Papa pensò alla riedificazione delle chiese ed il 28 novembre del 1544 non solo elevò il vescovo di Lipari, Ubaldo Ferratino, a Nunzio Apostolico, che era scampato alla deportazione perché viveva a Roma, ma lo investì di ampia autorità compreso quella di concedere indulgenze a coloro che con elargizioni avessero concorso alla riedificazione delle chiese distrutte. Contemporaneamente il Papa ordinava all'Arcivescovo di Messina di obbligare con censure e scomuniche coloro che possedevano volumi, documenti e altri oggetti appartenuti all'Archivio Vescovile di Lipari ed alle Chiese della città, usurpati durante la “ruina”, di restituirli[3].

Paolo III benedice Carlo V
Purtroppo questo “appello” non ebbe grande successo, tanto è vero che il 1544 rimane ancora oggi come il tempo di una grande cesura dopo quella dell’833. Non esistono praticamente documenti di Lipari che parlano delle vicende delle isole prima di quella data. Per il periodo normanno la documentazione è recuperata soprattutto dagli archivi di Palermo, Roma e Patti. Le consuetudini ed i privilegi sono stati ricostituiti dopo la “ruina” attingendo dagli archivi di Palermo e Napoli. Qualche altro documento è possibile rintracciarlo negli archivi di tutto il mondo. Migliore successo ebbe invece, come vedremo, l'opera di ricostruzione.
Intanto malgrado gli impegni di Carlo V e del papa di riportare le Eolie alla normalità, queste erano fatto spesso oggetto delle mire dei pirati saraceni. La fama infatti del sacco del Barbarossa aveva attirato l'attenzione di emuli. Si distinse fra gli altri il corsaro Dragut che era stato uno dei luogotenenti del Barbarossa e che alle nostre isole doveva essersi, in qualche modo affezionato. Varie volte Dragut operò nelle Eolie tanto che un quartiere di Panarea è rimasto intestato a suo nome.
L'autodifesa dei Liparesi
Dobbiamo dire che nel corso degli anni i liparesi andarono facendosi per mare più abili e agguerriti tanto da non avere più paura dei pirati ma anzi prendendo ad affrontarli direttamente.
“Il nome di Lipari – commenta Zagami – tornò , come nei tempi antichi, ad essere temuto sul mare e ben presto i Turchi cominciarono ad astenersi dall'avvicinarsi alle isole Eolie ed a farsi vedere nel mare del Tirreno”[4].


A sinistra don Giovanni d'Austria e a destra una scena della battaglia di Lepanto
Comunque anche l'epoca dei pirati barbareschi volgeva al termine. Nel 1565, nel tentativo di occupare Malta, Dragut trovò la morte. Ancora qualche anno e il 7 ottobre 1571 una grande armata navale organizzata da Stati cristiani al comando di don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V, si scontrava nel golfo di Lepanto con l'armata navale turca e dopo un'aspra battaglia riportò la vittoria che doveva distruggere per sempre la potenza marinara ottomana.
[1] Archivo Generale de Simancas, op. cit., legajo 1116, n.30). Fra l’altro il Terranova che si era recato a Lipari con un ingegnere oltre a suggerire al re di aggregare le Eolie al viceregno di Sicilia (“si fossero state unite a questo [ di Sicilia] Regno, per la vicinità se le haveria possuto fre migliore provisione..”), consiglia di realizzare tutto intorno alla rocca una cinta muraria continua e interrotta ed erigere dal lato mare tre torri di buona fattura, collegate da trincee con casematte correnti da torre a torre.
[2] P.Campis, op.cit.,pag. 306.
[3] P.Campis, op.cit., pag. 307.
Documento: Relazione del marchese di Terranova, presidente del Regno di Sicilia, all’imperatore Carlo V
(Il documento viene pubblicato per gentile concessione del prof. Giuseppe Iacolino ed è tratto dal suo libro “Le Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”, vol. IV, in corso di preparazione. Il Marchese di Terranova visitò le Eolie subito dopo la "ruina").

L'imperatore Carlo V
Con la caduta di Lipari. La deportazione di tante creature e la selvaggia distruzione della città, il viceré di Napoli don Pedro de Toledo accusava l’ennesima gravissima umiliazione che veniva ad aggiungersi all’amara consapevolezza del suo stato di impotenza. Meno umiliato ma più preoccupato ed inquieto era il presidente del Regno di Sicilia don Giovanni di Aragona e Tagliavia, marchese di Terranova. Questi, mentre il Barbarossa si andava avvicinando al basso Tirreno, temendo brutte sorprese nelle coste del triangolo peloritano, si era trasferito a Messina nel cui canale di lì a poco sarebbe apparsa la grande flotta nemica.
Da Messina il marchese di Terranova ebbe agio di seguire le manovre e gli spostamenti dell’armata e di venire informato di nuove scorrerie dei turchi nell’entroterra calabro. Di quei frenetici giorni egli inviò al re di Spagna e imperatore Carlo V una lunga e circostanziata relazione della quale amiamo riportare i passi che riguardano la nostra storia:
Lettera del 19 luglio 1544
“Sacra Cesarea et Catholica Maestà, Havendo per altre mie scritto a V.M.tà quanto è occorso, per questa sarà avvisata come l’armata turchesca, doppo la presa de Lipari essendo intrata in Faro et giunta alla Cattona, fecero intendere volere intertenerse per far riscatto delle anime prese, et che andasse chi volesse che li davano salvo condotto, dove hanno accordati molti et riscattato buon numero tanto de’ Liparotti come de Ischia. La matina di XIIIJ del presente [mese di luglio]in Callabria posero in terra da 600 turchi et corsero tra terra otto o dieci miglia, et presero da ottocento anime et ne amazzaro da mille et cinquicento…
Per relatione di alcuni d’essa armata, quello [che]se intende sarà con la presente il summario per informatione di V.M.tà; Lipari è de importanza per essere luoco forte et porto tanto vicino a questi doi Regni [di Sicilia e di Napoli], et si non si habita, sarà gran commodità de’ corsali; del che si ne causerà gran disturbo alla negociacione oltre che non potranno stare in tutta la costa di qua [cioè da Messina] a Palermo, né in la costa di Callabria, et molto più importa a questo Regno per essere piùvicina et al passo del tratto di questa Città a Palermo et delle navi che vengono di ponente. Queste Isole…,si fossero state unite a questo Regno, per la vicinità se le haveria possuto fare migliore previsione…
A XVJ del presente [mese di luglio]fu preso dalle guardie uno di Talamone venuto qui per riscattare di quelli del Sanese, il quale veniva dall’armata, et le ritrovarono un plico de lettere dal Priore di Capua che andavano a Roma; et quelle apperte, vi sonno trovate lettere di Polin per il Re di Francia et per lo Ambasciatore suo a Roma, et altri le quali con questa mando a V. M.tà…La matina seguente si partirono le quaranta galere et le navi; heri, che furon XVIIJ, si partì Barbarossa con il resto dell’armata costeggiando Callabria al camino di Levante. Questa mattina è partito Giannettino seguendo il camino dell’armata. Si son fatti riscatti di alcune anime di quelli de Ischia e di quelli de Lipari. Forse poche….”.
(NOTA – Archivio Generale de Simancas, Legajo 1116, n.38)

Ai primi di settembre il presidente del Regno, unitamente alla sua corte, ritornò a Palermo, e si servì di alcune galee della religione, di quelle, cioè, che erano in dotazione a certe comunità francescane dedite a procurare il riscatto di cristiani caduti in schiavitù. Durante il viaggio, il Terranova volle eseguire sopralluoghi a Milazzo, a Lipari e a Patti. A rigore, non sarebbe spettato a lui visitare Lipari che era una dipendenza del viceregno di Napoli; ma decise di venirci ugualmente a motivo della rilevanza strategica dell’arcipelago nei riguardi anche della costa settentrionale della Sicilia, oltre che di quella occidentale di Calabria. Di ciò che osservò, delle disposizioni che diede e dei suggerimenti che propose il marchese di Terranova spedì a Carlo V una breve relazione che è dell’8 settembre 1544. In essa si sostiene che Città Alta di Lipari, benché avesse una muraglia tutta di ‘pietra e terra’ e per giunta discontinua, non poteva cadere in potere del nemico anche quando questo la avesse ‘battuta’ con l’artiglieria per un mese intero. E’ vero, scrive il Terranova, che il Barbarossa ‘più facile l’haveria preso per altra parte’ cioè dal lato di tramontana, che per varie ragioni avrebbe potuto offrire agli assedianti un notevolissimo vantaggio. Sennonché l’ammiraglio preferì non spostare le artiglierie; era sicuro, del resto, che prima o poi i Liparoti, stretti dalla fame e dalla sete, avrebbero ceduto. Queste constatazioni furono per il Terranova una ‘làstima’, un motivo di rammarico e di rabbia. Il suo suggerimento? Eccolo: far condurre una cinta muraria continua e ininterrotta ed erigere sul lato mare tre alte torri, e di buona fattura, collegate da ‘traverse’ o robusti baluardi correnti tra torre e torre. Qui il documento:
Lettera 8 settembre 1544.
“Sacra Cesarea et Catholica Maestà,
Da Messina scrissi a V.M.tà dandole ragione di quanto era occorso et convenia al servitio di V. M.tà, così de ché partiva con questa Regia Coete per qua…
Havendomi ocorso la commodità delle Galere della religione,con quelle partettj [per]Melazzo dove reconoscettj il bisogno e lassai ordine che s’attendesse a continuar quella fabrica et fortification come parse essere bisogno. Dilà me parse [bene],con la comodità delle Galere, voler vedere Lipari portando con me l’ingegniero Ferramolino. Et intanto in quelle Isole la notte trovammo una galeotta de’ Turchi, la qual présimo. La mattina dopo sbarchai in Lipari dove mai ero stato. Per un conto mi parse [giusto] veddere quel luogho per darne raggione a V.M.tà; dall’altra parte [da Tramontana]me parse gran làstima veddere un sì bel luogo di quella fortezza; e con tutta la batteria che fecero, si bene havessero un mese battuto, non haveriano possuto fare effetto nessuno: tal che,si se havesseno volsuti defendere per quella parte non si posseva pigliare, perché restava la batteria alta due picche, et dalla parte de dentro tenéa una trencera fatta che le donne bastavano defendere; per l’altra parte [da Mezzogiorno]saria stata manco forte et più facile l’haveria preso. Mi parse veddere che Barbarossa sempre pensò che se rendessero: per questo non volle allargasse con l’artellaria da dove disbargò. Viddj quella fortezza di dentro e di fuore, la quale de sito è assai forte, però non tiene nessuno traverso né muraglia che vaglia, perché tutta è di pietra et terra. Fici misurare quello che circonda, lo qual è, per la parte de terra, canne duecento, per la parte del mare canne centocinquanta che fan tricento cinquanta canne in tutto. Vi bisognaria tre Torrioni; per far traverse bisogneria di nuovo murare tutte le mura; lo quale, e fatto il conto per Ferramolin et altri per lacommodità dela pietra che vi è a tratto con venticinque millia scudi se farria quella fortification complitamente e tal che sarrìa inespugnabile. La importanza di quel luogho per l’uno e l’altro Regno – e più per questo che per gli altri – V. M.tà l’haverà inteso, e de adesso sene sente travaglio de’ corsali, ultra che vi è un porto di cento galere che dicono Vulcano, un miglio discosto XXV millia scudj. M’ha parso [bene] darne particular raggione a V.M.tà. Da Lipari venni a Patti sì per veddere e dare ordine che quella terra se reparasse, perché con star Lipari dis’habitato, sempre vi sono corsali; quella terra essendo vicina, stariano quelle gente con periculo; trovo che con poco se reparirà, che se assecureranno de corraìe, dove ho lassato don Antonio Brancciforte per capitan d’arme perché attenda con la più prestezza a ditta reparacione; per lo che quella terra prontamente ho fatto che dia scudi dui millia; si mancan, sarà puoco cosa. Vuolsi veddere il danno che recevettero, e trovo che fu poca cosa. Nel che culparo essi per non s’havere governato come li fu ordinato per me si como da poi le fe defendere, che se le escusào che non revettero danno nissuno.
Da Lipari venni a Patti sì per veddere e dare ordine che quella terra se reparasse, perché con star Lipari dis’habitato, sempre vi sono corsali; quella terra essendo vicina, stariano quelle gente con periculo; trovo che con poco se reparirà, che se assecureranno de corraìe, dove ho lassato don Antonio Brancciforte per capitan d’arme perché attenda con la più prestezza a ditta reparacione; per lo che quella terra prontamente ho fatto che dia scudi dui millia; si mancan, sarà puoco cosa. Vuolsi veddere il danno che recevettero, e trovo che fu poca cosa. Nel che culparo essi per non s’havere governato come li fu ordinato per me si como da poi le fe defendere, che se le escusào che non revettero danno nissuno.
Il Vescovo di Patti me ha fatto instantia che dovesse informarmi deli danni[che]lui e sua Ecclesia hanno ricevuto per l’Armata che fu in quello mare, e trovo che in tutto il danno ricevuto con cento scudi se restora tutto, perché non fecero altro danno che ali Organi della Ecclesia. Il danno fu quello poco ad alcunipovere genti che li brusciaron da sissanta case di poca importanza…”.
(NOTA- Archivio General de Simancas, Legajo 1116, n°38).(Archivio Storico Eoliano.it)
Alcuni interrogativi sulla vicenda: quanti erano gli abitanti? quanti i deportati? ci fu tradimento e da parte chi?
Ipotesi sui deportati

Esercito ottomano
Partito il Barbarossa lascia dietro di sé devastazione, morte e le rovine ancora fumanti della città alta. Una serie di domande “difficili” che ci si pone è cercare di valutare quanti abitanti avesse Lipari prima della “ruina”, quanti furono i deportati, quanto furono quelli sfuggiti alla deportazione ed alla morte e - nascosti e dispersi per le campagne - rimangono per qualche tempo timorosi di riaffacciarsi in città per visitare i ruderi dei monumenti e delle case e piangere sui morti, quanti erano, infine, quelli che tornarono dopo la tragedia o perché erano fuggiti prima dell’arrivo dei turchi trasferendosi a Milazzo o in altre città della costa, o perché tornarono dalla deportazione, qualcuno subito, qualcuno dopo molti anni .
Cominciamo dai deportati per i quali esistono, come abbiamo visto, alcune cifre anche se fra loro un po’ discordanti. Maurando parla di 10 mila fra quelli che erano entro le mura e quelli che furono scovati( 1000) nelle campagne. Di novemila cittadini parla De Simone, di ottomila il Campis. La cronaca cappuccina conferma Maurando e dice che furono catturate da nove a diecimila persone.
Giuseppe Restifo[1] ritiene esagerate le cifre fornite dai testimoni dell’epoca, giacché come è tipico nelle catastrofi i resoconti dei testimoni tendono ad enfatizzare. A suo avviso Lipari poteva contare allora, al massimo, 4660 persone compreso quelle che moriranno nello scontro e quelle che riusciranno a fuggire. Ma questo conto si basa soprattutto sulle notizie che da il Campis – e che anche noi abbiamo riportato – dell'organizzazione della città in quartieri con comandanti e milizie volontarie. Infatti il Campis dice che la città fortificata fu divisa in sei quartieri e ad ognuno di questi furono assegnati due comandanti e centosessanta uomini in armi. In tutto 960 uomini abili al combattimento e cioè, secondo la norma del tempo, fra i 18 ed i 60 anni. Se si prende come base, suggerisce Restifo, il censimento del 1610, questa classe rappresenterebbe il 41,2% della popolazione maschile totale. La totalità dell’universo maschile a Lipari nel 1544 sarebbe stato cioè di 2330 maschi. Sempre basandosi sul censimento del 1610 siccome i maschi rappresentano il 53% della popolazione totale, la popolazione di Lipari sarebbe stata di 4396 abitanti; tutt’al più 4660 se si vogliono riportare le donne al 50% della popolazione totale. Ecco come Restifo ricava la sua cifra.
 Pur apprezzando il ragionamento proposto vorremmo forse osservare che i dati del Campis si riferiscono alla situazione nella città alla vigilia dell’arrivo del Barbarossa e riguardavano gli abitanti abituali del castello. Ma quando il pericolo diventò incombente e si delinearono all’orizzonte le navi saracene, allora si dovette verificare una corsa dal borgo e dalle campagne a cercare rifugio nella rocca fortificata. Quanti furono queste persone che si rifugiarono nelle case di amici e parenti o si accamparono nella cattedrale ed in ogni buco o magazzino, o anche all’aperto visto che era luglio e quindi il clima favorevole? Non lo sapremo mai, ma non è impensabile che il numero raddoppiasse rispetto agli abitanti che abitualmente risiedevano al castello.
Pur apprezzando il ragionamento proposto vorremmo forse osservare che i dati del Campis si riferiscono alla situazione nella città alla vigilia dell’arrivo del Barbarossa e riguardavano gli abitanti abituali del castello. Ma quando il pericolo diventò incombente e si delinearono all’orizzonte le navi saracene, allora si dovette verificare una corsa dal borgo e dalle campagne a cercare rifugio nella rocca fortificata. Quanti furono queste persone che si rifugiarono nelle case di amici e parenti o si accamparono nella cattedrale ed in ogni buco o magazzino, o anche all’aperto visto che era luglio e quindi il clima favorevole? Non lo sapremo mai, ma non è impensabile che il numero raddoppiasse rispetto agli abitanti che abitualmente risiedevano al castello.
Quanti nativi scamparono alla "ruina"?
Un secondo problema è quanti furono i deportati riscattati prima della partenza decisiva per Costantinopoli. Nella tappa che la nave fece a Messina o a Catona in Calabria, come dice il Maurando, ci furono sicuramente alcuni riscattati a cominciare dal Camagna e dai suoi famigliari. Ma quanti furono? La versione del Campis che sostiene che il Barbarossa fosse ben contendo di liberarsi da parte del suo carico a prezzo conveniente perché temeva che il sovraffollamento poteva provocare ribellioni e difficoltà nel viaggio, si scontra contro quella di p.Bonaventura che invece parla di trattative che non sono andate a buon fine perché mentre i messinesi temporeggiavano perché speravano che Ariadeno venisse a più miti consigli, questo levò le tende e parti. Il francese Maurando sa che le trattative erano aperte ma non sa come andarono a finire perché le navi di Francesco I partirono prima di quelle turche. Comunque si dovette trattare al massimo di poche centinaia non certo di migliaia.
La maggior parte dei prigionieri navigarono verso Costantinopoli., affrontando un viaggio carico di sofferenze non minori di quelle patite sino ad allora. “Condizioni inumane” le definisce Angelo Raffa[2] quelle che dovettero affrontare. L’affollamento e le conseguenti condizioni igieniche e forse anche la mancanza di un vitto adeguato provocarono molte malattie e molte morti[3]. Una testimonianza resa da Bartholo Boe - che era fra i deportati e poi riuscì a riscattarsi - dice che degli schiavi presi a Lipari ed in altri luoghi, durante il viaggio, ne sono morti assai e soprattutto ragazzi per “li mali patimenti” tanto che il Barbarossa arrivato a Lepanto ordinò che si vendessero subito quelli malati, fra cui c’era appunto Boe che venne riscattato per 20 ducati da alcuni liparoti rinnegati che lì si trovavano[4].
Ancora, quanti furono i liparesi che rimasero sull’isola nascosti e che erano scampati al sacco? Il Presidente del Regno di Sicilia don Giovanni d'Aragona marchese di Terranova, ai primi di settembre dello stesso 1544, tornando a Palermo, volle eseguire sopralluoghi a Milazzo, Lipari e Patti. Visitò anche Lipari sebbene non avesse competenza su questo territorio giacchè le isole dipendevano dal vice regno di Napoli. Anche se erano passati cinquanta giorni dall'11 luglio la trovò completamente disabitata salvo una galeotta dei Turchi che lì stazionava e che subito fecero prigioniera. Non parlò di case distrutte – come fece per Patti - perché probabilmente lo erano tutte e si soffermò a dare indicazioni per il restauro della cinta muraria[5].

Quindi i sopravvissuti, ancora a cinquanta giorni, dai fatti si guardavano bene dal mettersi in mostra visto che la zona continuava ad essere battuta da navigli saraceni. Comunque doveva trattarsi di poche centinaia visto che gli uomini del Barbarossa prima di partire avevano battuto meticolosamente l’isola - per due giorni, secondo De Simone, per otto giorni secondo, p.Bonaventura - proprio alla loro ricerca.
Col tempo però Lipari riprese ad essere abitata. Chi si era rifugiato in campagna tornò nella città se non nel borgo, tornarono anche a Lipari chi era fuggito prima dell’arrivo dei saraceni a Milazzo e sulla costa siciliana, chi era stato riscattato a Messina o a Catona. Crediamo che siano stati, in tutto, un 700-800 persone, certo meno di un migliaio. Via via nel tempo tornò anche qualche deportato che si era riscattato o a Lepanto, come abbiamo detto, o a Costantinopoli[6]. A questo nucleo storico di liparesi si aggiungono altri immigrati che vengono a ripopolare l’isola.
“A Lipari, dopo il sacco del 1544 e per tutta la seconda metà del '500. - osserva Giuseppe Restifo – si crea una sorta di Far West compensatore; giungono molti immigrati attratti dai privilegi accordati dall'Università, dalle esenzioni fiscali e penali, dalle opportunità che l'economia delle Isole Eolie può offrire”[7].
L’ipotesi del tradimento
L’interrogativo più intrigante che all’epoca si posero i contemporanei e non solo a Lipari o in Sicilia, fu il sospetto del tradimento. Abbiamo già visto come molti sospetti si puntarono su Jacopo Camagna e come questi subisse anche un processo dal quale uscì assolto. Ma il vicerè di Napoli, don Pedro de Toledo dichiara che si sa chi sono i colpevoli della resa di Lipari per cui comanda che si incarcerino e venga data una punizione esemplare. Giannettino Doria riferendosi alle trattative fra Ariadeno e maggior enti di Lipari parla di cinque successivi incontri, prima con delegazioni di quattro cittadini, poi di due ( Comito e Camagna?). Dalle sue parole si capisce che la responsabilità dell'andamento della trattativa e della resa finale non fu di uno solo ma collettiva, dei notabili, che dopo l'ultimo abboccamento con l'assediante diedero ad intendere che c’era una possibilità di salvezza per tutti. Su questa base si sarebbe formato il consenso generale alla resa.
 Don Pedro di Toledo
Don Pedro di Toledo
Fra coloro che si sono occupati della vicenda, due storici che probabilmente attinsero alle stesse fonti – il Campis ed il Pirri – sembrano giungere a conclusioni diverse. Decisamente innocentista il Campis, mentre il Pirri, ricapitolando i tre capi di accusa nei confronti di Jacopo Camagna - l’amicizia con il Barbarossa, gli abboccamenti reiterati e senza osservatori col nemico, l’esenzione che aveva ottenuta per se e i suoi parenti – sembra avallare il dubbio.
Chi era il Camagna? Sicuramente una delle persone più facoltose ed in vista della Lipari del tempo[8]. Proprietario terriero giacchè ancora nel XVII secolo vi era una piana ,nella zona di Balestrieri e Munciarda, che si chiamava “contrada di Camagna” ed anche armatore e navigatore con diverse imbarcazioni che operavano su un buon tratto di Marina lunga che si chiamava appunto “Plaia di Camagna”. I suoi commerci lo portavano spesso lontano da Lipari fino nelle terre più lontane, come Costantinopoli, dove pure, come abbiamo visto, arrivavano i prodotti delle Eolie. Nulla di strano che in questi viaggi sia venuto spesso a contatto con Ariadeno che appunto a Costantinopoli aveva residenza e probabilmente era anche stato suo cliente. Col Barbarossa aveva acquisito una certa familiarità, né conosceva la furbizia, la spietatezza ma anche l’attenzione a concludere dei buoni affari. Così quando a Lipari si seppe che sarebbe arrivata l’armata del Barbarossa, non è improbabile che Jacopo abbia parlato di lui agli altri maggiorenti nelle giornate e serate di apprensione e lunghe discussioni in cui Lipari si apprestava allo scontro.
Un sospettato: Jacopo Camagna
“Lo conosco bene – avrà detto -, l’ho incontrato diverse volte, ho fatto diversi affari con lui. E’ un uomo duro e risoluto ma anche una persona con cui si può parlare. Non è un mostro, ve l’assicuro. Anzi, per molti versi è anche una persona gioviale”.
Questo avrà detto Jacopo. Non certo che era suo amico. E probabilmente perché lo conosceva e quindi poteva essere avvantaggiato nella trattativa è stato scelto dal Capitano Governatore e dai giurati, nella fase più drammatica, la sera del 9 luglio, nel momento più cruciale, quando la delegazione che aveva trattato fino ad allora gettò la spugna perché l’interlocutore non mostrava spiragli di umana comprensione. Così lo andarono a trovare sulla sua postazione quella che dalla Porta Falsa andava sino a Santa Maria delle Grazie, i bastioni più esposti ai colpi di cannone. Ed era lì malgrado avesse una brutta sciatica che lo tormentava. Dice infatti il Campis: “Era il Camagna gentiluomo di molta stima appresso tutti e, come già avanzato in età, haveva buona pratica delle cose e prudenza nel maneggio degli affari. Lo pregarono tutti l’Officiali e tutto il popolo d’addossarsi la cura di ridurre Barbarossa a qualche ragionevole conventione… Di mala voglia abracciò il Camagna l’assunto inpostoli, sì per le sue indisposizioni come pur anco per dover trattare un negotio che nella riuscita non poteva mai essere approvato egualmente da tutti, non essendovi cosa di magiore difficoltà e meno accertata che pretendere di sodisfare al populo”[9]Ma, alla fine acconsentì.
Durante la trattativa, a sentire il Campis, è Ariadeno che fa la proposta di esentare dalla schiavitù venti famiglie, “il che sempre ho praticato in prendere alcuna terra per forza” . Camagna e Comito rilanciano e cercano di ampliare l’offerta e Barbarossa sembra accettare. Ma è ancora un’offerta limitata, selettiva, che riguardava circa 200 persone.
L’idea che tramuta la conoscenza di Camagna col Barbarossa in amicizia, supponendo addirittura una complicità a danno dei concittadini, sarà maturata nella mente di molti liparesi a cominciare dal 10 luglio quando Jacopo torna con questa proposta che non può non scontentare i più. Ed infatti la reazione è quella che si aspettava. “Et infuriati proruppevano in gravi doglianze et improperi contro quelli che havevano trattato con Barbarossa, ma singolarmente contro Japoco Camagna” . Perciò questi si chiude in casa e rifiuta di tornare a parlamentare. Ci andrà invece il Comito che torna dicendo di aver strappato al Barbarossa la promessa che esenterà tutti purchè ognuno paghi venti scudi. Quindi gli abboccamenti del Camagna col Babarossa, a dire del Campis, non furono reiterati, ma uno solo e insieme al Comito. Quello che c’è da chiedersi invece e se andò veramente il Comito al secondo incontro col Barbarossa. Il Campis è dubbioso ed infatti dice: “andò o finse d’andare”. Comunque la gente gli crede e si calma.
Diverso è il racconto del Maurando. Il francese segue il racconto del Campis sino all’accordo con il Camarga ed il Comito che riassume così:”li Liparoti darebero la cità con tutto quello che sarebe dentro, salvo 70 case, le qualle sarebbero salve con tuti li homini et done, puti e putine, et tutta la roba che sarebe trovato dentro”. Respinto l’accordo dai cittadini, questi mandarono altri ambasciatori che proposero la “resa a discrezione” cioè la resa senza condizioni, mettendosi nelle mani del conquistatore. Certo i liparesi vengono messi tutti sullo stesso piano ma, in questa versione, non c’è alcuna promessa di esenzione dalla schiavitù né per poche famiglie, né tantomeno per tutti.
 Assedio ottomano a Rodi
Assedio ottomano a Rodi
Uno dei punti più controversi della “ruina” è proprio questo, su che cosa si sarebbe formato il consenso alla resa e se a questo proposito alla gente fu detto proprio tutto o qualcosa fu nascosta. Vediamo di ricapitolare. Il Campis chiude con l’assicurazione del Comito che Barbarossa farebbe salve oltre le 26 famiglie, più 50 uomini con le mogli, più gli eccleasiastici e gli ultra sessantenni - che già aveva concesso al Camagna - anche tutti coloro che avrebbero pagato 20 scudi; il Maurando sostiene invece che l’ultimo accordo sarebbe stato la resa a discrezione; De Simone è sulla posizione del Campis solo che invece di 26 famiglie più cinquanta, parla di 60 casate; il Pirri parla di resa della città lasciando andare 60 cittadini con le loro robe; infine p. Bonaventura parla di tradimento del Camagna che avrebbe aperto le porte al nemico in cambio della salvezza per se i suoi parenti e la sua roba.
La responsabilità colletiva dei notabili
Angelo Raffa[10], invece, che ha avuto modo di consultare l’Archivio di Simancas[11]. fa sua la versione dell’accordo che fornisce Giannettino Doria e che da la responsabilità del tradimento, non ad uno solo, ma ai notabili che dopo l’ultimo abboccamento con l’assediante fecero credere al popolo che tutti si sarebbero salvati grazie al patrimonio delle 26 famiglie più ricche che avrebbe rappresentato il riscatto per tutti. Come si vede una versione dell’accordo inedita che non emerge affatto dai racconti che abbiamo analizzato.
Il giorno dopo, cioè l’11 di luglio, il Barbarossa – che certamente ha in mente solo la vendetta per l’umiliazione subita di un assedio che assolutamente non aveva messo in conto - finge di muoversi nella direzione dell’esenzione per le sole famiglie benestanti trasferendo i mobili di queste nella casa del Camagna. In realtà mette al sicuro il bottino più ricco, che farà trasferire dopo sulle galee, prima di dare il via libera al saccheggio. A questo punto getta la maschera e dà il via libera ai suoi uomini per saccheggiare, distruggere, incendiare. Egli sa che non potrà fare arrivare a Costantinopoli tutte quelle ottomila persone, ma deve sanare il suo orgoglio colpito. E non ha pietà per nessuno, nemmeno per il Camagna che permetterà che sia riscattato ma solo a Messina insieme ad altri eoliani vecchi ed inabili al lavoro. Jacopo con la moglie Minichella torneranno ad abitare a Lipari dove moriranno, il primo probabilmente nel 1563, la seconda nel 1581[12].
Ci fu tradimento? Quello che è certo – osserva Raffa – è che alcuni cittadini furono subito riscattati, altri lo furono in seguito, moltissimi non tornarono mai più. Ciò significa che la promessa fatta dai notabili ai concittadini non venne mantenuta. “ Il vero tradimento consistette – scrive Raffa – nel far credere l'incredibile agli ingenui popolani, nel garantirsi la salvezza presente con la promessa a tutti d'una salvezza futura”[13]. Quindi avrebbe ragione Giannettino Doria mentre la dichiarazione di don Pedro da Toledo sembra avere piuttosto il senso di un alibi per chi avrebbe dovuto difendere l’isola e non fece nulla perché era stato deciso che l’isola dovesse essere una vittima sacrificale. Per cui parla di tradimento per distogliere l’attenzione dalle responsabilità politiche del governo ma lascerà nel vago i colpevoli[14].
[1] G.Restivo, Un drammatico sradicamento e un convulse ripopolamento. Lipari dopo il 1544, in Atlante dei beni etno-antropologici eoliani, (a cura di Sergio Todesco ) , Messina 1955, pag. 46-59.
[2] A.Raffa, op.cit., pag.93.
[3] “ Si dice che fu così numerosa la massa delle persone d’ogni ceto, che stavano sulla flotta, che , lungo il percorso della navigazione diretta a Costantinopoli, parecchie salme di prigionieri, stremati dalla fame, dalla sete e dall’afflizione ( fittamente stipati com’erano nel fondo delle navi in mezzo ai loro stessi escrementi) quasi ogni ora venivano gettati in mare.”Paolo Govio nel suo Historiarum sui temporis, libri XLV, che giungono fino al 1547, nell’ultimo libro parla della caduta di Lipari (pp.585-6). In G. Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Vol. IV, in corso di preparazione. Govio parla nella sua Historia di settemila deportati ed attribuisce il tradimento ad un certo Nicolò, “uno dei cittadini di spicco e uomo pavido” di cui lo stesso Campis afferma che di questo nome “non c’è mentione”(op.cit., pag. 306).
[4] A. Raffa, op.cit., pag. 105 nota n. 16.
[5] Archivio General de Simancas, Legajo 1116, n.38. Informazione fornitaci dal prof. Giuseppe Iacolino proveniente dal IV volume delle “Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”, ancora in corso di preparazione. Comunque, visto il ritardo delle pubblicazione, il prof. Iacolino ha consentito a pubblicare, su questo sito, nella Documentazione del capitolo, un estratto della relazione riguardante le Eolie e dintorni (v. Documentazione),
[6] L.Zagami, op.cit., riprende un episodio ricordato da Girolamo Di Marzo-Ferro in una nota della storia di Maurolico, Storia di Sicilia, 1849, lib. VI, pag. 360 e riferito al 1545. Un bastimento viaggiando da Scio ( l’isola di Chios ( ?) dinnanzi alla Turchia) verso Messina fu spinta dalla tempesta su una spiaggia delle Puglie. Oltre a tessuti preziosi questo naviglio aveva a bordo 250 passeggeri fra liparesi e calabresi che avevano riscattato la loro libertà e tornavano in patria. A causa del naufragio se ne salvarono solo cinquanta. Sempre a proposito di liparesi tornati dalla prigionia in oriente Giuseppe Restifo ( op.cit.pag. 46-47) parla di alcuni casi ricavati dalla documentazione di Processi civili conservati nell’Archivio Vescovile di Lipari ( vol. I).
[7] G.Restifo, op.cit., pag. 47.
[8] In un elenco delle “famiglie cospicue de’ Gentiluomini di Lipari” che vi erano prima della “ruina” che Giuseppe La Rosa dice di avere letto fra le carte di Cristoforo Cesareo e pubblica nel suo “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole di Lipari”, a cura di Alfredo Adornato, vol. II, pp19-20, Iacopo Camagna è al secondo posto subito dopo “la nobilissima famiglia de Franco”. L’elenco cita 32 famiglie e parecchie di queste sono divise in due o tre rami. Il manoscritto, come dice lo stesso La Rosa, non fa menzione alcuna delle famiglie dei popolani.
[9] P.Campis, op.cit., pag. 301.
[10] Op. cit., pag. 94.
[11] (Lettere al Viceré di Napoli, in Archivo General de Samancas, Papeles de Estado, Corrispondenci y negociacion de Napoles, Virreynato, E- 135/57)
[12] E’ una ipotesi che fa Giuseppe Iacolino nel manoscritto del libro sulla “ruina” non ancora pubblicato, di cui abbiamo fatto cenno, basandosi sui due testamenti. Dalla “Visitatio totus Diocesis Liparensis” del vescovo Francesco Arata, del 1685, Archivio Curia Vescovile di Lipari, foglio 59 v.
[13] A.Raffa, op.cit., pag.93-94 Il Campis infatti chiude con l’assicurazione del Comito che Barbarossa farebbe salve oltre le 26 famiglie, più 50 uomini con le mogli, più gli ecclesiastici e gli ultra sessantenni ( che già aveva concesso al Camagna) anche tutti coloro che avrebbero pagato 20 scudi; il Maurando sostiene invece che l’ultimo accordo sarebbe stato la resa a discrezione; De Simone è sulla posizione del Campis solo che invece di 26 famiglie più cinquanta, parla di 60 casate; il Pirri parla di resa della città lasciando andare 60 cittadini con le loro robe; infine p. Bonaventura parla di tradimento del Camagna che avrebbe aperto le porte al nemico in cambio della salvezza per se i suoi parenti e la sua roba.
[14] Una valutazione delle accuse di tradimento che ripercorrono molte delle nostre osservazioni la compie Giuseppe Iacolino nel suo manoscritto non ancora pubblicato e cioè il già citato quarto libro dell’opera “Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”.(Archivio Storico Eoliano.it)
L'ipotesi del tradimento
Gli undici giorni di passione di Lipari.
Le fonti della "ruina"

Schizzo di Marina corta del Maurando fatto durante l'attacco del Barbarossa
Sugli undici giorni in cui durò l'attacco a Lipari, prima della sua caduta, abbiamo diverse versioni. Innanzitutto quella di Pietro Campis ed è probabilmente la più importante perché se è vero che egli scrisse il suo Disegno Historico nel 1694, per quanto riguarda la storia della “ruina” utilizzò, come lui stesso dice[1], “un manoscritto di quei tempi conservato appresso Giovanni Cesario Gentiluomo di essa città”e quindi le informazioni che egli riporta non solo sono di un contemporaneo ma di uno che doveva aver vissuto la tragica vicenda dall’interno. In secondo luogo il racconto di Geronimo Maurando che abbiamo già citato e che partecipò alla “ruina” dalla parte di Ariadeno in quanto era cappellano di una galea del re francese Francesco I , anche lui testimonio diretto, partecipe della vicenda ma sullo schieramento opposto. Quindi il poemetto epico di Giovanni Andrea De Simone composto all'indomani della “ruina[2]”, un contemporaneo di Messina[3] che apprese della “ruina” forse da testimoni diretti ma che a questa non ebbe parte . C'è inoltre una “Relazione della fondazione del 26° convento dei P.P. Cappuccini che è quello di Lipari”, un manoscritto, forse del 1683, di frate Bonaventura da Troina che si trova nell'Archivio del Convento dei Cappuccini di Messina che contiene sui fatti una memoria raccolta sul finire del 600, “per relazione dei suoi antecessori” [4].
 Comunque grazie a questi documenti è possibile tracciare il racconto comparato dal 30 giugno, che era un lunedì, fino al 17 luglio[5].
Comunque grazie a questi documenti è possibile tracciare il racconto comparato dal 30 giugno, che era un lunedì, fino al 17 luglio[5].
Il Maurando, oltre a parlarci dello scontro ci dà alcune interessanti informazioni sulle Eolie. Innanzitutto ci parla di Lipari. Questa isola di Lipari – dice - è assai grande, abitata, ed è sede episcopale. La città è fortissima e i borghi grandi. A mio giudizio, prima di essere distrutta dai Turchi, vi erano tra la città e i borghi duemila case.
Di Lipari ci fornisce uno schizzo con in primo piano la rocca del Castello, il borgo della marina di San Giovanni, la piccola altura di Sopra la Terra e della Maddalena dove spicca la Chiesa ed il Convento di San Bartolomeo, una costruzione con un alto campanile. Sul disegno la scritta “Lipari è facta cusì”.
Una stampa con i galeoni di Barnarossa
Di Salina dice che vi sono “bellissime vigne. Non di uva per far vino, ma solo da far zibibi; dove se ne fa una grandissima quantità, ed i mercanti ne portano fino a Costantinopoli” confermando quanto abbiamo detto a proposito dello sfruttamento delle nostre miniere e delle nostre terre collegati con traffici commerciali in tutto il Mediterraneo. Di Stromboli afferma che era la casa di Eolo;” dal fumo che esce dal cratere i paesi delle isole vicine capiscono quali saranno i venti dei prossimi tre giorni; e per questo Eolo è dai poeti detto Dio dei venti” .

Lo schizzo di Maurando che raffigura Stromboli
Infine parla più a lungo di Vulcano dove ha fatto una escursione conclusasi con una scalata al cratere. Vulcano è disabitata e assai grande. “Prima era divisa in due isole, Vulcano e Vulcanello. Al presente sono un'isola perché l'abbondante cenere uscita dalla bocca del cratere ha chiuso il passaggio bloccando il braccio di mare che divideva le due isole e così si è realizzato un bel porto...” Si tratta di una notizia importante, osserva Angelo Raffa, perché alcuni naturalisti hanno sostenuto che questo fenomeno si fosse verificato solo con l’eruzione del 1550.[6]
“Mi è stato riferito da certi Liparoti ,- racconta ancora il prete francese - che delle volte questo monte di Vulcano buttò fuoco in modo così forte ed orribile che arrivò nell'isola di Lipari incendiando un bosco e insidiando col fuoco persino la città che si sentì in gran pericolo. Così tutte le donne di Lipari fecero un voto: che se Dio le avesse guardate da questo pericolo, non avrebbero mai più bevuto vino e sarebbero andate sempre a piedi nudi. E ottenuta la grazia, le donne hanno osservato sempre il voto: non bevono vino e sempre vanno scalze”. Anche di Vulcano Maurando ci lascia uno schizzo nel quale si vedono Vulcano e Vulcanello.

Il disegno di Maurando di Vulcano.
Una descrizione colorita del “castello o città di Lipari” c’è fornita dalla memoria dei cappuccini. Questo castello situato “sopra una petra circondata di muri “ distanti da una parte all’altra “circa d’un tiro di muschetto piccolo” e complessivamnette ampia “due salmate e mezza o tre[7]”. Le strade erano anguste e strette come i nostri corridoi ed alcune addirittura più strette. Dalla parte del mare queste case erano alte “56 piche circa[8]”ed erano a strapiombo “di maniera che gettando alcuna cosa cade dentro al mare”. L’entrata era da una sola parte “et entrandovi bisogna passare per cinque porte, all’ultima delle quali vi è il presidio de’ soldati…”.
Il Campis prima di [9]iniziare il racconto delle giornate di scontro richiama alcuni antefatti. Il vicerè di Napoli ha notizia delle intenzioni di Ariadeno qualche tempo prima, forse addirittura diversi mesi e, informandone i Liparesi, tende a tranquillizzarli: le navi sono molte ma i soldati sono pochi (!?!). I Liparesi decidono di organizzarsi e mandano a Messina Bartolo Comito per procurarsi palle, polveri e micce. Qualcuno propone anche che si mandassero sulla terraferma le donne e i bambini e che a difesa della Città rimanessero i soli abili. Ma la proposta non ebbe seguito[10]. Prevalse l'idea che la gente avrebbe combattuto con più impegno se avesse difeso anche la propria famiglia oltre alla patria.

Pianta del Castello con la divisione in quartieri sotto il comando di due responsabili
Si organizzarono sei quartieri assegnandovi per ognuno, al comando, due “gentiluomini”. Il Castello fu così ripartito: il quartiere di Terranova che andava dalla Verdesca sino alla porta di città; un secondo quartiere dalla Porta di città alla torre di Jacopo Tovatino ora ribattezzata il Bastione Medina; un terzo ,dalla Torre di Trovatino sino alla Torre di Cirino; un quarto dalla torre di Cirino alla casa di Japichello Anza dove era la porta falsa; un quinto da qui a Santa Maria delle Grazie; infine il sesto da S.Maria delle Grazie alla Verdesca. Ai due capi, in ciascuno di questi quartieri, erano sottoposti centosessanta uomini d'armi, restando in tal modo tutto il recinto della mura di città ben guardato e difeso non mancando dell’artiglieria.[11]
Lunedì, 30 giugno
“L'ultimo del mese di giugno comparve a Lipari Ariadeno con 150 galere, alla qual vista si spopolò tutto quel borgo correndo a refugiarsi nella Città Murata colle loro robe” (Campis). Vengono mandati sulla più alta cima di Salina due osservatori, Bartolo Stanca ( Zanca?) e Polverino, i quali ritornati riferiscono alla gente riunita nella piazza della Matrice. I liparesi stringono il patto di solidarietà. Il Capitano disse:
“E’ bisogno chi fazamo prova!
Veniti tutti con l’armi in lin mano;
di iornu e notti nixuno si mova
di la moraglia con lo cori sano,
a tali che si dica per memoria
chi Lipari di Turchi happi vittoria”[12]
A sera l'avanguardia della flotta si vede dispiegata all'altezza di Capistello. Nel corso della notte sopraggiungono le altre navi (De Simone).
“Erano già arrivati i navilli nelli mari di Lipari e dicono le genti del presente, per relazione dei suoi antecessori, che dal Capo delle fiche, che è dell'isola chiamata della Salina, lontana da Lipari dodici miglia, si poteva viaggiare passando da un navilio all'altro per aversi messo et ordinati a filo quasi toccandosi l'un l'altro” (frate Bonaventura).
Martedì 1 luglio
Ariadeno fa sbarcare parte degli uomini e venti pezzi di artiglieria a Portinente. I Liparoti aprono il fuoco, e le galere turchesche, dopo che due restano sommerse, vanno a riparare dietro la punta di Capistello. Durante la notte però i Turchi riescono a mettere in terra, a Portinente l'artiglieria, e a piazzarla nei pressi del convento francescano e della chiesa di S. Bartolomeo alla Maddalena “dove il terreno restava alquanto più alto”. ( Campis[13]).
Dopo che due galere vengono colpite Ariadeno ordina il ritiro delle navi nella rada di San Giorgio, cioè a Portinente e colà fa eseguire dei riti divinatori che si rivelano non propizi. Il rais Dragut, dal canto suo, assicura la vittoria al Barbarossa e, avanzando in salita da San Giorgio, arriva a piazzare 17 pezzi di artiglieria nei pressi della chiesa francescana di San Bartolomeo. (De Simone).
“Il primo del mese di luglio, l'armata al far del giorno [a le doe hore di matina ] giunse tra l'isola di Lipari e di Vulcano, e qui, nel canale, diede fondo. [ e qui trovarono Sala Rais[14] che era giunto con 60 galere e le navi Conterina e Delphina ]...Giunto Sala Rais (capitano dell'avanguardia) all'isola di Lipari, subito discese in terra con le cinque insegne dei Turchi, e si diresse ai borghi della Città ma non vi trovò nessuno, perchè tutti i Liparoti si erano ritirati nel forte. Entrati nel borgo i turchi andarono ad assediare ed attaccare quelli del forte che difendendosi valentissimamente al primo assalto ammazzarono quaranta Turchi. Sentito Ariadeno ( il signor Bassan) da Sala Rais che i Liparoti erano entrati nel forte con animo di resistere e difendersi, la notte seguente fece discendere a terra tre grossi cannoni e colobrine, “in numero pese 16”, che furono piantate accanto al monastero, sul monticello all'inizio del borgo, di rimpetto al forte di Lipari. Piantata la l'artiglieria Ariadeno fece mettere in terra il suo “pavaglione” . Quella notte stessa discese Ariadeno e tutti i turchi che erano in numero di 5550. E appena scesi aprirono il fuoco contro il forte. Ne rimase ferito al ventre uno dei capi turchi.” (Maurando).
Mercoledì 2 luglio
Per alcuni giorni la città di Lipari viene sottoposta ad intenso bombardamento con “grandissimo danno delle muraglie”.(Campis).
 Don Giovanni d'Aragona
Don Giovanni d'Aragona
“Sono in terra sette o ottomila infedeli comandati da Draut. Si dà inizio ad una intensa carica di artiglieria. Vengono sparate non meno di trecento cannonate. I Liparoti rispondono al fuoco. Lo scambio dei colpi prosegue nel corso della notte e per altri giorni ancora. Sempre al due di luglio, martedì, al largo di Messina sopraggiunge Giannettino Doria con trenta galere. Le forze della città si mettono in allarme e si organizzano perché quelle navi sono credute barbaresche. Poi si tributano onori al Doria il quale si consulta col Presidente di Sicilia don Giovanni Aragona, marchese di Torrenova e, insieme con questi, parte per soccorrere Lipari. Ritenendo però di non essere in grado di affrontare l'armata di Ariadeno, i due si ritirano e dislocano i loro contingenti qua e là, lungo la fascia costiera, tra Capo Peloro e Patti, col proposito di impedire ai Turchi l'approvvigionamento di acqua alle fiumare. Milazzo è in agitazione, pronta a difendersi. A Messina si studia ancora di portare aiuto a Lipari, ma l'impresa appare rischiosa. Intanto sui colli San Rizzo gli osservatori recepiscono le segnalazioni di fumo e di fuoco che trasmette l'uomo di Monte Guardia di Lipari. Trenta galeotte turche, allontanatesi da Lipari, accostano ai lidi di Patti per fare rifornimento d'acqua. Sbarcano 400 uomini i quali operano devastazioni nell'abitato della marina. Si comporta da eroe il pattese Coletta Rosio con tre suoi congiunti. ( De Simone)
Il 2 di luglio, continuando l'assedio e la batteria dei Turchi contro quelli di Lipari, dalla città uscirono tre dei capi e vennero da Ariadeno per cercare di patteggiare. Avrebbero dato ad Ariadeno 15 mila ducati d'oro se l'armata se ne andasse via senza fare nessun male agli uomini e senza danneggiare i beni. Ariadeno rispose che sarebbe stato felice di salvare uomini e città ma voleva 30 mila ducati d'oro e 200 bambini e 200 bambine. Altrimenti non sarebbero partiti prima di avere conquistato la città e bruciato e distrutta l'isola. Avendo compreso i Liparoti che Ariadeno aveva più propositi di guerra che di pace, tornarono mesti in città a riferire quanto avevano appreso. Partiti gli ambasciatori Ariadeno fece continuare a tirare cannonate ed archibugiate contro la città (Maurando)
Giovedì 3 luglio
Al fine di scongiurare il peggio, i giurati di Lipari inviarono al Barbarossa quattro messaggeri, Ferrante Russo, Bartolo Comito, Lorenzo Proto e Bartolo Damiani. Barbarossa pretendeva centomila scudi per abbandonerebbe l'isola. I messaggeri ritornarono ed informarono i cittadini che li rinviarono ancora una volta dal grande ammiraglio per proporgli una più ragionevole cifra. Barbarossa però è irremovibile e continua a bombardare l'infelice città. Mentre i Liparoti rappezzano le falle che via via si vanno aprendo nelle muraglie, Barbarossa fa uscire da Capistello il grosso dell'armata e fa sbarcare il resto degli uomini e dell'artiglieria. Oramai i cannoni del Castello sono inutilizzabili e tacciono. Le mura restano “fracassate” in più settori.(Campis).
Barbarossa spedisce al Castello di Lipari due dei suoi cristiani rinnegati con l'incarico di invitare alcuni rappresentanti della città a portarsi a conferire con lui. I Liparoti mandano una delegazione composta da Lorenzo Proto,Comito e Mini (Minico) di Muni. Costoro offrirebbero 20 mila scudi che Barbarossa sprezzante rifiuta. Con altere parole Lorenzo Proto fa intendere al turco che la fortezza di Lipari è inespugnabile.
…”Nui semo dotati
di vettovaglia e bon’artelaria.
Semu più forti che non è Citati
in tuttu Imperio, e sia quali si sia.
Io vi consigliaria che vi ni andati
con vostro honuri per la vostra via,
cie quista fantasia che vui tiniti
con poco honuri vui la rexiriti.”[15]
Barbarossa ribatte con minacce e congeda i tre uomini i quali vanno a relazionare ai cittadini. Con più accanita determinazione riprende il martellamento dell'artiglieria nemica (De Simone).

Edizione francese del 1901 del libro del Maurando
Maurando unifica la cronaca dal 3 al 5 e dice che “mai cessarono i turchi di notte e di giorno di sparare cannonate e archibugiate contro la città e soprattutto contro i bastioni che si trovavano proprio di fronte al monastero dove stava l'artiglieria dei Turchi. Ma proprio la copertura dei bastioni oltre alla città, difendevano gli abitanti, che proprio al riparo dei bastioni i Liparoti sparavano sui Turchi e ne ammazzavano parecchi.
Dalla cronaca dei cappuccini apprendiamo che il bombardamento fatto dal Monastero non bastò ad aprire brecce utili ad un eventuale assalto delle truppe perchè i muri sono terapianati e “anco di questa parte segue la pietra soda”. Così Barbarossa ordinò che l'artiglieria si portasse ad altro posto, poco distante, dove oggi c'è la chiesa di San Pietro, e lì si fece spazio gettando alcuni muri per terra. Secondo il Barbarossa quindi la parte più debole delle mura e più facilmente espugnabile era quella occidentale.
Venerdì, sabato, domenica, lunedì 4-5-6- 7 luglio
A prima sera si verifica un'eclisse totale di luna. Tristi presagi. I bombardamenti proseguono pesantissimi nei giorni successivi. Il bastione meridionale della città crolla. Si hanno i primi corpo a corpo tra Liparoti e Turchi sul filo della breccia. Sulle abitazioni continua a cadere la pioggia dei proiettili. Gli ottomila assediati resistono oltre ogni umana possibilità. Di notte, calandosi per le scarpate, mettono in salvo alcuni bambini e donne.(De Simone).
Il giorno 5 le galere turche andarono per cercare acqua nell'isola di Salina. Il sesto del mese, continuando i Turchi ad attaccare e colpire la città di Lipari, quelli da dentro tirarono un colpo di cannone che ammazzò 18 Turchi e uno spagnolo rinnegato, ingegnere di Ariadeno, fu ferito in modo grave da un sasso alla testa . Il 7 si continuò tanto dai Turchi che dai Liparoti a sparare e tirare cannonate. La notte seguente, verso le tre, fuggirono 20 uomini dalla città e di questi ne furono presi 4, i quali condotti da Ariadeno dissero che se i turchi avessero continuato a sparare sulla città come facevano, la città si sarebbe arresa a discrezione, perchè i capi ed i governatori di questa erano fra loro divisi. Inteso ciò, Ariadeno fece mettere questi Liparoti alla catena e comandò di intensificare il tiro contro la città (Maurando)..
Martedì 8 luglio

Giannettino Doria
Al fine di ottenere una tregua i Liparoti inviano allo stato maggiore nemico tre gentiluomini: Bartolo Comito, Lorenzo Proto e Jacopello Marazzita. Barbarossa rimane sordo ad ogni loro richiesta e dà ordine di continuare a fare fuoco contro la città. ( Campis).
L'8 si continuò a battere la città e sparare, e quelli da dentro a difendersi. E la notte seguente,verso le tre o le quattro, Giannettino Doria con 30 galere viene all'isola di Vulcano dalla parte di Milazzo. Ma saputo che le nostre galere (cioè del Barbarossa) lo andavano cercando, se ne fugge (Maurando).
 Le galee di Giannettino Doria
Le galee di Giannettino Doria
Mercoledì, 9 luglio
“Per mitigari un tanto atroci mali” Bartolo Comito e Jacopo Camagna, senza prendere accordi con alcuno, si recano dal Barbarossa e lo supplicano di desistere dall'assedio. Il feroce turco respinge le loro preghiere. Gli oratori replicano che, affidandosi alla di lui clemenza, Lipari è disposta ad arrendersi. Barbarossa accenna a voler fare qualche concessione. A questo punto il Comito e il Camagna scongiurano il corsaro che conservi almeno sessanta casate liparesi ( ogni casata comprende più famiglie), delle quali gli presentano una lista. Chiedono inoltre che non vengano molestati uomini e donne di età superiore a 60 anni, il clero secolare e quello regolare, dandosi facoltà, a quanti lo volessero, di riscattarsi per 20 scudi a testa.
Rispusi Barbarussa:”Orsù, sia fattu
comu voliti.Resto per contenti”
Così senza scriptura né contrattu
Lipari fu venduto con le genti.
Poi a conclusioni di lu fatti
-comu di supra, e dico ciaramenti -,
lu Mércuri e li novi di Iugnettu
conclusu fu quistu dogliusu effettu.
Così conclude il poeta, Camagna i suoi concittadini, li “vendio senza denari”[16].
Lipari è ormai posta in ginocchio, tant'è che Milazzo non coglie più segnalazioni dall'isola. I due rientrano in città e riferiscono alla cerchia del loro parentado. Poi adunano il popolo in assemblea. Camagna sostiene che non c'è altra possibile alternativa al disastro totale se non quella già prospettata al Barbarossa .
Audendu quistu, assai si contentavano
Timendu di chiù peiu non aviri,
e multi respondendu replicavano
dicennu: “Megliu volimu moriri”.
Li donni tutti quanti lacrimavanu;
con li figlioli in brazzo, con sospiri,
dicianu:”O figli, quali crudu cori
vi darìa in manu di Turchi e di Mori?”[17].
Nell'animo delle donne affiorano funesti presentimenti. Rabbia negli uomini e pianto di fanciulli. Nel clima di generale smarrimento, Comito vorrebbe affrettarsi dal Barbarossa per ratificare gli accordi, ma cerca ancora di convincere il popolo che non è possibile trovare diversa soluzione. Le donne ritengono accettabili i patti, ma sono molti i cittadini i quali sostengono che arrendersi per paura è disonorevole. Le polemiche si vanno attenuando. Infine, quando la maggioranza appare concorde, Comito e Camagna tornano dal Barbarossa.(De Simone).
Mentre De Simone descrive lo strazio delle donne liparesi che pensano ai figli da consegnare ai turchi e ai mori, Maurando esalta il suo “signor Bausan” cioè il Barbarossa.
Il giorno nove si continua a combattere e sparare tanto da i Turchi che dai Liparoti. Ariadeno, non mai sazio di compiere opere di carità, nonostante che a porto d'Ercole avesse riscattato parecchi cristiani, a Vulcano riscattò un napoletano con la sua donna e un figliolo: ancora riscattò tre bambine da 12 fino a 14 anni e un bimbo di 4, e donò parecchi denari in elemosina a certi poveri cristiani per potersene tornare alla loro patria.(Maurando).
Giovedì, 10 luglio
La cronaca che Pietro Campis fa del giorno 10 praticamente ripercorre, grosso modo, il racconto che De Simone ha collocato nella giornata del 9 con alcune differenze sulla conclusione dell’accordo col Barbarossa.. Il capitano d'armi e i giurati di Lipari, constatando la situazione disperata del paese, decidono di inviare al Barbarossa, l'anziano Jacopo Camagna – uomo pieno di acciacchi, ma di “buona pratica delle cose e prudenza nel maneggio degli affari”, perchè insieme con Bartolo Comito, raggiunga un “qualche ragionevole conventione “ col nemico onde non “ restare tutti morti per mano de' Turchi”. Al tiranno il Camagna dichiara : “siamo pronti ad aprirvi le porte quando voi promettiate libertà a quanti siamo in quel piccolo recinto di mura”. Dal canto suo il Barbarossa pretende avere tutto e tutti . “Troppo tardi veniste – disse al Camagna – non è più tempo di clemenza. Dove apprendeste offerirmi quel che è già mio. Tutti sarete miei schiavi![18]”. Comunque – come ha sempre fatto, dice, nelle sue conquiste – “sarà atto di gran pietà se venti soli famiglie farò esenti dalla schiavitudine”. Il Camagna e il Comito scongiurano che le famiglie da salvare siano non 20, ma 26, più cinquanta uomini con le loro mogli, più tutti gli ecclesiastici secolari e regolari, e tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni. Barbarossa acconsente, ma, benché insistentemente pregato, non cessa di martoriare la città con l'assiduo fuoco della sua artiglieria. Alla relazione del Camagna e del Comito i cittadini tumultuano e gridano al tradimento. Devono salvarsi tutti o nessuno, dicono. Si propone, pertanto, di rinviare i due oratori al grande capo per chiedergli che conceda ad ogni singolo cittadino la facoltà di riscattarsi per 20 scudi. Intanto il Camagna, perché è sospettato di voler salvare sé e i suoi parenti, e anche “ per scansare le furie della plebe”, si ritira in casa. Comito, invece, fattosi calare dalle mura ( o sceso attraverso la porta falsa), va ( o finge di andare) a compiere la nuova missione e torna affermando che il Barbarossa ha accettato il nuovo compromesso.( Campis).
Anche il manoscritto di padre Bonaventura riporta alcune righe che devono riferirsi a questo giorno. Righe che raccontano i fatti già descritti da De Simone e da Campis con più succinta crudezza, sposando esplicitamente la tesi del tradimento già adombrata da De Simone. “Vedendosi così crudelmente combattuti, giudicando non potendosi difendere per lungo tempo, uno dei principali della città gli [al Barbarossa] fece a sentire che, perdonando la vita a lui et a suoi parenti, et anco la roba, la mattina seguente gli darìa la chiave della città”. Il Barbarossa acconsente per evitare il rischio della lotta, considerando le perdite subite e giacché in fondo aveva poche speranze di conquistare la città visto “che gagliardamente si difendeva”.
Sempre si continuò a cannonare e sparare tanto dai Turchi che dai Liparoti.(Maurando).
Venerdì, 11 luglio.
 La piazzetta della Maddalena dove avviene l'incontro
La piazzetta della Maddalena dove avviene l'incontro
Con in testa il capitano d'armi, i giurati e gli esponenti del paese, tutto il popolo di Lipari – racconta il Campis - si porta ai piedi di Barbarossa il quale, sempre impenetrabile sotto la sua scorza di arroganza, sta seduto su di un tronetto improvvisato accanto alla Chiesa di San Bartolomeo alla Maddalena. Dopo di aver passato in rassegna uomini, donne e fanciulli, rinvia tutti nella città murata e ad un suo scrivano ordina di prender nota delle ventisei famiglie “delle più cospicue” che non devono essere molestate ( il Campis non fa più menzione delle altre cinquanta).Poi fa l'ingresso in città lo stesso Barbarossa seguito da un immenso stuolo di suoi uomini. Dichiara “franche” le ventisei famiglie, e i loro mobili fa, per cautela, trasportare nella casa del Camagna. Sotto questo suo apparente comportamento di correttezza, egli nasconde nell'intimo l'intenzione di “non perdonare ad alcuno”. Infatti dà ordine di iniziare il saccheggio e l'incendio.” …non solo spogliarono le case, ma a molte di esse posero il fuoco riducendole in mucchi di pietre. Non la perdonarono né pure alle Chiese incendiando la Chiesa di San Bartolomeo vicino a Porto di Gente et incenerendo il nobile Monastero ad esso unito dove soleva mantenersi un buon numero di religiosi di San Francesco dell’Osservanza…Di più messero anco il fuoco alla Chiesa Catredale eretta già con Regia magnificenza dal Conte Rugiero Normanno… tutta fabbricata di vive pietre di smisurata grandezza, che, nondimeno, molto patì dalle fiamme, le quali consumarono e ridussero in cenere tutto il gran suffitto di essa e quanto vi era di legname con danno assai considerabile, oltre l’abrugiamento di tante sacre pitture che rendevano non meno adorno che ricco quel tempio. E perché unito a quello si trovava l’archivio in cui tante pubbliche scritture si conservavano ad eterna memoria sì della Chiesa che della Città di Lipari, il tuto s’incenerì: perdita tanto deplorabile non potrà mai bastantemente piacersi per tutti i secoli d’avenire essendosi in tal modo smarrite memorie di gloria non ordinaria e consumati registri d’opere meravigliose”[19](Campis).
Barbarossa, con le sue numerosissime genti, entra nella città. I suoi intenti sono di distruzione e di morte. I turchi cominciano a saccheggiare le case, a cercar denari, a spogliar le donne, a dissigillare le sepolture nelle chiese e depredare vasi sacri. A spintoni trascinano le genti verso il mare. Scene di strazio. Seduto alle porte della città, Barbarossa assiste alla miserevole sfilata dei prigionieri e si stupisce del gran numero. Altre scene di strazio. Eseguiti i conteggi e la selezione, Barbarossa fa avvisare tutti alle galere. Sono novemila individui. Altre scene di dolore e di crudeltà. Avviene l'imbarco.
“ A l’undici lu misi di Giugnettu
di Venneri fu tuttu quantu quistu,
lu iorno quando con tanto rispettu
per redimiri a nui fu mortu Cristu,
per cui lu Suli, ch’era chiaru e nettu,
si persi havendu tali murtu vistu.
Di tali iornu fu vintu e pigliatu
Lipari afflittu, persu e ruinatu”[20]
( De Simone).
L'11 luglio, facendo Ariadeno più presto del solito tirare le cannonate contro la città di Lipari, alle 8 del mattino, uscirono quattro liparoti responsabili della città ed andarono per trattare. I Liparoti avrebbero data la città con tutto quello che essa possedeva, salvo 70 case, le quali sarebbero state salve con tutti gli uomini e le donne, i bimbi e le bimbe, e tutta la roba de contenevano. Trovato l'accordo gli ambasciatori ritornarono in città e raccontarono al popolo che cosa si era deciso. Il popolo subito si levò ad una voce, e chiese altri ambasciatori proponendo : o tutti liberi o tutti schiavi. Mandati altri ambasciatori essi proposero la resa a discrezione e Ariadeno di buona voglia l'accettò. Così si potè conoscere di quanto male è occasione la differenza e la divisione tra i cittadini. Non solo questa maledetta divisione e parzialità civile è stata la causa della distruzione della città di Roma che era “domina e signora di tutto il mondo” al tempo di Giulio Cesare, di Augusto e di altri Imperatori, ma anche della distruzione tutta l'Italia, e ora di questa povera città di Lipari. Se dentro quella città ci fossero stati 200 soldati insieme con i cittadini non l'armata che noi eravamo, ma il doppio, non ce l'avrebbe fatta a prenderla nemmeno in sei mesi. Perché la città è posta sopra un balzo di rocce tutte intorno così alte come il castello di Antibes dalla parte del mare. E nonostante che per il sito sia fortissima, era anche circondata di bellissimi muri e fortissimi robusti cinque bastioni fatti di pietre e calcina (“et fortissimi beroardi sive bastioni fatti di prede et calsina”).
La resa di Lipari
Arresa che fu la città di Lipari, dopo tante cannonate che queste mura avevano subito, quelli che dentro la città avevano cercato di entrare vi erano riusciti con grande difficoltà perchè restava ancora alta la breccia da cui passare – l'altessa di una bona pica e mezza” - e bisognava salire uno per uno a gattoni e con difficoltà (“et era forsa montar ad uno ad uno in quattro piedi e con difficultà”). La presa di questa fortissima città ha creato ammirazione in tutta la Cristianità ma probabilmente Lipari è caduta per i suoi peccati. “ e il giusto Idio scorrosatto (scoraggiato) manda questi flagelli ne la Chiesia proprio Babilonica, non Cristiana, vindicandose dei soy inimici per li soy innemici” . E dico questo, per come mi è stato riferito da un Marsigliese che abitava a Lipari e lì si era maritato, la cui moglie fu presa quando la città si arrese, “questi Liparoti erano deditissimi al peccato sodomitico, in tanto che se avveseno visto uno bello giovene, per aver piacer del giovene, era[no] contenti che lui usasse con le loro done, era presente il marito”.
Preso che ebbe Ariadeno i Liparoti e la loro città a sua discrezione, fece cessare i bombardamenti e comandò che tutti quelli che erano dentro uscissero e venissero fuori di fronte a lui che stava seduto nel borgo presso la città. E per fare uscire i Liparoti e anche per evitare che i Turchi non cominciassero il saccheggio mandò quattro guardie. Tutti i Liparoti che furono trovati dentro la città furono menati da sua Signoria, e tutti li faceva passare dinnanzi a sé individuando gli uomini e le donne invalidi, e il resto, uomini e donne, bimbe e bimbe, mandò schivi sulle navi e le galere. Certo, il vedere tanti poveri cristiani e maggiormente tanti bimbi e bimbe procurava una grandissima pietà.
Fra le altre crudeltà praticate dai turchi la più grave fu quella accaduta nella chiesa episcopale di Lipari. Qui furono trovati un certo numero di uomini e donne vecchissimi ( a mio giudizio avevano più di cento anni), questi presi, furono subito spogliati e squartati vivi, e questo per prendere il fegato. Chiesi perché usassero una così grande crudeltà a questi poveretti e mi risposero che quel fegato aveva grandi virtù. Usciti fuori da Lipari tutti i cristiani e distribuiti fra le navi e le galere, fu caricata sulle galere anche tutta l'artiglieria trovata. E subito fu messa a sacco e fuoco la misera città e questo avvenne alle quattro dopo mezzo giorno dello stesso giorno. Quindi Ariadeno comandò di fare confluire tutte le galere turche al porto di Lipari mentre le nostre navi ( quelle dei francesi) dovevano tenersi alquanto distanti. Perchè avesse fatto questo, non lo sapemmo. Venuta tutta l'armata al porto di Lipari, Ariadeno si imbarcò con tutta l'artiglieria.
In un'altra parte del suo scritto Maurando parla di Iacopo Camagna e lo definisce “mal Cittadino” perché “ essendo padrone di una nave, e trafficato avendo con salvacondotti, più volte in Levante e in Barbaria, era conosciuto e amico del Barbarossa”.
La versione di p. Bonaventura sul giorno della resa inizia affermando che “la mattina seguente della promessa fece quel traditor della patria trovar le porte aperte. Vi entrò il tiranno incrudelito, la saccheggiò, con dar fuoco ad alcune parti, e fra gl’altre al vescovato, dove si vedono oggi le pietre sopra dell’Archivio liquefatte a modo di vetro squagliato”. Barbarossa, continua p. Bonaventura, fece prigioniera tutta la gente e cioè da nove a dieci mila persone visto che allora Lipari contava sedici o diciasettemila abitanti, Tra gli altri fece anche prigioniero “il traditore con tutti i suoi, e questa fu la paga e premio della promessa e del tradimento”.
Sabato e domenica, 12 e 13 luglio
L'incendio perdura in questo e nei giorni seguenti. I mobili che stavano ammucchiati nella casa del Camagna vengono caricati sulle galere. Alla stessa casa del Camagna si appicca il fuoco. Furono ottomila i cittadini condotti schiavi. ( Campis).
Le giornate del 12 e del 13, sabato e domenica, i Turchi le impiegano a razziare le campagne dell'isola. Catturano varia gente fuggitiva e tutto il bestiame possibile.(De Simone).
Il giorno 12 continuando il fuoco nella città, il resto dei Turchi con tutti i bagagli si imbarcarono. Il 13, continuando il fuoco, fu fatto riscatto di certi cristiani, che erano stati presi all'isola di Ischia. Il numero dei turchi scesi a terra per combattere ed assediare la città di Lipari erano cinque mila (5550). L'artiglieria era formata da tre cannoni e 16 pezzi di colobrine grosse di bronzo . L'artiglieria presa dentro Lipari fu un cannone rinforzato, una “mezana”, due “esmeriglj”, tre pezzi che gettavano palle di ferro. I turchi morti nell'assedio furono 343; i Liparoti 160 fra feriti e morti. 9000 furono le presone dei due sessi, prese schiave, senza contare quelli che “messo il fogo ali quatro canti de Lipari, furono trovati ascosi dentro le sotterranee caverne”. Quindi 10 mila in tutto. I Turchi hanno tirato contro il forte di Lipari 2800 colpi di cannone. Chi avesse avuto l'animo più crudele della tigre, vedendo pianti, gemiti, singhiozzi dei poveri Liparitani che abbandonavano la loro città per essere condotti schiavi, il padre guardando il figlio, la madre la figliola, non avrebbe potuto contenere i propri occhi dall'abbondante pianto, mentre quei cani parevano lupi rapaci in mezzo a timide pecorelle. Il 13 l'armata parte da Lipari e va in Sicilia per cercare acqua nel capo di Mortelle...( Maurando).
Anche p. Bonaventura parla dei giorni seguenti. Il Barbarossa – dice il cappuccino – si trattenne altri otto giorni per cercare i liparesi che si trovavano per l’isola nascosti e non si erano rifugiati nella città. Ma senza successo perché questi non si arresero per la fame, come Ariadeno pensava, ma preferirono nutrirsi di erbe e del poco pane che avevano conservato.
.
Questo libro narra la storia di un deportato in Turchia al tempo di Barbarossa
14 luglio, lunedì
(Campis non dà la successione dei giorni): L'armata turchesca lascia Lipari e giunge nei pressi di Messina, dove alcuni Liparoti prigionieri, tramite gli amici messinesi, trattano il loro riscatto. Barbarossa è ben felice di liberarsi di tanta merce scomoda a prezzi di convenienza. Anche il Camagna si riscatta. Trattenuto in Messina per essere giudicato dall'accusa di tradimento, è assolto. Dopo qualche mese rientra a Lipari. (Campis).
Al mattino i Turchi fanno vela alla volta di Messina. Colà Giannettino Doria attende l'opportunità di potersi scontrare col temibile avversario, ma Barbarossa, sospettando eventuali agguati da parte del Doria, si stringe alle coste di Calabria. A Messina si sta sulle difensive. A tarda sera le navi turche appaiono ancorate, lontano, nell'area dello Stretto. Le ciurme di trenta galeotte, composte di cristiani rinnegati, saltano in terra presso Fiumara di Muro, frugano per i boschi e su per le colline e braccano la popolazione fuggitiva. Fanno così una retata di 2000 prigionieri (De Simone).
Martedì, mercoledì, giovedì, 15- 17 luglio.
Alle prime ore del mattino i giurati di Messina spediscono al Barbarossa un messaggero autorizzato ad avviare trattative di riscatto a favore dei Liparoti prigionieri. Barbarossa si dichiara disposto a cederli escludendo, però, le donne e gli uomini validi. Il messo, che vorrebbe contrattare a vantaggio di tutti, in blocco e senza eccezioni, fa ritorno alla base. I giurati sperano che il tiranno si trattenga ancora per qualche giorno sì da poterlo convertire a più miti consigli. Invece Barbarossa fa ripartire alla volta del Levante un primo contingente dell'armata che porta il triste carico umano non senza prima aver fatto sbarcare alcuni Liparoti di rango, i vecchi e gli inabili. Alle prime luci del giorno seguente, 18 luglio, venerdì, salpa anche lui. “Partito. Che dio li pozza profundari!”. ( De Simone)
 Dalle parti di Catona in Calabria
Dalle parti di Catona in Calabria
Maurando narra che il 16 e 17 luglio i Turchi fecero il baratto dei cristiani presi a Lipari nel porto di Catona in Calabria. I Messinesi venuti presentarono 15 mila ducati per tutti i cristiani presi in Lipari, e Ariadeno oltre i 15 mila domandò per il riscatto 8 mila quintali di biscotto. Il prete però non sa come la trattativa fu conclusa perché il mattino seguente la squadra francese partì.
La cronaca cappuccina parla di una trattativa solo sulla base dell'offerta di “rinfresco” ( rifornimento di viveri). Barbarossa avrebbe risposto che “gli darebbe le cose sacre ed ecclesiastiche e le presone vecchie e decrepite”. Dopo due giorni, non mutando le offerte dell'ammiraglio turco, la trattativa “ non ebbe effetto”. I poveri Liparoti andarono in Turchia e Ariadeno per il rinfresco ottenuto regalò a Messina, fra le altre cose, la campana grande di Lipari. Quella che oggi è nel castello di Rocca Guelfonia.

Castello di Rocca Guelfonia oggi
[1] P.C. Campis, op.cit., pag. 306.
[2] G.Iacolino, I turchi alla marina di Lipari, 1544, Lipari, 1985.
[3] G.Iacolino. I turchi…, op.cit. pp 75-84.
[4] “Il manoscritto di P. Bonaventura da Troina (+1704)” trascritto dal prof. Giuseppe Lipari, Libro III, Messina 1999. Alcune pagine alla vicenda dedica anche R.Pirri in Sicilia Sacra, Panormi, 1733, vol.II, Notitia Octava Ecclesiae Liparensis , riportate in G.Iacolino, I turchi…, op.cit., pp- 69-74. Il Pirro non aggiunge quasi nulla alle notizie che abbiamo sulla vicenda, salvo confermare quanto riportato dal Maurando che le accuse che alcuni fecero ricadere sul Camagna si basavano sul fatto che egli era amico del Barbarossa, che aveva avuto abboccamenti con il nemico reiterati e senza testimoni, quindi l’esenzione accordata (ma non mantenuta) a lui, parenti amici e proprietà. Il Pirri fu a Lipari intono al 1630 e raccolse le memorie degli anziani e probabilmente ebbe mondo di conoscere lo stesso manoscritto al quale , nel 1694, attinse anche Campis.
[5] Una comparazione fra il racconto del Campis e quello di Se Simone è fatta da G.Iacolino,. I turchi alla marina, op.cit.,pp. 39-47, a cui abbiamo largamente e liberamente attinto.
[6] A. Raffa, op.cit., pag. 97.
[7] M.C. Cannella , “Le unità di misure locali e il sistema metrico decimale nella scuola elementare”, Tesi di laurea dell’Università degli studi di Palermo, Facoltà di scienze della formazione, anno accademico 2004-2005, pag. 62 e ss..Il valore della salma cambiava da località a località della stessa Sicilia.
[8] La pica era un’altra unità di misura del tempo derivante dalla lancia di guerra, probabilmente intono al metro o poco più.
[9] P. Bonaventura da Troina, manoscritto, op.cit.
[10] Secondo P. Bonaventura sarebbe stato il vicerè di Napoli a dare l’ordine “che mandassero le donne, figlioli e figliole a Milazo”, ordine che fu eseguito solo in parte.
[11] P. Campis, op. cit.,pag. 159-160.
[12] G.Iacolino, op.cit., pag. 99.
[13] Campis, op.cit., pag.298-299
[14] Si tratta di Chanchelubin, uno dei capitani di Barbarossa.
[15] G. Iacolino, I turchi…., op.cit., pag. 118.
[16] G. Iacolino, I turchi…, op.cit., p.147.
[17] Idem, pag. 152. La più parte dei cittadini approva l’operato del Camagna e del Comito, altri invece preferiscono morire combattendo.
[18] P.Campis, op.cit., pag.302.
[19] P. Campis, op.cit., pag. 304-305.
[20] G. Iacolino, I turchi---, op.cit., pag.170.(Archivio Storico Eoliano.it)
Jacopo Camagna
Le premesse della “ruina”.
La lotta fra Carlo V e Francesco I

Il Castello è stato il centro dello scontro fra liparesi e turchi
Nell’aprile del 1503,le disfatte francesi in Puglia permettono alla Spagna di completare la riconquista del regno di Napoli. Il regno che fu dei Normanni viene ormai affidato a un viceré e integrato nell’impero di Carlo Quinto, titolare delle corone di Spagna e dell’impero romano germanico. Tale situazione viene definitivamente sancita dal trattato di Cateau-Cambrésis, il 3 aprile 1559 : un accordo tra Enrico II, re di Francia, e Filippo II di Spagna, pone fine alle pretese francesi in Italia.
Ma nel 1544, quando avviene la “ruina” di Lipari ad opera del Barbarossa con l’appoggio dei francesi, questo trattato è ancora lontano. La lotta fra Carlo V e Francesco I è ancora in corso e trasforma l'Europa intera in un grande campo di battaglia. In questo contesto – dopo vent'anni di scontri, battaglie, guerriglie – Francesco I, stimandosi inferiore di forze, stringe una alleanza con Solimano il Grande con cui già in passato erano intercorsi parziali intese e addirittura un trattato nel 1536. Per la Francia era in gioco infatti la sua stessa esistenza come stato indipendente e sovrano. Ormai da lungo tempo viveva accerchiata dalla Spagna e dai suoi alleati e stati satelliti. Quindi la scelta di andare a cercarsi gli alleati fuori dalla “cristianità” era un passo obbligato. Un passo obbligato ma molto delicato perché il Solimano era il capo degli “infedeli” ed in un momento in cui la Chiesa era travagliata dallo scisma dei luterani, si poteva rischiare di cadere in un ulteriore e più grave isolamento. Ed infatti nella letteratura dell'epoca si parlò di “empia alleanza”.
 Carlo V e Francesco I
Carlo V e Francesco I
Il lavoro di tessitura degli ambasciatori portarono alla definizione dell'azione comune. Si sarebbe messa in campo una flotta di 140 ( 142 ne conterà Maurando o Maurand, il prete francese aggregato alla spedizione, di cui parleremo) navi da battaglia accompagnate da numerose navi da trasporto. Questa flotta prese il mare da Costantinopoli il 17 aprile 1543 e dopo lunghe tappe in Egeo e nello Ionio, per imbarcare soldati e rifornimenti e per aggregare altre navi, raggiunse le rive italiane nel maggio 1544.
Angelo Raffa che ha studiato questa spedizione consultando anche gli archivi turchi osserva che “si trattava d'una delle più imponenti formazioni navali nell'intera storia del Mediterraneo”[1].
La flotta di Ariadeno il Barbarossa
Erano truppe – circa 23 mila fra marinai ed ufficiali esclusi i barbareschi,a cui si aggiungevano le truppe da sbarco , altri 7 mila uomini - al comando dei più alti ufficiali dell'esercito turco.
Il condottiero di questa incredibile flotta era Ariadeno il Barbarossa. Il suo vero nome era Khizr. Hayreddin da cui l'occidentale Ariadeno era un titolo arabo generale e generico che significava “Protettore della religione”. Barbarossa era un soprannome che aveva ereditato, insieme al sultanato di Algeri stato satellite dell'Impero Ottomano, dal fratello Oruc a cui era succeduto nel 1519. Il titolo ufficiale che gli riconosceva il Solimano non era però quello di Sultano o re, bensì di Beylerbey che significava governatore.
Ariadeno era stato un pirata in gioventù ma ormai da tempo si era lasciato alle spalle quel passato avventuroso e leggendario. Nel 1533 era divenuto grande ammiraglio ( Khapudan Pasha) di tutta la flotta imperiale facendo dell'impero turco la massima potenza marittima del Mediterraneo.

Una flotta di navi saracene

Sopra: fotta sarecena. Sotto : nave della flotta del Barbarossa disegnata da Maurando
Abbiamo detto che complessivamente la flotta ottomana mobilitò per questa missione oltre 30 mila uomini. Per il suo allestimento, fonti francesi parlano, di un esborso complessivo del Sultano di oltre 1.200.000 ducati. Somma ampiamente ripagata dal bottino. Si pensi che i prigionieri ridotti in schiavitù furono almeno 20 mila a cui vanno aggiunti preziosi, armi, denari, stoffe pregiate, oggetti d'arte sottratti dai luoghi attaccati. Moltissimi schiavi furono utilizzati come rematori nelle galee, ma molti furono venduti o riscattati ( soprattutto ecclesiastici e appartenenti a famiglie importanti e facoltose): le richieste per il riscatto erano fra 100 e 500 ducati. Di minor rilievo la squadra francese aggregata alla flotta. Si parla di cinque galere più una nave da trasporto. In realtà sotto il controllo diretto francese erano solo due galere, le altre tre rispondevano a Leone Strozzi, fuoriuscito fiorentino, cavaliere gerosolimitano, priore di Capua. Imbarcato sulla francese Réal agli ordini dell'Ammiraglio Antoine Escalin des Aimars, signore di Garde, detto Poulin o Polin, vi era Hieronimo Maurando ( Jerome Maurand), cappellano della nave, prete di Antiboul (Antibes) che redasse durante la navigazione ed il sacco di Lipari, un diario manoscritto che è giunto fino a noi[2].
Quindi quella flotta che terrorizzò per circa due anni tutto il Mediterraneo non era una flotta di pirati ma una vera armata militare formata in gran parte da ottomani, ma non solo. Lo erano in grande maggioranza, ma vi erano anche numerose imbarcazioni barbaresche, imbarcazioni pirate o corsare cioè ma inquadrate, per l'occasione, sotto un unico comando strategico; e vi era la presenza francese.

Ariadeno detto il Barbarossa
Una immagine di Ariadin il Barbarossa
Il percorso della flotta ottomana
La flotta colpisce per prima la città di Reggio Calabria dal 20 al 23 maggio del 1543. Dopo Reggio la essa compì sbarchi quotidiani e furono numerose le incursioni nei regni di Napoli, di Sardegna, forse della Sicilia, sicuramente della Toscana. Dopo Reggio la flotta ebbe un primo contatto con le Eolie passando da Stromboli dove venne presa un'imbarcazione, il cui equipaggio fu in parte trucidato, in parte catturato e ridotto in schiavitù. Non vennero invece toccate le coste dello Stato della Chiesa.
Il 4 luglio i turchi passano dinnanzi a Nizza e si fermano a Marsiglia dove rimangono 15 giorni svolgendosi numerosi incontri fra i capi ottomani e nobili e dignitari francesi. Intanto Polin era andato a conferire con Francesco I e tornò comunicando la decisione del re. La flotta poteva occupare Nizza e svernare nella città francese di Tolone. L'assedio a Nizza ebbe inizio il 10 agosto e la città si arrese il 22 agosto. L'impegno era che gli abitanti restassero liberi e la città non venisse distrutta. Invece la città fu incendiata e gli episodi di violenza furono feroci e numerosi. Sebbene i francesi accusarono di questo i turchi vi sono testimonianze anche francesi che danno la responsabilità alle truppe di Francesco I. Il Castello comunque resistette e l'assedio fu tolto l'8 settembre quando si diffusero le notizie che dalla Lombardia e da Genova i stavano mobilitando truppe di terra e galee.
Per far posto agli ottomani Tolone fu sgomberata di tutti gli abitanti e la città assunse i connotati di un centro mussulmano con la trasformazione delle chiese in moschee e dei campanili in minareti. Da Tolone partì una squadra navale per Algeri carica delle prede fino a lì raccolte che non mancò, lungo la rotta, di attaccare porti ed isole.
Il viaggio di ritorno iniziò il 24 maggio 1544 dall'Isola di St. Marguerite di fronte a Cannes, e Francesco I dovette sborsare per convincere Ariadeno a salpare 800 mila scudi oltre ai viveri che i francesi avevano dovuto fornire durante la permanenza a Tolone.
Il viaggio dall'isola di St. Marguerite allo stretto di Messina durò 54 giorni durante i quali si susseguono continui attacchi a città, paesi, castelli, isole con distruzioni, incendi, eccidi, cattura di schiavi e bottino.
L'obiettivo strategico
Ma sarebbe un errore pensare che questi assalti non facessero parte di un piano programmato e che gli ottomani si abbandonassero all'aggressione istintiva e senza freni. Lo scopo di questi attacchi era quello di mettere in stato d'allarme le città, i porti e le isole dell'impero spagnolo nel Mediterraneo costringendo l'apparato spagnolo a mobilitarsi sulla difensiva e a frantumare le sue forze fra i vari obiettivi non avendo tempo e forze per pensare ad un attacco risolutivo al regno di Francia. A questa strategia contribuì lo stesso Solimano che mentre Ariadeno ed i francesi combattevano a Nizza guidava un possente esercito contro il regno di Ungheria mettendo in grave pericolo i possedimenti asburgici in Austria. Inoltre tutti questi attacchi e scontri obbligavano gli spagnoli a continui esborsi di denari per le ricostruzioni delle difese incidendo negativamente sul già disastrato bilancio. Non era negli obiettivi dei due alleati una loro espansione territoriale che li avrebbe messi in competizione e presto in conflitto, ma solo quello di indebolire l'avversario comune. Obiettivo che fu pienamente raggiunto.
La Spagna dovette decidere, per evitare un disastro economico e finanziario ancora più ampio, che avrebbe provocato il collasso definitivo dell'impero, di sacrificare alcune città e alcune isole non essenziali alla strategia della difesa. Fra queste ci fu Lipari. Le risorse difensive ed economiche spagnole si concentrarono nella salvaguardia dei luoghi essenziali dal punto di vista politico e militare per la tenuta complessiva dell'impero.
Lipari in cambio di Malta?

Leone Strozzi
In questo quadro c'è da chiedersi perchè Ariadeno non attaccasse Malta che pare fosse fra gli obiettivi prestabiliti della flotta. “Questa salvezza – scrive Angelo Raffa – ci è parsa connessa direttamente con la distruzione di Lipari. I documenti maltesi e fiorentini indicano con chiarezza questa ipotesi. La preoccupazione d'un eventuale attacco a Malta fu anzitutto di Leone Strozzi, vice comandante della squadra navale francese, che, a tal proposito scrisse al gran Maestro dell'ordine gerosolimitano dei cavalieri di San Giovanni, cui lui stesso apparteneva, e che era sovrano dell'isola di Malta. I Cavalieri, espulsi dall'antica sede di Rodi dai Turchi nel 1522, avevano ottenuto da Carlo V le basi di Tripoli e di Malta. In quest'isola erano giunti nel 1529 e quindici anni dopo mancavano ancora adeguate e definitive opere di fortificazione[3]”.
Per questo grande fu la preoccupazione per un attacco degli ottomani. Leone Strozzi mentre la flotta era fra Gaeta e Pozzuoli inviò segretamente a Malta un frate perchè desse assicurazioni al Gran Maestro che avrebbe fatto di tutto perché la flotta dirigesse altrove i suoi attacchi considerando che non avrebbe potuto dedicare molto tempo alle coste tirrene. Strozzi mette subito in atto in colloqui col Barbarossa questa strategia di convincimento verso altre mete. Nel caso estremo, promette, in cui non fosse riuscito nell'obiettivo avrebbe abbandonato la flotta e con le sue tre navi sarebbe andato in soccorso di Malta. Strozzi, forse con l'aiuto di Polin, riesce nel tentativo di convincere Ariadeno. Malta è salva, ma Lipari è condannata.
E che sia stato l'attacco a Lipari a salvare Malta lo rivelano stesse fonti maltesi che osservano come l'armata turca rimase dopo la presa di Lipari “ tanto esausta di munizioni, e tanto impedita e imbarazzata di robbe, e di schiavi; che rimase l'Armata sopradetta inhabile, à poter tentare per all'hora alcun altra impresa”[4].
Fra affari e miracoli
Prima di affrontare il tema dell’attacco a Lipari, dell’assedio e infine della devastazione, dobbiamo dare conto di alcuni episodi, i pochi che si sono tramandati, che riguardano le Eolie ed accaddero negli anni precedenti alla “ruina”. Il primo fatto è del 1530 ed è in relazione al sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi che avvenne nel 1527. Papa Clemente VII aveva bisogno di rilevanti risorse per ricostruire la città e pensò di attingere dalle mense vescovili e quindi anche dalla diocesi di Lipari. In particolare per Lipari si pensò di inasprire le decime abolendo, nel frattempo, il privilegio dell’esenzione totale di cui godevano proprietari terrieri a basso reddito, piccoli allevatori e modesti pescatori. Era un provvedimento particolarmente pesante e così si pensò di ricorrere alla Santa Sede ed il ricorso ebbe buon esito ed il 12 novembre del 1530 il papa scrisse ai liparesi confermando questo privilegio che risaliva “ab immemorabili tempore” e prevedeva l’esenzione totale dalla decima di quanti non riuscivano a ricavare dalle loro attività frutti, proventi e redditi non superiori al “valore annuo di sei ducati d’oro”[5].

Papa Clemente VII
Del 1533 è la notizia che il vescovo di Lipari, che però viveva a Roma dove era governatore, aveva dato in concessione ed enfiteusi perpetua tutte le cave di zolfo, vetriolo ed allume delle isole e, per questi prodotti, in particolare nell’isola di Vulcano. I beneficiari erano genovesi e forse anche veneti. Ed è questo il segno dell’attenzione e degli interessi che in quel periodo maturavano sulle Eolie da parte di commercianti che operavano su tutto lo scenario del Mediterraneo. Gente esperta dello sfruttamento del suolo e del sottosuolo che producevano e commerciavano. Infatti oltre ai prodotti minerari di Vulcano è in questo periodo che si parla di esportazione di passole e passoline - probabilmente soprattutto da Salina – fino a Costantinopoli.[6]
L’ultima notizia è del 1541 e riguarda uno dei tanti miracoli che gli eoliani attribuiscono al loro santo patrono. Era il 17 giugno ed un naviglio di forestieri con i marinai affetti di peste voleva a tutti i costi sbarcare nell’isola facendo leva su falsi attestati di “perfetta salute” degli imbarcati. Ma improvvisamente, sopra l’isola, comparve San Bartolomeo, “in aria cinto di sblendori con la sua destra armata di rilucente e ben affilato coltello, propria difesa di quell’Apostolo, adirato nel volto e sdegnato nella voce, e, fattosi visibile a tutti in aria sopra l’appestato vascello, scridò a quanti su quello si trovavano minacciando a quelli subita morte se altrove non volgevano subitamente la prora con allontanarsi da quelle Isole al suo patrocinio raccomandate dalla provvidenza Divina”[7].
I marinai si spaventarono e “con tutta prontezza vollero obbedire” senza però prima avere voluto informare i liparesi perché conoscessero la “vigilante sollecitudine” del loro patrono. Così una delegazione in barca si staccò dal vascello e raggiunto il porto, senza attraccarvi, narrò ad alta voce l’accaduto. Ed i liparesi fecero voto di celebrare in quel giorno, ogni anno, una solennissima festa in onore del Santo.
[1] A.Raffa, “La fine della Lipari medioevale” in Dal “Constitutum” alle “controversie liparitane”, Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano, 1998, pag.79.
[2] Jerome Maurand, La flotta di Barbarossa a Vulcano e Lipari nel 1544, Palermo, 1995. L’originale si trova nella Bibliothèque Inguimbertine di Carpantras e porta il titolo “Itinerario da Antibes a Costantinopoli del 1544”. Il volumetto pubblicato nel 1995 da Vittorio Giustolisi ne riproduce solo una parte ed in particolare i fogli 178-221 che furono esposti, per interessamento di A.Raffa, nella mostra che si tenne a Lipari dal 4 al 9 maggio 1995 alla Chiesa di S. Maria delle Grazie promossa dai quatto comuni eoliani in occasione delle celebrazioni del IX centenario del “Constitutum” dell’Abate Ambrogio. “La fondazione della ‘communitas’ eoliana”.
[3]A.Raffa, “La fine della lipari medioevale” , op.cit. , pag.89.
[4] A.Raffa, op.cit., pag.90
[5] G. Iacolino, op.cit., pag. 290-291; Archivio segreto Vaticano, Armadio XL,28,fogli 184-5.
[6] G. Iacolino, op.cit., pag. 292-293. L Genuardi e L. Siciliano, Il Dominio del Vescovo sui terreni pomici peri dell’Isola di Lipari, Acireale, 1912, p.82, n.5 nella nota 3 è detto che nell’Archivio di Stato di Roma fu ritrovato l’atto notarile del 1623.
[7] P. Campis, op.cit., pag 198-199.(Archivio Storico Eoliano.it)
Ancora un miracolo di S.Bartolomeo
A cavallo dei due secoli. L'era di Carlo V
Progetti di sviluppo

Sul finire del 400 Lipari conta ormai 6 mila abitanti anche se per la gran parte sono tutti concentrati al Castello, nel borgo di Marina San Giovanni- Sopra la terra; pochi nelle campagne, pochissimi nelle isole fra cui la più popolata è sicuramente Salina. Un dinamismo della popolazione che è forse legato ai commerci suffragati da collusioni con le imbarcazioni dei saraceni. Erano voci che circolavano nel regno e lo stesso re Ferdinando I il 22 marzo del 1493 ne fa cenno in lettera in cui lamenta l’accoglienza e i rifornimenti dati ai corsari[1] da parte dei liparesi..
Qualunque sia l’origine di questo contenuto sviluppo degli eoliani, esso si manifesta in alcune iniziative. Innanzitutto nel progetto di costruire sulla Civita un quartiere per dare sfogo alla città troppo concentrata nel castello. In una lettera al re Ferrante del 15 novembre 1492 i liparesi chiedono l’autorizzazione a costruire, a loro spese, un quartiere di 300 case che, affermano, facilmente si potrebbe fortificare. Ma questa richiesta non va a buon fine per non dare alloggio e riparo ad eventuali assalitori.
L’altro progetto è quello di creare un piccolo molo per facilitare l’attracco a Sottomonastero che allora si chiamava porto di Tramontana perché offriva riparo in particolare quando soffiava questo vento. Anche questa opera sarebbe stata realizzata a spese dell’università di Lipari ed al re si chiedeva solo che venisse messo a disposizione un pontone per uno o due anni fino a che l’opera non fosse stata realizzata[2].

Marina corta sul finire dell'800 (da Luigi Salvatore d'Austria).
Non sappiamo se il pontone fu concesso ed il molo realizzato, comunque i traffici con le città marinare si erano intensificati ed i liparesi dovevano nominare in questi centri dei loro consoli che facessero da riferimento e da interlocutori con gli operatori liparesi che lì si recavano. Consoli che venivano nominati in una seduta pubblica che si teneva nel piano di San Giovanni cioè a Marina corta. Di queste riunioni, che avvenivano alla presenza dei giurati e del baiulo, e dei giudici oltre che del notaio che stilava il verbale, ci è pervenuto un verbale del 5 maggio 1484 riguardante una assemblea per la nomina del console di Siracusa svolta “nel rispetto della consuetudine che da lungo tempo manteniamo di eleggere e nominare consoli in tutto il mondo ad arbitrio nostro e secondo la nostra libera volontà”[3].
Un’altra opera a cui si mise mano sul finire del secolo fu l’ampliamento della cattedrale normanna che ormai era divenuta troppo angusta per gli abitanti dell’isola. Comunque la realizzazione dell’opera andò per le lunghe e probabilmente nel corso d’opera si dovette intervenire a ridimensionare il progetto che inizialmente doveva essere molto ambizioso[4].
Una comunità ebraica
Sempre sul finire del secolo, ma forse anche qualche decennio prima, a Lipari si insediò una comunità di ebrei provenienti da Mazara e forse anche da Trapani in seguito agli editti del re di Spagna contro gli ebrei di Sicilia che li costringeva ad emigrare. Questa comunità, che doveva essere numerosa, si dedicava alla pesca del corallo a Panarea, all’artigianato ed al commercio, entrò in conflitto con i locali. Un conflitto tanto serio da portare gli ebrei ad appellarsi al re di Napoli e l’8 aprile 1494 la Regia Camera della Sommarìa, che aveva il compito di tutelare i cittadini dagli abusi dei baroni e dei governatori, ordinò al capitano di Lipari di prendere informazioni e di riferire senza apportare nessuna innovazione alle norme che regolavano i rapporti con gli ebrei[5]. Comunque probabilmente la comunità abbandonerà le isole fra la fine del secolo e l'inizio del secolo seguente allo scatenarsi di una nuova persecuzione antiebraica che raggiunse anche le Eolie. Nel frattempo però gli ebrei avevano eretto una sinagoga per il loro culto dove è ora la chiesa dell'Annunziata allora distante sia dal centro abitato di Lipari sia da quello di Quattropani. Naturalmente con la fine dell'insediamento ebraico anche la sinangoga fu abbandonata e divenne magazino per la coltivazione dei campi e ricovero per le derrate alimentari fino a quando nella seconda metà del 500 il vescovo Cavalieri non la fece restaurare trasformandola in chiesa.

Chiesa dell'Annunziata sul finire dell'800.
Il coraggio dei Liparesi
A cavallo dei due secoli i liparesi si distinsero non solo per la lealtà e la fedeltà al loro sovrano ma anche per il grande coraggio in alcune situazioni. Così nel giugno del 1495 quando nottetempo, a Napoli, con una arditissima impresa, scalarono Castel dell’Ovo che era una munitissima piazzaforte in cui erano asserragliati i francesi di Carlo VIII, smantellando il presidio e permettendo al re Ferdinando II di riconquistare Napoli; così, qualche giorno dopo in Calabria nella battaglia di Seminara dove “insupparono i Liparoti col loro sangue quelle campagne restate coperte da’ loro cadaveri nella strage che di essi fu fatta da’ calabresi, con tutto ciò buona parte di quella provincia fu per il loro valore ridotta alla divozione di Ferdinando”; così ancora nel 1502 quando, fedeli al re Federico d’Aragona, resistettero da febbraio a maggio al gran capitano Consalvo di Cordova, comandante delle truppe spagnole in Sicilia, che fingendosi amico del re si era invece impossessato del regno ed ora voleva impossessarsi anche delle Eolie. Alla fine i liparesi dovettero capitolare ma lo fecero a ben precise condizioni e cioè conservazione e conferma di tutti i privilegi fino ad allora goduti dagli isolani; nessun provvedimento punitivo nei confronti di coloro che si fossero maggiormente esposti nella resistenza o che avessero arrecati danni alla flotta spagnola. Da parte loro gli spagnoli ingiunsero ai liparesi solo di restituire le imbarcazioni da loro catturate nel corso dell’assedio[6]. Un pacchetto di franchigie e di esenzioni di ben quarantaquattro richieste, “il più alto bottino che gli isolani riuscirono mai a conquistare”[7]

Napoli, Castel dell'Ovo
Le richieste dei liparesi con le approvazioni di Consalvo di Cordova sono contenuti nel Libro dei Privilegi della città di Lipari[8]. Come sempre nel Libro dei Privilegi è contenuto il diploma del 28 marzo 1497 con cui Federico III che era succeduto a re Ferdinando, morto logorato dalle fatiche della guerra, riconosce il valore e il contributo dei liparesi negli eventi del 1495 dove hanno dato “prove evidentissime della particolare loro fidelità e divotione verso la Nostra Causa intrepidi sempre in tutti i pericoli et in tutte le difficoltà”[9].
Ancora nel Libro dei Privilegi sono riportati quelli che il re concesse nel 1505, nel 1509 e nel 1514. Invece non ottennero i liparesi, ora che il regno di Napoli ed il regno di Sicilia appartenevano entrambi al re di Spagna, di sganciare le Eolie da Napoli per essere aggregati alla Sicilia. Come non ottennero. di fatto, soddisfazione alla petizione, formalmente accolta, di non inviare più nell’isola soldati forestieri per fare spazio ai giovani del luogo che erano costretti ad andare fuori a lavorare lasciando sole le famiglie[10].
La missione di Del Nobile

L'imperatore Carlo V
Quando, a partire dal gennaio del 1516, salirà al trono di Spagna Carlo I che alla morte del nonno paterno diventerà Carlo V, unificando sotto di se un regno che oltre alla Spagna contemplava la Sardegna, i regni di Napoli e di Sicilia e tutti i domini austriaci, dopo decenni di guerre e di dissesti catastrofici, si manifestano segni di distensione ed in ogni parte si spera in un futuro più tranquillo e promettente. Anche i liparesi entrano in questo clima ed il 27 aprile del 1517 inviano in Spagna, come loro ambasciatore, il patrizio Antonello del Nobile, per farsi confermare i privilegi ed avanzare delle nuove richieste che presentano interessanti elementi di novità.
Del Nobile partì da Lipari con un documento dove erano segnati una ventina di punti che avrebbe dovuto illustrare al sovrano, fidando nella sua “probità,virtù e legalità”, ma anche nelle sue capacità oratorie: “vice set voces suas, che in dicte supplicatione e domande se possa regulare, jongere et mancare, ad suum velle moderare secondo che meglio ad ipso parerà expedire in lo più comodo et utile de la Università”[11]. E stando ai risultati Antonello dovette farsi onore.

Lipari, borgo della Maddalena e Sopra la Terra
Fra le nuove richieste, che il sovrano concede, vi è l’istituzione di una figura nel governo locale, quella del tesoriere – che era già prevista nella riforma di Federico III ma che probabilmente a Lipari o non si era applicata o era caduta in disuso - con responsabilità nella contabilità e nell’amministrazione finanziaria, eletto in occasione dell’elezione dei giurati e sottoposto, come ogni altro amministratore o funzionario pubblico,ogni tre anni ad ispezione da parte di un emissario del viceré di Napoli; quindi la possibilità di utilizzare le tasse sul grano, che i liparesi commerciavano, per recintare con mura tutto il costone del borgo della Maddalena e di Sopra la Terra e per riscattare i cittadini che cadevano nelle mani dei pirati; il controllo della pratica corsara autorizzata che alcune volte non si rivolgeva contro i saraceni ma contro gli stessi correligionari rendendo così insicure le rotte marittime ed i traffici commerciali. A proposito proprio di questa pirateria che da pratica autorizzata per contrastare le incursioni dei saraceni si trasformava in pirateria tout court, che non aveva rispetto per nessuno, i liparesi avevano qualche esperienza diretta[12]. Le cronache dell’epoca parlano, a questo proposito, di un Ferrante Russo di Lipari e secondo Iacolino la “praia di Ferrante” che si trova a Lipari sotto la contrada di San Salvatore, potrebbe aver preso il nome proprio da questo pirata[13].
Una specifica richiesta riguarda la situazione ecclesiastica. I liparesi osservano che la Mensa vescovile ha una entrata annua di 700 ducati ma essi non vengono spesi né per il culto, né per restaurare le chiese, né per contribuire ad edificare le mura del borgo, anzi siccome i vescovi a Lipari si vedono poco, i liparesi vorrebbero che “vacando quisto Episcopato, che se faccia episcopo citadino e non forastiero”. Una speranza che andò delusa perché quando il vescovo Genoino nel 1530 rinunciò alla sede gli successero altri vescovi che continuarono a rimanere assenti, forse seguendo la diocesi da lontano[14].
Infine una richiesta specifica riguardava la Cattedrale: i liparesi chiedono che il sovrano intervenga presso il papa perché la Chiesa Maggiore di Lipari abbia l’organo, gli indumenti liturgici, gli ornamenti e le suppellettili necessari per gli altari, un decoroso tabernacolo ed una porta degna di questo nome. Il re acconsente ma non ritiene che per questo vada scomodato il papa, basta sollecitare il viceré di Napoli ed il vescovo di Lipari.
Da questo documento apprendiamo che i lavori per la nuova Cattedrale, iniziati sul finire del secolo precedente non erano ancora ultimati. La Chiesa era aperta al culto ma era abbastanza trascurata nei decori e negli arredi e probabilmente presentava nell’aspetto un carattere di provvisorietà che veniva accettata come definitiva. “Sostanzialmente – annota Iacolino[15] - sarà questa la forma – una sola navata angusta e oblunga – che la nostra Cattedrale conserverà sino al 1772 allorché le sarà data quella planimetria ampia e abbastanza simmetrica che al giorno d’oggi vi riscontriamo”.
 Ma il problema non era solo quello dei lavori non ultimati e degli arredi trascurati o mancanti, il fatto è che la chiesa non disponeva di un vero e proprio sagrato ma l’entrata dava immediatamente sulla strada principale della cittadina che ne era anche il punto centrale, dove si concentrava ogni giorno il mercato con frastuono di carri e le grida dei banditori a cui si cercava di ovviare, inutilmente, con bandi che proibivano di passare “innanti la Chiesa Cathredrale in tempi di Divini Officij per l’inconvenienti di sentire bennizzare ricotti ed altri simili per non disturbare il Divino Sacrificio”[16].
Ma il problema non era solo quello dei lavori non ultimati e degli arredi trascurati o mancanti, il fatto è che la chiesa non disponeva di un vero e proprio sagrato ma l’entrata dava immediatamente sulla strada principale della cittadina che ne era anche il punto centrale, dove si concentrava ogni giorno il mercato con frastuono di carri e le grida dei banditori a cui si cercava di ovviare, inutilmente, con bandi che proibivano di passare “innanti la Chiesa Cathredrale in tempi di Divini Officij per l’inconvenienti di sentire bennizzare ricotti ed altri simili per non disturbare il Divino Sacrificio”[16].
[1] F. Trinchera, Codice Aragonese, vol.II Napoli 1868,pp.58-59. G. Iacolino , op.cit., pag.254-255.
[2] F. Trinchera, Codice aragonese, vol. III, Napoli 1874, pag. 331. G. Iacolino, pag. 250-251.
[3] S. Polica, Carte adoperate dell’Archivio Gargallo, in “Archivio Storico Siracusano”. N.S. III (1974), Siracusa, pag. 32. G. Iacolino, op.cit., pag. 252-254.
[4] G. Iacolino, op, cit. pp 259-260.
[5] Archivio di Stato, Napoli-Sommarìa, Partium 40, 177, in C. Colafemmina, Per la storia degli ebrei in Calabria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p.134. G.Iacolino, op.cit., pp 255-256. Per quanto riguarda la sinagoga all'Annunziata, una scarna notizia sulla primitiva destinazione della costruzione e quella successiva il prof. Iacolino l’ha trovata in un manoscritto dell’800 opera di un anonimo e di proprietà della famiglia Mancuso cui abbiamo fatto riferimento anche precedentemente..
[6] G.Iacolino, op.cit. pp 261-274.
[7] C.M. Rugolo, op.cit., pag. 401.
[8] Dal foglio 31 al foglio 41 v. G. Iacolino, op. cit., pag. 267-273.
[9] Libro Verde o Libro dei Privilegi foglio 20, P. Campis, op.cit., pp 381-82; G.Iacolino, op.cit., pag 264.
[10] Libro Verde, foglio 38; G. Iacolino, op.cit., pag. 274.
[11] C. Trasselli, Da Ferdinando II Cattolico a Carlo V, Soveria Mannelli, 1982, vol.II, pp 687-8. G. Iacolino, op.cit., pag, 275- 287.
[12] La distinzione tra “corsa” e “pirateria”, acquisita dalla storiografia, risulta però difficile da applicare in genere in Sicilia ed in particolare nelle Eolie dove il confine non è mai così netto. V. Rossella Cancila, Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna, in Quaderni storici, 107, n. 2 agosto 2001, pag. 363-377.
[13] G.Iacolino, op.cit., pag 280-1;
[14] A Genoino o Zenone fu chiamato a succedere un certo Pietro di cui non sappiamo niente salvo che era forestiero ed amministrò la diocesi tramite il vicario generale Nicolò Comito che era liparese. A Pietro il 23 agosto 1532 succede Gregorio Magalotti che era romano ed aveva già l’incarico di governatore di Roma che si guardò bene dall’abbandonare. Quindi fu la volta di Baldo Ferratini di Amelia in provincia di Terni che rimase vescovo di Lipari dal 1534 al 1553, anch’egli senza mai mettere piede in diocesi.(Archivio Storico Eoliano.it)
[15] G. Iacolino, op.cit., pag. 283.
[16] G. La Rosa, op. cit. p. 247.

Antonello del Nobile
Le Eolie nel 400
Difficoltà economiche e pratica della pirateria

All’inizio del 400 le Eolie contavano ormai circa 5 mila abitanti ma - anche se andava emergendo una borghesia terriera e nel settore dei trasporti - le condizioni di vita non erano agevoli soprattutto per il popolo. Gli scontri che si susseguivano sulla terraferma con devastazioni non favorivano le attività produttive. Inoltre Lipari dipendeva dall’esterno per quasi tutto: grano, legname, metalli lavorati, stoffe, carne salata, stoviglie di terracotta ecc. mentre si esportavano poche cose: qualche partita di vino, di uva passolina, di allume, di zolfo, di pomice, di pesce, i cereali. Inoltre i prodotti della terra non bastavano nemmeno alle necessità degli abitanti. Per questo vi era bisogno di rapporti con la terraferma. Cosa non facile visto che le Eolie appartenevano al regno di Napoli diversamente dal resto della Sicilia e le terre del regno di Napoli erano distanti. Già nel 1394 i liparesi avevano chiesto al duca Martino di autorizzare un accordo con i messinesi che permettesse l’accesso al loro porto e vicendevoli rapporti di traffico. Ora, il 2 settembre del 1400 si rivolgono al re di Napoli perché confermi i privilegi che le isole godevano di esenzione da gabelle, dazi, pedaggi, tasse di esportazione, diritti di ancoraggio, sia per il mare che per la terra, relativamente ad ogni genere di beni, di merci e di mercanzie. Ed il re, che aveva tutto l’interesse di tenere legate a se queste isole, le conferma[1].

Rappresentazione teatrale su Alfonso il magnanimo
Ma proprio gli scontri continui e le guerre intestine favorivano in quegli anni la pirateria per mare. La pirateria dei turchi ma anche la pirateria della gente delle coste italiane fra le quali i liparesi – la cui marineria si dedicava al trasporto merci per buona parte del Mediterraneo - che non erano certo gli ultimi anche in questo settore. Sono proprio gli studi sul commercio genovese che ci dicono come dal 1485 al 1498 un buon numero di imbarcazioni di Lipari, di piccola portata assicuravano i collegamenti, per conto dei genovesi, per il trasporto di merci ( grano, zucchero, lino, panni, formaggi) fra la Sicilia, il nord Africa ( Susa, Tunisi, Orano), Venezia e i porti toscani[2].Mentre altri documenti ci informano proprio sull’attività di pirateria a cominciare dalla licenza del 1432 del re Alfonso il Magnanimo che autorizzava la “cursarìa contra li inimichi”[3], senza trascurare la testimonianza di Sabatino Russo, mercante ebreo di Lecce, che nel 1399 racconta di essere stato depredato della mercanzia che aveva stivato sulla cocca[4], proprio da una galea di Lipari[5].
 Schiavi delle galee
Schiavi delle galee
Contro le angherie dei militari
Inoltre la vita degli abitanti era resa difficile dalle soperchierie e dalle angherie dei militari, a cominciare dal capitano d’armi e di giustizia e dagli altri funzionari del regno. Non si spiegherebbe altrimenti le concessioni ottenute per l’ Università di Lipari il 21 luglio del 1404 dal re Ladislao e che sono trascritte nel “Libro dei Privilegi”[6]. Si tratta di divieti a soprusi o arbitri che dovevano essere abituali da parte del Capitano della città e che vengono intesi come “privilegi”. Valga per tutti questo : “Nessun liparese può né deve essere molestato o costretto a dare vitto, alloggio, ospitalità o altra cosa al Capitano della medesima Città o ad alcuno del suo seguito o ad altri funzionari inviati dalla maestà del Re; o obbligato, nella persona o nelle sue bestie o nelle sue cose, per qualche fabbrica o per mura da elevare nella detta Città di Lipari o altrove per conto della Maestà del Re; comunque, se di qualcosa quelli hanno bisogno, possono ottenerla a discrezione e per il tramite dei Giurati della Città e non con l’imposizione o l’estorsione, bensì dietro giusto compenso di denaro”.
Essendo di fatto le Eolie un territorio di frontiera fra Napoli e Palermo, tutto il 400 è caratterizzato dai privilegi per conservarsi la fedeltà degli eoliani o delle strategie, spesso accompagnati da altri privilegi, per conquistarseli che i regnanti dell’una e della’altra parte loro riconoscono o si impegnano di riconoscere. Così il 15 gennaio del 1420 la regina del regno di Napoli Giovanna II d’Angiò- Durazzo confermava i privilegi dei liparesi ed al tempo stesso tempo sosteneva la sua legittimità di regina di Sicilia rivendicando cioè la podestà sull’intero regno del meridione d’Italia, come esso era al tempo dei normanni e degli svevi.

La tratta dei privilegi
Il 18 luglio del 1421 ancora i privilegi erano confermati da Alfonso V d’Aragona che era re di Trinacria ma aspirava, essendo stato adottato dalla regina Giovanna, ad acquisire di fatto e non solo di diritto tutto il regno del meridione. Inoltre lo stesso re che comprendeva quanto questa prospettiva fosse fragile – anche per la volubilità e l’influenzabilità della regina Giovanna - voleva profittare della situazione contingente che gli dava un ruolo anche su Napoli per tirarsi dalla sua parte i liparesi, e così qualche mese dopo, il 21 ottobre, deliberava l’equiparazione dei liparesi nei diritti – franchigie, immunità e prerogative, privilegi e grazie - con quelli degli altri cittadini del Regno di Sicilia. Una mossa astuta perché, come commenta Pietro Campis[7], si rese ossequiosi ed obbedienti i liparesi “ dismenbrandoli insensibilmente dal Governo della regina Giovanna e sugettandoli come Re che era di Sicilia”. Ed infatti già l’anno dopo i rapporti fra Alfonso e Giovanna sono in crisi e il re il 18 luglio 1422 torna ad occuparsi delle Eolie e riconosce ai liparesi anche i privilegi che sono propri dei cittadini di Messina. Una disposizione che non venne gradita dal viceré e dai ministri del re a Palermo e così Alfonso fu obbligato ad un nuovo intervento d’autorità presso questi il 21 agosto.
Ed i liparesi ricambiarono Alfonso con impegno e fedeltà fornendogli un contributo notevole nello scontro dentro la città di Napoli che nel maggio del 1423 contrappose questi alla regina. Così Alfonso torna a scrivere, il 31 maggio, in favore dei liparesi ai suoi subordinati di Palermo accompagnando l’ordine con la minaccia di una sanzione. E questa volta il viceré recepisce.
 Porto di Napoli
Porto di Napoli
Ancora qualche settimana e Alfonso, prima di tornarsene in Spagna, compie un ultimo atto di governo del regno di Napoli, che stava per perdere, aggregando le Eolie alla Sicilia. Una ordinanza che viene formalizzata il 6 agosto 1425 dal viceré. Ecco la parte centrale di questo documento come ce lo riporta Pietro Campis: “ditta Città et Isola di Lipari s’abbia in avvenire e s’intenda agregata al regno di Sicilia insegregabilmente come sono l’altre Isole del ditto Regno o al ditto Regno adiacenti, e godano li ditti Liparoti quelli prerogative, esemptioni, gratie, favori et ancora quelle franchezze et onori i quali godono e de’ quali si servono i ditti abitatori della Città di Messina, intendendosi sempre et in ogni tempo ditta Città di Lipari agregata et unita al Regno di Sicilia”[8].
Quando poi Alfonso conquista Napoli e nel 1543 ottenendo l’investitura dal papa con la designazione del figlio Ferdinando a suo erede e coronando così il suo sogno che perseguiva da anni, non si dimentica dei liparesi ed in un documento del 31 maggio 1445[9] conferma i privilegi e ribadisce i richiami a quei funzionari che si ostinano a non riconoscerli.
Fra recrudescenza vulcanica e pirateria saracena
Sono poche le notizie che abbiamo delle Eolie anche per quegli anni e per la gran parte legate alle strategie dei regnanti. Fa eccezione una informazione connessa ad un fenomeno vulcanico. Proprio mentre avvenivano i fatti che abbiamo narrato, il 5 febbraio del 1444, all’alba ci ha una violenta eruzione di Vulcano che provoca grande spavento anche perché furono lanciate verso l’alto mucchi di pietre infuocate, di straordinaria grandezza, e queste caddero in mare ad oltre sei miglia dall’isola[10].
 Ferdinando I di Aragona
Ferdinando I di Aragona
Nel 1450 re Alfonso che era divenuto re di tutto il mezzogiorno, riporta le Eolie sotto il regno di Napoli che aveva voluto autonomo, destinandolo al figlio. In previsione della sua morte – avvenuta nel 1458 - Alfonso divise nuovamente le corone assegnando al figlio Ferdinando detto Ferrante il territorio italiano continentale (regno di Napoli o ''regno di Sicilia al di qua del faro''), mentre l’Aragona e isole al fratello Giovanni II di Aragona. Le Eolie riprendono a questo punto una strada diversa della Sicilia e tornano ad avere come riferimento Napoli.
A Lipari intanto oltre alla preoccupazione per la recrudescenza dei vulcani e forse, più di questa, vi era la preoccupazione della pirateria saracena e quindi balza in primo piano il problema della prevenzione e della difesa. Così nel 1458, il 25 luglio, una delegazione di ambasciatori e Sindici di Lipari si presentarono alla corte del re con una serie di richieste ma soprattutto quella che si ordinasse al vescovo di Lipari, che deteneva ricordiamolo la signorìa sulle Eolie, di riparare dove necessario le mura e di ripristinare la “guardia de lo monte”come avveniva in passato. E nel caso il vescovo non avesse provveduto di autorizzare il Capitano della Città a realizzare queste opere e a svolgere queste attività con gli introiti del vescovato[11]. Il sovrano acconsentì a tutte le richieste, compresa quella che venissero assoggettati ai privilegi e quindi non pagassero dazio non solo le mercanzie che i liparesi vendevano direttamente nel regno ma anche quelle che vendevano tramite intermediari, purchè – precisava il re - si avesse la certezza che si trattasse di merci dei liparesi. Infine il re acconsentì anche alla richiesta che la galea reale fossa armata con uomini di Lipari, come usava fare re Alfonso, e che la città potesse fregiare il suo stemma con la corona reale attestando così la sua fedeltà. Ed è appunto dal 25 luglio 1458 che lo stemma di Lipari porta sopra al castello con le tre torri e la figura di San Bartolomeo sulla porta, la corona reale con la scritta “Per troppo fedeltà porto corona”[12].

Il vescovo di cui si parlava in questo documento era Bartolomeo di Salvo che era stato nominato dal papa il 13 ottobre del 1432, due mesi e mezzo dopo la morte di Antonio Comito. E comunque allo stesso vescovo proprio nel 1458, all’inizio di aprile, il viceré di Sicilia aveva ordinato “di innalzare una torre nell’Isola di Lipari col concorso dei Liparesi; nel caso in cui disattendono l’ordine si portino alla sua presenza in Palermo”[13].
Quando Bartolomeo di Salvo morì il papa Pio II elesse vescovo di Lipari, il 19 giugno 1461, un frate domenicano dotto e religiosissimo, Francesco da Stilo di Calabria, Si deve probabilmente a questo vescovo l’insediamento a Lipari, tra il 1465 ed il 1480, di una comunità di frati minori osservanti della provincia monastica di Calabria che sancì, suggerisce Giuseppe Iacolino[14], la cessazione dell’esperienza nelle Eolie dei fraticelli spirituali. Probabilmente infatti questo vescovo, pur essendo divenuto domenicano, doveva aver frequentato e conosciuto questi francescani che proprio a Stilo erano presenti fin dal 1426.
Il convento di San Bartolomeo alla Maddalena

Il disegno di Maurando (particolare)
Comunque questi frati a Lipari insediarono il loro convento e la loro chiesa alla Maddalena che dedicarono a San Bartolomeo. Una chiesa con un alto campanile ed a lato un convento che dovevano sorgere pressappoco dove oggi è la chiesa di San Giuseppe e la cui immagine ci è stata tramandata nel disegno del cappellano francese Jerome Maurand che partecipò con le navi di Ariadeno Barbarossa alla ruina del 1544. A questi francescani si deve il rinvigorirsi della pietà religiosa a Lipari con la pratica di alcune devozioni come quella del SS. Nome di Gesù con la diffusione di un monogramma a caratteri greci IHS di cui qualche esempio forse è possibile ancora trovare nelle vecchie case dell’isola ed il culto di San Bartolomeo legato alla data del 13  febbraio in ricordo dell’arrivo a Lipari del corpo del Santo.
febbraio in ricordo dell’arrivo a Lipari del corpo del Santo.
Oltre a questa reviviscenza religiosa l’altra informazione che si riesce a ricavare dai pochi riscontri del periodo è la discreta presenza di gente di Lipari su imbarcazioni da combattimento e mercantili. Facendo riferimento alle annotazioni di carico[15], Giuseppe Iacolino[16] ha individuato almeno quindici riferimenti a cittadini liparesi che fra il maggio del 1486 e l’aprile del 1497 hanno frequentato i porti di Manfredonia e Barletta.
Quando Francesco da Stilo si dimise per l’età avanzata gli succedono vescovi che probabilmente non hanno mai risieduto alle Eolie o vi hanno compiuto qualche fugace apparizione. D’altronde era una abitudine particolarmente diffusa all’epoca e per di più la diocesi di Lipari poteva vantare i disagi della navigazione per raggiungerla ed i rischi connessi alle incursioni dei pirati[17].
[1] Libro dei Privilegi della città di Lipari, f.7v. in G.Iacolino, op.cit., pag. 163-164.
[2] D. Gioffré, Il commercio d’importazione genovese alla luce dei registri del dazio (1495- 1537), in “Studi in onore di Amintore Fanfani,V, Evi moderno e contemporaneo”, Milano, 1962, pag. 195, n.169.
[3] C.M. Ruvolo, Operatori commerciali di Lipari nel Mediterraneo – secoli XV-XVI, in “Scritti in onore di Salvatore Tramaontana” ,Cava dei Tirreni, 2003, pag. 351,n. 14.; G.Iacolino, op.cit. pag. 165.
[4] Tipo di nave medioevale,di forma rotonda, che poteva raggiungere una stazza di mille tonnellate.
[5] A.Stussi, Antichi testi salentini in volgare, in “Studi di filologia italiana”, Bollettino italiano dell’accademia della crusca, 23 (1965) pag. 197; G. Iacolino, op.cit., 166-167.
[6] G.Iacolino, op.cit., pag. 170-171.
[7] P. Campis, op. cit. , pag. 256; G. Iacolino, Le Isole Eolie, III, op.cit., pp 197-209.
[8] P. Campis, op.cit., pag. 268-70; G.Iacolino, op.cit., pagg. 207-209.
[9] G. Iacolino, op. cit., pag. 220-222.
[10] T. Falzello, De rebus siculis decades duo, Libro I, cap. I. G. Iacolino, op. cit. , pag, 222.
[11] Il testo di questo documento è trascritto nel Libro Verde o Libro dei Privilegi di Lipari a pp 16 e ss. G: Iacolino, op. cit. , pag. 228-230.
[12] G.Iacolino, op.cit., pag. 228-231.
[13] R. Pirri, Sicilia SACRA. Eccl. Liparensis Not. Octava, p. 958; G. Iacolino, op.cit., pag. 226.
[14] G. Iacolino, op.cit., pp 239- 147.
[15] Fonti Aragonesi a cura degli Archivisti Napoletani, serie II, vol. VI, Napoli 1968, pp.14-23.
[16] G. Iacolino, op.cit. pp. 234-237-
[17] G. Iacolino, op. cit., pag. 260.. A Francesco da Stilo succede Jacopo Carduino o Arduino, nominato il 9 ottobre del 1489, che era un canonico della cattedrale di Napoli ed aveva ricoperto l’incarico di vicario generale nella diocesi di Mazara del Vallo. A Carduino il 19 settembre 1506 succede Luigi de Amato che rimarrà vescovo fino al 26 gennaio 1515 quando verrà trasferito a S. Marco Argentario nel Cosentino. Fra il 1515 ed il 1530 vescovo della diocesi sarà il chierico napoletano Antonio Zenone o Genoino.(Archivio Storico Eoliano.it)
Lo stemma del comune
Frate Umbertino e la separazione della diocesi
Frate Umbertino da Corleone

Avignone
Fra il 1373 ed il 1386 la diocesi di Lipari e Patti fu assegnata al frate Umbertino di Corleone, uno degli artefici del Trattato di Avignone, firmato da papa Gregorio il 20 agosto del 1372, che sanciva la pace tra il regno di Napoli e quello di Sicilia che da allora in poi si sarebbe dovuta chiamare Trinacria come si era già stabilito nel trattato di Cartabellotta..
Umbertino oltre ad essere un buon diplomatico era riuscito a entrare in buoni rapporti sia con la regia siciliana che con quella napoletana e probabilmente fu per questo che venne nominato vescovo di una diocesi di cui Lipari rimaneva in possesso degli angioini e Patti degli aragonesi. Come vescovo egli si adoperò con zelo a recuperare i beni della diocesi.[1]
 Urbano VI
Urbano VI
Senza che se ne conosca la ragione Umbertino fu destituito all’inizio del 1386. Fu lo stesso papa Urbano VI che nell’estate del 1385 ebbe a sostare a Messina, l’artefice di questa rimozione? E per quale motivo? Iacolino avanza una ipotesi[2]e cioè che il papa avesse chiesto al capitolo messinese ed al vescovo di Lipari-Patti delle sovvenzioni e che non avesse ritenute queste soddisfacenti per cui, essendo di temperamento irascibile ed alterato nella mente, lasciò Messina ancora per due anni senza presule e rimosse Umbertino dal comando della sua diocesi. Al posto di Umbertino il papa nominò sempre nel 1386 nuovamente il domenicano Francesco.
Ma anche Francesco rimase poco nella diocesi perché lo stesso papa lo trasferì il 18 marzo 1388 a Mazara lasciando la diocesi vacante per due anni.
Toccò a papa Bonifacio IX il 16 maggio 1390 riabilitare Umbertino da Corleone e riportarlo nella chiesa di Lipari-Patti.
Le mire del duca Martino
E sarà proprio il vescovo Umbertino a fronteggiare le mire che il duca Martino, per conto del figlio Martino divenuto re di Sicilia, aveva sulle Eolie e sulla diocesi di Lipari-Patti. A nome del figlio, a cui aveva fatto assumere la potestà di legato apostolico, il duca di fatto divide la diocesi. Toglie a Umbertino la potestà su Patti e nomina amministratore con dignità vescovile Giovanni Alagona, un giovane chierico suo parente, chiedendo al papa la dispensa per la giovane età di questi[3]. Ma il papa, riconoscendo comunque di fatto la scissione della diocesi, nega l’assenso e chiede che si scelga un altro candidato. Umbertino rimane così vescovo solo di Lipari anche se continuerà a firmarsi come vescovo di Patti e di Lipari.
 Martino il giovane, re di Sicilia
Martino il giovane, re di Sicilia
Ma ora il duca Martino esplicita le sue mire su Lipari. Il 6 maggio del 1392 invia una lettera ai giurati, ai nobili, all’Università ed ai singoli cittadini di Lipari chiedendo loro di rientrare spontaneamente sotto il regno di Sicilia di cui “è stata sempre, sin dall’antichità (…) fino a che con la forza e con la violenza fu presa e tenuta in regime tirannico e sotto un potere violento. Separata illegittimamente dal predetto Regno, ora Noi vorremmo giustamente e legittimamente ricuperarla e occuparla”. Li informa quindi che avrebbe inviato a Lipari Gualdo Guanetti, padrone di galera, e suo delegato a cui devono prestare giuramento, devozione e fedeltà ed espletare “ogni altra formalità che si richiede per il rientro vostro e per il riconoscimento del Sovrano”[4] . I liparesi, d’accordo col loro vescovo Umbertino, si rivolgono al papa che risponde con due bolle di esortazione a rimanere fedeli al re di Napoli e di resistere alle pressioni del duca. Le due bolle vengono quindi inviate a Catania, dove risiede il duca, tramite un loro ambasciatore Giovanni di Tesia. Ma il duca rimane sulle sue posizioni. Il 29 dicembre risponde con una seconda lettera: al papa si deve obbedienza sulle cose spirituali ma sulle cose temporali l’obbedienza spetta al re legittimo. I liparesi facciano quello che si ordina nella prima lettera e sappiano che questa è l’ultima ed è perentoria[5].
Anche questa lettera i liparesi inviano al papa e il papa nei primi mesi del 1393 manda in Sicilia un suo delegato, Francesco Hermemir, per trattare con i due Martini, il duca ed il re figlio. Il papa conosceva bene il duca, la sua ambiguità, il fatto che giocasse spregiudicatamente fra papa e antipapa, per cui non accetta di assecondare il suo disegno di riappropriarsi di Lipari e delle Eolie.
Il 20 ottobre 1393 il duca Martino aveva nominato amministratore della porzione siciliana della diocesi di Lipari e Patti Giovanni di Thaust, suo confessore. Facendolo confermare dall’antipapa mentre il papa Bonifcacio IX per Patti creava vescovo Giovanni di Caussa, dei frati minori, ma i Martini non gli consentirono di prendere possesso della sede.
E’ a questo punto, cioè nel 1396, che i Martini si decidono a praticare la via diplomatica appoggiandosi a Francesco Hermemir,il delegato che il papa aveva mandato a Palermo. La partenza del duca Martino per la Spagna dove andava ad assumere la corona di Aragona, dovette facilitare le trattative. Il fatto è che nei primi mesi del 1397 il giovane re Martino trasferisce da Patti a Monreale Giovanni di Thaust mentre il papa assegna Umbertino alla diocesi di Gaeta.
La diocesi di Lipari-Patti rimase così vacante e il re pensò che il passo successivo del papa sarebbe stato quello di ricostruire l’unità della diocesi, la nomina di un unico vescovo e l’aggregazione delle Eolie al regno di Sicilia. Ma le sue attese andarono deluse. Il papa nominò un unico vescovo nella persona di Francesco Gattulo, dell’ordine dei minori, ma non si impegnò assolutamente nel trasferimento di Lipari alla Sicilia. La reazione di Martino fu dura e il re impedì al nuovo vescovo di prendere possesso della sede di Patti e di contentarsi di fissare la residenza a Lipari.
Bonifacio IX divide la diocesi

Riprese l’attività diplomatica di Hermemir che ora però partiva dal presupposto che Lipari rimanesse agli aragonesi mentre si poteva operare sulla divisione della diocesi sganciando Patti da Lipari e quindi dalla assoluta potestà apostolica del papa. E così Bonifacio IX il 16 aprile del 1399 emette un suo breve in cui crea ufficialmente la diocesi di Patti separandola da Lipari con la motivazione che essendo cresciuta la popolazione nelle città e nelle diocesi non può un solo pastore “per la distanza de’ luoghi conoscere di vista tutte le sue pecorelle”[6]. Nello stesso documento il papa conferma Francesco Gattulo vescovo di Lipari e nomina vescovo di Patti Francesco Hermemir che era compatriota e amico di Martino. Inoltre la bolla di nomina di Hermemir fu sottoposta all’approvazione del re riconoscendogli pienamente la sua qualità di Legato Apostolico nel regno di Sicilia che il trattato di Avignone aveva invece negato. E’ questo fu l’unico punto a favore per il re nella trattativa.
Probabilmente nello stesso 1399 – o qualche decennio più tardi - chiudeva a Lipari il Monastero benedettino di San Bartolomeo, mentre quello di Patti continuerà ad operare fin verso la fine del cinquecento[7].
I beni della diocesi rimangono a Lipari
La separazione delle diocesi non fu del tutto tranquilla. La maggior parte dei beni che la diocesi unita possedeva, ed erano molti e non solo in Sicilia ma anche in Calabria, erano intestati alla Chiesa di San Bartolomeo di Lipari e il nuovo vescovo di Patti, Hermemir, ne pretendeva una congrua parte. Il contenzioso fu portato dal vescovo di Lipari dinanzi al papa Bonifacio IX e questi il 10 luglio del 1399 emise una bolla in cui si affermava che “l’avvenuta separazione della Chiesa Liparese non pregiudica in alcun modo i beni e i diritti suoi ovunque siano” e si ordinava al vescovo di Patti di non infastidire, molestare e in qualsivoglia modo importunare il vescovo di Lipari[8]. Gattulo morì subito dopo nel 1400 e la diocesi risentì dello scompiglio dello scisma nel quale la Chiesa arrivò ad avere fino a tre papi, e dell’ambigua politica religiosa del re.

Ladislao, re di Napoli
Il re di Napoli Ladislao voleva per Lipari, vista la situazione di frontiera della diocesi, un vescovo di cui potersi fidare ma il papa non si fidava di questo re e preferiva un presule che sapesse prendere le difese della sede pontificia. Così , provvisoriamente, scelse un diacono della chiesa locale, Antonio, lo nominò ma non lo consacrò. E due anni dopo mandò a Lipari un prelato piemontese, Tommaso, trasferendolo dalla diocesi di Mondovì. Qui i riferimenti storici si fanno confusi e c’è chi ignora sia Antonio sia Tommaso, chi vuole che Antonio rimanga vescovo fino al 1406, chi ancora vuole che Tommaso rimase poco a Lipari e venne presto mandato nella diocesi di Marsi dove nel 1430 muore. Iacolino, tenta di dipanare l’intricata matassa. A Tommaso verrebbe ordinato di trasferirsi nel 1402 ma egli raggiunge la sede di Lipari solo nel 1404 e questa. nel frattempo, rimane sotto il governo di Antonio. Tommaso era un vescovo fedelissimo del papa Gregorio.
 Benedetto XIII
Benedetto XIII
Quando questi tentò nel 1408 di stabilire un accordo con l’antipapa Benedetto XIII, l’operazione non piacque al re Ladislao che si riteneva avvantaggiato dallo scisma perché pensava così di tenere Gregorio in sua balìa. Ladislao ruppe col papa, occupò militarmente Roma e fra le altre cose rimosse da Lipari il vescovo fedele al papa. A questo punto viene nominato vescovo di Lipari Antonio Comito che potrebbe essere lo stesso Antonio che aveva retto la diocesi fino al 1404. Antonio rimarrà vescovo eletto e non consacrato.
Nel corso delle complesse vicende della politica e delle connessioni con lo scisma, Ladislao nel 1412 si schiera col secondo antipapa Giovanni XXIII e questi , preso dall’ossessione di contrastare il papa legittimo e nutrendo mire sulla Sicilia a cominciare da Messina, destituisce molti vescovi al papa fedeli fra cui il nostro Antonio Comito[9]. Quindi a partire dal 1412 la sede vescovile di Lipari diviene vacante, affidata ad un membro del Capitolo della cattedrale, e tale rimane fino al 31 luglio del 1419 quando, posto fine allo scisma col concilio di Costanza, viene eletto papa Marino V, che reintegra Antonio Comito nella carica episcopale autorizzandone, finalmente, la consacrazione. E Antonio rimarrà vescovo fino alla sua morte, il 31 luglio del 1432.
[1] N.Giardina, Patti e la cronaca del suo Vescovato, op.cit. pag. 85 e ss.
[2] G.Iacolino, op.cit., pag. 142
[3] G.Iacolino, Le isole Eolie…, vol. III, op.cit. pag. 145
[4] G. Iacolino, op.cit., pag.147-148 che l’ha tradotto dal latino nel testo pubblicato da R.Pirri, Sicilia sacra, Eccl. Lipar, Not. VIII pag. 995-996.
[5] G.Iacolino, op. cit., pag. 147-150.
[6] P.Campis, op.cit., pagg. 256-257. G. Iacolino, op.cit., pag. 157-158.
[7] G. Iacolino, op.cit., pag. 158-159.
[8] R,Pirri, Sicilia Sacra. Eccl. Lip. Not. VIII, pp 956-7; G. Iacolino, op.cit. pag. 176-7.
[9] G.Iacolino, op.cit., pag 177-181.(Archivio Storico Eoliano.it)
Lipari fa diocesi a sé
I “fraticelli spirituali”
I monaci eremiti e i toponimi delle Eolie

S. Madoro sulla strada per Pianoconte. Queste piccole chiesette oggi abbandonate avevano visto un tempo la presenza e l'attività di monaci ed eremiti.
Probabilmente la nomina di Giovanni Graffeo che apparteneva all’ordine dei francescani conventuali e che dovette avvenire il 17 luglio del 1360 aveva una ragione specifica. Il vuoto di potere che si era creato nelle isole e nella diocesi aveva favorito la penetrazione di diversi monaci, chiamati “fraticelli spirituali” che, insoddisfatti di come era applicata la regola francescana, avevano abbandonato i conventi, si erano distaccati dall’ordine e riuniti in piccoli gruppi si ritiravano in luoghi solitari vivendo una povertà integrale. Vestivano una semplice tunica stretta ai fianchi da una cordicella e portavano i capelli tagliati corti con la sommità del capo interamente rasa che chiamavano “chierica”.I fraticelli accusavano la Chiesa ed in particolare le gerarchia, di avere tradito la legge evangelica e la Chiesa, li ricambiava, considerandoli ribelli ed eretici e venivano perseguitati dalla Inquisizione. Molti di questi frati si erano stabiliti in Calabria prima e poi in Sicilia guadagnandosi, in qualche modo, la protezione degli angioini e degli aragonesi e alimentando forti preoccupazioni nei vescovi e nei pontefici per via della loro capacità di proselitismo.
Che questi fraticelli spirituali si fossero insediati alle Eolie non abbiamo nessun documento se non il riscontro – come nota Giuseppe Iacolino – di molti toponimi che ad essi si riferiscono o sembrano riferirsi. Toponimi legati al nome “monaco”, “monaco santo”, ”monachello”, “chirica”, “chirica rasa”, ma anche “mosche[1]” si trovano a Lipari tra Acquacalda, Punta Castagna e Lami; nell’isola di Salina a Leni, Pollara e presso Lingua, a Filicudi presso Punta Brigantini, a Basiluzzo, a Stromboli fra Punta Lena e lo Sciarato e sono, osserva sempre Iacolino, almeno ventuno[2].
 L'isolotto di Basiluzzo
L'isolotto di Basiluzzo
Il monachesimo ufficiale
Gli anni che vanno dal 300 al 400 sono anni di crescita per la popolazione delle Eolie. Le statistiche[3] ci dicono che si passa dai 3000 abitanti del 1330 ai sei mila del 1450 segno che l’economia prosperava e che si andava affermando una ricca borghesia terriera ed una intraprendente classe mercantile. Ma la popolazione cresceva soprattutto nell’isola principale e prevalentemente nel Castello mentre diminuiva nelle altre isole per via della pirateria turca . E così di fatto si veniva a creare una divisione dei compiti fra la Chiesa ufficiale ed i fraticelli spirituali. La prima si occupava di Lipari e delle contrade più popolose ed accessibili dell’isola, i fraticelli delle altre isole e delle contrade più difficili dell’isola principale, cioè di quelle situate oltre Canneto. Per questo abbiamo un maggior numero di toponimi che si riferiscono ai monaci sia nella parte settentrionale dell’isola sia a Salina, Stromboli, Filicudi. Qui i fraticelli probabilmente vivevano appartati ed in solitudine dando consigli ed insegnamenti a chi veniva a fare loro visita. Non dovette esserci mai conflitto aperto da noi fra le “due Chiese” e questo spiega forse perché i Vescovi che furono mandati alle Eolie lungo il trecento ed il quattrocento fossero tutti monaci. La strategia usata dalla Chiesa per arginare il proselitismo dei fraticelli sarebbe stata quella di contrapporre loro un monachesimo ufficiale che si curasse anche di riformare il clero locale e mantenesse con loro ed i fedeli che li seguivano, un rapporto cordiale che li inducesse alla riconciliazione.
La rabbia di Artale

Artale, maestro giustiziere del regno, sul finire di marzo del 1361 crede che sia venuto il momento di riportare Messina e Lipari sotto il governo della Sicilia. Approfittando del fatto che si trovavano a Catania sei galere che avevano scortato la principessa Costanza che andava sposa al re Federico IV, le rifornì di uomini e mezzi e partì alla volta di Messina, ma qui trovò resistenza per cui puntò decisamente su Lipari. Sbarcò e tentò di prendere il Castello ma fu respinto. Allora preso di rabbia pensò di rivalersi mettendo a ferro e fuoco tutte le terre e le poche abitazioni che si trovavano nella città bassa, tutto intorno alla Marina di San Giovanni ( la Marina corta di oggi). “Vigne, ulivi,cotone, coltivazioni, animali, barche che erano in porto, tutto bruciarono”[4],” né volle – aggiunge il Campis – che perdonasse anco a’ fiori, svellendo tutte le garofani e le viole” di cui il paese abbondava. Infine “se ne partì carico di ricca preda”[5].
Nel 1364 muore il vescovo Gaffeo e al suo posto pare che venga designato un frate domenicano di nome Francesco di cui non si conosce né patria né casato. Non si sa con precisione nemmeno il periodo del suo ministero anzi mentre alcuni lo collocano fra il 1364 e il 1371 e altri lo vogliono vescovo per un solo anno, il 1369, altri ancora[6] lo collocano fra il 1386 e il 1388[7]. Con ogni probabilità egli viene eletto vescovo ma non consacrato fin dal 1364 e rimane lontano da Lipari e da Patti in attesa proprio dell’avallo del papa e della consacrazione. Ma papa Urbano V, in quel periodo, è preso da tutt’altri problemi impegnato com’era a trasferirsi da Avignone a Roma per poi tornarsene nuovamente ad Avignone e lì morire. Nel frattempo Francesco, d’accordo col vescovo metropolita di Messina, Dionisio de Murcia, inviò a Lipari un canonico della reale casa di Palermo, Simone Maniscalco, a prendere possesso della diocesi e quindi la responsabilità della gestione della Mensa[8].Nel 1371 avrebbe dato le dimissioni o sarebbe stato destituito da una qualche autorità, per tornare ad essere vescovo di Lipari, questa volta a tutti gli effetti, dal 30 maggio 1386 al 18 marzo 1388 quando verrà trasferito alla sede di Mazara del Vallo[9].

Papa Urbano V dinnanzi ad Avignone
[1] Secondo Iacolino anche i toponimi che contengono il nome “mosche” potrebbero riferirsi ai fraticelli. Infatti gli spagnoli chiamavano i monaci “monjes” che si pronuncia “monkes”, da cui potrebbe derivare il nostro “mosche” di “Grotta delle mosche” ad Acquacalda. G. Iacolino, op.cit. pag. 109, nota n. 2.
[2] G. Iacolino, Le isole Eolie…, vol. III, op.cit.. Sui fraticelli spirituali si veda il capitolo pp.97-109; per i toponimi nelle Eolie in particolare pag. 102.
[3] G.M. Arena, Note sull’economia delle Isole Eolie dal Neolitico alla prima metà del XVI secolo d.C, in “Annali dell’Istituto Tecnico A.M. Jaci di Messina, II serie, a II 1991, pag. 141.
[4] M.da Piazza, Cronaca, Palermo, 1980,II,69.
[5] P. Campis, op.cit., pag. 248.
[6] C. Eubel, Hierarchia Catholica, Padova, 1968.
[7] G. Iacolino, op. cit., pag. 116.
[8] R.Pirri, Sicilia Sacra. Ecclesia Messanensis, N.Giardina, Patti e la cronaca del suo Vescovato, Siena, 1888,pag.85 in G..Iacolino, op.cit., pag.116-118.
[9] G.Iacolino, idem, pag. 118.(Archivio Storico Eoliano.it)
mosche
I privilegi di Lipari
Fra Angioini e Aragonesi

Il porto di Napoli nel XIV secolo
La battaglia di Lipari sancisce un nuovo passaggio delle Eolie in questo andirivieni fra Palermo e Napoli che andò avanti praticamente per due secoli. Se,infatti, a conclusione dei Vespri siciliani del 31 marzo 1282 i liparesi – che pur in qualche modo li avevano promossi con la protesta dinnanzi al re del loro vescovo Bartolomeo - rimasero alla dipendenza di Napoli e degli Angioini perché si sentivano troppo esposti alle rappresaglie, già nel 1302 vengono riannessi alla Sicilia. Tornano nelle mani degli Angioini nel 1339 con un accordo di pace che è tutt'altro che un documento di resa e che in qualche modo inaugura quella che verrà chiamata “l'era dei privilegi”[1]. Cioè in tutti i passaggi fra Regno di Napoli e regno di Sicilia - nel 1347 tornano ai Siciliani, nel 1357 di nuovo a Napoli, nel 1372 , col trattato di Avignone, rimangono assegnate a Napoli fino al 1423 quando re Alfonso le dichiara aggregate alla Sicilia per riaggregarle al regno di Napoli nel 1450;. infine nel 1458, secondo le disposizioni testamentarie di Alfonso il Magnanimo in favore del figlio Ferdinando, risponderanno per circa un secolo e mezzo al viceré di Napoli - i Liparesi riusciranno spesso ad avvantaggiarsi con sgravi fiscali, franchigie, riparazioni di edifici, autorizzazioni a portare le armi, ecc.

Alfonso il magnanimo
L'era dei privilegi
Questi privilegi erano “il frutto della grande abilità del ceto dirigente liparese, pronto a sfruttare a proprio vantaggio ogni opportunità, ogni varco che si apriva nel complicato svolgersi degli avvenimenti”[2]. Alla fase iniziale della concessione dei privilegi – che si configurano al tempo di Federico imperatore , come elargizione dall’alto – fa seguito in età successiva una pratica pattizia tra governanti e potere centrale che è prova del dilatarsi e rafforzarsi delle autonomie periferiche[3] ma anche, nel caso delle Eolie, nell’importanza strategica che le Eolie avevano assunto nello scacchiere del basso Tirreno. Non a caso il maggiore “bottino” di privilegi i liparesi lo faranno, come vedremo, il 15 maggio 1502 quando lo scontro fra Napoli e Sicilia è più acceso, malgrado essi trattino una resa.
Comunque, al di là di queste notizie generali ¸ le informazioni su questi anni, sul conto delle Eolie sono scarse o addirittura assenti. Rimangono da registrare la successione dei vescovi che però presentano alcuni vuoti e alcuni dubbi e, a volte, hanno poco a che vedere con la diocesi giacchè la loro nomina assume, per lo più, il carattere di un riconoscimento onorifico piuttosto che un incarico pastorale e politico.
 Papa Clemente VI
Papa Clemente VI
Così il 27 novembre 1342 il papa Clemente VI nomina vescovo , dopo almeno sette anni di sede vacante, Vincenzo dell’Ordine dei Minori che probabilmente riuscì a raggiungere Lipari ma non Patti visto che le due sedi erano politicamente nuovamente separate fra Napoli e Sicilia. Vincenzo, pur in questo possesso precario della diocesi si rese conto che molti beni erano stati occupati e distolti e per questo si rivolse al papa che il primo ottobre del 1346 lancia la scomunica contro i detentori in malafede dei beni della diocesi.
Vincenzo, però, era morto nei primi del 1346 e papa Clemente aveva nominato con bolla del 15 febbraio un altro frate minore, Pietro de Pernis, di origine tedesca come rivela l’appellativo di Theotonicus, che era stato cappellano maggiore della corte di Palermo e fedelissimo alla corte siciliana.
Intanto nell’estate del 1347 otto galere aragonesi attaccavano Lipari e fra la fine d’agosto ed i primi di settembre i siciliani ne riacquistano il pieno controllo.
La pratica della pirateria
Pietro de Petris muore il 21 gennaio del 1354 e si apre di fatto un’altra vacanza anche se il 15 novembre 1354 viene nominato vescovo di Lipari e Patti fra Pietro Tomasio[4]. Ma si tratterà di una nomina del tutto onorifica, e così il 15 novembre del 1354 verrà nominato vicario e procuratore per le cose spirituali e temporali, un certo Francesco di Catania cappellano regio. Fra le poche notizie che riguardano le Eolie spiccano due serie di documenti che si riferiscono al periodo 1355-1357 , fino a quando cioè le Eolie non tornano sotto il governo angioino. La prima serie riguarda lo svilupparsi nell’arcipelago di una pirateria locale probabilmente come reazione alla situazione di incertezza e di precarietà che si era abbattuta sulle isole. Una pirateria che non distingue fra amici e nemici e che porta il re Federico IV detto il Semplice, salito al trono appena tredicenne, come successore del fratello Ludovico, a fare presente “ a tutti gli uomini della città di Lipari suoi fedeli”, che non è possibile armare galee, barche e vascelli di qualsivoglia tipo, atti a praticare la pirateria, senza la licenza dell’ammiraglio del Regno o del vice ammiraglio[5].

Corsari e pirati
La seconda serie[6] riguarda invece le richieste di somme e contributi che la curia del re ordina alla diocesi di Patti e Lipari e specificamente al procuratore e vicario del vescovo, Francesco di Catania. Sono somme richieste per realizzare fortificazioni nelle Eolie e nella piana di Milazzo, pagare armigeri del castello di Tindari e il capo della guarnigione di Lipari. Proprio il castellano e capo della guarnigione di Lipari, Berteraymo Formica, sul finire del 1356, fiutando il pericolo di un cambiamento di regno, rassegna le dimissioni e fugge, così il re è costretto a nominare capitano e castellano Vinciguerra figlio di Artale d’Aragona, Maestro giustiziere del regno[7]. Infatti alla fine del mese di dicembre del 1356 gli angioini, con poche galere, senza colpo ferire, occupano Lipari dopo che qualche giorno prima avevano occupato Messina.
La perdita delle Eolie arrovella il re siciliano che studia come rientrarne in possesso promettendole a chi si fosse adoperato per il loro recupero. Contemporaneamente il papa Innocenzo VI che era schierato con gli angioini pensò di consolidare il loro controllo nominando vescovo Giovanni Graffeo visto che Pietro Tomasio era oberato da impegni che lo legavano alla Sede Apostolica[8] e il procuratore vicario Francesco di Catania era accusato di scorretta amministrazione.

Palazzo dei normanni o Palazzo reale del Regno di Sicilia a Palermo
[1] C.M.Rugolo distingue fra capitoli e privilegi. I capitoli sarebbero le richieste inoltrate dai sudditi al potere centrale e alle quali l’approvazione regia conferisce valore normativo, i privilegi, seguono lo stesso iter ma avevano una più specifica valenza economica. “Il recupero della memoria. I codici dei Capitoli e Privilegi di Lipari” in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 105, 2003, pag. 387.
[2] Idem, pag. 400. E’ stato fatto osservare che “probabilmente già in età sveva, in ambiente meridionale si distinguevano privilegia, cioè norme di ius singulare specificatamente connesse alle singole città con provvedimenti del sovrano in forza della sua piena maestà, spesso attinenti a rapporti di diritto pubblico; consuetudines aprobatae, cioè norme cittadine regolanti i rapporti di diritto privato, forse non ancora definite in forma scritta, seppure di corrente applicazione, delle quali era riconosciuto e accertato l’uso, e forse anche statuta, cioè provvedimenti deliberati dalle assemblee cittadine e trascritti in libri privilegiorum custoditi dalla città”, A. Romano, Vito la Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana meridionale, prefazione a La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Messina 1993, pp LVI-LX, nota 119, in C. M. Rugolo, op.cit., pag.423.
[3] C.M. Rugolo, op. cit., pag. 423-424.
[4] Fra Pietro Tomasio sarà canonizzato santo e verrà proclamato coprotettore della diocesi con giornata commemorativa fissata al 19 gennaio.
[5] G. Cosentino, Codice diplomatico di Federico III d’Aragona e IV re di Sicilia (1355-1377), in “Documenti per servire la Storia della Sicilia”, I serie, vol. IX, Palermo, 1855, pag. 34; 14 e 287. G. Iacolino, Le isole Eolie…, vol. III, op. cit. pagg. 84-87.
[6] G. Cosentino, idem, pp 25, 56, 57, 250, 251, 280. G. Iacolino, op.cit., pag. 88-89.
[7] L. Zagami, Lipari e i suoi cinque millenni di storia, op.cit., pag. 199, nota 18.
[8] A. Sidoti, I documenti dell’Arca Magna del Capitolo Cattedrale di Patti, in “Timeo”, periodico annuale della Soc. Pattese di Storia Patria, n.1, marzo 1987; G. Iacolino, op.cit., pag. 95.(Archivio Storico Eoliano.it)
Fortificazioni
La battaglia di Lipari (1339)
Le mire di Roberto d'Angiò sulla Sicilia

L’evento più significativo di questo periodo è la battaglia di Lipari del 17 novembre 1339. Essa ha avuto non solo rilevanza storica ma ha anche creato, all’epoca, grande emozione da richiamare l’attenzione di uno scrittore e poeta come Giovanni Boccaccio che viveva a Palermo da dieci anni. Federico III era morto il 20 giugno 1337 e – contrariamente a quanto prevedeva il trattato di Cartabellotta - gli era succeduto il figlio Pietro II, debole ed inetto. Questo e le tensioni che si erano create fra i nobili siciliani con forme di vera e propria guerra civile prima e poi con fughe presso la corte di Napoli - riacutizzarono le mire di Roberto d’Angiò, re di Napoli, sulla Sicilia. Ma dopo alcuni tentativi infruttuosi d’Angiò si convinse che se voleva conquistare la Sicilia doveva prima  appropriarsi delle Eolie ed i particolare di Lipari facendone una testa di ponte. Così nel giugno del 1339 si armano venticinque galere al comando del conte di Squillace, Goffredo Marzano che giungono a Lipari e stazionano di fronte al Castello e lungo le due marine. Dalle galere sbarcano una gran quantità di uomini armati ma anche di carpentieri fiorentini che si mettono subito all’opera per realizzare le strutture necessarie all’assedio. L’obiettivo infatti era la resa della città che era praticamente tutta concentrata nel castello con i suoi giurati ed i suoi ufficiali.
appropriarsi delle Eolie ed i particolare di Lipari facendone una testa di ponte. Così nel giugno del 1339 si armano venticinque galere al comando del conte di Squillace, Goffredo Marzano che giungono a Lipari e stazionano di fronte al Castello e lungo le due marine. Dalle galere sbarcano una gran quantità di uomini armati ma anche di carpentieri fiorentini che si mettono subito all’opera per realizzare le strutture necessarie all’assedio. L’obiettivo infatti era la resa della città che era praticamente tutta concentrata nel castello con i suoi giurati ed i suoi ufficiali.
La notizia dell’assedio di Lipari giunge subito a corte, che allora risiedeva a Catania, e fa il giro di tutte le città e di tutti i feudi. Hanno inizio allora una serie di incontri – che si protrassero per tutta l’estate - perché era chiaro che in gioco era il regno e con il regno anche molti possedimenti e molti interessi giacché i nobili fuoriusciti hanno indubbiamente propositi di rivincita. Non c’era molto ottimismo ed il primo a covare preoccupazioni ed apprensioni era proprio il re Pietro.
Tutte le discussioni ruotavano intorno a due poli: la debolezza della Sicilia sul mare e quindi la preoccupazione a promuovere uno scontro in mare aperto, e l’esigenza di dovere attaccare al più presto la flotta nemica perché Lipari non avrebbe potuto resistere per molto.
Infatti i liparesi, che avevano rifiutato rifornimenti di viveri da parte degli assedianti, avevano però fatto sapere che se non fossero giunti entro il 18 novembre i soccorsi dalla Sicilia la città, in quella data, si sarebbe arresa.
Una flotta per difendere Lipari
Finalmente il 15 di ottobre, dopo tante discussioni fra incertezze e tentennamenti, nel porto di Messina si riuscì ad organizzare una flotta composta da 15 galee e sei legni sottili alcune galeotte genovesi e catalane requisite con la forza che sarebbero servite per il trasporto delle armi e delle vettovaglie. A capo di questa spedizione furono messi i nomi più prestigiosi del regno – fra cui Giovanni Chiaromonte ed i fratelli del re Giovanni, marchese di Randazzo e Orlando d’Aragona - come a significare che si aveva consapevolezza dell’importanza della posta in gioco. Fatta rotta prima su Milazzo il 15 novembre verso sera le galee giungono nei presi di Vulcano. La flotta degli assedianti, temendo che i siciliani volessero prenderli alle spalle e quindi si apprestassero a girare dietro l’isola, comparendo da Monte Rosa, decidono di lasciare al baia e di porsi loro al largo fuori il monte per avere la visuale della flotta nelle due direzioni, sia se da Vulcano facevano direttamente rotta su Lipari sia se comparissero dietro punta Castagna.

Il Castello e la veduta verso Vulcano
I siciliani interpretano la manovra come una ritirata e pensano che gli avversari non si sentano in grado di sostenere lo scontro e si mettano quindi in posizione di fuga, d'altronde sanno che i liparesi sono ormai allo stremo e se loro tergiverseranno ancora il 18 si arrenderanno. Sulle torri del Castello le bandiere del re di Sicilia sembrano spronarli e incoraggiarli alla lotta e i comandanti della flotta siciliana pensano che il momento non può essere più rinviato. E’ l’alba del 17 novembre, di mercoledì, e così ordinano alle galee di affrontare le navi angioine. Questi vedendo i siciliani dirigersi verso di loro indietreggiano. Ma è solo una mossa tattica per disporsi in ordine sparso e tentare l’accerchiamento. La flotta capitanata da Giovanni di Chiaromonte cade in pieno nel tranello credendo che gli avversari stiano fuggendo. Così si avventano loro addosso e sarà una sconfitta clamorosa. In capo ad un paio d’ore le sorti dello scontro saranno chiare: poche le navi che si salveranno, la gran parte saranno colate a picco e gli equipaggi uccisi, le galeee dei condottieri con Giovanni di Chiaromonte, Giovanni marchese di Randazzo, Orlando d’Aragona ed il fior fiore della nobiltà siciliana cadranno in mano agli angioini e gli equipaggi vengono fatti prigionieri. I liparesi che hanno assistito dagli spalti del Castello allo scontro col cuore in gola, ammainano i gonfaloni in segno di resa e i loro sindici scendono dal Castello a sottoscrivere con i i capitani angioini i patti di resa che erano stati decisi prima del giorno dello scontro. Il documento fu quindi inviato a Napoli, insieme ai comandati siciliani in catene, perché il re lo approvasse.

Il Castello, oggi
La sconfitta dei siciliani e i patti di resa
Ecco che cosa prevedeva la resa il cui testo, in volgare, non è giunto a noi in originale ma in un trascritto riportato nel “Registro Angioino”[1]. Nelle trascrizioni qualche capoverso è stato probabilmente accidentalmente saltato e qualche termine riportato in forma errata, per cui alcuni dettagli risultano incompleti o di dubbia interpretazione.
- I liparoti si arrenderanno se entro il 18 novembre il re di Sicilia non invii gli aiuti richiesti. Trascorso questi termini l’isola e il Castello di Lipari saranno immediatamente consegnati al re di Napoli e gli stessi liparoti immetteranno nel possesso dell’isola e del Castello i capitani del re.
- A tutti gli abitanti di Lipari saranno garantiti la vita e gli averi con indennizzo al doppio del valore per le cose che a cagione della guerra fossero andate in rovina; indulto generale per gli omicidi commessi.
- Ai liparoti sarà concesso di prelevare tavole, carbone e travi dai boschi di Squillaci in Calabria, con promessa di avere, provenienti da fuori, quaranta muratori e venti falegnami per rifabbricare le case distrutte. Tutto, compreso il trasporto dei materiali, a spese del re Roberto d’Angiò.
- A titolo di contributo per le riparazioni la comunità liparota avrà 270 gigliati d’oro da parte della tesoreria di Napoli.
- Entro il termine d’un anno a ciascun abitante, escluso i poppanti, sarà fatta elargizione di una salma di grano.
- Come è consuetudine, per la riparazione delle mura della Città e della Cattedrale – tolto il necessario al sostentamento dei monaci – si utilizzeranno gli introiti della Chiesa.
- Gli isolani non saranno tenuti a fornire vitto e alloggio gratuiti al presidio che il re avrebbe tenuto nell’isola.
- Tutti gli atti pubblici rogati sotto la dominazione aragonese dovranno essere considerati validi, riconosciuti i notai in attività, confermati i privilegi, compreso quello, per i cittadini, di portare armi in ogni luogo del regno.
- Le cause eccedenti il valore di 10 onze saranno portate avanti al capitolo di Calabria essendo esso più vicino che Napoli.
- Intanto i capitani del re Roberto consentano a Pietro Formica e alla sua famiglia di portarsi in Sicilia entro il 15 di novembre; lo stesso valga per tutti quelli che abitano al Castello.
Per i liparesi un risultato soddisfacente
Si può osservare che, tutto sommato, per i tempi che correvano, andò bene ai liparesi. Non solo venivano garantiti la vita ed i beni ma anche una salma di grano, 270 gigliati d’oro, e la ricostruzione delle case andate distrutte che, visto il ricorso al legnane ed ai falegnami, per la gran parte dovevano essere di legno. Il Formica, a cui veniva consentito di abbandonare l’isola con la sua famiglia doveva essere, probabilmente, un ufficiale militare come militari dovevano essere quelli a cui veniva concesso di trasferirsi in Sicilia prima del 15 novembre.
In relazione al punto 6, in coda alla richiesta, il re Roberto annotò in latino alcune righe che facevano riferimento ad un “monaco nominato”, alla facoltà di esigere le “dette rendite”, ad un accordo col Pontefice, e ad una assoluzione. Queste righe risultano un po’ oscure forse perché si riferivano a parti del documento che nelle trascrizioni sono state saltate o mal riportate. Secondo Iacolino questa annotazione potrebbe così intendersi: “ Se le rendite della Chiesa Liparitana sono da destinarsi quasi unicamente alla riparazione delle mura e della Cattedrale, prospetteremo al Sommo Pontefice l’opportunità che egli, per alcuni anni, soprassieda alla nomina del vescovo titolare, giacché il vescovo con la sua corte e la sua famiglia, assorbirebbe parecchio degli introiti ordinari della Mensa”. Quanto al “monaco” che non è nominato perché nella trascrizione è saltata la parte che lo riguardava, potrebbe essere Pietro de Aloysio, vescovo eletto ma non consacrato. Infine il riferimento all’assoluzione riguarderebbe uno degli interdetti dei pontefici verso la Sicilia per cui re Roberto avrebbe chiesto, “con lettera sigillata”, la revoca al papa[2].
Meno bene per la flotta siciliana e Orlando d'Aragona

Eleonora d'Aragona
Meno bene andò invece ai capi della flotta siciliana che dovettero riscattare la libertà con le proprie risorse. Giovanni Chiaromonte dovette vendere ad uno zio una parte dei suoi beni e col ricavato, 10 mila fiorini, sua moglie ; Eleonora d’Aragona, si recò alla corte di Napoli per negoziare la liberazione guadagnandosi una citazione di Giovanni Boccaccio, affascinato dalla sua bellezza e dalla sua dignità e commosso dal suo gesto, che la definisce “ninfa sicula per cui si meravigliaron gli occhi miei” la quale “… già perdéo l’amato sposo, in cieco marte speso allor che tutto vinto si rendéo in Lipari lo stuolo…”[3].
Più travagliata la vicenda di Orlando d’Aragona che si guadagnò anch’essa l’attenzione del Boccaccio[4]. Di lui il re, che forse non disponeva nemmeno dei 10 mila fiorini, se ne lavò le mani continuando a sostenere che i capi della spedizione non erano stati ai suoi ordini. Orlando forse sarebbe rimasto a lungo in prigione se non fosse intervenuta una nobildonna senese che viveva a Messina di nome Camìola che Orlando aveva conosciuto quando era in quella città, in ottobre, per approntare la spedizione. “Vedova, donna famosa delle bellezze del corpo e de’ costumi, di cortesia e laudabile onestà”, dice di lei il Boccaccio. Sarà lei che raccoglierà e sborserà tutta la somma necessaria per la taglia del fratellastro del re che le aveva promesso di sposarla. Ma una volta libero Orlando non vuole tenere fede a questa promessa adducendo la differenza di natali. Allora Camiola si appella al re e chiede che le sia fatta giustizia in Tribunale. Ma ottenuta la sentenza favorevole ricusò di sposarsi e preferì entrare in convento dove, ci dice lo storico Caruso, “menò una santissima vita”[5].(Archivio Storico Eoliano.it)


[1] G,B Siragusa, Le imprese angioine in Sicilia, in “Archivio Storico Siciliano, anno 1891- XV, pp. 283-315. G. Iacolino, Le Isole Eolie…, vol. II, op.cit., pag. 360-363.
[2] Idem, pag. 262.
[3] G. Boccaccio, Amorosa visione,canto XLIII, vv.23-32. S. Tramontana, Una fonte trecentesca nel “De rebus sicilia” di Tommaso Falzello e la battaglia di Lipari del 1339, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano”, N. /5, Roma, 1962, pp. 227-255. G. Iacolino, Le isole Eolie.., vol. II, op.cit., pag. 335.
[4] Volgarizzazione di maestro Donato da Cosentino dell’opera di Messer Boccaccio “De claris muliiebris” rinvenuto in un codice del XIV secolo dell’Archivio Cassinese, pubblicato per cura e studio di D. Luigi Tosti monaco della Badia di Montecassino, seconda esizione, Milano 1841, pag. 434. G. Iacolino, idem, pp. 348-349.
[5] G.B. Caruso, Bibliotheca Historica Regni Siciliae, 1. edizione Palermo, 1723. G. Iacolino, Le isole Eolie.., vol.II, op.cit., pagg 357 e ss.
Boccaccio
Il tempo di Federico III d’Aragona
Il vescovo Pandolfo fra angioini ( a Lipari) e aragonesi ( a Patti)

Caltabellotta è il paese della Sicilia dove si conclude la vicenda del Vespro.
In capo a poco più di tre settimane, tutta la Sicilia aveva messo alle porte i francesi esclusa Messina e alcune terre vicine e, fra queste, l’arcipelago delle Eolie, che erano rimasti fedeli agli angioini. E Lipari continuò a rimanere angioina anche quando, finalmente, Messina si ribellò. Da quel momento le Eolie dovettero trovarsi al centro di un via vai di navi militari, sia aragonesi che napoletane. La piazzaforte del Castello dovette allora essere presidiata da forze provenzali e napoletane e da contingenti militari del luogo. Certamente non mancarono agli isolani momenti di paura per gli scontri cruenti, dinnanzi alle loro coste, nello specchio di mare fra le isole e Milazzo.
La realtà delle Eolie aggregate a Napoli e Patti alla Sicilia, dovette avere dei riflessi gravi sulla diocesi e dovettero travagliare duramente la vita del vescovo Pandolfo II mandato dal papa Onorio IV, nel febbraio del 1286 a reggerla. Pandolfo, prima di essere nominato vescovo era stato cappellano del papa e questo fatto lo mise in cattiva luce presso Federico che lo riteneva schierato con gli angioini e gli attribuiva la responsabilità di alcuni moti che si erano verificati a Patti e per questo prese a perseguitarlo fino a costringerlo ad abbandonare prima Patti e poi la diocesi[1].
Comunque il problema della Lipari angioina in un contesto aragonese ebbe a risolversi con la pace di Cartabellotta firmata il 31 agosto del 1302 che per quanto ci riguarda riportava le Eolie sotto il potere aragonese di Federico III anche se questi non poteva chiamarsi re di Sicilia ma solo di Trinacria e il possedimento della Sicilia gli veniva attribuito a titolo personale, fino alla morte, dopo di che sarebbe tornato agli angioini.
Federico e il conflitto con i vescovi
Se Federico non andava d’accordo col vescovo Pandolfo e finì per scacciarlo dalla Sicilia, non si trovò in migliori rapporti col suo successore, il vescovo Giovanni che era stato nominato il 31 gennaio del 1304, a qualche mese di intervallo dalla morte di Pandolfo. Anche Giovanni entrò in contrasto con il re e per questo fu espulso nel 1312.[2] Lo stesso Federico nominerà nel 1325 vescovo un frate domenicano di nome Pietro. E con Pietro si apre un periodo buio e confuso[3] dove anche le notizie, almeno quelle sin’ora rinvenute, sono scarse.
 Federico III
Federico III
“Di tutti i tempi – commenta Rosario Gregorio[4] , giurista e storico del Medievo - non mai presentansi si oscuri e digiuni gli annali delle chiese siciliane che quei di quest’epoca, in cui sino la successione dei vescovi è incerta e in più luoghi interrotta: argomento chiarissimo che non lasciarono di sé gloriose e lodevoli ricordanze”.
Ma nella storia delle Eolie Federico III non può essere ricordato principalmente per i suoi conflitti con i vescovi, in particolare quando questi venivano nominati dal papa, ma soprattutto per l’apporto che diede allo sviluppo della nostra municipalità. Nel 1312 infatti,sicuramente Patti ma probabilmente anche Lipari, venivano dotate di un corpo giuratorio elettivo con precise funzioni di gestione municipale.
Il potenziamento della municipalità
Non si trattava di una scelta isolata e improvvisa. Era dal 1296 che Federico ci pensava, e questo perché aveva bisogno di un rapporto più intenso e pronto con i territori e quindi i municipi rappresentavano una rete di referenti della corona[5].
Obblighi e diritti dei giurati divennero più complessi e impegnativi: rappresentatività giuridica dell’Universitas civium et habitatorum di fronte allo stato, scrupolosa gestione dei beni e del denaro comune, obbligo di organizzare l’archivio e di tenerlo in ordine, provvedere alla pubblica annona con creazione dei centri di stoccaggio delle derrate e di nominare un tesoriero, un notaio, un addetto alla colletta dei tributi ed un esperto di arte edificatoria per la manutenzione delle opere di pubblica utilità come le muraglie della città alta alle cui periodiche riparazioni per lo più provvedeva il vescovo, di curare l’ordine pubblico e la disciplina dei vari settori della vita cittadina e di mantenere la “sciurta” cioè il corpo di vigilanza notturna in terra e diurna in mare. A loro fianco i giurati potevano tenere dei consulenti e avvalersi di ambasciatori ed individui di cultura chiamati sindici (voce di origine greca che significava procuratore, avvocato o difensore) quando bisognava conferire col sovrano o ufficiali di corte e, in caso di guerra, interloquire con potenze straniere.
Le elezioni dei giurati e di alcuni ufficiali si svolgevano ogni anno sul finire di agosto. Alle operazioni, che si tenevano molto semplicemente, presiedevano inviati del re e poi del viceré e un ecclesiastico.
Abbiamo una copia del verbale[6] di una votazione del 24 agosto 1618 ma si ha ragione di ritenere che le votazioni di 300 anni prima non fossero di molto differenti. Aveva diritto al voto circa un decimo della popolazione che lo esprimeva a voce per i tre giurati del comune, per il baglio, per il credenziero, per il segretario, per i due catapani (guardie municipali), per i due giudici “annali”( revisori dell’operato degli eletti) e per due serventi. Le cariche duravano un anno ma spesso venivano confermate, tutti di comune accordo, per dare stabilità e continuità agli organi.
Nella particolare situazione di Lipari in cui i funzionari cittadini erano di emanazione o del re, o del vescovo o della universitas, certamente la riforma di Federico andava a potenziare al curia civile cioè quella che veniva emanata direttamente dalla universitas.
Il privilegio dello scranno in Cattedrale

Lo scranno oggi in Cattedrale lo occupano le autorità civiche durante le più importanti funzioni religiose.
Nel 1325 al Comune di Lipari, Federico III d'Aragona concesse un singolare privilegio. Trovandosi egli a navigare nel Basso Tirreno, sorpreso da un fortunale o, forse, da un tentativo di agguato, si rifugiò a Lipari. Era la vigilia della festa di S. Bartolomeo, quella del 24 agosto e volendo partecipare alla cerimonia della Messa, gli fu allestito in Cattedrale uno scranno quasi dirimpetto al soglio vescovile. Il suo seggio, opportunamente ampliato, egli volle che in seguito venisse occupato dai membri del Municipio ogni qualvolta intervenissero in Cattedrale, alle grandi solennità liturgiche. Con il tronetto dei rappresentanti municipali, eretto in Cattedrale, sormontato da pensilina e con sull'alzata di tessuto lo stemma reale e quello civico.
Federico d'Aragona, da convinto ghibellino, intese affermare che l'autorità laica era da considerarsi paritaria, in dignità, a quella ecclesiastica, ma al tempo stesso volle dare un riconoscimento alla Amministrazione di Lipari per la calorosa accoglienza fattagli dalla cittadinanza.[7]
[1] L.Zagami, op.cit., pag. 187. Dice Iacolino – Le isole Eolie…, vol.II, op.cit. p.328-9 – che probabilmente Pandolfo avendo ricevuto lo sfratto dal regno di Sicilia si trasferì in un primo tempo a Lipari fino a quando il 4 luglio 1290 il papa , pur lasciandogli il diritto titolo di vescovo di Lipari e di Patti non lo nominò amministratore apostolico in Sardegna probabilmente per toglierlo da una situazione difficile e insostenibile. Come vescovo Pandolfo ebbe cura di rimettere ordine nella complessa documentazione dei diritti della sua chiesa facendoli tradurre in latino e facendoli confermare per farla valere nei confronti delle due signorie che governavano nel suo territorio, gli aragonesi su Patti e gli angioini su Lipari. Oltre a questo di lui si ricorda che fu nella delegazione di tre vescovi che nel luglio del 1294 andarono da Pietro di Morrone per comunicargli l’avvenuta elezione a Papa. Morì a Roma, dove nell’ultimo decennio aveva a lungo dimorato, sul finire del 1303.
[2] Non si ha notizia certa della morte di Giovanni: chi dice il 1320, chi il 1324, chi nel 1325 all’età di 75 anni. Comunque secondo Iacolino, - Le isole Eolie… vol.II , pag.331 e ss. - nel 1325 Giovanni era già uscito di scena, infatti nel 1325 Federico nomina vescovo il frate domenicano Pietro, siciliano, anche se la curia pontificia che si trovava ad Avignone non saprà mai di questa elezione o si rifiutò di riconoscerlo. Comunque a Pietro il re avrebbe attribuita la facoltà di giudicare nel suo tribunale le cause civili e criminali degli ebrei residenti in diocesi.
[3]R. Gregorio, Libro V, pag. 146. Infatti dopo Pietro troviamo un Francesco de Petro che nel 1352 risulta essere cappellano maggiore di re Ludovico, nel 1342 un Pietro de Aloysio che sarebbe stato eletto dai capitoli monastici e secolari di Lipari e Patti. Tutti prelati, questi ultimi tre, che dalla Santa Sede non ebbero mai né conferma e quindi nemmeno autorizzazione ad essere consacrati (G. Iacolino, op.cit., pag.345, 347).(Archivio Storico Eoliano.it)
[4] . R. Gregorio, Libro V, pag. 146.
[5] R. Gregorio, vol.II, libro IV, cap.III, par.120; G. Iacolino, Le isole Eolie…,vol.III, pag. 242-245.
[6] G. Iacolino, le isole Eolie..,vol.II. op.cit., pag. 333-334; G. La Rosa, Pijrologia topo storiografica dell’Isole di Lipari, a cura di Alfredo Adornato, Lipari 1997, Parte II, pag. 25 e ss.
[7] G. Iacolino, Le isole Eolie…,vol.II, op.cit. pag. 3338 e pag.340-342; G.Iacolino, Le isole Eolie…, vol.III, op.cit. pag. 49-50.
I vescovi Giovanni e Pietro.
Bartolomeo da Lentini, il vescovo dei Vespri
Bartolomeo da Lentini e le difficoltà ad insediarsi

Papa Alessandro IV
Abbiamo detto che il 17 aprile del 1255 papa Alessandro comunica al popolo della diocesi di Lipari-Patti di avere consacrato vescovo Bartolomeo da Lentini che era stato nominato già l’anno precedente. Ma anche ora, malgrado Filippo non lo possa più ostacolare, Bartolomeo non riesce a prendere possesso della sua diocesi. Messina come altre città della Sicilia si era ribellata al re e si era costituite in repubblica e lo stradigoto di Messina, Leonardo Aldigieri, avventurandosi in una gestione tutta familistica del suo ruolo, nomina il proprio figlio Matteo che era chierico, amministratore della diocesi di Lipari-Patti. E malgrado il papa spedisca tre lettere[1] per sostenere Bartolomeo – una esaltandone il ruolo concedendogli la facoltà di assolvere chi era colpito dalla scomunica contro Federico; la seconda ai fedeli della diocesi perché lo accolgano come loro vescovo; e la terza agli Aldighieri perché restituiscano la chiesa a Bartolomeo – Matteo lascerà la diocesi solo quando Messina verrà riconquistata dagli svevi, la repubblica si dissolverà e lui verrà arrestato. Ma anche questa volta non sarà Bartolomeo a prenderne possesso ma un funzionario laico del re, Leone di Pardo, in qualità di procuratore della diocesi[2].
 Carlo d'Angiò sconfigge Manfredi
Carlo d'Angiò sconfigge Manfredi
E’ ancora il papa ad intervenire a beneficio di Bartolomeo. Alessandro si rivolge all’arcivescovo di Palermo perché recuperi i beni - che “il fu Filippo, che si faceva passare per vescovo di Patti, di fatto trasferì” - e li recuperi per conto del vescovo Bartolomeo che dimora a Roma. Il fatto che il papa invochi l’intervento del vescovo di Palermo e non quello di Messina come sarebbe logico. visto che è il metropolita della diocesi di Lipari-Patti, è perché lo ritiene un migliore interlocutore nei confronti del re Manfredi[3]. Ma Manfredi non vuole riconoscere il vescovo nominato dal papa e così prima agisce tramite il procuratore Leone di Pando e poi nomina vescovo Bonconte di Pendenza nel maggio del 1261.
I traffici di Bonconte
Questo Bonconte doveva essere un personaggio poco affidabile, venale e trafficone. Dopo avere spremuto Patti e Lipari – badando bene di farsi rilasciare degli attestati che quanto davano i locali lo davano di loro spontanea volontà[4] - egli si trasferiva nel Lazio e nella Sabina dove concludeva affari personali e politici non sempre limpidi[5]. E sono questi affari illeciti che spingono Bartolomeo a rivolgersi al papa Urbano IV che era succeduto ad Alessandro. E Urbano il 7 luglio del 1264 denuncia Bonconte al podestà di Rieti accusandolo “con i proventi della suddetta chiesa di Patti compra estesi e vasti poderi e, soggiornandovi pubblicamente a suo piacimento, ma uomo pestifero e manifesto sostenitore dello stesso persecutore ( Manfredi) ha l’ardire di conchiudere ogni giorno in quella città perversi intrighi con alcuni Nostri cittadini e non esita di fare occultamente altre cose che potrebbero portare alla sottomissione della stessa città ( Rieti) e un notevole danno per la Romana Chiesa”[6]. Ancora un paio di anni e poco più e il 26 febbraio del 1266 a Benevento il re Manfredi viene sconfitto dalle armate di Carlo d’Angiò e Bonconte, finalmente, si rassegnò ad abbandonare Patti, scomparendo, per cui finalmente il vescovo Bartolomeo da Lentini poté prendere possesso della sua diocesi.
“Una vicenda del tutto singolare[7]” la definisce Luigi Pellegrini, quella del vescovo Bartolomeo. “Da tale vicenda si evince – osserva- come lo stato di confusione creatori in Italia meridionale dopo l’avvento di Manfredi abbia influito anche sulle possibilità di comunicare tra la curia romana ed i suoi inviati nel Regno ed abbia indotto elementi di scompiglio anche nella nomina dei vescovi”[8].
Alla morte di Federico i suoi eredi non riescono a stabilire un modus vivendi con la Santa Sede che ad essi preferisce i Comuni ed il regno di Francia e sarà proprio il fratello del re di Francia, il conte d’Angiò, che nel 1266, scende in Italia meridionale e, sconfitto Manfredi, figlio illegittimo di Federico, nei pressi di Benevento, si impossessa del regno. In Sicilia il dominio angioino durerà però poco perchè il lunedì di Pasqua 1282, una provocazione abbastanza banale provoca contro gli Angioini la sommossa nota come “Vespri Siciliani”. Umiliati dall’occupazione dei nuovi conquistatori e dal duro fiscalismo angioino, i siciliani massacrano migliaia di francesi.
Il governo dell’isola viene affidato al genero di Manfredi, Pietro III d’Aragona che era uno degli istigatori della rivolta con il sostegno dell’imperatore bizantino Michele Paleologo.

Un dipinto sui Vespri.
Bartolmeo promuove i Vespri
Conviene soffermarsi sui Vespri perché vi giocò un ruolo di rilievo proprio il nostro Bartolomeo da Lentini. Bartolomeo riuscì a prendere possesso della sua diocesi, abbiamo detto, solo nel 1265 dopo dieci anni di esilio trascorsi nei conventi del Lazio e presso la Curia pontificia. All’inizio del 1266 quando Carlo d’Angiò batteva Manfredi a Benevento , Bartolomeo era già all’opera rivendicando le terre della sua chiesa e cercando di rimediare ai guasti di oltre dieci anni di abbandono. E quest’opera di regolarizzazione della diocesi continuò - malgrado fosse un vescovo per lo più assente che viveva la maggior parte del suo tempo nel Lazio - ristabilendo buoni rapporti con Carlo d’Angiò ed approfittandone perché concedesse la riattivazione dei porti di Patti e di Lipari e Vulcano a favore del commercio locale. Tornò a vivere nella diocesi nel 1276 ma si trovò di fronte a molte resistenze degli abitanti che si sentivano vessati sotto l’aspetto economico da tasse e balzelli del regno e cercavano di compensare non pagando quanto dovuto al vescovo.
Vivendo nella sua diocesi e fra la gente Bartolomeo si convince delle loro buone ragioni e si immedesima nelle loro condizioni di vita facendosi portavoce delle loro angustie contro le malefatte delle signorie. Allo stesso tempo va prendendo le distanze dal re che viveva lontano dalla Sicilia e soprattutto a Roma ed Orvieto presso la corte pontificia specie da quando, nel febbraio del 1281, era salito al trono pontificio il francese Martino IV.
E fu così che nella primavera del 1281, Bartolomeo con il confratello Bongiovanni Marino, accettano la missione di farsi ambasciatori delle istanze dei siciliani. Si recano ad Orvieto per rappresentare al papa le lamentele ed alla corte papale i due inviati trovano anche il re Carlo d’Angiò che vuole assistere alla loro esposizione.

Carlo d'Angiò sbarca a Palermo
Bartolomeo non è per nulla intimorito da questa presenza, forse inattesa, ma comincia la sua perorazione richiamandosi al vangelo di Matteo ed all’invocazione che la donna cananea rivolge a Gesù: ” Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio”. Quindi aggiunse “Se le lunghissime guerre, se la rivoluzione dei popoli, se gli umori vari e diversi del regnare oppressero la Sicilia nei tempi passati, nessuna di queste calamità è paragonabile a quella che viviamo oggi, perché questi furono momenti felici paragonati con le miserie di oggi. La Sicilia fu memorabile per le molte ricchezze e la sua potenza, per l’antichità e nobiltà delle origini, per la gloria delle cose fatte. Oggi invece è tanto umile e abietta che essa stessa ne prova vergogna, ha sopportato per molto tempo le acerbe crudeltà fino a quando non si è oltrepassato il segno dell’onore, per cui vedendosi privata di quello, a voi Re Carlo si richiama e anche a voi Martino , pontefice massimo. La Sicilia, ultima nel gregge cristiano, si raccomanda a voi per essere protetta dalle rapaci Arpie e dalle acute e velenose zanne dei fieri lupi”[9]. E dopo questo “incipit” Bartolomeo proseguì con energia e coraggio esponendo le ingiustizie, le rapine, le libidini, le tirannie, che in Sicilia si praticavano da parte dei ministri del re e dai nobili e funzionari francesi[10].
Il risultato di tanto impegno fu che i due ambasciatori furono arrestati e buttati in prigione. Bartolomeo riuscì a fuggire pagando i carcerieri mentre il suo confratello, meno fortunato, vi perì . Scampato dal carcere Bartolomeo si tenne lontano dalla sua diocesi fino a quando scoppiarono i Vespri e i francesi furono cacciati dalla Sicilia. Allora il vescovo tornò a Patti ma senza frequentare Lipari che era rimasta angioina. Morì nell’estate del 1282 o nel primo semestre del 1283. (Archivio Storico Eoliano.it)
[1] G:Iacolino, Le Isole Eolie…, libro II, op.cit., pp.284-286.
[2] G.Iacolino, idem, pag. 287.
[3] Idem, pag. 288-9.
[4] Per Lipari vi è un atto notarile del 3 settembre 1261 che manifesta questa “liberalità” dei liparesi con atto pubblico“perché in qualcuno non sorga dubbio circa la forma e la natura di questo donativo e offerta”, in G. Iacolino, op.cit., pag 293-4.
[5] Idem, pag. 295.
[6] Idem, pag. 297.
[7] L.Pellegrini, “Che sono queste novità?”. Le religiones novae in Italia meridionale (secoli XIII e XIV), Napoli 2005, pag.99.
[8] Idem, pag. 99.
[9] G. Iacolino, Le Isole Eolie, vol II, op.cit. pag. 312-313; F. Mugnos, I ragguagli Historici del Vespro Siciliano, Palermo, 1645, pp50-51;
[10] P. Campis, op.cit. , pagg 233.
Bongiovanni Marino
Le consuetudini : norme locali
Il libro delle Corrie

Fin dal tempo dell’Abate Ambrogio erano venute definendosi nel territorio delle “consuetudini”[1] che riguardavano la civile convivenza ed in particolare la disciplina dei pascoli, la regolamentazione dei diritti di famiglia, la divisione dei beni le esecuzioni testamentarie, il rapporto locativo, ecc. Nei primi decenni del XIV secolo queste norme locali vennero redatte in iscritto in lingua latina, raccolte e sistematizzate in un unico testo che purtroppo non ci è pervenuto nella forma originaria ma solo in una trascrizione del XVIII secolo contenuto nel Libro delle Corrie col titolo “Consuetudines scripte huius civitatis Lipare”[2]. Riteniamo che questa prima stesura debba risalire ai primi decenni del trecento perché portano la data del 1312 le Consuetudini di Patti. Ma a differenza di quest’ultime che furono ratificate dal re, le consuetudini di Lipari lo furono da parte del vescovo anche se, non conoscendo la data della loro ratifica, non conosciamo nemmeno il nome del vescovo.
Per renderci conto del tenore di queste norme pubblichiamo alcuni stralci del documento. A proposito degli affittuari o coloni morosi: “Il locatore di case o di altri immobili propri, se l’affittuario o il colono non paga il canone al locatore della casa o dell’immobile, il locatore stesso può, di sua iniziativa, entrare e appropriarsi di un pegno corrispettivo a quanto gli è dovuto”.
A proposito della vendita diretta : “Qualsivoglia persona…può ogni anno, uccidere e vendere al macello tre bestie del suo allevamento liberamente e senza tasse, e può vendere, per ogni rotolo, ad un denaro in più di quanto vende un macellaio”.
Particolarmente rigorosi si era rispetto ai danni provocati dai propri animali – buoi, pecore, capre, maiali, asini – alle vigne, alle messi, agli ortaggi di terzi per incuria. Per ogni tipo di coltura è specificata una ammenda. Una eccezione era prevista per gli animali lattanti sorpresi con la madre, in terreni di terzi che non erano sottoposti a nessuna penalità. Per le bestie da ovile, pecore e capre in particolare, si procedeva a multarli per centinai di capi.
Il toponimo "sotto il palo"

Se i responsabili dei greggi non erano individuati, il baiulo ordinava che le bestie fossero condotte nei pressi della città e raccolte in un apposito recinto. Questa zona si trovava dove oggi vi è piazza Mazzini, lungo il margine orientale e per questo la spianata della Civita veniva chiamata “carcere animalium” o più comunemente “palium” che significava largo, spiazzo, radura da cui il toponimo “sotto il palo” che è giunto fino ai nostri giorni.
Se invece non si trattava di greggi ma di pochi capi come accadeva per i maiali la norma era diversa:”Se un uomo o una donna alleva porci di ‘mannara’… e questi porci vengono sorpresi in orti o vigne senza pali né recinzione, ai padroni delle vigne e degli orti – dopo aver prima diffidato i padroni dei porci a tenerli a bada perché non arrechino danno ai vigneti e agli orti – è data facoltà di chiedere al baiulo l’autorizzazione di potere liberamente abbattere questi porci; i porci stessi, così uccisi, resteranno di proprietà del possessore e padrone delle vigne e degli orti a titolo di risarcimento del danno subito; al baiulo però spetta – in ragione di ogni capo ucciso – un quarto e la testa”.


Due pagine del libro Verde o dei Privilegi
[1] Questo paragrafo è stato redatto sulla base di quanto a questo proposito ha scritto Giuseppe Iacolino in Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla rifondazione della communitas eoliana alla battaglia di Lipari del 1339, (Lipari, 2001 pp. 212-215) e La fondazione della Communitas eoliana agli albori della Rinascenza (1095- 1995), (Lipari, 1995. pag. 61-63).
[2] G.Iacolino, Le isole Eolie…, op.cit., pag. 213-216. “Il libro delle corrìe” si trova presso la biblioteca del Museo Archeologico regionale Bernabò Brea di Lipari, come correttamente è riportato in G.A.M. Arena, Bibliografia Generale delle Isole Eolie, Società Messinese di storia patria, Messina, 1985, pag. 210.. Ma a differenza di quanto riporta l’Arena che parla di 582 pagine, la copia che abbiamo visionata è composta di 250 fogli e quindi da 500 pagine. Esso – sempre secondo Arena – sarebbe il registro della Corte Capitaniale di Lipari in cui si trovano copiati numerosi atti che furono di fondamentale importanza per l’economia e la vita sociale delle Isole Eolie. Ed appunto fra questi atti, al foglio 212 sono copiate le Consuetudines scripte huius visitati Liparae. Per il resto il libro contiene lettere ed ordinanze che vanno dal 1574 al 1785. Sempre al Museo, afferma C.M. Rugolo (Il recupero della memoria. I codici dei Capitoli e Privilegi Lipari, in Bulletino dell’Istituto Storico italiano per il Medioevo, n. 105, 2003, pp 404-426), che sembra non sapere niente del Libro delle corrìe perché non ne parla, esisterebbero invece tre codici manoscritti: il primo, indicato con la lettera B, di 83 carte, in pessimo stato di conservazione. Esso contiene i privilegi concessi alla città di Lipari fino alla prima metà del XVI secolo e ricalca fedelmente il contenuto del Libro verde o dei privilegi che si trova nella Biblioteca comunale di Lipari ( contrassegnato dalla Rugolo con la lettera A). Entrambi i due libri avrebbero come origine la Camera di Sommarìa di Napoli. Avrebbero invece come origine la Regia Cancelleria di Palermo altri due codici, contrassegnati dalla Rugolo con le lettere C e D, che si trovano anch’essi presso la biblioteca del Museo Archeologico. Il codice C composto da 18 carte ha una copertina in cartone con il titolo Libro de’ privilegi, gratie, franchezze, etc. riconduce immediatamente ad un esemplare del 1613 che a sua volta rimanda ad un archetipo perduto del 1519. Il codice D composto di 84 carte evidenzia il proprio carattere di uso quotidiano, una copia di rapida consultazione. Il Libro dei privilegi o libro verde che si trova nella biblioteca comunale di Lipari è composto di 60 carte ed è certamente la copia redatta dalla Camera della Sommarìa di Napoli a metà del 500. All’inizio del libro oltre lo stemma asburgico vi è lo stemma di Lipari. Infine vale la pena segnalare che presso la Biblioteca comunale di Lipari vi è anche un altro manoscritto chiamato Libro rosso citato da Arena ma non citato dalla Rugolo. Questo libro rosso, secondo Arena, contiene gli atti dell’Università di Lipari dal XVI al XVIII secolo e sarebbe composto da 388 fogli. Iacolino a margine di una fotocopia selettiva di questo libro definita, raccolta antologica, dice che contiene decreti vicereali e “banni” del Comune dal 1620 al 1720 circa, non perfettamente ordinati, né tutti al completo. Le pagine che Iacolino indica sarebbero 373.(Archivio Storico Eoliano.it)
Sotto il Palo
La creazione della municipalità a Lipari
Lo strutturarsi della municipalità in Sicilia

L'antico palazzo vescovile oggi sede del Museo archeologico
Nel periodo che va dal XIII al XV secolo, il fuoco della nostra storia delle Eolie non sta più nelle vicende della diocesi quanto nello strutturarsi della municipalità nell’ambito di un processo che investe tutta l’Europa, a partire dal secolo XI, e che ha il suo dinamismo nell’urbanesimo e nell’emergere di nuovi ceti sociali in particolare nelle realtà urbane. Continuerà la signoria feudale dei vescovi nell’ambito del regno che vedrà succedere agli svevi prima gli angioini e poi gli aragonesi, ma andrà maturando ed emergendo, all’interno di questo potere, una autonomia richiesta dalla società civile.
“Il Comune – osserva Mario Ascheri[1] - non fu voluto né dall’impero né dalle sue autorità locali legittime – vescovi, conti, marchesi - ; non ebbe un ordinamento calato dall’alto, ma fu una creazione nuova, autonoma venuta su dal basso tra mille difficoltà, passo dopo passo, anche in modo inizialmente provvisorio, a tempo, e che peraltro non potè che legittimarsi da sé, come avviene per ogni fatto rivoluzionario”.
Da noi, a differenza di quanto avvenne ad esempio in Lombardia, non si trattò di autodeterminazione politica sull’onda di un conflitto, più o meno cruento, con i poteri costituiti come l’Impero, ma piuttosto del manifestarsi di una autonomia che portò – sostanzialmente in accordo col vescovo ed il re quando non addirittura da questi promosso - ad un autogoverno dei problemi cittadini in relazione ad attività che integrano quelle previste dall’ordinamento, rimediando alle sue carenze.
Vero è, come abbiamo visto nel capitolo precedente, che nel 1199 il vescovo Stefano deve piegarsi alle proteste dei possessori dei terreni in enfiteusi di Salina ed Alicudi che richiedevano la concessione libera e gratuita di questi. Ma, per quello che sappiamo, siamo in presenza qui di un conflitto circoscritto ed eccezionale che proprio per questo viene registrato dal Campis. Un conflitto che, per’altro, ben presto rientra col pentimento di chi l’aveva promosso.
Ben più interessante è il documento che ci parla del giudizio, sempre del vescovo Stefano, tenuto a Lipari nel marzo del 1190 contro dei razziatori di falconi che conferma la presenza nell’isola di uno stradigoto e di un certo numero di incaricati di avanzare richieste di natura amministrativa alla corte di giustizia del vescovo e verosimilmente anche alla corte del re quando il contenzioso investe lo stesso prelato, come emerge da un altro documento del settembre del 1191 riguardante gli abitanti di Patti a proposito dei terreni di Librizzi. Da questi documenti si palesa che già sul finire del XII secolo si ha nell’ambito del vescovato di Lipari- Patti, la “presenza di un ceto di piccoli proprietari e operatori locali impegnati attivamente nell’esercizio di diritti elettivi e nella conquista di spazi autonomi di governo”[2] .
Difficile è però parlare, a proposito di questi, di organismi municipali in qualche modo distinti dagli uffici del Vescovo.
Federico II e i "giurati"
 Per tutta la durata della dinastia normanna e nei primi decenni della dominazione sveva (sino al 1230) non ebbero, infatti, i comuni siciliani organismi che fossero abilitati a deliberare in piena autonomia nell'interesse della collettività. Bisogna giungere all'avvento dell'imperatore Federico II (1198 – 1250) - primo re di Sicilia di questo nome – perchè si riscontri il termine “giurato”. Fu il titolo che si cominciò a dare a taluni boni homines de melioribus terrae, i quali scelti dal re stesso e dopo aver giurato sui Vangeli fedeltà alla corona, assumevano precise minute incombenze da espletare nell'ambito delle singole terre e città: di polizia monetaria, di repressione delle frodi mercantili, di vigilanza sulla corretta applicazioni delle consuetudini. Di giurati a Lipari si parla in documenti del 1222 e del 1231[3].
Per tutta la durata della dinastia normanna e nei primi decenni della dominazione sveva (sino al 1230) non ebbero, infatti, i comuni siciliani organismi che fossero abilitati a deliberare in piena autonomia nell'interesse della collettività. Bisogna giungere all'avvento dell'imperatore Federico II (1198 – 1250) - primo re di Sicilia di questo nome – perchè si riscontri il termine “giurato”. Fu il titolo che si cominciò a dare a taluni boni homines de melioribus terrae, i quali scelti dal re stesso e dopo aver giurato sui Vangeli fedeltà alla corona, assumevano precise minute incombenze da espletare nell'ambito delle singole terre e città: di polizia monetaria, di repressione delle frodi mercantili, di vigilanza sulla corretta applicazioni delle consuetudini. Di giurati a Lipari si parla in documenti del 1222 e del 1231[3].
Federico nel 1231 – dopo aver ristabilito la pace col papa ed avere ricondotto sotto la sua autorità i baroni ed i saraceni - emana le Costituzioni di Melfi, chiamate anche Liber Augustalis[4]. Come per Federico anche su queste Costituzioni abbiamo giudizi contraddittori. Per qualcuno siamo di fronte a leggi del primo stato moderno d’Europa[5], per altri invece di fronte ad “una combinazione ben dosata di fonti romane, canoniche e feudali”, ma sostanzialmente prive di originalità[6]. E’ certo comunque che si tratta del primo grande codice del Medioevo che introduce nella legislazione, pur fra contraddizioni ed una forte tendenza centralistica, elementi di modernità. Infatti, Federico superando la concezione feudale germanica, ritorna alla tradizione romana affermando l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; elimina il potere dei baroni, del clero e delle città, e tutte le funzioni giuridiche ed amministrative vengono esercitate dal re per mezzo di una organizzazione burocratica centrale, posta alle sue dipendenze; i magistrati sono stipendiati dallo Stato ed eletti per un solo anno, salvo riconferma; per garantire gli introiti necessari alla vita del regno crea un saldo sistema finanziario, basato sulle imposte dirette, con organi incaricati della riscossione; organizza inoltre un esercito regolare di saraceni, per non dipendere dai baroni e dai comuni che spesso si sottraevano agli obblighi di fornire la milizia.
Gli organi centrali sono il Sovrano, i grandi ufficiali della Corona, la Magna Curia ed il Parlamento. Al vertice sta il re, il solo che possa fare le leggi, dal momento che il suo potere gli deriva direttamente da Dio. Al suo fianco stanno i grandi ufficiali della Corona, i moderni ministri con funzioni ed attribuzioni ben definite. I ministri non sono scelti tra i nobili feudali, come avveniva in passato, ma tra la gente di cultura, come notai e giuristi. La Magna Curia, rappresenta la Suprema Corte di Giustizia, con funzioni ispettive e di controllo su tutti i funzionari. Il Parlamento, infine, era un’assemblea generale alla quale potevano partecipare, i feudatari, i rappresentanti delle Università, ed i Comuni demaniali, per essere messi a conoscenza delle leggi promulgate dal sovrano e non per discuterle od approvarle. Potevano però fare presente eventuali necessità.
Ai Parlamenti generali o Curie, fanno riscontro le assemblee provinciali, presiedute da un giustiziere.
Statua di Fedeirco II
I comuni aspiravano evidentemente ad avere una certa autonomia, come le città dell’Italia settentrionale; ma Federico non poteva certo concedere alle città siciliane l’autonomia che vantavano i comuni del nord che andava combattendo. Pur tuttavia non poteva ignorare le istanze di autonomia che si andavano diffondendo col rischio che se ne facesse portatore, in contrapposizione a lui, il papa che rivendicava la signoria sul regno di Sicilia, così volle che nei più importanti centri abitati del regno si desse vita ad un sistema amministrativo municipale stabile e confortato dai crismi del diritto pubblico caratterizzato da tre giudici e sei notai. I notai, come i baiuli ( funzionari regi a cui spettava di deliberare circa le lamentele contro i feudatari; una figura introdotta nella Francia del nord sul finire del XII secolo) erano allora considerate non come attività autonome a sé stanti ma componenti del corpo municipale. I notai fungevano da consulenti legali accanto ai giudici e così anche i baiuli se preparati culturalmente.
Il formarsi delle istituzioni municipali a Lipari
 Fino a qualche anno fa non era possibile sostenere che a Lipari fosse stato attivato, secondo le disposizioni di Federico, un corpo municipale. E’ solo nel 2002 che il prof. Iacolino[7] viene in possesso, nella sua integrità sebbene si tratti di un trascritto, di un documento – un atto notarile – del 22 maggio del 1246 in cui nell'intestazione può leggersi: “Noi Bartolo de Bruno, Amico de Aldimerio, Benedetto de Maracita, giudici di Lipari,....”. Sempre questo documento ci dice che a Lipari c’è anche il baiulo di cui si fa il nome, Andrea Saurano, ed il notaio che però è morto e viene sostituito, nella redazione del verbale, da un notaio messinese. La presenza di questi funzionari non intaccavano il potere del vescovo giacchè venivano da esso nominati come risulta da un documento contenuto nell’Archivio Capitolare di Patti riguardante il vescovo Bartolomeo di Lentini dove è detto espressamente che egli “creò e istituì il baiulo, i giudici, gli avvocati, gli accattapanos, e gli altri ufficiali della città di Patti” e che questi ufficiali prestarono al vescovo giuramento di fedeltà. E se questo avveniva per Patti doveva, ugualmente, avvenire per Lipari.Il documento aggiunge che questa prerogativa di creare ed istituire gli ufficiali di città era stata anche dei predecessori di Bartolomeo.[8]
Fino a qualche anno fa non era possibile sostenere che a Lipari fosse stato attivato, secondo le disposizioni di Federico, un corpo municipale. E’ solo nel 2002 che il prof. Iacolino[7] viene in possesso, nella sua integrità sebbene si tratti di un trascritto, di un documento – un atto notarile – del 22 maggio del 1246 in cui nell'intestazione può leggersi: “Noi Bartolo de Bruno, Amico de Aldimerio, Benedetto de Maracita, giudici di Lipari,....”. Sempre questo documento ci dice che a Lipari c’è anche il baiulo di cui si fa il nome, Andrea Saurano, ed il notaio che però è morto e viene sostituito, nella redazione del verbale, da un notaio messinese. La presenza di questi funzionari non intaccavano il potere del vescovo giacchè venivano da esso nominati come risulta da un documento contenuto nell’Archivio Capitolare di Patti riguardante il vescovo Bartolomeo di Lentini dove è detto espressamente che egli “creò e istituì il baiulo, i giudici, gli avvocati, gli accattapanos, e gli altri ufficiali della città di Patti” e che questi ufficiali prestarono al vescovo giuramento di fedeltà. E se questo avveniva per Patti doveva, ugualmente, avvenire per Lipari.Il documento aggiunge che questa prerogativa di creare ed istituire gli ufficiali di città era stata anche dei predecessori di Bartolomeo.[8]
La figura del baiulo, che sovraintende alle funzioni giudiziarie, non intacca, ripetiamo, le prerogative del vescovo e della sua curia ai quali rimangono, come vedremo, un’ampia competenza.. Inoltre spettavano al vescovo la maggior parte delle cause dette di “misto foro” di cui parleremo più avanti..
Probabilmente, ritiene Iacolino, risale ai primi decenni del XIII secolo la creazione dello stemma civico cittadino[9] che riproduce il castello con le tre torrette allora esistenti e l’immagine di S. Bartolomeo sulla porta del Castello.
Più, tardi, presumibilmente nella prima metà del XIV secolo a Lipari compaiono anche i giurati, accostati o subordinati ai giudici. Si trattava di una figura che aveva istituito Federico nel 1222, ancor prima delle Costituzioni di Melfi, con una ordinanza per le città di una certa importanza. Si trattava di scegliere due o più boni homines da affiancare ai giudici per controllare la qualità e i prezzi di generi alimentari in vendita, di indagare sulle frodi monetarie, di verificare la “legalità” dei prodotti farmaceutici e sciroppi. Siccome queste persone giuravano prima di affrontare il loro incarico vennero chiamati giurati. Di fatto i giurati godevano di pari dignità dei giudici infatti alcune lettere redatte da Federico d’Aragona e dai suoi funzionari fra il 1355 e il 1356 sono indirizzate ai giurati ed ai giudici della Città di Lipari.
Nel corso del XIV secolo i compiti dei giurati furono trasferiti ai catapani, chiamati a svolgere pressa a poco la funzione che hanno oggi i vigili urbani, mentre furono i giudici a chiamarsi giurati ed infatti solo ai giurati di Lipari si rivolge una lettera della Curia reale del 6 maggio 1392.[10]
Lo stemma civico di Lipari
La competenza del vescovo nella nomina di questi funzionari dovette durare forse fino alla fine del XVI secolo. Abbiamo un riscontro storico del 1618 che ci informa che la loro elezione era passata all'assemblea popolare e cioè ai nobili e ai possidenti, mentre al vescovo era riservata soltanto la scelta del candidato del baiulato.[11].
E’ importante capire quando si ha il passaggio dell’amministrazione cittadina, almeno per alcune importanti funzioni, dalle mani degli officiali regii a quelli di organi elettivi[12], perché a questo processo è legato un importante salto di qualità nella universitas ed il delinearsi di un ceto medio che diventa classe dirigente. Inoltre questo processo a Lipari risulta più complicato perché fra il re e l’universitas c’è il ruolo e la figura del vescovo che assomma in sé alcuni compiti del re ed essendo figura prossima alla comunità ritarda in qualche modo anche il processo di crescita autonoma della universitas.

L'incipit del documento del 1246 citato da Iacolino e ripreso dal suo libro.
“Consuetudini, privilegi, fiscalità locale, istituzioni elettive divenivano il nucleo di identità cittadine che esercitavano un controllo sul territorio, contendendolo all’aristocrazia fondiaria , e si esprimevano essenzialmente intorno a un ceto dirigente composito ma che si presentava collettivamente come espressione della città. L’apparato istituzionale della città rappresentava il luogo in cui questo certo eminente si cristallizza e si aggrega”[13].Questo apparato varia di luogo a luogo e da luogo a luogo variano le competenze ed i poteri delle specifiche figure[14]. Comunque in genere la nuova élite cittadina espressione della universitas è formata dal baiulo ( a Lipari abbiamo visto che il baiulo è nominato dal vescovo fino al XVII secolo) , da un gruppo di giudici e da giurati elettivi, da funzionari subalterni , nominati permanentemente o ad hoc per lo svolgimento di compiti specifici: sindaci (ambasciatori), notai degli atti della curia baiulare, tesorieri e razionali creati per diversi compiti che andavano dalle costruzioni delle mura all’annona. In questa élite in senso lato rientrano pure gli appaltatori delle gabelle cittadine, i veri arbitri della fiscalità e del debito pubblico della città[15].
Col tempo una certa dialettica si crea fra i dirigenti espressioni della universitas e quelli espressione dell’autorità regia ed in particola con il capitano regio. Il capitano regio, titolare della giustizia criminale, era depositario di un potere di enorme rilievo, e per questo i dirigenti locali tendono a limitarlo chiedendo al sovrano o un controllo maggiore sul suo operato o di circoscrivere la sua autorità. Più tardi si chiederà che la carica vada ad uno del luogo[16].Nelle realtà, come Lipari, in cui il baiulo non era elettivo esso non assumeva il ruolo di coordinamento della curia civile, ed il ruolo preminente nella rappresentanza della comunità veniva assunto dai giurati quando con Federico III nel 1312 viene affermata la loro designazione per elezione.
Il complesso rapporto fra poteri: vescovo, amministratori locali, autorità regia.
Si è detto che il rapporto fra i poteri a Lipari risulta più complicato ed in qualche modo anomalo per la particolare autorità del vescovo che “gioca un importante ruolo di mediazione istituzionale con evidenti riflessi nella gestione del governo locale”[17]. Questo si rivela in particolare sul piano giudiziario.
Come abbiamo visto ai giurati spettava – soprattutto quando sono divenuti organi elettivi – la rappresentanza ufficiale della città, l’amministrazione locale degli uffici e del patrimonio, nonché l’esercizio della giurisdizione civile attraverso una corte presieduta dal baiulo con l’assistenza di un giudice assessore. La corte capitaniale, presieduta dal capitano d’armi o governatore, anch’esso provvisto di un giudice togato, esercitava la giurisdizione penale: un fiscale svolgeva le funzioni di pubblico accusatore nei procedimenti ex officio, notai e maestri d’atti curavano la redazione formale dei processi, i serventi avevano funzioni esecutive e di notifica degli atti giudiziari. Infine vi era la curia vescovile che in qualche modo incideva sulle due corti laiche. Nell’ambito della giurisdizione civile, essa era titolare per antico privilegio del diritto d’appello sulle cause decise dalla corte baiulare e, per suo tramite, le cause potevano in ultima istanza essere trasmesse al Sacro Regio Consiglio presso la corte. Riguardo alla giurisdizione criminale la giustizia ecclesiastica si interessava degli ecclesiastici in senso lato comprendendo familiari e servi; tutte le cause in cui veniva coinvolto in qualche modo un appartenente al foro ecclesiastico ed infine, come abbiamo detto,le cause mixti fori[18] cioè reati che riguardavano sia il codice civile sia quello ecclesiastico come il concubinato, la bigamia, l’adulterio, lo stupro, l’incesto, il lenocinio, le pratiche superstiziose, la bestemmia e persino gli approcci amorosi e lo stesso bacio che finiva coll’assumere la figura di promessa di matrimonio. Proprio queste cause di “misto foro” finiranno – quando con gli spagnoli verrà creata la figura del capitan d’armi e di giustizia – col dar luogo a diversi conflitti di competenza fra questa nuova figura e la curia vescovile[19]..
Sin dalle sue origini e per oltre cinque secoli, il corpo dirigente municipale occupò, in locazione, un paio di vani terranei del vecchio Palazzo Vescovile attiguo alla Cattedrale. La sede si chiamò tocco, dal termine greco thòkos significante il seggio o lo stare a sedere in consiglio. Si andò avanti così per secoli, “in una condizione intermedia di compromesso, di scontro e di confusione - commenta Iacolino[20] - in cui non si saprà veramente entro quali spazi di libertà e di movimento dell’organismo comunale fosse consentito di agire”. Fu solo ai primi del settecento che il Comune ebbe una sua sede autonoma. Probabilmente i locali in dotazione al comune non dovevano essere molto ampi e a Lipari il consiglio pubblico, talvolta, si teneva nella spianata della Marina di San Giovanni, come accadde nel 1484, quando si dovette nominare un console per Lipari nella città di Siracusa, o nella piana della Civita o anche nella Cattedrale che allora aveva una sola navata e le dimensioni, rispetto ad oggi, erano più ridotte. E’ dal verbale di questa seduta si evince che il titolo di giudice era passato a designare tre nuove figure del governo municipale: i tre assistenti del baiulo nelle funzioni di giudici togati. Risulta altresì che uno dei tre giurati e due dei tre giudici dichiarano di non sapere scrivere.

Alle sedute partecipava di diritto il baiulo e quando si dovevano discutere problemi gravi si chiamavano una decina di cittadini ,”uomini veterani” e “mercanti cittadini” – che in qualche modo prefiguravano il futuro consiglio comunale.
[1] M. Ascheri, Istituzioni medioevali, Bologna 1994, pag. 209.
[2] L. Catalioto, op. cit., pag. 133.
[3] G. Iacolino, Le isole Eolie…, op.cit. pag. 205-206; G. Iacolino, La fondazione della Communitas eoliana…, op.cit. pagg. 53-55; G. Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla battaglia di Lipari del 1339 alla vigilia della “ruina” del 1544, Lipari 2007, pagg. 5-11.
[4] M.Fumagalli Beonio Brocchieri, Federico II. Ragione e fortuna, Bari, 2004.
[5] E.Kantorovicz, Federico II imperatore, Milano 2000.
[6] D. Abulafia, Federico II. Un imperatore medioevale, Torino, 1990, pag. 167.
[7] G.Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla battaglia di Lipari del 1339 alla vigilia della “ruina” del 1544, Lipari, 2007, pagg. 5-58.
[8] G. Iacolino, op.cit., pag. 14-15. G.C. Sciacca, Patti e l’amministrazione del Comune di Patti nel Medio Evo, Palermo 1907, pp.226-7.
[9] Idem, pag. 13.
[10] Idem, pag. 50.
[11] Idem, pag. 50-51; G. La Rosa, Pijrologia Topostorigrafica delle Isole Eolie, a cura di A. Adornato, Lipari 1997, Vol.II, pag. 25 e ss.
[12] F. Calasso, La legislazione statutaria dell’Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all’epoca degli statuti, Roma, 1929 (ristampa anastatica Roma 1971), pp.175 e ss.; L. Catalioto, Il medievo: economia, politica e società., in F.Mazza, Messina. Storia.cultura,economia, Soveria Mannelli, 2007, pag. 81-82.
[13] P. Corrao, Città ed élites urbane nella Sicilia del tre-quattrocento, in Revista d’Historia Medioeval, n. 9, pp 176-7.
[14] F. Titone, Istituzioni e società urbane in Sicilia, 1392-1409, Storia e società, n.105, 2004, pp469 e ss.
[15] P.Corrao, op.cit., pag. 177.
[16] F. Titone, op.cit., pag. 470.
[17] F. Vergazza, Società e giustizia nelle isole Eolie ( secc.XVI-XVIII). I processi penali della Curia Vescovile di Lipari, Soveria Mannelli, 1994, pag. 11.
[18] Idem, pp 11-12.
[19] G. Iacolino, op. cit., pag. 51.
[20] G.Iacolino, Le isole Eolie, II, op.cit., pag. 343 .(Archivio Storico Eoliano.it)
I giudici e il baiulo di Lipari
I vescovi di Lipari al tempo di Federico
I vescovi Anselmo e Giacomo Amalfitano

Papa Innocenzo III incontra una delegazione mussulmana
Il fatto che alla morte di Stefano si tardò ad eleggere il nuovo vescovo potrebbe essere dovuto alle incertezze legate al diritto di nomina conteso e discusso fra il re (o chi per lui giacchè Federico aveva ancora dodici anni) ed il Papa. Proprio nel 1206, fra marzo e dicembre, Innocenzo III fu sollecitato dal suo notaio pontificio Filippo a destinare in una sede della Calabria (Mileto o Sant’Eufemia) o della Sicilia ( la diocesi di Lipari-Patti) l’abate di San Lorenzo di Aversa, dotato di buone doti diplomatiche, per sostenere, nel regno di Federico, la politica papale; sempre in quell’anno, nel nome di Federico, si staccava dalla diocesi la Chiesa di S. Lucia del Mela col suo territorio a favore di un cappellano di corte.
 Comunque a cavallo fra il 1206 ed il 1207 i capitoli conventuali di Lipari e Patti rompono gli indugi ed eleggono abate e vescovo Anselmo, monaco benedettino che probabilmente proveniva da un convento di Catania. Dell’operato di Anselmo si conoscono poche cose fra cui un viaggio ad Augusta, in Germania, nell’aprile del 121in compagnia dell’Arcivescovo Berardo di Palermo probabilmente per incontrare Federico che, in quel tempo, vi soggiornava e probabilmente, sempre con Berardo, lo stesso anno partecipò al Concilio Laterano IV dove incontrarono San Domenico[1]. Invece, realisticamente, senza fondamento sono le voci che vogliono il vescovo Anselmo amico, oltre che ammiratore, di S. Antonio da Padova in quanto Anselmo morì fra il maggio del 1216 ed il giugno del 1219 mentre S. Antonio non venne in Italia prima del 1221[2].
Comunque a cavallo fra il 1206 ed il 1207 i capitoli conventuali di Lipari e Patti rompono gli indugi ed eleggono abate e vescovo Anselmo, monaco benedettino che probabilmente proveniva da un convento di Catania. Dell’operato di Anselmo si conoscono poche cose fra cui un viaggio ad Augusta, in Germania, nell’aprile del 121in compagnia dell’Arcivescovo Berardo di Palermo probabilmente per incontrare Federico che, in quel tempo, vi soggiornava e probabilmente, sempre con Berardo, lo stesso anno partecipò al Concilio Laterano IV dove incontrarono San Domenico[1]. Invece, realisticamente, senza fondamento sono le voci che vogliono il vescovo Anselmo amico, oltre che ammiratore, di S. Antonio da Padova in quanto Anselmo morì fra il maggio del 1216 ed il giugno del 1219 mentre S. Antonio non venne in Italia prima del 1221[2].
Ad Anselmo dovette succedere Giacomo Amalfitano meglio conosciuto come Giacomo di Capua. Divenne vescovo di Lipari-Patti fra il 1219 ed il 1221 e conservò il titolo fino al 1227 quando Onorio III lo nominò vescovo di Capua. Fu il primo vescovo della Diocesi non benedettino e probabilmente aveva precedentemente ricoperto l’incarico di notaio reale. Durante il suo episcopato Giacomo visitò Lipari forse un paio di volte e non molto più tempo dedicò a Patti visto che gli incarichi politici che Federico gli affidava lo portavano spesso in giro per il mondo lasciando la diocesi in mano ai due capitoli. Ma i suoi meriti diplomatici furono riconosciuti anche da papa Onorio che volle ascoltarlo per cercare di venire a capo del contenzioso con Federico che non transigeva sul fatto che solo a lui spettasse la scelta dei vescovi nell’ambito del suo Regno. Durante il vescovato di Giacomo si ha la fondazione a Patti del primo convento francescano che la tradizione vuole essere avvenuta fra il 1222-1223 e la attribuisce a S. Antonio da Padova[3].
A Giacomo Amalfitano seguono due presuli eletti e non consacrati probabilmente perché la loro nomina fu voluta dall’imperatore senza accordo col papa. Si tratta di Pagano, forse monaco benedettino, che governò dopo il marzo del 1227 fino a 1232 quando probabilmente morì e di Gregorio Mustaccio. Di Pagano si ricorda solo che curò con molto impegno l’integrità del patrimonio e il rispetto dei privilegi della sua chiesa tanto che nel 1229 è a Sora, nei pressi di Frosinone, dove Federico era impegnato in scontri con le truppe di papa Gregorio, e proprio lì ottiene dal re un diploma che confermava ,appunto, beni e privilegi. Gregorio Mustaccio era quel cappellano di corte a favore del quale e nel nome di Federico, nel 1206, era stato scorporata, dalla diocesi di Lipari-Patti, la Chiesa di S. Lucia. Ora Federico, alla morte di Pagano, lo nomina vescovo ma il papa si rifiuta di confermarlo e gli contrappone il suddiacono della curia romana e notaio Pandolfo, nato a Rieti, che si era impegnato in molte missioni a favore del papa ed allo stesso tempo però era anche stimato dall’imperatore. Il risultato fu che Federico accettò Pandolfo ma scorporò nuovamente S.Lucia dalla diocesi, riaffidandola a Mustaccio. Così Mustaccio sarà vescovo “eletto” di Lipari-Patti solo per il 1232-1233[4].
Pandolfo e Filippo
Pandolfo governerà la diocesi dal 1234 o 1235 fino al 22 marzo del 1246 come risulta dall’atto notarile relativo allo “spoglio”dei beni e dei crediti da lui lasciati e che venivano requisiti a favore della Camera Imperiale, e di cui parleremo fra poco. Governerà in un periodo turbolento in cui si riacutizza lo scontro fra l’imperatore ed il papa ed in cui eserciterà tutta la sua abilità diplomatica per rimanere al tempo stesso fedelissimo sia al papa che al re. Del suo impegno sul territorio possiamo arguire da quanto è detto nel verbale notarile e cioè che l’ammontare delle decime percepite dalle isole doveva essere elevato, che le isole erano quasi tutte abitate o meglio frequentate da contadini e cacciatori, che probabilmente – proprio per questo - il vescovo adottò, forse lui per la prima volta, il sistema dell’appalto per la riscossione dei tributi ricorrendo a gabellieri.[5]
 Innocenzo III
Innocenzo III
A Pandolfo successe fra il 1246 e il 1247 il vescovo Filippo che governò fino a maggio del 1255, quando la morte lo colse qualche settimana dopo che il papa Alessandro IV, che non l’aveva mai riconosciuto, aveva nominato il suo sostituto. Ad attirare su Filippo i fulmini della Santa Sede, di Innocenzo IV prima e di Alessandro IV dopo, fu l’eccessivo attaccamento di questi alla causa sveva e dell’impero – non dimentichiamo che il vescovo Filippo sarà nella delegazione dell’imperatore che trattò col papa e sarà ancora lui che celebrerà le esequie di Federico nella cattedrale di Patti - ma è certamente infondata l’accusa che, dopo morto, gli rivolse il pontefice di avere dilapidato molti beni della sua chiesa. Anzi – dai pochi documenti che sono giunti a noi relativi al suo vescovato – risulta un suo impegno costante nella difesa del patrimonio e una scrupolosa diligenza nel curare gli interessi della giustizia e dell’amministrazione. Comunque il conflitto fra Filippo e la Santa Sede portò il papa Innocenzo ad emettere il 5 gennaio del 1254 una bolla rivolta al capitolo di Patti dove, ignorando completamente la nomina di Filippo, parla di prolungata vacanza della Diocesi e notifica la nomina del domenicano Bartolomeo da Lentini, che viveva nel convento di Anagni ed era un professore. Si trattava di una nomina che non poteva avere esecuzione pratica ma serviva a segnalare che la Santa Sede non aveva dimenticato i suoi diritti sulla Sicilia. D’altronde che questo fosse il senso della bolla lo dimostrava il fatto che il 6 ottobre dello stesso anno, papa Innocenzo affida proprio a Filippo, insieme al vescovo Gregorio di Siracusa, l’incarico di intervenire in una difficile situazione diocesana. Ma sul finire sempre del 1254 a Messina e nel messinese investendo anche il territorio di Patti, esplode la ribellione contro il dispotismo e l’ambiguità della politica del conte Pietro Ruffo che porta alla creazione di una repubblica autonoma che vede in Filippo un deciso fautore. La cosa non piacque alla Santa Sede che nel gennaio del 1255 riprese in considerazione la consacrazione di Bartolomeo da Lentini che ormai da un anno era stato designato vescovo di Lipari-Patti, dall’altra chiede a Filippo di presentarsi a Roma il 21 marzo per esporre le sue ragioni. Filippo non rispettò l’appuntamento – probabilmente giudicandolo inutile - e papa Alessandro ruppe ogni indugio: il 17 aprile comunicò al popolo della diocesi di avere consacrato il nuovo vescovo in sostituzione di Filippo definito “pseudo-vescovo”. Filippo non aveva nessuna volontà di arrendersi ma penserà la sua morte a risolvere questa intricata situazione.

Tomba di Federico II nella Cattedrale di Palermo
Filippo
Il governo del Vescovo
La città di Lipari all'inizio del XIII secolo

Fra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII, probabilmente Lipari aveva raggiunto i mille abitanti. L'abitato era distinto nella Città alta (“il Castello”) e nel Borgo. Nella città alta vi erano la Cattedrale con monastero che ospitava il vescovo, la chiesa delle Grazie, ed una nuova cappella dedicata a Sant’Andrea nell’area dove ora sorge l’Addolorata e più tardi, sempre in quell’area, sorgeranno altre due chiesette dedicata una alla Madonna dell’Odigitria patrona dei viandanti e dei pellegrini e la Vergine Addolorata voluta dai militari spagnoli. Sempre al Castello si trovava anche il sistema difensivo nel quartiere detto della Verdesca e il presidio militare nel quartiere della Comandata; per il resto la cittadina consisteva in un insieme di case di cubatura limitata affastellate le une alle altre con vicoli strettissimi e tortuosi che confluivano in una strada principale che dalla Comandata andava alla Cattedrale e poi a S. Maria delle Grazie e che collegavano questa con gli spalti[1].
Fuori delle mura della città alta le abitazioni si dividevano in due nuclei: quello di Sopra la Terra che dalla chiesa di San Bartolomeo (dove ora c'è San Giuseppe), il "templum magnum" di cui parla Gregorio da Tours,si estendeva fin al vallone del Ponte e quello ai piedi della rocca sulle pendici di quello che verrà chiamato il Timparozzo. In città stava la borghesia del tempo formata da contadini fittavoli poi divenuti proprietari di estesi appezzamenti, mercanti e piccoli armatori; nel borgo i lavoratori: modesti contadini, mezzadri, braccianti, pescatori, carpentieri, bottai, tintori e artigiani d'ogni genere. E nel Borgo le strade ed i vicoli prendevano nome da questi artigiani: strada dei Bottai, vicolo dei Tintori, vicolo dei Carpentieri,ecc.

Il "templum magnum" disegnato dal Maurando nel 1544
Da Lipari si esportavano zolfo, allume, pesce in salamoia, scope di fascina, sale raccolto nel laghetto di Lingua; mentre si importavano granaglie di diverso tipo, lana, canapa grezza, legname, ferro, rame, calce e altro materiale edilizio. Il mare rappresentava una importante risorsa e non solo per la pesca o per l’impiego su imbarcazioni di passaggio, ma anche per quanto si poteva recuperare da imbarcazioni che rimanevano incagliate fra gli scogli versando al vescovo la decima del recuperato. La decima bisognava pagarla – a pena del carcere e della scomunica - anche per quanto si prendeva o catturava nelle isole che erano per lo più deserte: conigli, falconi, capre e porci selvatici, frasche, legna da ardere, ecc. Per via dei commerci si vennero a stabilire rapporti con le principali città marinare della Penisola da cui si importarono, oltre a merci ed esperienze, anche devozioni come San Nicolò da Bari, San Giovanni Battista da Genova, la Madonna dell'Arco da Napoli. Ad essi fù dedicata al Castello una cappella che oggi non esiste più. A San Nicolò e San Giovanni vennero dedicate le due marine. A Sant'Andrea patrono di Amalfi oltre che una cappella oggi inglobata nella chiesa dell'Addolorata, fu intitolato, al Castello, un quartiere.
Il vescovo fra religione e governo
Il Vescovo racchiudeva in se la duplice funzione religiosa e politica. Pontificava in Cattedrale e sul sagrato amministrava la giustizia. Era coadiuvato dai due Capitoli di Lipari e Patti che avevano la funzione oltre che di eleggere i vescovi, di amministrare la diocesi durante la vacanza della sede episcopale. Nel Capitolo il vescovo sceglieva il teologo, il cantore, il penitenziere e il tesoriere e, più tardi, l’arcidiacono e il vicario generale[2]. I Capitoli della diocesi erano conventuali cioè formati da monaci benedettini ma probabilmente, proprio alla fine del XII secolo, a fianco a questi vennero a formarsi Capitoli dei canonici regolari, cioè preti che facevano vita comune con i monaci o abitavano in un fabbricato vicino, condividendo le pratiche religiose. Una forma di transizione che non durò molto ma che aprì la strada all’istituzione capitolare non più conventuale che affiancò il vescovo e che rimase in funzione fino ai giorni nostri.
Intanto la Santa Sede cominciò ad esercitare un più stretto controllo sulle diocesi a cominciare dall’elezione del vescovo. La rivendicazione di un diritto che non fu facile imporre perché si era creata nei territori una situazione di interferenza e di contrasti fra centri di potere diversi. E probabilmente proprio a questi contrasti si deve la vacanza – non si sa quanto lunga – che travagliò la dicesi di Lipari-Patti alla morte di Stefano[3].
Le marine S.Nicolò e S.Giovanni
Il vescovo Stefano e la fine della dinastia dei normanni.

Matrimonio di Enrico VI con Costanza d'Altavilla
Il vescovo Stefano
Chi era Stefano? Un monaco benedettino senza dubbio ma che forse aveva avuto in passato esperienze di corte e quindi una buona scuola di diplomazia. Potrebbe essere infatti lui quello Stefanus cappellanus domini regis di cui parla Evelyn Jamisn[1]. Comunque l’impegno di Stefano fu quello di “mantenere ed accrescere il patrimonio rurale della Chiesa e, in modo particolare, a definire la sua capacità di azione politica in un contesto caratterizzato da precari equilibri di potere, nel tramonto della dinastia normanna e nella temperie dell’affermazione sveva”[2]. Così in diverse occasioni il vescovo aveva avuto modo di confermare la convergenza della sua Chiesa con gli orientamenti della monarchia e a dimostrare abilità diplomatica come nel caso dell’incarico dato a Riccardo Goito nel gennaio del 1186, cancelliere e segretario di Guglielmo II, a proposito di un possedimento alle porte di Palermo, di recuperare i diritti perduti, ricondurre all’obbedienza i villani che avevano abbandonato le terre, incrementare la proprietà e mantenere alta la produzione. In più, si stabiliva, che alla sua morte “ tutto ciò che egli avrà edificato, piantato, seminato e migliorato nelle terre della stessa Chiesa, tutto per intero rientrerà in potere della stessa Chiesa”[3].
Secondo Catalioto[4], lo spessore politico di questo vescovo ed i suoi rapporti con la organi regi sarebbero dimostrati, fin dal suo insediamento, a cominciare dal primo atto di cui si ha notizia, nel dicembre del 1180[5], e cioè la disputa con l’arcivescovo di Messina per alcuni diritti di decima. Nella quale oltre ad avere confermati dei diritti che erano più consistenti di quelle di altre chiese, ottenne il riconoscimento di una nutrita serie di prerogative[6]. In questa luce deve essere anche letto l’affitto nel 1194 concesso ad un influente personaggio di corte di una casa in Termini[7]. Una prerogativa quella di saper dialogare con la corte che non venne meno con la caduta della dinastia normanna ma continuò con la dinastia sveva fin dal suo insediamento.
Federico I (o II)
 Nascita di Federico a Jesi
Nascita di Federico a Jesi
Abbiamo visto che nel dicembre del 1194 Enrico VI occupava Palermo e si incornava re di Sicilia, ma già ai primi del 1195 doveva correre in Germania per sedare insubordinazioni e così lasciava il regno nelle mani della moglie Costanza, figlia del normanno Ruggero II, assistita dal gran cancelliere Gualtiero di Pagliara, vescovo di Troja diocesi della Puglia. L’anno dopo proclamò il figlioletto Federico Re dei Romani irritando il Papa che lo scomunicò. Nel 1197 il re scoprì o credette di avere scoperto una grande congiura ai suoi danni e diede sfogo ad una violenta ferocia contro i nobili uccidendone ed accecandone a centinaia. La repressione cessò solo nel mese di novembre di quello stesso anno quando Enrico morì a Messina. L’anno dopo il papa, supplicato dalla regina Costanza, incorona re di Sicilia il figlio di lei, col nome di Federico I, che non aveva ancora 4 anni. Alla morte della mamma, qualche mese dopo, il papa prese sotto la sua tutela il bambino, inviando il cardinale Cencio Savelli a curarne l’ educazione e creando una corte di gestori del regno con a capo Gualtiero di Pagliara. Seguirono anni burrascosi e difficili per il piccolo re ed il suo regno insidiato, fra gli altri, dal barone Marcovaldo di Anweiter che morì a Patti nel 1202 dopo aver giocato una complicata partita di alleanze e tradimenti con Gualtiero di Pagliara.
Il Vescovo Stefano, dopo la grande rivolta del 1197, nel mese di luglio è testimone a Linara presso Patti in un documento di Enrico VI ed in quella occasione gli assicura fedeltà[8]. Un altro documento di un certo rilievo è del novembre del 1200. Sono anni difficili e Gualtiero di Pagliara cerca di rastrellare fondi per far fronte al governo ed alla guerriglia. E’ in questa occasione che Stefano versa 17 mila tarì e Gualtiero gliene è così grato che gli fa indirizzare una lettera dal piccolo re Federico in cui si dice che “il Vescovo di Patti, a Noi fedele, in un momento di emergenza con molta liberalità offrì 17.000 tarì al nostro diletto e fedele consigliere e cancelliere Gualtiero ai fini della preparazione dei Nostri armamenti”[9]. Per questo servigio il re concede l’altra metà della terra di Naso che era tornata di proprietà della corona perché il proprietario era stato riconosciuto traditore.
Il documento viene rilasciato però nel 1201, l’anno successivo, quando Gualtiero fa l’accordo con Marcovaldo contro il volere del papa. Significa che Stefano condivise questa scelta malgrado l’ostilità del papa? Così sembrerebbe e per questo si può pensare che quando, l’anno dopo, Marcovaldo morì a Patti in seguito ad un’operazione chirurgica, al suo capezzale ci fossero Stefano e i suoi monaci[10].
 Federico
Federico
Dai documenti rimasti riguardo al suo vescovato si possono arguire altri tratti della personalità e del modo di operare di Stefano. Come il fatto che fosse un vescovo che viaggiasse molto, che andava spesso a Palermo – ed è per questo che nel documento a Riccardo Goito del 1186 rivendica i diritto dell’ospitalità per se ed il suo seguito nel possedimento alle porte di Palermo che aveva in affido[11] - ma soprattutto che visitava i diversi luoghi della Diocesi e i possedimenti più remoti.
La presenza di Stefano a Lipari
Doveva venire spesso anche a Lipari ma i documenti segnalano solo le visite ufficiali di governo non quelle di ordine spirituale e pastorale. Relativamente a Lipari ed alle Eolie sono due le notizie che ci sono state tramandate. Nel marzo del 1190 si sa di una seduta giudiziaria in cui il vescovo processò e condanno dei razziatori di falconi ed emanò delle norme sulla gabella dei conigli e la disciplina della caccia, per combattere l’evasione fiscale ai danni della Mensa vescovile. Vengono comminate anche pene come il carcere e l’esilio. Il documento è interessante perché conferma la presenza nell’isola di uno stratigoto, cioè un giudice con giurisdizione criminale, e di un certo numero di boni homines incaricati di avanzare richieste di natura amministrativa verso la corte di giustizia del vescovo. Ed a questo proposito va ricordato un altro documento, del settembre 1191, nel quale ambaxatores civitatis, dotati di rilevanti prerogative, rappresentarono gli abitanti di Patti, davanti al re Tancredi, in una contesa col vescovo relativa a terreni di Librizzi acquisiti dalla Chiesa fin dal 1117.[12]
La seconda notizia ha come fonte il Campis[13]. Essa ci parla di un conflitto fra il vescovo Stefano ed una parte dei cittadini di Lipari nel 1199 che protestavano per gli effetti del precetto del vescovo Giovanni di 65 anni prima. Questo conflitto ha una prima conclusione: i cittadini riescono a piegare il Vescovo alla cessione gratuita e perpetua dei poderi di Alicudi e di Salina. Un successo che si ritorse però contro gli stessi perché “quel Dio che custodisce con gloria le ragione delle Chiese e ai violatori di esse fa sempre provare castighi – commenta il Campis – non volle che li usurpatore delle due Isole ne andassero impuniti, e così rendè sterili quei terreni, per altro fertili e ubertosi, del tutto aridi e sterili. Onde in due anni che da quelli Cittadini furono coltivati non produssero alcun frutto; anzi invece di grano, quale vi seminavano, cresceva in copia grande erbe selvatiche et inutili senza vedersi una spica di grano, e l'Isola stessa di Lipari non ebbe per un anno né pure un'occiola d'acqua dal cielo”. I contestatori allora pentitesi si buttarono ai piedi del prelato e con una supplica scritta gli chiesero perdono e rimisero nel suo possesso le due isole usurpate che apportarono quindi abbondantissimi frutti.
I documenti ci parlano ancora di uno Stefano scrupoloso nelle pratiche amministrative. Siccome esistevano due Capitoli monastici, uno a Lipari e l’altro a Patti, Stefano prima di prendere decisioni di una certa importanza li interpellava entrambi come nel 1198 quando vuole assegnare ad un confratello una casa di proprietà della Chiesa[14].
Infine White sostiene che in Stefano vi era lo stesso spirito litigioso che aveva riscontrato in Giovanni da Pergana[15]. Addirittura “cronico” quello coll’arcivescovo di Messina tanto che il 9 febbraio del 1183 Papa Lucio III scrisse da Velletri ai Vescovi di patti e Cefalù raccomandando devozione ed obbedienza verso il vescovo metropolitano. Richiesta che dovette cadere nel vuoto visto che la sollecitazione fu ripetuta il 25 luglio 1184-85 da Verona[16].
Probabilmente Stefano rimase vescovo e abate fino al 1201 anche se sembra vivesse fino al 1205. Gli successe Anselmo che però non compare fine al 1207[17].
[1] E. Jamisson, Judex Tarentinus, in “Proceeding of the Britich Academy”.LIII (1968), pp. 331 e seguenti, n. 2 citato in E. Catalioto, op. cit., pag. 126.
[2] E. Catalioto, op.cit. pag. 126.
[3] G. Iacolino, op.cit. , pag. 191-192. Testo originale in latino in E. Catilioto, op.cit., pp. 232-3, L.T. White, pag. 432.
[4] E. Catalioto, op. cit., pag.127
[5] Secondo Iacolino, op.cit. pag. 190 indica il 1179.
[6] E. Catalioto, op.cit. pag. 127.
[7] G.Iacolino, op.cit., pag. 192; E. Catalioto, op.cit., pag. 127-8.
[8] E. Catalioto, op.cit. ,pag. 128-9; G. Iacolino, op.cit., pag. 197.
[9] G: Iacolino, op.cit., pag. 197-8; E. Catalioto, op.cit., pag. 129.
[10] G. Iacolino, op.cit., pag. 198; E. Catalioto, op.cit., pag. 129.
[11] G. Iacolino op.cit., pag. 192.
[12] Idem, pp. 134-5.
[13] P. Campis, Disegno Historico…, op.cit., pag. 224. G. Iacolino, op.cit.,pp 193-4.
[14] G. Iacolino, op.cit., pag. 195
[15] L.T.White, op.cit., pag . 154 “Lo spirito dell’abate Giovanni era dappertutto nei suoi monasteri”.
[16] Idem, pag. 153.
[17] Idem., pag. 153. E. Catalioto, op.cit., pag. 125 vedi la nota n .34 con riferimenti bibliografici relativi a Stefano.(Archivio Storico Eoliano.it)
Gualtiero di PagliaraIl Vescovato di Lipari-Patti dopo Giovanni
La crisi del regno normanno


Morto Giovanni la Chiesa di Lipari-Patti cadde in un clima di provvisorietà e di incertezza. D'altronde il regno normanno entrò in quegli anni in una lunga fase di crisi che lo portò alla sua dissoluzione. Ancora vivente Ruggero II il regno fu caratterizzato da un “cupo clima che ne oscurò le ultime fasi”[1] sia a causa dei gravi insuccessi sul piano internazionale sia per la crescita di protagonismo dei signori feudali che fino ad allora il re aveva autorevolmente controllato. Ma fu soprattutto alla sua morte - e l’avvento al trono del figlio Guglielmo I - che le cose precipitarono e si aprirono momenti di grave tensione e persino di scontro aperto con il papato che si protrassero per oltre dieci anni e si sanarono solo nel 1166 alla vigilia della morte del re. A Guglielmo I subentrò il figlioletto tredicenne Guglielmo II sotto la reggenza della madre Margherita di Navarra, che dovette fronteggiare da una parte l’insofferenza crescente del baronato e dall’altra le difficoltà finanziarie dello Stato.[2] Divenuto re nel 1172 Guglielmo II riuscì a garantire un periodo di relativa stabilità e tranquillità. Alla sua morte ripresero le tensioni e gli scontri. Non avendo discendenti gli successe – creando problemi e andando contro alle aspettative della zia Costanza, figlia di Ruggero II, moglie di Enrico VI figlio dell’imperatore Federico Barbarossa - il

A destra, Guglielo II che si fa ritrarre come Ruggero II incoronato da Cristo.
cugino Tancredi che governò meno di cinque anni. Alla sua morte venne nominato re il figlio Guglielmo III di soli 9 anni sotto la reggenza della madre Sibilla ma dopo pochi mesi, nel dicembre del 1198, l’imperatore Enrico VI occupava Palermo, si incoronava anche re di Sicilia e metteva fine alla dinastia dei normanni.


A sinistra, Margherita di Navarra. A destra, la morte di Guglielmo II
Non meraviglia quindi, dopo il governo di Giovanni, che i rapporti tra la monarchia e il vescovato sembrino – osserva Catalioto - quasi congelati[3] e tutta la vita dell’abazia è come caduta in un immobilismo amministrativo riflesso sicuramente delle tensioni fra il re ed il papato. Essa rimase senza abate per quattro anni, fino a quando nel 1952 venne scelto il diacono Alessandro, sopravvissuto pochi mesi alla nomina. Dopo di lui venne nominato il monaco Osberno che rimase in carica dal 1153 al 1155 quindi fu la volta di Gilberto[4] nominato nel 1156 . E’ solo con la nomina di Gilberto che il vescovato ed i rapporti con gli Altavilla sembrano ritrovare un equilibrio. E se nelle carte capitolari Giovanni da Pergana, Alessandro , Osberno e lo stesso Gilberto fino al 1164 non furono mai menzionati come episcopi, ma sempre col precario titolo di electi, proprio nel 1164[5]Alessandro III dispone la definitiva legittima elevazione vescovile dei monasteri di Lipari e Patti[6].
La nomina di Gilberto
Ma l’equilibrio ritrovato con Gilberto non significa sviluppo e trascurabili furono gli interventi che incisero sul patrimonio e le prerogative episcopali. Il presule seguì l’impegno di Giovanni nel recupero dei beni del vescovato e nella salvaguardia dei propri diritti in un quadro di staticità economica e di gestione tendenzialmente conservatrice dovuta anche al fatto che era finita l’epoca delle importanti donazioni dei signori alla Chiesa.[7] . Il vescovato appare come chiuso in se stesso, tenendosi lontano dalle vicende politiche e soprattutto dallo scontro che si andava acuendo in seno al baronato. Comunque nelle rivolte che maturano nella nobiltà contro la curia reale, in particolare quelle fra il 1159 ed il 1161, i presuli siciliani si mossero sempre a tutela di Guglielmo contro il suo rovesciamento[8]. E questa fu la linea anche del Vescovato di Lipari-Patti - che sempre più andava emergendo come vescovato di Patti tout court – che anzi manifestava, nelle poche carte rimaste, una condizione di ossequiosa sudditanza del vescovo Gilberto nei confronti del sovrano[9]. E se il re asseconda i sentimenti antimussulmani che emersero nella rivolta così Gilberto, nell’ottobre del 1164[10], motiva la vendita di una casa di Palermo perché ubicata in un quartiere “indecente ed immorale”. “Nel quartiere della porta di Sant’Agata, evidentemente, vi era – osserva Catalioto – una significativa presenza di musulmani, come tende a confermare l’identificazione, a parte orientis, di una contigua domus saracene, e questo avrà fornito a Gilberto l’occasione per dichiarare il luogo indecoroso e disonesto, sull’onda peraltro del diffuso orientamento antimusulmano che in quegli anni continuava a crescere in tutta l’isola”[11]. Lo scontro etnico serve anche a distogliere le tensioni da altri obiettivi come il conflitto nobiltà- regno o aristocrazia terriera-signorie ecclesiastiche.
Dopo Gilberto fu la volta del vescovo Pietro (1171-1174)[12] sotto il cui priorato avvengono alcune donazioni a favore della Chiesa di Lipari-Patti, quindi fra il 1176 e il 1177 abbiamo il vescovato di Dalferio[13]. E’ del vescovato di Dalferio conosciamo due episodi. Nell’agosto del 1176, un certo Bartolomeo, prete, proveniente da Genova, decide di dare i suoi beni ed offrire i suoi servigi alla Chiesa di Lipari-Patti giacchè “io voglio per sempre e in tutto restar fedele, subordinato e obbediente a voi e alla vostra Chiesa, come a voi mi sono donato interamente, per così dire, e da vivo e da morto, così le cose che ho sopra nominato [una vigna e due buoi] siano di vostra proprietà e della vostra stessa chiesa in perpetuo: E se il Signore in avvenire mi farà guadagnare altro, tutto sarà vostro, come di sopra ho affermato”[14]. Nel novembre del 1177 Dalferio riuscì ad ottenere per il monastero un privilegio di esenzione, in perpetuum et omni tempore, dell’obbligo di fornire annualmente venti operai ed il legname necessario al mantenimento della flotta regia.[15]
Di Dalferio non si sa più niente dopo il 17 dicembre del 1177 che dovrebbe essere la data della sua morte[16]. Dopo di lui ci fu un amministratore temporaneo con la qualifica di priore di nome Bono[17] quindi nel dicembre del 1179 assumeva la direzione del vescovato il benedettino Stefano II[18].
[1] E, Catalioto, op.cit. , pag. 107.
[2] G.Iacolino, op.cit., pag. 158-160.
[3] E.Catalioto, op.cit., pag. 113-4.
[4] Mentre Iacolino indica la data del 1154 o 1155 (op.cit., pag 161) per questa nomina , secondo Catalioto il monaco Gilbertus è alla guida della sede con il titolo di venerabilis electus Pactensis monasterii nel settembre 1156 sebbene Adriano IV non ne avesse regolarizzato la nomina nel dicembre 1157, né la consacrazione sarebbe giunta ancora nell'ottobre 1164 “ quando Gillibertus, Dei gratia humilis Lipparensis et Pactensis Ecclesie electus, vendeva una casa posseduta dal monastero a Palermo e sul soglio pontificio sedeva da cinque anni Alessandro III.
[5] E.Catalioto, op.cit., pag.110. La successione degli abati è fornita da E.Catalioto in op.cit. pagg, 111-112 ed è tratta dal Libro Maestro dell’Archivio Capitolare di Patti, fogli 1-4. “Il termine electus – chiarisce White - indica che Lipari-Patti fu ancora considerata come vescovato” cioè – spiega Iacolino – il vescovo veniva eletto dal capitolo congiunto dei due monasteri, ma Roma non ratificava né autorizzava l’ordinazione o consacrazione dell’eletto.(op. cit. pag. 161). G.Iacolino, op.cit., pag.163-4. Di Gilberto si perdono le tracce, osserva Iacolino, dopo l’ottobre del 1164 mentre di Pietro abbiamo la prima notizia solo nel 1171.
[6] Dal momento che (…) nel 1166 era prossima l'ordinazione da parte dell'arcivescovo messinese di unum Episcopum in Caphaluth, aliam vero in Lippari et Pactem ed il primo rettore della Chiesa pattese ad essere nuovamente indicato come venerabilis episcopus sarebbe stato il monaco Pietro, in una donazione vergata a Patti nel 1171”.(op.cit., pagg. 89-90).
[7] E. Catalioto, op.cit. , pag.114.
[8] E. Catalioto, op.cit., pag.117;
[9] idem, pag.116.
[10] G.Iacolino, op.cit., pag.162-3; E. Catalioto , op.cit., pagg. 118-9.
[11] E.Catalioto, op.cit., pag. 119.
[12] E.Catalioto, op.cit. pag. 119. Nella nota n.18 si dice: “Nell’elenco manoscritto del 1664, conservato presso l’Archivio capitolare, Petrus ex Monacho Episcopus è indicato alla guida del vescovato tra il 1171 ed il 1174.” (ACP, Libro Maestro, f.1). G. Iacolino, op.cit. , pagg. 164-165.
[13] E. Catalioto, op.cit., pag. 124. Nell’elenco manoscritto del Libro Maestro Dauferius, seu Dalferius, ex Monacho Episcopus è indicato come settimo rettore di San Bartolomeo.
[14] G.Iacolino, op.cit., pag. 166.
[15] G.Iacolino, op.cit.,pagg. 166-7; E. Catalioto, op.cit., pag. 124.
[16] E.Catalioto cita il Kamp che sposta la data al 15 Novembre 1178.
[17] E. Catalioto, op.cit., pag. 125 “ dominus Bonus humilis Pacti” così viene definito il priore in un documento dl settembre 1179; G.Iacolino, op.cit., pag. 189.
[18] G.Iacolino, op.cit, pag. 189 e ss.; E.Catalioto, op.cit.,pag, 125 e ss.(Archivio Storico Eoliano.it)
Giovanni da Pergana, abate e vescovo
Giovanni e Ruggero II

Ruggero II riceve la corona di Re di Sicilia dal Cristo. Chiesa della Martorana , Palermo.
Ad Ambrogio, come abate successe Giovanni. La specifica “da Pergana” compare solo in un documento del 1134 in lingua greca e White sostiene che questo riferimento significa che egli era di Bergamo, lombardo quindi come lombardo doveva essere Ambrogio.
Del profilo caratteriale di questo abate ne abbiamo due versioni diverse e contrapposte. Secondo White “era orgoglioso e sempre pronto ad attaccar briga. In verità pare che fosse una di quelle strane persone che si divertono a litigare[1]”. Secondo Iacolino[2] invece era “di temperamento tranquillo nei primi anni, amministratore scrupoloso dei beni dei suoi monasteri. Poi, a datare dal 1130, la sua personalità si dà a manifestazioni di risentimento e di puntigliosa insofferenza. Ad ogni modo, a renderlo di temperamento così risoluto e diffidente o, se più aggrada, litigioso, di certo contribuirono la torbidezza dei tempi, le incertezze e le lacerazioni dei massimi vertici istituzionali – il Papato e l'Impero – e non ultimo, il comportamento astuto e spavaldo dello stesso secondo conte e primo re di Sicilia”.
 Papa Onorio II
Papa Onorio II
Giovanni era abate da qualche anno quando la situazione politica e religiosa si andò ingarbugliando forse al di là della piena comprensione che si poteva avere da Lipari o da Patti. Raggiunta la maggiore età Ruggero II si dichiarò duca dell'Italia Meridionale. Non si curò delle proteste di papa Onorio II che era salito al soglio pontificio nel 1124 ma lo affrontò e lo sconfisse in battaglia nel 1128 persuadendolo a donargli l'investitura a pieno titolo. Morto Onorio nel 1130 i cardinali si divisero in due fazioni: gli uni eleggono Innocenzo II, gli altri Anacleto II. Anacleto era l'antipapa ed ebbe fra i suoi pochi sostenitori Ruggero II che ottenne come contropartita la nomina a re di Sicilia e l'incoronazione avvenne il 25 dicembre del 1130. Ruggero – sulla cui posizione il clero siciliano si allineava compatto[3] - manifestò subito l'intenzione di costituire in Sicilia una sorta di Chiesa “nazionale” facendo concedere all'arcivescovo di Palermo la facoltà di consacrare vescovi estromettendo la Santa Sede. In questo disegno rientrò anche la rifondazione della Diocesi di Lipari che si chiamò di Lipari -Patti, con bolla di Anacleto II del 14 settembre 1131[4] e vescovo venne nominato l'abate Giovanni.
L'antipapa fa Giovanni vescovo
“Ben si sa – si legge nella bolla – che il Monastero di Lipari è stato sino ad ora uno dei più grandi monasteri di Sicilia e che dipende dall'autorità della Chiesa Romana. Crescendo ora la gloria del Nostro prestigioso figlio Ruggero re, gloria che la liberalità delle sede Apostolica ha a lui attribuito e ai suoi figli, ci è parso assai degno e giusto che pure lo stato della medesima Chiesa venga anche nel Nostro tempo, accresciuto. Pertanto, col consiglio dei Nostri fratelli Vescovi e Cardinali, abbiamo deliberato e , col presente decreto, stabilito che il predetto Cenobio Liparitano detenga d'ora in avanti la dignità vescovile e si abbia un proprio vescovo il quale riceva il sacramento della consacrazione per le mani del venerabile nostro fratello Arcivescovo di Messina, e che tanto lo stesso Vescovo quanto i suoi successori debbano in perpetuo star soggetti alla Chiesa Messinese come a propria Chiesa Metropolitana, fatte salve tuttavia le concessioni e i privilegi della Chiesa Romana elargiti al glorioso Nostro figlio Ruggero e ai suoi eredi”.
 L'antipapa Anacleto
L'antipapa Anacleto
Così Lipari passa da terra a Città, Civitas Episcopalis. La popolazione era in continuo aumento e la superficie urbana andava espandendosi oltre il perimetro del Castello lungo la scarpata del Timparozzo e più densamente su quel costone roccioso che si alza tra Marina Corta e Portinente che prese il nome di terra anzi Sopra la Terra.
Fu proprio forse per questa crescita notevole[5] che il Vescovo Giovanni il 4 marzo del 1133 emise un praeceptum che drasticamente ridimensionava le agevolazioni che erano state stabilite da Ambrogio nel Constitutum del 1095.
La revisione del "constitutum"
In questa nuova ordinanza[6] si stabiliva:
“A nessun uomo venga assegnata la terra in perpetuo né se ne conceda il possesso con diritto a lasciarla in eredità, ma solo a tempo determinato. Precisamente: fino a che uno con fedeltà e sottomissione presta il suo servizio alla Chiesa, a costui si consenta l'uso della terra che gli è stata assegnata, e ne abbia il godimento.
Qualora poi per un moto di superbia o di rivolta si opporrà alla Chiesa o le resisterà, oppure se al Vescovo o ai monaci della Chiesa non sarà di gradimento che costui tenga la terra, gli sia tolta la terra e venga restituita alla Chiesa.
Se qualcuno di questi uomini, che hanno avuto la terra a tali condizioni, vorrà allontanarsi da tale paese, non avrà facoltà né di vendere né di pignorare la stessa terra, né potrà lasciarla in eredità al figlio ma alla Chiesa che ne è l'originaria detentrice. E, se il figlio di costui sarà fedele e sottomesso al Vescovo e alla Chiesa, a lui si darà in affidamento la medesima terra alle identiche condizioni con le quali l'ha tenuta il padre suo, e ciò, tuttavia, se piacerà al Vescovo e alla comunità del Monastero.
A quelli, infine, che dal tempo della venerata memoria del nostro predecessore Signore Abate Ambrogio possiedono la terra per sua donazione e concessione, e anche a coloro che tengono terra per mia donazione e concessione con rescritto recante il sigillo, concedo e confermo che tengano la terra secondo le favorevoli condizioni stabilite dal medesimo padre Ambrogio”.
"Litigioso" per difendere i beni del monastero?
Con ogni probabilità i patti che seguirono questa ordinanza furono gravati non solo dal consueto versamento delle decime ma anche dal canone di affitto che si chiamò censo. Forse il giudizio di “litigioso” al vescovo Giovanni è stato attribuito anche perchè diede vita a numerose cause contro signori di pochi scrupoli che cercavano di approfittarsi di beni del Monastero. Nel 1130, quando era ancora abate, entrò in causa con l'arcivescovo di Palermo dinnanzi alla corte di Ruggero, per un contenzioso sulle decime di Termini e la vertenza si concluse con la ripartizione fra i due delle decime in egual misura e l'attribuzione a Giovanni di due chiese a Termini e Vicari. Nel 1133 dovette fronteggiare a Messina, sempre di fronte al re, la protesta di un grandissimo numero di possessori di terreni che si lamentavano per gravosi oneri e divieti che il vescovo imponeva al di là di quanto prevedesse il Constitutum di Ambrogio. Secondo Iacolino[7] l'esito della controversia fu sostanziamente favorevole a Giovanni ma Catalioto[8] osserva che il vescovo fu costretto a cedere dinnanzi alle rivendicazioni dei cittadini, riconoscendo il loro diritto all'uso dei boschi comuni come pascolo e libera riserva di ghiande salvo la quarta parte dovuta al vescovo e di legna da ardere. Lo stesso Iacolino constata che la corte regia condonò agli imputati metà della somma delle ammende comminate dai tribunali vescovili di Lipari e Patti perchè giudicate particolarmente pesanti.[9]. Comunque la sentenza mentre accoglie le istanze dei pattesi tende a confermare l'esistenza di una soggezione di tipo vassallatico degli abitanti di Patti nei confronti del loro vescovo[10].
Lo scontro fra il vescovo Giovanni e Gualtiero di Garres, signore di Naso, del febbraio 1134 rivela come a fianco alla signoria ecclesiastica stesse emergendo un potere baronale delineando così un sistema politico che rispondeva pienamente all'essenza del feudalesimo[11]. La contesa riguardava i diritti dei monaci sul monastero di Naso che Giovanni riteneva infranti. Comunque un accordo venne raggiunto e confermato dallo stesso Ruggero. Ma il re dovette rimanere particolarmente irritato della litigiosità del monaco, perchè nel documento[12] di conferma dell'accordo viene rivolto un monito esplicito a Giovanni: “Ove mai si venga a sapere che il detto Signore Giovanni Vescovo voglia violare quelle cose che di buono accordo e col di lui assenso sono state concesse e i patti stipulati innanzi alla nostra Potenza, non gli si conceda udienza, ma venga punito con l'iscrizione nel registro fiscale affidato alla nostra Potenza per una libra d'oro, cioè per settantadue monete”.
La Platea dei beni della diocesi
 Comunque questo episodio non incrinò i rapporti fra il vescovo di Lipari ed il re se un paio di mesi dopo, il 28 aprile 1135, Giovanni chiese ed ottenne da Ruggero un privilegio di basilare importanza che confermava il possesso di una lunga serie di beni e diritti a cominciare dall'intero arcipelago eoliano.[13] . Questo scrupolo di Giovanni a mettere in chiaro i diritti ed i beni del vescovato di Lipari-Patti lo portò, tra il 1131 e 1148, a far trascrivere il testo della Platea antiqua bonorum Ecclesiae Pactensis (Inventario dei beni antichi della Chiesa di Patti). La Platea è in linea con il privilegio del 1135 e il contenuto dei due atti fornisce “un completo e dettagliato prospetto dei beni e dei diritti posseduti e comunque rivendicati ab antiquo dal vescovato di Lipari-Patti alla metà del XII secolo, negli anni in cui il regno di Ruggero II raggiungeva l'acme della potenza in campo internazionale”[14]:
Comunque questo episodio non incrinò i rapporti fra il vescovo di Lipari ed il re se un paio di mesi dopo, il 28 aprile 1135, Giovanni chiese ed ottenne da Ruggero un privilegio di basilare importanza che confermava il possesso di una lunga serie di beni e diritti a cominciare dall'intero arcipelago eoliano.[13] . Questo scrupolo di Giovanni a mettere in chiaro i diritti ed i beni del vescovato di Lipari-Patti lo portò, tra il 1131 e 1148, a far trascrivere il testo della Platea antiqua bonorum Ecclesiae Pactensis (Inventario dei beni antichi della Chiesa di Patti). La Platea è in linea con il privilegio del 1135 e il contenuto dei due atti fornisce “un completo e dettagliato prospetto dei beni e dei diritti posseduti e comunque rivendicati ab antiquo dal vescovato di Lipari-Patti alla metà del XII secolo, negli anni in cui il regno di Ruggero II raggiungeva l'acme della potenza in campo internazionale”[14]:
Per quanto riguarda le Eolie nella Platea si legge come le “aride isole dell'arcipelago eoliano fossero oggetto di particolari cure per la messa a cultura, che si mantenne sempre a livelli appena accettabili, e per lo sfruttamento di specifiche risorse, che nel lungo periodo avrebbero acquisito risalto sotto il profilo economico. Così Vulcano, ricca peraltro di zolfo, forniva allume assieme a Panarea, ed a Salina si raccoglieva il sale, la cui richiesta aumentava per la crescita delle tonnare di Oliveri e Roccabianca. In tutte le isole erano comunque attive colture intensive e veniva praticata la caccia del coniglio e, soprattutto ad Alicudi, anche a porci e capre selvatiche”[15]. Sempre nella Platea si dice che il vescovo deteneva il potere giudiziario a Lipari e Patti, nei casali di Zappardino e Librizzi e nella tenuta di Fitalia, cioè nei territori in cui si concentrava la maggior parte dei possedimenti terrieri e i diritti di natura signorile[16].
L'”avvertimento” del febbraio 1134 non fermò Giovanni nemmeno dal portare dinnanzi al re altre dispute come quella del 1135 contro l'abate Soibrando di Gerusalemme e Falcone priore di Agira in ordine al monastero di San Filippo d'Agira[17] fino all'ultima, risalente al febbraio 1148 pochi mesi prima di morire, contro Arnaldo, vescovo eletto di Messina, in ordine a certi diritti su alcune città del litorale settentrionale della Diocesi che erano stati conferiti dal presule messinese del tempo ad Ambrogio. Giovanni probabilmente interpretò estensivamente i benefici di cui era titolare e Arnaldo lo chiamò in giudizio di fronte a Ruggero. “La vecchia ostilità del Re – afferma White – verso il vescovo intrigante si riaccese: egli annullò e fece a pezzi la donazione del vescovo Roberto su cui Giovanni aveva basato le sue eccessive pretese e compose la lite sui diritti delle due chiese senza concedere appello”[18]. Iacolino tende a minimizzare il fatto e non crede ad un gesto rabbioso del re che fa a pezzi la pergamena della concessione. A suo avviso il termine ruptum che White traduce “fatto a pezzi”, starebbe invece per “annullato”, “invalidato”. Il re annullò il vecchio privilegio ed al suo posto emise una nuova convenzione. Comunque il giudizio non fu favorevole a Giovanni perché ne ridimensionò le pretese.
L'esenzione per i beni della Mensa vescovile
Ma Giovanni non si mosse solo per dispute e contenziosi. Si interessò anche della attività produttiva del suo territorio e delle risorse del monastero. I prodotti della campagna di Lipari non erano certo bastevoli alle esigenze della comunità. I prodotti della vigna, i legumi, il piccolo armento bastavano a malapena per il consumo interno mentre grano, grassi animali e latticini dovevano importarli dall’esterno, soprattutto dalle terre che il monastero aveva in Sicilia e Calabria. Su questi beni, quando venivano esportati, spesso scattavano le imposte doganali. Giovanni si recò da Ruggero, nel gennaio1134, per chiedere che fossero esentate almeno le merci e le derrate destinate al sostentamento della comunità monastica e del vescovo stesso. Ed il re acconsente ed ordina a tutti i guardiacoste della Sicilia e agli altri ufficiali “che sia consentito a che le imbarcazioni del Vescovato di Patti e Lipari carichino il grano prodotto dagli stessi Monasteri del medesimo Vescovato e quel grano ad essi donato o offerto per amore di Dio; e non solo, ma anche il burro e il formaggio nello stesso modo senza alcun impedimento, danno e molestia da parte dei nostri esattori” a condizione però che non vengano commerciati[19].
Ma oltre che per i contenziosi, lo scrupolo e una rigida severità nell'esercizio del suo ruolo di abate e di feudatario, Giovanni va ricordato anche tutta una serie di opere importanti realizzate a Lipari come l'edificazione di un ospedale la cui esistenza è documentata fin dal febbraio 1142[20], l'ampliamento della chiesa abaziale, la ristrutturazione del Monastero, il chiostro interno con gli ambulacri e le belle volte a crociera poggianti su archi sorretti da colonne di pietra. Quasi tutto materiale di età ellenistica e bizantina recuperato e riutilizzato[21].

Nuove immigrazioni e nuovi toponimi

Probabilmente negli anni di Giovanni, e con maggiore intensità a cominciare dal 1131, nelle isole giunsero gruppi di persone provenienti da diverse parti dell’Italia (Pisa, Firenze, Genova, Venezia, Amalfi, Salerno, Puglia) trovando qui accoglienza e lavoro, connotando con la loro provenienza contrade, quartieri, famiglie. Potrebbe nascere in questo tempo il toponimo di Varisana indicando dei pugliesi che vi importarono vitigni baresani, come quello di Malfa da famiglie scappate da Amalfi a seguito dei saccheggi del 1135-1136, oppure cognomi come Veneziano, Fiorentino, Malfitano ecc.[22] . In quegli anni Iacolino calcola che l’isola contasse circa 750 abitanti di cui 500 nella città alta e gli altri distribuiti nelle campagne. Forse è in quegli anni che viene ripristinata e rafforzata la cinta muraria e sugli spalti del castello che guardano a mare, vengono innalzate tre torri che si aggiungono alle altre due preesistenti ed anch’esse restaurate: quella quadrata che presidiava l’acceso e quella di Medina lasciata dagli arabi. Saranno queste tre torri – oggi scomparse - che assieme al Castello entreranno a far parte dello stemma cittadino.

Chiesa dell'Annunziata anni '30
Una esistenza frugale e tutto sommato tranquilla quella che si conduceva in quegli anni nell’isola mentre la vita degli abitanti si snodava intono al Monastero ed alla Cattedrale. Il Monastero con il tocco regolare della sua campana scandiva il ritmo della vita anche per i laici che lavoravano nei campi o nelle abitazioni; la Cattedrale era il cuore di tutta la comunità, residenza del vescovo –abate, dove, nelle grandi feste, si ritrovavano praticamente tutti gli abitanti dell’isola. Infatti era la Cattedrale l’unica parrocchia per tutto l’arcipelago dove si celebravano battesimi, matrimoni e funerali. Nelle altre due chiesette dell’isola – quella dell’Annunciazione nei presso di Piano dei Greci e S. Basilio a Quattropani – il vescovo concedeva ai contadini la messa la domenica con l’eucarestia e le confessioni.[23]

Chiesetta di S. Basilio
Intanto nel 1139 deposto l'antipapa Anacleto il legittimo pontefice Innocenzo II tolse a Giovanni il vescovato e lo retrocesse ad abate. Ma questo non fece venire meno il suo zelo e rimase sempre vigile ed operoso nei nove anni che gli rimasero da vivere[24].
[1] L.T White jr, op.cit. Pag. 140.Il ritratto delineato dallo studioso anglosassone continua: “Nel lungo periodo di tempo durante il quale Ambrogio era stato abate, non ci viene riferito di un solo processo; sotto Giovanni, i documenti riportano ben altro. La nostra prima conoscenza con lui, o quasi, la facciamo in un tribunale perchè si è azzuffato coll'arcivescovo di Palermo; l'ultima notizia su di lui è connessa con una disputa con l'eletto di Messina diciott'anni dopo”.
[2] G.Iacolino, op.cit., pag. 104.
[3] L. Catalioto, op.cit. Pag. 86.
[4] La bolla si trova in G. Iacolino, op. cit., pagg. 197-108; il testo latino in L. Catalioto, op.cit, pag.198. Catalioto osserva che quella dell'elevazione papale di San Bartolomeo alla dignità episcopale è una questione che rimane tutt'ora aperta, dal momento che non è giunta a noi la bolla della definitiva e legale promozione a vescovato dei monasteri di Lipari e Patti e l'unico atto ufficiale di cui si dispone è la bolla anacletana del settembre 1131, annullata tuttavia, dopo la ricomposizione dello scisma, dal legittimo papa Innocenzo II, che nel Concilio Lateranense del 1139 ribadì l'interdetto a carico di Ruggero II e dichiarò nulle tutte le ordinazioni disposte da Anacleto II.”(pag.88). Catalioto aggiunge che con un privilegio emanato nell'ottobre 1131 dall'arcivescovo di Messina Ugo, Giovanni, che di fatto agiva come presule ormai da tempo, era stato formalmente riconosciuto vescovo di Lipari-Patti, con il consenso dei Capitoli di Messina e Troina. (pag. 90). Ancora Catalioto osserva che Giovanni è definito venerabilis episcopus in una donazione del febbraio 1142 mentre in documenti del 1148 verrà qualificato semplicemente come “categumeno” e Lippariensis et Pactensis monasterii abbas in carte del 1142, 1143, 1148.(pag. 89 nota 30).
[5] Carlo Alberto Garufi, in “Le isole Eolie a proposito del “constitutum”...”, op. cit. pagg. 183-87 sostiene che le nuove restrizioni apportate da Giovanni Pergana dipendevano “più dalle ribellioni continue dei coloni che dal crescente numero di essi” e che nelle isole Eolie la popolazione rimase scarna, non continua, fluttuante, emigratoria. Ad avvalorare questa tesi Garufi cita il geografo arabo Endrisi che a metà del secolo XII nel “Sollazzo per chi si diletta a girare il mondo” dice di Lipari :”Cotesta isola è abitata in alcuni tempi...Ha una fortezza, acqua, legna ed un picciol porto”. Di parere diverso White ( op. cit. pagg. 142-143)che sostiene che la colonizzazione di Lipari progredì anche se “più lentamente di quella della regione di Patti”(Archivio Storico Eoliano.it)
[6] G.Iacolino, op.cit., pag.126-127.
[7] Idem,pag. 125.
[8] L.Catalioto, op.cit., pag. 93
[9] Il documento si trova nell'Archivio Capitolare di Patti ed è citato da G.Iacolino , op.cit., pagg. 125-6.
[10] E.Catalioto, op.cit., pag. 95.
[11] E. Catalioto, op. cit., pag. 94 e pp. 194-106.
[12] In G.Iacolino, op.cit., pag. 148.
[13] E. Catalioto, op,cit. ,pagg. 95 e ss.. Il testo integrale in latino in appendice a pag.206-208. V. anche G. Iacolino, pp.148-9,
[14] E. Catalioto, op.cit., pag. 97.
[15] E. Catalioto, op.cit., pag. 101.
[16] Idem, pag. 98.
[17] G. Iacolino, op.cit., pag. 149.
[18] L.T.White jr, op.cit., pag. 144-5.
[19] G. Iacolino, op.cit., pag. 140-1.
[20] G. Iacolino, op.cit., pag.150-152. Secondo Iacolino l’Ospedale di San Bartolomeo era ubicato accanto alla Chiesetta di Santa Maria delle Grazie, sul Castello. “Evidentemente doveva trattarsi di un modesto edificio di pochi vani che, più che a vero e proprio nosocomio, era adibito ad ospitare gli anziani poveri e soli( i baldi pionieri di sessant’anni prima) e fungeva pure da brefotrofio. Dell’esistenza di codesto ospedale abbiamo notizia da un documento del 1142 ove leggesi che un tal Martino Curatore cedeva alcune sue terre presso Oliveri ad uso e beneficio della nuova struttura”. E. Catalioto ritiene invece che l’Ospedale San Bartolomeo fosse di Patti ed in nota (n.70) aggiunge che “per Ospedale di San Bartolomeo si intende con molta probabilità la chiesa di Nostra Signora del Tindari” (pag. 108). L.T. White (op.cit.) pag.405 conferma l’ospedale in questione è il S.Bartolomeo di Lipari.
[21] G. Iacolino. op.cit. Pagg. 110-118.
[22] G.Iacolino, op.cit., pag. 136-7
[23] G. Iacolino, op.cit., pag. 142-4.
[24] G. Iacolino, op.cit. pag. 147.
L'esenzioneLipari, un "comune rurale"
La prima struttura comunitaria

Pianta del Castello che si veniva organizzando.
Lo storico Garufi parla per Lipari, grazie al Constitutum, di “Comune rurale”[1] già configurato nelle sue connotazioni costitutive: c'è un territorio, una popolazione stabile, una regolamentazione contrattuale degli interessi fondiari collettivi; gli uomini hanno la facoltà di disporre dei propri beni e il riconoscimento della libertà personale di azione e di mobilità. Mancava soltanto – osserva Iacolino – il diritto di creare un organismo rappresentativo-amministrativo-municipale laico a base elettiva e popolare ma di questo non se ne avvertiva ancora il bisogno. Non se ne avvertiva il bisogno o mancava ancora la cultura ed il coraggio per rivendicarlo?
Comunque Ambrogio poteva contate – per gestire il suo potere – su un gruppo abbastanza strutturato, come risulta dai sottoscrittori del Constitutum. Vi era un Visconte, Alberto, che svolgeva funzioni di vice conte, in questo caso di vice dell'abate per quanto riguardava la giurisdizione civile e militare; un Giovanni guardiano del Castello che aveva al suo comando degli uomini per garantirne la sicurezza; un Martino camerario che era una sorta di cassiere o tesoriere che si occupava della riscossione delle decime.
Oltre a Terranova altri toponimi che riguardavano il castello e che emersero in quegli anni furono: Verdesca che derivava dal tipo di struttura lignea, tipo balconata, che fungeva da spalto schermato per la sicurezza delle persone in caso di attacco. Bretèshe la chiamavano i francesci e bertesca gli italiani e quindi per corruzione verdesca. E Verdesca fu il nome alternativo del quartiere Terranova. Un'altra zona del Castello si chiamò Comandata perchè era la zona in cui risiedeva il comando delle guardie del Castello[2].
Fuori dal Castello, Castiddaru si chiamarono i luoghi ove sorgevano torrette e strutture per gli uomini di vigilanza, termine dialettale derivato da Castellare.
 Veduta del Castellaro, oggi.
Veduta del Castellaro, oggi.
I territori dell'isola divisi in "Piani"
Oltre che al Castello, i primi abitanti andarono a collocarsi nelle zone dove avvenivano le coltivazioni ed i pascoli. Innanzitutto Piano Greca sede della colonia degli indigeni che parlavano greco, poi via via occuparono la Piana sotto il Castello – poi Piano del Pozzo e Piano di Diana e Sopra il Piano -, Piano del Conte così chiamata forse perchè il visconte dell'abate vi risiedeva o aveva un possedimento, mentre Chiusa venne chiamato il podere riservato all'abazia. Il termine piano o piana ( dal latino planum) fu alla base della nuova toponomastica e nella catalogazione dei balzi o ripiani. Quattropani deriva da quattuor plana e cioè Chianu 'i Quartara, Chianu 'a Criesia Vecchia, Chianu 'i l'Autra Piècura, chianu du Castiddaru.
In quel periodo dovettero nascere anche i toponimi, sempre della zona di Quattropani, di Aria Morta, perchè zona tranquilla dove non soffiano lo scirocco o la tramontana; e di Tiuli che deriva il nome da alcuni capanni che dovettero sorgere per dare riparo a pecore e capre: da tègere che significa coprire si è arrivati a tigùlium, a tiguli da cui, in seguito, l'italiano tegola. Madoru deriverebbe dal latino madère che significa essere umido e da maàdor , madoris umidità. Infatti a Madoro un largo tratto della parete rocciosa da cui sgorgava la sorgente si presentava umida.[3]
 Strada fra Pianoconte e Quattropani dalle parti di Madoro
Strada fra Pianoconte e Quattropani dalle parti di Madoro
Comunque un risultato il Constitutum dovette ottenerlo. Dopo cinque anni gli abitanti, all'inizio del XII secolo, erano almeno 400 o 500 anime o forse di più, come diremo. D'altronde la Sicilia in quegli anni non superava le 300 mila persone, Palermo 20.000 e Messina contava dagli 8 a 10 mila abitanti.
La fattoria dei suini
Un altro episodio di cui abbiamo notizia relativo ad Ambrogio ed al Monastero di Lipari è del novembre del 1100. L'Abate pensa di realizzare un allevamento di suini ma nell'isola non c'è un terreno adatto e così si rivolge al Conte Ruggero .Si reca a Palermo chiede – come sappiamo da un rescritto dello stesso Conte - un piccolo territorio dove costruire un casale, pascervi gli animali, coltivare dei campi e con vicino un monte dove si possano raccogliere ghiande per i porci. E Ruggero gli concede una vasta tenuta a Melvisio, o Meliuso, nei pressi di Librizzi.
Questa vicenda ha dato vita a diverse discussioni e considerazioni soprattutto con riferimento a quel passaggio di Ruggero in cui si dice “in quanto nella terra di Lipari non possono vivere gli animali del Monastero a causa della ristrettezza ( o sterilità) del luogo”[4].
Possibile che a Lipari non ci sia spazio sufficiente per dare vita a questa impresa? Possibile che Ambrogio avesse distribuito tutte le terre ai coloni? Anche quella delle isole minori? Non è forse che la pretesa proprietà delle isole non esisteva e che egli aveva avuto solo il castello e qualche spezzone di terra limitrofo? Il Garufi[5] fa osservare che il testo originale è malandato e la parola non è “ristrettezza” ma Ambrogio chiede uno spazio idoneo, pianeggiante o pascolativo con, vicino, un lussureggiante querceto, e questo a Lipari manca. Secondo Catalioto[6] invece la richiesta è dovuta al fatto che Lipari è divenuta sovrappopolata e minacciata dalla carestia ed è per questo che Ruggero le accoglie. “La vastità del territorio che Ruggero donava al monastero in questa occasione, il tenimentum Melvisium (Meliusum), primo nucleo di Gioiosa Guardia, lascia intuire quanto fosse nutrito il numero dei coloni che da Lipari sarebbero dovuti defluire verso le terre assegnate per dare impulso al nuovo insediamento rurale e garantirne il regolare ciclo produttivo”[7].
La munificenza degli Altavilla

La regina Adelaide ripudiata da Bldovino
Dopo questo episodio noi abbiamo poche altre notizie relative ad Ambrogio e il suo Monastero, e cioè la querelle dei vassalli di Librizzi del 1117 e l'officiatura, assieme ai due vicari di Lipari e di Patti, a fine aprile 1118, delle esequie della regina Adelaide ( il Gran Conte Ruggero era morto a Mileto il 22 giugno del 1101) morta a Patti dove si era trasferita l'anno precedente fallito il matrimonio con re Baldovino di Gerusalemme. Probabilmente Ambrogio visse ancora qualche anno e dovette morire nel 1122 giacché nel 1123 appare per la prima volta documentato il nome del secondo abate di Lipari Giovanni da Pérgana[8]. Comunque la disponibilità e la munificenza degli Altavilla nei confronti del Monastero di San Bartolomeo non mutò assolutamente sia sotto la reggenza della regina Adelaide (1101-1112) sia sotto il regno di Ruggero II e, questo riguardo, al riconoscimento di diritti ed alla assegnazione dei beni. La struttura monastica era inquadrata secondo i canoni della gestione feudale[9].
Anzi in qualche modo, sotto Ruggero II, il sostegno al monastero si fece più attento perchè rientrava nell'obiettivo primario dell'Altavilla che era quello del rapido rafforzamento del suo potere all'interno del regno “per la cui realizzazione era parso irrinunciabile l'assoggettamento delle chiese locali e l'appoggio della feudalità, oltre che il sostegno dei borghi e delle campagne, e cioè di quella porzione consistente di forza lavoro inquadrata entro gli schemi ormai consolidati della signoria rurale”[10]. Comunque Ruggero II – ricorda Iacolino[11] - va innanzitutto ricordato, più del padre suo, come l’artefice e l’organizzatore di quell’unità dello Stato che doveva preludere all’amalgamazione etnica e culturale del popolo siciliano, pur sotto l’energica disciplina imposta dal sovrano, e che sarebbe durata sino al 1860”.
[1] G. Iacolino, op.cit. , pag. 60.
[2] G. Iacolino, idem, pag 60-63.
[3] G. Iacolino, op.cit. Pag. 65 e ss.
[4] Il diploma rilasciato da Ruggero ad Ambrogio si trova in G.Iacolino, op.cit., pagg. 95-96, il testo latino in L. Catalioto, op.cit. Pagg. 181-82.
[5] C.A. Garufi, Le isole Eolie a proposito del “Constitutum” dell'Abate Ambrogio del 1095. Studi e ricerche, in “Archivio storico per la Sicilia orientale “, anno IX, 1912,pagg.183-84.
[6] L.Cattalioto, op.cit., pagg.58-59.
[7] Idem, pag. 59.
[8] G. Iacolino, op.cit., pagg. 99-101.
[9] L. Catalioto, op.cit., pag. 73.
[10] L.Catalioto, op.cit., pag.102.
[11] G.Iacolino, op.cit., pag. 155.(Archivio Storico Eoliano.it)
Il camemario MartinoLa ricostruzione e riorganizzazione di Lipari
Lipari, una piccola comunità.

Piano Grec a dove probabilmente vivevano gli ultimi liparesi di Lingua greca quando arrivarono i Normanni.
Nella sua bolla , Papa Urbano, oltre all'osservazione che gli abitanti erano scarsi fornisce anche un'altra notizia che riguarda la realtà territoriale e sociale di Lipari: “l'operosità dei monaci ha fatto affluire nell'isola moltissimi coloni”. Ma quanti abitanti poteva contare Lipari un decennio dopo l'arrivo dei monaci, nel 1094? Non più di 250 unità, osserva Iacolino[1], complessivamente una cinquantina di famiglie comprese quelle indigene che parlavano il greco. In dieci anni erano certamente cresciute se alla fondazione del Monastero non dovevano essere, gli abitanti, più di un centinaio: una cinquantina residenti a Piano Greca ed una cinquantina arrivati con Ambrogio ed i monaci. Un modesto seguito di muratori, di fabbri e di assortite altre maestranze che dovevano attendere all'edificazione della chiesa e del convento, e – cosa assolutamente prioritaria – allo scavo di una cisterna comune. Quindi un gruppetto di primi coloni con sacchi e cestoni ricolmi di scorte alimentari, attrezzi da lavoro e seguiti da bestie da soma e da animali da fattoria.,

Probabile ricostruzione della chiesa col monastero.
Appena giunti ci si mise al lavoro per edificare il monastero e la chiesa proprio nel posto dove affioravano ben visibili i resti della chiesa bizantina e lo si fece utilizzando pietrame raccolto sul posto e blocchi monolitici asportati dalla cinta muraria greca che si intravedeva a tratti nella piana bassa prima di Diana. Ne risultò una modesta costruzione probabilmente di venti metri per sei ad aula unica. L'edificio aveva l'orientamento tradizionale: facciata a ponente e abside a levante che si concludeva con una cupoletta emisferica. Naturalmente niente campanile ma solo una campanella di bronzo appesa ad un cavalletto di tronchi.
Il monastero, la chiesa e la cisterna comune
 Strada di accesso al Castello
Strada di accesso al Castello
Abbiamo accennato ad una cisterna comune che fu scavata al centro dell'abazia e che avrebbe dovuto raccogliere l'acqua piovana al servizio di tutta la comunità. Cisterna, che ampliata in tempi successivi, è giunta sino ai nostri giorni. Insieme alla chiesa si mise mano al monastero addossato al fianco meridionale della chiesa stessa. Un cenobio-fattoria costruito anch'esso in muratura ma con l'utilizzo di legname, intono ad un cortiletto scoperto non ancora circondato dal chiostro. A pianterreno doveva esserci un magazzino-cantina per le derrate ed il vino, la sala del refettorio, la cucina con un grande forno, la stalla; al primo piano le celle, l'archivio, l'infermeria e uno studiolo biblioteca che all'occorrenza fungeva da aula capitolare. Fuori dal complesso dell'abazia, a nord-est le case dei lavoratori che formavano il primo nucleo dell'abitato che era chiamato allora “terra” e “Terranova” fu chiamato questo primo quartiere con le case dei primi abitanti. Quando si parla di “case” bisogna pensare che queste allora avevano più sembianze del “pagliaio”: quattro muretti di pietre e pietrisco, il resto di frasche, tutto coperto da rami, canne e paglia. Di villaggi costituiti di pagliai in Sicilia se ne trovavano fino a qualche secolo fa; si pensi che Ustica nel '700 fu all'inizio un villaggio di pagliai.
Ma se questo era agli inizi Lipari, c'è però da pensare che la situazione nell'arco di qualche secolo evolvesse verso strutture più solide realizzate oltre che in pietra, calce e gesso anche con l'apporto di tronchi e di assi di legno. E presto dovette imporsi l'esigenza di tetti-terrazza in malta battuta per raccogliere l'acqua piovana. Rimase invece la struttura delle case addossate le une alle altre realizzando vicoli strettissimi e tortuosi che se da un lato erano pittoreschi dall'altra lasciavano a desiderare dal punto di vista igienico sanitario per l'accumulo della spazzatura e lo scorrere delle acque.

Il chiostro normanno. Ma qui si dovrebbe essere già nel XII secolo.
Il constitutum del 9 maggio 1095
A dieci anni dall'arrivo a Lipari certamente Ambrogio si trovò a fare un primo bilancio e si rese conto che la popolazione cresceva, ma a ritmi assai lenti. Inoltre il collegamento di Lipari a Patti faceva si che la gente privilegiasse le terre che si trovavano sulla costa giacché l'isola era ancora sinonimo di insicurezza e segregazione. Bisognava incentivare chi era disposto a venire a lavorare nelle isole[2]. Nacque così il constitutum del 9 maggio 1095[3]. Esso appartiene al genere della chartae divisae o partitae, dette così perché su due settori – alto e basso – dello stesso foglio si stilavano due copie identiche che poi venivano staccate: una restava in mano al signore concedente, l'altra veniva consegnata al rappresentante dei beneficiari. Gli storici attribuiscono una grande importanza a questo documento che si trova nell'archivio della Diocesi di Patti e la ricordano come la protocharta siciliana per la fondazione di un comune.

Copia del constitutum conservata nell'archivio della diocesi di Patti.
L'XI secolo è il secolo in cui in Italia ed in Europa nascono i Comuni come forma di governo e di organizzazione che supera il feudalesimo. Si ripropose allora il fenomeno dell'urbanesimo; nelle città in crescita lo sviluppo del sistema manifatturiero e commerciale modificò le basi della ricchezza e del potere politico, si formarono nuovi ceti borghesi, i contadini inurbati si trasformarono in artigiani, ma anche i nobili e gli ecclesiastici modificarono le loro attitudini economiche. Via via che le città si ingrandivano, i cittadini più facoltosi e potenti rivendicavano la libertà di governo, tollerando sempre meno l'autorità del signore feudale o quella del vescovo o quella più lontana dell'imperatore. Tale fenomeno, che portò alla nascita dei comuni, si manifestò in tutta Europa, ma in modi differenti da zona a zona, da città a città. L'area tedesca e quella dell'Italia settentrionale e centrale furono le zone del continente nelle quali si radicò maggiormente l'esperienza storica dei Comuni. L'organizzazione politica che si diedero i Comuni prevedeva l'elezione di rappresentanti in un consiglio della città e l'approvazione di statuti che ne regolavano la vita sociale e politica.
Certamente se si vuole pensare che a Lipari con quel documento nasce un vero e proprio comune si compirebbe un errore. Ambrogio è ancora a tutti gli effetti un signore feudale ma si comporta come un signore illuminato che viene a patti con i sudditi e stabilisce ( patteggia) con loro diritti e doveri. In particolare il patto è che Ambrogio concede dei diritti sulla terra a chi la lavora per un certo tempo in cambio di un periodico versamento a Dio e San Bartolomeo delle decime dei prodotti agricoli e della pesca e – sebbene non specificato nel constitutum liparese – l'obbligo di prendere le armi nella deprecata eventualità di una incursione che giungesse dal mare. Quali sono questi diritti? A Lipari dove, oltre ai timori dell'isolamento, le colture erano meno remunerative, si dava libero accesso a tutte le etnie: lombardi e italici, normanni, greci ed arabi. L'assegnazione delle terre non comportava prestazioni dovute e gratuite di servizi a vantaggio del Monastero. Esenti a tutti gli effetti erano i coloni anche per quanto riguardava pagamenti di censo e di canone di affitto; anzi, l'appezzamento concesso, dopo tre anni di dimora continuata del beneficio, diveniva proprietà assoluta del coltivatore e dei suoi eredi; i quali avevano il diritto di vendere liberamente il podere a uomini del luogo. Maturato un solo anno di residenza, ognuno aveva facoltà di vendere “il frutto del suo lavoro, cioé : la casa costruita, la vigna piantata, la cisterna scavata, o altre simile cose; ma non avrebbe potuto vedere la terra che gli era stata conceduta”.
I constitutum di Patti e Librizzi

Veduta di Librizzi
La situazione di particolare favore accordata ai coloni di Lipari emerge dal raffronto con il constitutum di Patti[4] che dovrebbe ( manca l'originale ed abbiamo solo un trascritto senza che indichi la data) essere di poco posteriore a quello di Lipari. Definendo il constitutum di Patti, Ambrogio doveva avere in mente due obiettivi: moderare la corrente degli immigrati inducendoli a preferire le isole; rafforzare l'elemento latino nella popolazione per erigere un baluardo contro la possibile insubordinazione dei mussulmani e dei bizantini. In più si faceva obbligo ai coloni della terraferma, di offrire sostegno militare ai Liparesi in caso di emergenza di guerra o, cosa più probabile, di aggressione banditesca da parte dei predoni musulmani-berberi dell'Africa settentrionale.
Il constitutum di Librizzi[5] è di dieci anni dopo, infatti porta la data dell'8 luglio 1117. Sulla montagna di Librizzi risiedeva il gruppo più compatto di villani soggetti all'Abazia di Lipari e Patti, che – per prassi consolidata – sopportava oneri gravosissimi che però non dovevano essere più pesanti di quelli che subivano villani ed anche coloni di altre parti della Sicilia. Dopo avere ascoltato i villani ed essersi consultato con i monaci, Ambrogio stabilisce che essi lavorassero tre settimane al mese “ a profitto loro e dei loro figli” ed una sola a servizio del Monastero. I villani si sentirono così tanto beneficati che spontaneamente vollero che si aggiungesse, a vantaggio del Monastero, quaranta giornate l'anno per la semina con i propri bovi aggiogati e una giornata per la mietitura, tre giornate per la vendemmia o in occasione di altre necessità del Monastero.
E' importante cogliere nel constitutum di Librizzi un elemento. I nomi dei monaci e dei mallevatori nominati sono greci, franco-normanni, arabi, e italici a dimostrazione non solo di un importante processo di integrazione fra etnie diverse ma anche di tolleranza. L'arabo citato è Filippo, un monaco di stanza a Lipari, apostata islamico, indice che questa tolleranza era operante anche verso la minoranza islamica[6]. (Archivio Storico Eoliano.it)
[1] Idem, pag.69.
[2] Secondo Luciano Catalioto la differenza di trattamento fra chi si trovava già a Lipari - a cui la terra veniva data in proprietà perpetua immediatamente a semplice richiesta, esenti da tributi e prestazioni di servizio – e chi sarebbe venuto in seguito al Constitutum che l'avrebbe ricevuta in eredità solo dopo tre anni di residenza, sarebbe un chiaro segno del fatto che “l'urgenza del ripopolamento era rapidamente venuta meno e che il flusso migratorio, alimentato da incentivi evidentemente allettanti, aveva superato ogni aspettativa ed invertito la tendenza”, L. Catalioto, IL Vescovato di Lipari-Patti, op.cit. Pag.58.
[3] Idem, pag. 54-56.Il testo in lingua latina si può leggere in L: Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Pattti, op.cit. Pag. 179-180.
[4] Idem. 56.
[5] Idem, pag. 59. Il testo latino in L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Patti, op.cit. 189-190.
[6] L.Catalioto, op.cit. Pag. 46.
Quelli di Patti e LibrizziL'abate Ambrogio e i normanni
L'abate Ambrogio
 Ruggero e Roberto il Guiscardo
Ruggero e Roberto il Guiscardo
L’apertura di questo monastero si deve collocare necessariamente nel biennio1082-83 perché la decisione fu presa di comune accordo col fratello Roberto il Guiscardo che morì nel 1085 ed aveva tenuto il dominio delle Eolie fino proprio al 1082-83. Manca l’atto ufficiale di fondazione ma siamo in possesso di un diploma rilasciato da Ruggero II, figlio del Conte Ruggero, il 28 aprile del 1134, col quale si confermano le donazioni fatte al Monastero di Lipari ed espressamente si accosta Roberto il Guiscardo al Conte Ruggero come autore delle donazioni. Questo diploma è importante perché, prima dei beni assegnati al monastero, parla dell’assegnazione delle sette isole - nominandole una per una – con le loro pertinenze.
Un altro documento importante in cui questa volta il Conte Ruggero direttamente cita il Monastero di Lipari e l’Abate Ambrogio è del 26 luglio del 1084 in cui sono elencate terre donate al Monastero vicine e davanti al Castello di Mileto con indicati i confini. In questo documento prima di passare all’elencazione di queste terre il Conte dice “dopo che con i miei figli ( forse intendeva fratelli) venni dalla Francia a Mileto, io diedi all’Abate Ambrogio, a favore del Monastero San Bartolomeo di Lipari, le terre qui sotto indicate”.
Ora l’arrivo dalla Francia risale a prima del 1061 per cui ci si è chiesti se questo voglia dire che il Monastero esisteva più di vent’anni prima di quanto si riteneva. Tesi questa che curiosamente la si ritrova sostenuta da Mons. Tedeschi che fu vescovo di Lipari fra il 1710-1722 e che nel 1713 scriveva che “l’isola di Lipari era abitata dai Monaci moltissimi anni prima che egli [ Ruggero] liberasse la Sicilia dal giogo de’ Saraceni”[1]. In questo caso ammesso che Ambrogio avesse trent’anni nel 1061 quando divenne abate e ammesso, come diremo, che sia morto intorno al 1122, se ne concluderebbe che sia vissuto novantadue anni. Certo possibilissimo. Il problema è che a sostegno di questa tesi, salvo queste righe del diploma, non esiste nessuna prova storica. Inoltre, secondo Iacolino[2], di queste righe potrebbe darsi un’altra interpretazione: nel 1061 Ruggero giunto a Mileto si rese persuaso dell’importanza strategica delle Eolie e parlò ai Benedettini del proposito di ricostruirvi il monastero e di affidarlo a loro. Forse ne parlò addirittura con Ambrogio che allora doveva essere un giovane monaco. Ma questo proposito si sarebbe realizzato almeno vent’anni dopo.
Ambrogio a Mileto
Che ci faceva Ambrogio a Mileto? Da dove proveniva? Chi era veramente questo frate? Lo statunitense Lynn Townsend White ir[3], ha scritto che “il monachesimo nord-europeo esercitò una notevole influenza su quello del regno normanno. Comunque, in questa influenza sulla Sicilia interveniva la Calabria che la diluiva nel passaggio(...) La caratteristica più enigmatica della migrazione dei monaci del nord verso i domini normanni è la loro concentrazione in Calabria, da dove si diffusero sia in Puglia che in Sicilia”[4]. Qui si raccolsero Benedettini, Cistercensi, Agostiniani, Ospedalieri e fra tutti questi sicuramente furono scelti i Benedettini proprio perché i più adeguati a condurre una colonizzazione visto che il loro fondatore aveva loro assegnato, col motto “ora et labora”, il compito di coltivare la terra e visto che avevano avuto importanti ed interessanti esperienze, in questa direzione, in Francia ed in Italia.
Che Ambrogio fosse benedettino ce lo conferma lo storico Garufi [5]aggiungendo che apparteneva alla congregazione cluniacense ed in Calabria aveva fatto capo o al monastero di Sant’Eufemia fondato nel 1061 o a quello di Mileto fondato nel 1081. Aggiunge che si ignora se fosse di origine francese o italiana. Per la verità, stando al nome verrebbe di pensare piuttosto ad una origine lombarda ed a Pavia esisteva una comunità fondata direttamente dall’abate di Cluny, Odilone, fino dal 967[6]. Essere abate era una dignità importante, pari quasi a quella di vescovo, per cui doveva ricevere la consacrazione o da un vescovo metropolitano o da un delegato del papa o dal papa in persona. Il White sostiene che Ambrogio come il suo successore Giovanni ricevettero a Roma la consacrazione


In alto: antica stampa di Mileto. Sopra: le Eolie viste dalla costa calabra.
Era un avventuriero?
Pino Paino[7] afferma prima che Ambrogio era “con molta probabilità un vero capitano di ventura lombardo”[8], poi, più avanti “un crociato anti litteram[9]”. Da dove abbia potuto ricavare questo giudizio è difficile capirlo giacchè le fonti non sono moltissime ed, oltre quelle citate, vi sono soprattutto i tre “constitutum “che Ambrogio emise – come vedremo – in riferimento a Lipari, a Patti e a Librizzi. Ed a proposito di questi giustamente Iacolino osserva che se riconsideriamo in un’ottica complessiva i tre documenti, chiaramente “risaltano le qualità dell’uomo: grande capacità organizzativa e di governo e una forte carica di sensibilità alle esigenze della gente, una sensibilità non improntata certo a spirito 'democratico', quale oggi si suole intendere, bensì originata da spontanei moti di “pietà, compassione e commiserazione”, sentimenti che andavano al di là si quanto si potesse pretendere da un 'signore' dell’XI-XII secolo in una Sicilia che era in gran parte un agglomerato feudale.

Un uomo Ambrogio, che pur stando al vertice del comando, sapeva ascoltare la voce della base, e che alla sua stessa autorità imponeva dei limiti facendo ricorso, prima di ogni grave decisione, al consiglio e al parere dei membri della famiglia monastica”[10].
Ancora il Paino afferma perentoriamente che “nessun documento riporta di conferimenti di beni ricadenti nel territorio delle isole Eolie o Lipari o comunque fatti al Monastero o ad Ambrogio”[11], né il diploma del Conte Ruggero del 26 luglio 1088, né le bolle di Urbano II del 3 giugno 1091, né il documento del 1094. Ora indubbiamente si può discutere se il possesso delle Eolie che, sia il Conte Ruggero sia Papa Urbano II, avevano conferito espressamente ad Ambrogio ed al suo monastero fosse di natura feudale o allodiale, se cioè il beneficio era di tipo politico ed escludeva la proprietà , come sostennero gli amministratori di Lipari all’inizio del 900 in varie cause conclusesi nel gennaio del 1921 con sentenza favorevole al Comune, o se invece il territorio trasferito diventava proprietà piena del beneficiario come sosteneva il Vescovato che si riteneva erede dei titoli dell’Abate Ambrogio. Ci sembra impossibile negare che sia il Papa che il Gran Conte abbiano voluto conferire la potestas feudale sulle isole ad Ambrogio ed al suo Monastero per cui l'Abate di San Bartolomeo oltre all'autorità spirituale ecclesiastica, esercitò ampi poteri civili: quello giudiziario e quello amministrativo.

Papa Urbano II benedice l'esercito normanno.
I documenti della potestà di Ambrogio
Vediamoli infatti questi documenti. E’ vero che il documento del 1088[12] non cita le Eolie ma solo alcuni terreni di Mileto ma intanto il discorso – come abbiamo visto – sembra riferirsi ad un tempo precedente , forse al 1061, quando ancora le Eolie non erano state conquistate e comunque già allora Ruggero pensa di dare da subito per il futuro una dote ad Ambrogio; in secondo luogo il discorso è lì circoscritto a Mileto, non si parla nemmeno delle altre donazioni distribuite un po’ per tutta la Sicilia. Questo elenco invece lo fa Ruggero II, figlio di Ruggero. Nel diploma rilasciato il 28 aprile del 1134 conferma le donazioni cominciando proprio dalle “isole di Lipari, Vulcano, Salina, Panaria, Stromboli, Arcudi, Filicudi con tutte le loro pertinenze”.[13] Inoltre proprio nella bolla che Urbano II inviò ad Ambrogio il 3 giugno 1091 si legge[14]:
“Ora Noi – su cui per divino volere ed in forza dell'autorità della Sede Apostolica, incombe la cura di tutte le Chiese, benché siamo a conoscenza , tramite gli scritti di San Gregorio, che nella medesima isola ci fu un tempo la sede vescovile, poiché la ristrettezza del territorio e la scarsezza degli abitanti non meritano la presenza di una tale dignità, tuttavia, con l'autorità del presente documento, confermiamo che detta isola abbia un Monastero e che questo possegga il comprensorio di tutta l'isola (“totius insulae ambitum”). … Pertanto, col presente privilegio e in forza dell'autorità apostolica. Noi abbiamo stabilito che tutte quelle cose che al momento il detto Cenobio legittimamente possiede o che in seguito – per elargizione dei Pontefici e per liberalità di Principi o per donazione di fedeli – esso potrà legittimamente e canonicamente acquisire, rimangano ferme e integre per te ed i tuoi successori “.
Si può osservare che questa bolla non solo non riconosce ai Normanni la liberazione delle isole dai saraceni ma bensì “alla potenza della Divina Misericordia” ma non tiene affatto conto dei decreti di Ruggero, nè accenna alle donazioni da questo fatte, ma tutte le conferma senza nominarle. Ora, per quanto riguarda il possesso delle isole, questo modo di procedere è comprensibile giacchè la bolla inizia proprio ricordando il diritto della Chiesa di Roma sulle isole risalente all'imperatore Costantino : “Tutte le isole, secondo le regali istituzioni, sono di diritto pubblico: si sa con certezza che , in forza del privilegio del pio Imperatore Costantino, tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San Pietro e ai suoi successori; e, in particolare, le isole adiacenti all'Italia, molte delle quali, a causa dei peccati degli abitatori, furono occupate dai Saraceni e perdettero l'onore del nome cristiano. Tra queste isole, Lipari, un tempo famosa per il corpo dell'Apostolo San Bartolomeo, ben sappiamo che è stata ridotta quasi a deserto; trascorsi poi molti anni ed avendo la potenza della Divina Misericordia vinto le forze dei Saraceni, monaci dediti al servizio divino, venuti in quest'isola, fecero edificare il Monastero e, con la loro operosità, nella medesima isola fecero affluire moltissimi coloni”.
L'abate fra Ruggero e il Papa
 La cittadina di Patti con sullo sfondo le Eolie
La cittadina di Patti con sullo sfondo le Eolie
Ma il resto? Perchè nessun riferimento ai Normanni ed a Ruggero. Si può pensare che anche questa bolla rientri nella guerra fredda – pur all'interno di una salda alleanza - fra Ruggero ed il Papa. Il Gran Conte ignora il Papa quando si tratta di aprire Diocesi e Monasteri e nominare Vescovi ed Abati e il Papa si prende qui una rivincita. Afferma cioè il suo pieno potere su questo arcipelago, così importante nella strategia di Ruggero, nega la possibilità che possa tornare ad essere Diocesi e sottolinea il suo diritto di nominare gli abati: “Questo monastero, cui la fraternità tua, per volere del Signore, presiede, e che è intitolato a San Bartolomeo. Noi lo prendiamo nel grembo della Sede Apostolica e intendiamo favorirlo con speciale protezione”.
Ruggero certamente venne a conoscenza di questa bolla ma apparentemente non reagì al fatto che il Papa stabiliva un rapporto diretto col Monastero che lo tagliava fuori, come non reagì alla bocciatura della sua idea di fare delle isole una Diocesi, preparò però una strategia per cercare di ovviare alla negazione della Diocesi che era un punto che gli stava particolarmente a cuore. Così creò a Patti un monastero e lo mise alle dipendenze di Ambrogio. A questo punto il problema della Diocesi avrebbe riguardato il territorio di Patti e delle Eolie aggirando sia la questione della “ristrettezza del territorio” sia quella della “limitatezza degli abitanti”.(Archivio Storico Eoliano.it))
[1] N.N. , Difesa della verità a favore di Monsignor Nicolò Tedeschi Vescovo di Lipari, ecc.,pag. 45. Il libretto è senza data e luogo di stampa ma Iacolino, nel libro citato, afferma che potrebbe essere stato stampato a Roma e che autore ne fosse lo stesso vescovo.
[2] G.Iacolino, op.cit,. pag.27.
[3] L. Townsend White jr, Il Monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania, 1984,
[4] Idem, pag. 84.
[5] C.A. Gafuri, Memoratoria, Chartae et Instrumenta divisa, in Sicilia nei secoli XI-XV, in “Bollettino dell'Istituto Storico Italiano”, n. 32 Roma 1912, pag. 79.
[6] M. Acherio, Istituzioni mediovali, Bologna 1994, pag.189.
[7] “P.Paino, La vera storia di Lipari, op.cit.
[8] Idem, pag.97.
[9] Idem, pag. 102.
[10] G.Iacolino, op.cit., pag. 60.
[11] P.Paino, op.cit., pag. 104.
[12] G. Iacolino, op.cit. Pag.25.Il Testo in latino in L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Patti, op.cit., pag. 173.
[13] G. Iacolino, op.cit., pag. 28-29.Il testo latino integrale in L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari, op.cit. Pag. 206-208.
[14] G.Iacolino, op.cit.oag. 38-40. Il testo in lingua latina si può leggere in L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Patti, op.cit. Pag. 174-175.
Il Monastero di S.BartolomeoI normanni alle Eolie
I normanni in Sicilia

Chi erano i Normanni[1]? Letteralmente la parola significa “uomini del Nord” ed erano un misto di popolazioni della Scandinavia, insediati in Danimarca, in Norvegia ed in Svezia, di origine germanica dotati di una propria cultura ed abituati a navigare nel mar Baltico nel mare del Nord, anche se la maggior parte di essi non erano navigatori ma contadini.
 Normanni è quindi il nome collettivo di varie popolazioni scandinave, che compirono imprese diverse tra il IX e il XII secolo. La cultura normanna, come quella di molti altri popoli migratori, era particolarmente versatile e aperta al nuovo. Per un certo periodo, questa caratteristica li portò a occupare territori europei tra loro eterogenei. Dopo l'insediamento in Normandia nel 910, nell'XI secolo si riversarono in Inghilterra, in Francia e nell'Italia Meridionale. In Italia i Normanni si accordarono con il Papa a cui davano sicurezza nella vertenza delle investiture con l’imperatore in cambio della legittimazione delle loro conquiste. Proprio nel 1059 a Melfi si perfezionava questo accordo e Nicolò II riconosceva Roberto il Guiscardo vassallo della Santa Sede nominandolo, di diritto ancora prima che di fatto, “Duca di Puglia e di Calabria per grazia di Dio e di San Pietro e, con il loro aiuto, futuro Duca di Sicilia”. In cambio Roberto giurava di sostenere la Santa Romana Chiesa ovunque ce ne fosse stato bisogno.
Normanni è quindi il nome collettivo di varie popolazioni scandinave, che compirono imprese diverse tra il IX e il XII secolo. La cultura normanna, come quella di molti altri popoli migratori, era particolarmente versatile e aperta al nuovo. Per un certo periodo, questa caratteristica li portò a occupare territori europei tra loro eterogenei. Dopo l'insediamento in Normandia nel 910, nell'XI secolo si riversarono in Inghilterra, in Francia e nell'Italia Meridionale. In Italia i Normanni si accordarono con il Papa a cui davano sicurezza nella vertenza delle investiture con l’imperatore in cambio della legittimazione delle loro conquiste. Proprio nel 1059 a Melfi si perfezionava questo accordo e Nicolò II riconosceva Roberto il Guiscardo vassallo della Santa Sede nominandolo, di diritto ancora prima che di fatto, “Duca di Puglia e di Calabria per grazia di Dio e di San Pietro e, con il loro aiuto, futuro Duca di Sicilia”. In cambio Roberto giurava di sostenere la Santa Romana Chiesa ovunque ce ne fosse stato bisogno.
Ma la meta più ambita dei due Altavilla era la Sicilia a cui guardavano anche incalzati dal papa che auspicava la cacciata degli Arabi e il ritorno dell’isola in seno alla Chiesa di Roma. “In Sicilia, infatti, dopo cinque secoli di dominazione bizantina e musulmana, il rito latino era praticamente inesistente e con i Normanni si presentava al papato l'occasione propizia per rinnovare le rivendicazioni della Chiesa Romana e per avviare la riorganizzazione del proprio clero e la progressiva reintroduzione della giurisdizione romana, attraverso delicate fasi dirette alla ripresa dell'opera di riforma ecclesiastica”[2].
Alla conquista della Sicilia si dedicò soprattutto il fratello minore di Roberto , Ruggero che nel 1059 conquistò Reggio e due anni dopo Messina e la Val Demone dove sopravviveva il cristianesimo greco. Nel 1062 Ruggero reclamò ed ottenne dal fratello la sovranità della parte inferiore della Calabria e piazzò il suo quartiere militare a Mileto. Mileto era una piazzaforte strategica nella prospettiva della conquista della Sicilia e proprio da lì pose gli occhi sull’arcipelago eoliano e ne valutò l’importanza per il suo progetto.
I normanni a Lipari
Nel 1081 Roberto lo aveva nominato Conte di Sicilia - Ruggero si fece chiamar però “Gran Conte”-, gli assegnò i pieni poteri sull’isola riservando a sé, oltre i diritti sovrani, metà di Palermo, metà di Messina e l’intero Val Demone, comprese dunque le Isole Eolie. Ma era una riserva formale giacchè gli interessi di Roberto si spostavano sull’altro versante dell’Adriatico, verso l’Albania e la Grecia dove la morte lo colse nel 1085.
Spirito geloso della propria autonomia Ruggero visse un rapporto col papato molto dialettico, con forti momenti di tensione ma senza arrivare mai nemmeno a sfiorare una rottura. Sembra ormai una tesi consolidata e largamente condivisa fra gli studiosi, “il riconoscimento della costante identità di vedute tra Ruggero I e Urbano II, che avrebbero operato senza alcuna divergenza essenziale(...). [Il] giuramento prestato da Ruggero a Melfi, con cui egli si impegnava sostanzialmente alla promozione ed alla salvaguardia degli interessi della Chiesa cattolica, costituisce il cardine attorno al quale si muove la politica del tempo“[3]. Il punto più alto di questo patto, almeno nella prospettiva di Ruggero, fu la concessione dell'Apostolica Legazia con cui Urbano II, nella bolla di Salerno del 1098, attribuiva ufficialmente a Ruggero d'Altavilla il diritto alle nomine episcopali in Calabria e Sicilia[4].
 Urbano II
Urbano II
L’obiettivo che si era prefissato il Gran Conte era l’unificazione stabile della Sicilia incentrata su una sovranità autorevole. L’apertura di Diocesi e di monasteri latini aveva un ruolo ben preciso in questa strategia perché servivano a ripopolare zone disabitate, a rilanciare la coltivazione delle terre e quindi a fondare la propria sovranità. “Cristianizzazione e recupero in chiave economica del territorio sono pertanto due strade che i primi Altavilla percorsero in modo talvolta autonomo, sebbene esse finiscano col confluire in un unico disegno e per costituire, come un blocco omogeneo e inscindibile, la base del potere politico della signoria normanna”[5].
Così Ruggero non si fece scrupolo di perseguire questi due obiettivi – pure quando si trattava di decisioni di carattere ecclesiastico - senza la debita autorizzazione pontificia, ponendo a capo delle diocesi vescovi di propria fiducia. Fu il caso – nel 1080 -dell’istituzione della prima sede episcopale a Troina, affidandogli tutto il territorio della Val Demone che avrebbe dovuto far capo a Messina, nominandovi vescovo un proprio parente, il cognato Roberto. Papa Gregorio VII se ne risentì in un primo momento ma poi fece buon viso a cattivo gioco e riconobbe diocesi e vescovo affermando però che un fatto del genere non avrebbe più dovuto ripetersi per il futuro. Ma Ruggero non se ne diede per inteso e nel 1083 chiamò Alcherio a reggere l’arcivescovado di Palermo.
L’impegno a promuovere una chiesa latina non impedì a Ruggero di curare fra l’altro la riattivazione dei monasteri greco-bizantini che trovò in Sicilia. E questo sia per spirito di tolleranza religiosa e nella strategia di recupero del territorio ad attività produttive, ma forse anche per lanciare al Papa un velato avvertimento che in caso di sua indisponibilità a sostenerlo c’era sempre … il Patriarcato di Costantinopoli.
In questo “amichevole” braccio di ferro col Papa rientrarono anche l’apertura dei nuovi monasteri. Ne eresse quattro di sana pianta affidandoli ai benedettini: Lipari, Catania, Patti e Santa Maria de Scalis a Messina. Il primo monastero in assoluto Ruggero lo volle costituire a Lipari: lo intitolò a San Bartolomeo e vi prepose l’abate Ambrogio[6].
[1] D. Matthew, I normanni in Italia, Milano 2009.;John Julius Norwich, I normanni nel Sud, Milano 1971.
[2] L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Patti, op.cit. Pag.31.
[3] L. Catalioto, Il Vescovato di Lipari-Patti..., op.cit. Pag. 44.
[4] L.Catalioto, op.cit., pag. 29. G. Iacolino, op.cit. Pag. 82-84. Dice Iacolino: “Il concetto di Legazia Apostolica si affermerà con maggiore consapevolezza tra i secoli XIV e XV e assumerà forme più decise di invadenza a cominciare dal Cinquecento. Per tutto il corso del Sei e del Settecento, la Diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede”, diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia, che sosterranno le loro prerogative anche sulla Chiesa Liparitana, e i papi, che le osteggeranno. E sarà allora che la vicenda registrerà i suoi momenti di più drammatica conflittualità “(pag.84).
[5] Idem, pag. 44.
[6] G. Iacolino, Le isole Eolie... Dalla riforndazione..., op.cit., pagg 24 2 ss. Questo volume ci ha fatto da guida costante, pur negli approfondimenti con altri testi, alla stesura di questo capitolo.(Archivio Storico Eoliano.it)
L'occupazione araba

Abbiamo visto come le Eolie a cominciare la sacco dell'838 furono oggetto di occupazioni e di abbandoni nel buio pressoché assoluto delle fonti storiche dove, di tanto in tanto, si intravedono dei puntini di luce che però non riescono mai a rischiarare il quadro ed a fornirci informazioni sugli abitanti e le condizioni di vita. Questo dura fino all'arrivo dei Normanni che secondo Bernabò Brea[1] avviene approssimativamente nel 1083 ma che per Iacolino[2] potrebbe risalire a due decenni prima quando i Normanni cioè attaccano ed occupano Messina. Il 13 febbraio del 1061[3] erano sbarcati nel porto di Milazzo e vi avevano fatto scendere già i cavalli quando precipitosamente riguadagnarono le navi, lasciando i cavalli allo stato brado, perchè non si ritenevano abbastanza numerosi per fronteggiare i saraceni. Qualche mese dopo, quando occuparono Messina, “le truppe normanne sciamarono nei dintorni facendo razzia e carneficina”[4], e quindi è pensabile che non trascurarono le Eolie che potevano rappresentare un importante ponte per preparare l'assedio di Palermo. D'altronde il presidio arabo non doveva essere poi tanto forte se diverse volte era stato sopraffatto da bizantini e pisani.
Ma se i normanni presero Lipari fra il 1061 e il 1063 usandole come base d'appoggio per i navigli militari, la vera colonizzazione dell'isola dovette avvenire proprio intorno al 1083 quando affidarono l'isola all'Abate Ambrogio ed ai suoi monaci benedettini col compito di aprirvi un monastero e di ripristinare, a partire dalla rocca, una normale vita comunitaria.
La tesi delle Eolie praticamente deserte

Ma chi trovarono a Lipari Ambrogio ed i suoi monaci? La discussione su questo punto è stata molto vivace e vedremo più avanti il perché. La tesi prevalente vuole che le Eolie all'arrivo dei normanni fossero praticamente disabitate[5]. Iacolino da per “certissimo” che “al momento del loro arrivo, la campagna i Benedettini la trovarono trascurata ed in abbandono nell'intero ambito dell'Arcipelago. Se poi, qua e là scorgevansi in Lipari segni di lavoro umano, questi erano opera dello sparuto nucleo di nativi, epigoni della tradizione bizantina, stentatamente sopravvissuti nel silenzio e nella più totale segregazione dal resto del mondo”[6]. Più precisamente la tesi è che sull’isola, dopo l'838, rimase solo un gruppetto di liparesi che disertarono il Castello e la cittadina e si rifugiarono all’interno, verosimilmente nella conca di Piano Greca – che si chiamava allora Vulcanello per via delle fumarole e delle manifestazioni vulcaniche - che in qualche modo li riparava dagli occhi indiscreti delle navi di passaggio.
Sulla rocca di Lipari dovette insediarsi una guarnigione araba che presidiava i mari circostanti ma doveva avere una funzione esclusivamente militare. [7]Lo stesso papa Urbano II nella bolla del 3 giugno 1091, indirizzata all'Abate Ambrogio a proposito di Lipari dice “che è stata ridotta quasi a deserto”[8] . Le cause di questa desertificazione sarebbero state oltre alla recrudescenza dei fenomeni vulcanici, di cui abbiamo detto, le varie incursioni degli arabi a cominciare dalla prima metà del IX secolo e quindi la loro occupazione (anche se probabilmente saltuaria).
La tesi di una lipari popolata che conviveva con gli Arabi
 Palermo. San Giovanni degli eremiti
Palermo. San Giovanni degli eremiti
Giuseppe la Greca, commentando il testo di Mons Tronci, di cui abbiamo detto, sulla spedizione pisana del 1035 a Lipari, osserva: “possiamo dedurre che gli uomini impegnati nell'attacco e nell'assedio vanno da un minimo di 1.200 ad un massimo di 2.000. Per utilizzare un contingente così numeroso, è da ipotizzare che l'isola dovesse avere una guarnigione consistente ed una cospicua presenza di popolazione dedita all'agricoltura. La popolazione liparese, inoltre, non era certamente confinata soltanto a Piano Greca ma doveva essersi distribuita nelle zone agricole a ponente dell'isola, già occupate in epoca greca, ed in minima parte risiedere nelle immediate adiacenze della Chiesa di San Bartolomeo nell'area conosciuta oggi come 'Sopra la terra'.”[9].
La Greca eccepisce anche alla tesi di una dominazione araba sull'isola particolarmente repressiva. “La Sicilia con la conquista araba – osserva -, rifiorì sia economicamente che culturalmente e godette di un periodo lungo di pace e prosperità. Nulla vieta di pensare che lo stesso modello si sia proposto nel caso dell'isola di Lipari (…). Ai liparoti, inoltre, venne tollerata la libertà di culto consentendo di raggiungere agevolmente[10] la Chiesa dedicata a san Bartolomeo, collocata sulla costa, nel sito oggi occupato dalla Cappella di San Bartolomeo e dalla Chiesa di San Giuseppe. La continuità del culto di San Bartolomeo, dopo la traslazione delle reliquie da parte dei Beneventani, conferma la presenza di una comunità, certamente superiore alle 250 unità in grado di preservare usi e costumi antecedenti all'invasione saracena. Possiamo ipotizzare un discreto incremento demografico nel periodo di pax araba”[11].
D'altronde lo stesso Iacolino[12] considerando alcuni testi arabi[13] e scritti di Kislinger[14] e Golb[15] riconosce che nell'epoca della dominazione araba il porto di Lipari abbia continuato ad essere frequentato anche se la città, a suo avviso, doveva essere “quasi del tutto spopolata” e conclude “uno studio più specifico su tale argomento, e il rinvenimento di atri eventuali documenti potrebbero riservarci straordinarie sorprese”.
Un presidio militare arabo sulla rocca

Comunque allo stadio attuale delle conoscenze e facendo riferimento alla situazione che trovarono i benedettini ci sembra di poter concludere che per gli arabi Lipari era soprattutto un presidio militare. Infatti rabberciarono al meglio le fortificazioni della rocca, sul ciglio orientale innalzarono tre torrette di avvistamento e un’altra, quadrata e più imponente, la edificarono sulla porta di accesso che chiamarono Torre di Medina. Altri reperti risalenti a questo periodo non ci sono rimasti. Probabilmente convissero con i liparesi di Piano Greca e forse anche di un piccolo insediamento “Sopra la terra” e di qualche altra fattoria sparsa nelle campagne, credibilmente fra le due comunità si stabilirono relazioni di tolleranza, ma, quasi sicuramente, continuarono a vivere separate.
[1] L. Bernabò Brea, Le isole Eolie dal tardo antico..., op.cit., pag.32.
[2] G. Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla rifondazione della communitas eoliana alla battaglia di Lipari del 1339, Lipari 2001, pag. 16.
[3] S.Greco, Messina medioevale e moderna. Dai normanni ai Borboni, Messina 1998, pag.9 nota 3.
[4] S.Greco, idem, pag.10.
[5] L. Bernabò Brea, Le isole Eolie dal tardo antico..., op.cit., pag. 31;
[6] G.Iacolino, Le isole Eolie...Dalla rifondazione..., op cit., pag. 41.
[7] G.Iacolino, Le isole Eolie...Il primo millennio..., op.cit., pag. 225 e ss; G.Iacolino, La fondazione della Communitas eoliana agli albori della rinascenza (1095-1995), Lipari 1955..
[8] G. Iacolino, idem, pag. 38.
[9] G.La Greca, Lipari al tempo degli arabi, op.cit. Pag. 42.
[10] Vittorio Giustolisi ipotizza in “Lipari bizantina” che con l'avvento degli arabi i cristiani che prima occupavano il Castello e le pendici limitrofe si siano trasferiti proprio “Sopra la terra”.
[11] G. La Greca, Lipari al tempo degli arabi, op.cit. Pag. 43. Questa tesi di una convivenza pacifica fra arabi e liparesi è sostenuta pure da Pino Paino in “La vera storia di Lipari”( 1996) che aggiunge come anche sotto i normanni gli arabi non mancarono di svolgere attività culturali tanto che re Ruggero aveva affidato ad Edrisi l’incarico di geografo ufficiale e furono proprio gli architetti arabi, che sempre nell’età normanna realizzarono a Palermo gli splendidi palazzi della Zisa. Luciano Catalioto in “Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194)”( Messina 2007), riconosce , con particolare riferimento al Valdemone, che “ un clima di tolleranza sarebbe subentrato nei rapporti tra i dominatori mussulmani ed i monaci rimasti entro il territorio insulare, contro i quali non pare si verificasse alcuna persecuzione sistematica; i monasteri ubicati nell'area pattese, che i Normanni trovarono attivi al loro arrivo in Sicilia, seppure ridotti sotto il profilo patrimoniale, disponevano infatti di ampi margini di autonomia ed esercitavano probabilmente diritti di signoria sulle terre che possedevano” (pag. 36).(Archivio Storico Eoliano.it)
[12] G. Iacolino, Le isole Eolie...Il primo millennio...., op.cit. Pag. 231-234.
[13] Ibn-Khurdadhbih, Libro delle vie e dei regni, Biblioteca Geographorum Arabicorum, Leida, 1889,vol,VI.
[14] E. Kislinger, Le isole Eolie in epoca bizantina e araba, in “Archivio storico messinese”, n. 57, Messina 1991.
[15] N.Golb, Aspects of Geographicl knowledge among the Jews Earlier Middle Age, in “Popoli e paesi nella cultura altomedioevale”, I-II Spoleto, 1983.
Torre di MedinaLipari non è più diocesi autonoma
Quando un vescovo segna un'epoca

Mons. Re a Marina corta con sacerdoti e fedeli in partenza per un pellegrinaggio.
E’ indubbio che mons. Re avesse della simpatia per il fascismo. Già nel discorso per la riapertura della scalinata per la Cattedrale, con una enfasi indubbiamente cara al regime, affermava “Camice Nere, voi avete ridato alla chiesa la strada maestra con calce impastata col vostro sudore e col vostro sangue; ma avete fatto di più: avete dato la prova che voi sapete trovare il tempo per fare del bene oltre i limiti di ciò che costituisce il vostro stretto dovere[1]”. Ed in questa stessa direzione vanno l’impegno per la raccolta dell’”oro alla Patria”, per la “battaglia del grano”, la partecipazione alla manifestazione per Mussolini a piazza Venezia il 9 gennaio 1938. Mons. Re era anche un uomo dalle idee molto conservatrici soprattutto a proposito delle donne.
“La donna, madre sposa, figlia,- scriveva nella lettera pastorale del 19 marzo 1930 sulla “procacità della moda femminile” - che dovrebbe essere arcangelo difensore del santuario domestico, forza moderatrice degli ardimenti dell'uomo, giglio di purezza nell'aiuola della famiglia, si è fatta schiava di una dea capricciosa e volubile: la moda. Sotto la ferula di questa tiranna, voluttuosa e corruttrice, la donna ha piegato il collo, si è sottoposta a tutte le torture, le ha sacrificato il candore, la dignitosa compostezza, la forza conquistatrice della sua modestia pavida e contegnosa e si è mostrata in pubblico come una provocante ballerina, con veste che dovrebbe cominciare là dove finisce; con scollacciature tagliate fine alle scapole, con gli omeri denudati e con gonnelle e corpetti così aderenti che lasciano intravedere le linee del corpo”.
Ma sia sul piano politico che anche su quello morale non si trattava di posizioni ideologiche. Amava l’Italia e credeva che il fascismo fosse la risposta giusta ai suoi problemi e sul piano dei costumi era fortemente condizionato da una cultura dominante allora non solo nel mondo ecclesiastico ma anche in ambienti laici. Una cultura decisamente “maschilista”, si direbbe oggi, ma che allora, in quel clima, sembrava del tutto naturale soprattutto da parte di un vescovo.
Ma siccome Mons. Re era un uomo riflessivo e di cultura, che non disdegnava di incontrare anche persone che avevano problemi col regime e si trovano a Lipari al confino - come il magnate della finanza Riccardo Gualino e l’etiope Ras Immirù, con i quali amava conversare - non è improbabile che molti dubbi sulla bontà del fascismo gli si ponessero alla mente proprio in quegli incontri e che poi i fatti delle leggi razziali ed il conflitto del regime con la chiesa a proposito dell’Azione cattolica, a cui era particolarmente legato, glieli avessero fatti approfondire.
Il fatto è che non ebbe remora alcuna a collaborare, per il bene del suo popolo, come abbiamo già avuto modo di vedere, prima col governatore inglese e dopo con i politici della democrazia.

Mons. Re con Madre Florenzia Profilio nel 50° anniversario dell'Istituto delle Suore.
Dedicò la prima parte degli anni 50 a visitare gli immigrati eoliani prima negli Stati Uniti e poi in Australia. Negli Stati Uniti fu a Brooklyn che allora era la città dove si concentrava la maggior presenza di eoliani e soprattutto di loro associazioni e confraternite. In Australia incontrò gli eoliani di Sidney e di Melbourne.
Per tutti gli anni 50 continuò a svolgere il suo ministero in particolare con le sue lettere pastorali e le omelie declamate col suo timbro di voce penetrante nella Chiesa della Cattedrale. E se ancora nel 1950 lo si poteva incontrare per le strade di Lipari e delle isole, in visita alle parrocchie su un asinello, nel 1956 si convertì anche lui all’automobile e cominciò a girare per Lipari con una 600 blu che gli aveva regalato il papa Pio XII.
L’ultima battaglia per la sua diocesi la combatterà nel giugno del 1961 quando sulla stampa si diffuse la voce che il Vaticano stava pensando ad una ricomposizione delle diocesi della provincia di Messina e che probabilmente la piccola diocesi di Lipari e la prelatura di S. Lucia del Mela sarebbero state soppresse a favore di una nuova diocesi che avrebbe avuto come sede Barcellona Pozzo di Gotto, una cittadina che era cresciuta negli ultimi anni, oppure la città di Milazzo. Mons. Re legge la notizia sulla Gazzetta del Sud e subito scrive a mons. Carpino, assessore della Congregazione Concistoriale ricordandogli che Lipari è, per fondazione, la quinta diocesi della Sicilia che senso avrebbe avuto, dopo diciotto secoli gloriosi chiamarla “diocesi di Milazzo”? E la risposta del prelato romano fu allora rassicurante.
Quando morirà all’inizio del 1963 sembrò che un’epoca si fosse chiusa per le Eolie. Un’epoca, con i suoi drammi ed i suoi problemi, vissuta nell’austerità. Ora se ne apriva un’altra completamente diversa e non era certo l’austerità la sua cifra.

L'ultimo viaggio a Lipari di Mons. Re
Gli ultimi vescovi di Lipari
Il 21 marzo gli successe mons. Salvatore Nicolosi da Pedara che il 23 giugno faceva il suo solenne ingresso in diocesi. Mons. Nicolosi riprense l’antico progetto di mons. Ideo di costruire una Cattedrale nella città bassa vicino al palazzo vescovile. Fece stendere il progetto completo di locali parrocchiali e riuscì ad ottenere anche un finanziamento dal Governo. Ma la Sovrintendenza aveva vincolato tutta l’area come “zona archeologica” perché proprio nell’area dove si voleva costruire vi erano le terme romane, più volte dissepolte e poi sempre risepolte.
Il 18 giugno 1970 mons. Nicolosi verrà trasferito a Noto anche se resterà Amministratore apostolico di Lipari fino all’1 novembre 1972. Quando va via nessuno sa che sarebbe stato l’ultimo vescovo di Lipari. Infatti l’1 novembre 1972 verrà sostituito da Mons. Salvatore Di Salvo col titolo però di Amministratore apostolico che rimarrà a Lipari fino al 10 dicembre 1976. Il 10 dicembre 1977 mons. Ignazio Cannavò, Arcivescovo di Messina, viene nominato anche vescovo di Lipari, ed il 16 novembre 1981 sarà mons. Domenico Amoroso, vescovo ausiliare di Messina, a venire assegnato alla diocesi di Lipari.

Il Vescovo Nicolosi inaugura reparto ospedale
Il fatto che negli ultimi anni si avvicendassero nomine che tendevano ad evitare che la diocesi di Lipari avesse un vescovo proprio, faceva presagire quello che il 30 settembre sarebbe divenuta una realtà, quando l’Arcivescovo di Messina, mons. Cannavò diede esecuzione al Decreto di unificazione della diocesi di Lipari con quella di Messina e con la Prelatura di S. Lucia del Mela.
Finiva così la storia millenaria dell’autonomia di una diocesi.
Mons. CannavòI servizi sociali nelle Eolie negli anni 70
La qualità della vita nelle isole

L'ospedale di Lipari.
Nel momento in cui, nel bene e nel male, l’economia eoliana si mette in moto, quale è la situazione più complessiva della qualità della vita nell’arcipelago? Come si presentano in particolare due servizi cruciali come il sistema scolastico e quello sanitario? In linea generale possiamo dire che proprio la strutturazione dell’arcipelago molto frammentata in isole e borgate produce due effetti : la polverizzazione dei servizi scolastici e la concentrazione di quelli sanitari con il risultato che i costi gestionali finiscono col non ripagare i “ricavi sociali”.
A metà degli anni ‘80[1] le distanze tra le isole e le regioni vicine si era significativamente ridotta per via dell’introduzione di aliscafi veloci, con un effetto positivo sull’isolamento ma non sull’emarginazione soprattutto delle isole minori che non avevano collegamenti giornalieri ed in inverno spesso rimanevano, e rimangono, isolate a causa delle avverse condizioni meteo marine. Particolare era la situazione di Alicudi il cui centinaio di abitanti, non avendo l’isola ancora l’approdo per gli aliscafi, accadeva che rimanesse isolata anche per lunghi periodo.
Cominciamo col servizio scolastico che è quello che si modella sulla intelaiatura degli insediamenti abitativi che nell’arcipelago erano 19 centri abitati e 16 nuclei e, soprattutto per la scuola elementare che è quella che deve cercare di offrire un servizio il più possibilmente generalizzato, la frammentazione diventa praticamente polverizzazione.

Il sistema scolastico
Per l’anno scolastico 1984-85 le scuole materne funzionanti nell’arcipelago risultavano essere 13 con 19 sezioni e queste erano presenti in tutte le isole, esclusa Alicudi. L’isola di Lipari contando 250 alunni sui 398 dell’arcipelago deteneva oltre il 45% delle scuole e quasi il 60% delle sezioni. Tutti gli alunni iscritti figuravano frequentanti, ma non tutti erano ospitati in plessi scolastici : solo 4 scuole ( 8 sezioni) occupavano insediamenti scolastici, le restanti 9 (11 sezioni) erano sistemate in case private. Le aule erano sufficienti ma non per tutte era soddisfacente l’indice di affollamento - cioè il numero di studenti per aula -, specialmente in alcune delle sezioni collocate in case private a causa della modesta ampiezza delle stanze. Insufficiente risultava essere anche il livello di igiene, soprattutto nelle scuole materne delle piccole isole, dove il personale ausiliare era solitamente assunto con contratto a termine, per cui per periodi di tempo anche non brevi non essendo sempre tempestiva la nomina questo aspetto finiva per essere trascurato.
Più complessa era naturalmente la situazione delle elementari perché le scuole cercavano di raggiungere anche luoghi abitati abbastanza periferici. Magari, sotto forma di pluriclasse, come Monte Pilato, Serra e S. Margherita a Lipari e Lingua e Rinella nell’isola di Salina. Anche nelle restanti isole – con l’eccezione dei centri di Malfa, Leni e S. Marina Salina, che sommavano 13 classi – prevalevano le pluriclassi. Non mancavano scuole con aule piccole, spesso umide e buie, e frequenti erano i casi in cui i servizi igienici erano rudimentali e sistemati all’esterno. Oltre il 50% delle scuole elementari si trovavano in case private. L’indice più elevato di affollamento apparteneva alla scuola elementare di Lipari centro (18,64), seguita da Lipari Canneto (12,64) e da Malfa(11,2). Gli indici di affollamento delle aule nelle pluriclassi delle case private si mantenevano inferiori a 10. La situazione igienico sanitaria presentava i medesimi caratteri di precarietà delle scuole materne.
Differente era invece la situazione per le scuole medie dell’obbligo. Ad Alicudi, Filicudi, Panarea ed Acquacalda di Lipari non vi erano scuole medie ma venivano organizzati, per i pochi ragazzi residenti, dei Centri di Preparazione Esami (C.P.E.), cioè delle pluriclassi affidate ad un insegnate unico o a due docenti che da novembre a maggio preparavano gli alunni agli esami. A Lipari centro risultava attivo anche un corso sperimentale per lavoratori. Anche nelle scuole medie inferiori l’indice di affollamento si manteneva abbastanza basso con punte massime a Lipari centro (20,58) e con il minimo a Pianoconte (10). Qui la presenza di 37 alunni non frequentanti su 616 iscritti metteva in mostra che dopo i dieci anni, cominciavano ad avvertirsi condizionamenti di ordine economico legate a forme di lavoro minorile e chiusure di tipo sociale e culturale come la scarsa considerazione nelle famiglie più popolari dell’elemento istruzione.

La scuola elementare di Lipari
Le scuole medie superiori comprendevano un Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e un Liceo Scientifico entrambi a Lipari e confermavano la funzione polarizzante esercitata da questo centro urbano sull’intero arcipelago. L’indirizzo per ragionieri era il meno recente ed il più frequentato; nell’anno scolastico 1984-85 rappresentava il 71% dell’intera popolazione scolastica superiore. I due indirizzi tecnici erano ospitati nel medesimo plesso scolastico originariamente costruito per una sezione dell’indirizzo ragionieri. Le cinque aule erano state suddivise in due vani ciascuna e successivamente altre stanze erano state “convertite” in aule, senza riuscire a superare la cogestione. Il Liceo era di più recente attivazione non era ancora autonomo ma operava come sezione distaccata del Liceo di Milazzo. Era composto da una sola sezione ed accoglieva il 12% della popolazione scolastica superiore. La scuola, ospitata in locali di proprietà comunale, si presentava in scadenti condizioni ed era sprovvista di ogni infrastruttura di base ( palestra, laboratori, biblioteca…).
Il servizio sanitario
Il servizio sanitario nelle isole Eolie era affidato alla Usl 44 e coincide con l’arcipelago. La deroga al numero minimo degli abitanti di riferimento è derivata proprio dalle peculiarità della vita insulare. E proprio la deroga al tetto di 30 mila abitanti, ha portato a concentrare nell’isola di Lipari i servizi sanitari primari come l’ospedale – il nuovo Ospedale civile di via San’Anna era stato inaugurato il 28 ottobre 1940 in pieno periodo bellico - e il pronto soccorso mentre nelle altre isole si provvedeva all’assistenza sanitaria di base tramite le guardie mediche. Il servizio sanitario ruotava di fatto intorno al presidio di Lipari attrezzato con cinque reparti – medicina generale, malattie infettive, chirurgia, ginecologia e ostetricia, pediatria e neonatologia –, due servizi – anestesia e pneumologia -, tre sezioni – emodialisi, radiologia e analisi cliniche- ed una dotazione di 150 posti letto.
Per la situazione delle altre isole risultavano funzionanti 10 ambulatori attrezzati per servizi di primo intervento e di medicina di base, ma questi non corrispondevano ad altrettanti posti di guardia medica: a Salina, per esempio, vi era un solo medico per tre ambulatori, mentre a Stromboli due medici per due ambulatori poiché fra il centro principale e il nucleo di Ginostra non c’è collegamento via terra.
Questo tipo di struttura che riscontro aveva sulla qualità della salute degli eoliani? L’indagine a cui abbiamo fatto riferimento assumeva i dati di mortalità come primo indicatore.E questo tasso nel 1984 nelle Eolie era del 9 per mille e quindi nei limiti della normalità. A Lipari risultavano sette decessi per “liparosi”, una malattia che ancora nel 1984 colpiva i lavoratori della pomice anche se in misura minore del passato.

[1] Facciamo riferimento ai dati della ricerca di cui disponiamo e cioè quella dei professori A. Pipino e C. Cavallaro “I servizi sociali bell’arcipelago eoliano: istruzione e sanità attraverso l’uso di indicatori”, in, L’approccio interdisciplinare nelle ricerche sull’arcipelago eoliano, a cura di G. Giavelli e A. Moroni, 1987 Parma pp. 105- 116(Archivio Storico Eoliano.it)
OspedaleIl turismo ed oltre il turismo negli anni 70
La vocazione turistica delle singole isole

Alla fine di questa convulsa fase di sviluppo, intorno alla metà degli anni 80, come si qualificano le diverse isole nei riguardi del turismo? Cominciamo da Lipari che richiama circa il 50% dei flussi che si dirigono alle Eolie. Lipari attira nel suo territorio due tipi di turismo: sia quello di tipo residenziale amante della natura e della cultura ma che non riesce a rinunciare alle opportunità offerte dalla civiltà urbana anche se qui percepita in misura ridotta; sia quello di transito dove l’isola svolge la funzione di centro logistico e di smistamento per escursioni nelle altre isole dell’arcipelago. Il risultato è stato che Lipari ha dedicato molto del suo territorio sia agli alloggi che ai servizi privati e pubblici e questo ha inciso profondamente sul paesaggio. All’inizio degli anni 80 il turismo costituiva la componente più importante dell’organizzazione dell’isola ma non la sola. Infatti a Lipari si avvertiva l’importanza delle cave di pomice e della pesca.
Vulcano. Il villaggio francese all'inizio degli anni 50
Cosa che non esisteva a Vulcano dove tutta l’organizzazione economica ruotava introno al turismo. Un turismo soprattutto residenziale, da seconda casa ed in quegli anni furono molti i borghesi siciliani che comperarono un alloggio o fra il verde di Vulcanello, o lungo la spiaggia di Ponente, o sull’altopiano di Lentìa. A questo turismo residenziale si aggiungeva una sorta di turismo pendolare nelle domeniche e giorni festivi di gente che dalla costa tirrenica veniva a trascorrere una giornata nell’isola spalmandosi il fango sulla pelle e camminando avanti e dietro per le spiagge ostentandolo come un cimelio. Vulcano, l’isola selvaggia della Magnani, a distanza di pochi decenni si qualifica come l’isola dell’improvvisazione e della speculazione per eccellenza che avrà anche portato benessere alla popolazione locale ma con uno spreco di risorse naturali ed ambientali veramente impressionante. Così all’inizio degli anni 80 a Vulcano Porto si concentrano caratteri che non sono certo quelli di un turismo naturalistico e di qualità: abbondanza di cemento, rumori e traffico, scempi paesaggistici. A Vulcano, - scrive Raffa – per costruire ed aprire piste, sono state sventrate formazioni di zolfo e di allume; sono stati distrutti o asportati prodotti vulcanici caratteristici, come le ‘ bombe a crosta di pane’, sono state spianate e sbriciolate rocce di forme particolari o è stato sbarrato l’accesso che vi conduce, come per la ‘Valle dei Mostri’ nella penisoletta di Vulcanello; si è costruito fin sul demanio marittimo”[1].

Anna Magnani in una scena del film Vulcano
Eppure nonostante questo, in quegli anni, proprio Vulcano poteva vantare di raccogliere una fetta cospicua, il 25%, dei flussi delle Eolie.
Stromboli invece veniva al terzo posto con il 13 %. E’ un centro turistico residenziale ma qui il paesaggio non ha subito, in quegli anni, violente trasformazioni. Naturalmente non mancano anche qui improvvisazione, abusivismo, speculazioni ma proprio il grande patrimonio edilizio abbandonato – come abbiamo sottolineato - dagli isolani in fuga sul finire degli anni ’40 ha frenato il proliferare di nuove costruzioni. Anche a Stromboli ormai il turismo è tutto anche se c’è da dire che non sono stati opportunamente sfruttati, con centri di interesse organizzati, né la storia del vulcano con i suoi fenomeni, né i luoghi immortalati da Rossellini e dalla Bergaman. L’attenzione al turismo più che volta a promuovere servizi culturali era diretta soprattutto alla ricettività ed alla ristorazione.
 A Panarea, invece, gli abitanti sono rimasti per lungo tempo spettatori dello sviluppo turistico dell’isola affidato appunto all’intraprendenza di persone venute da fuori e soprattutto, come abbiamo detto, dal nord Italia. A partire dagli anni ’60 sono stati infatti i nuovi proprietari delle seconde case a dettare le linee di gestione del territorio, tese alla “conservazione” dell’integrità della natura, requisito indispensabile per il loro soggiorno, arrivando persino ad osteggiare l’introduzione di servizi importanti – soprattutto per chi nell’isola doveva viversi tutto l’anno – e cioè la luce elettrica ed il telefono.
A Panarea, invece, gli abitanti sono rimasti per lungo tempo spettatori dello sviluppo turistico dell’isola affidato appunto all’intraprendenza di persone venute da fuori e soprattutto, come abbiamo detto, dal nord Italia. A partire dagli anni ’60 sono stati infatti i nuovi proprietari delle seconde case a dettare le linee di gestione del territorio, tese alla “conservazione” dell’integrità della natura, requisito indispensabile per il loro soggiorno, arrivando persino ad osteggiare l’introduzione di servizi importanti – soprattutto per chi nell’isola doveva viversi tutto l’anno – e cioè la luce elettrica ed il telefono.
A Salina, il turismo, benché si sia manifestato solo a partire dagli anni 70, sul finire degli anni 70 e l’inizio degli anni 80 ha mostrato di poter diventare un polo di attrazione determinante accentuando la sua qualità di “isola verde” una immagine che ormai né Vulcano, né Lipari potevano più offrire. E certamente l’esempio proprio di queste isole ha prodotto nella consapevolezza dei salinari un netto cambio di prospettiva nei confronti di certe tendenze, che come abbiamo visto, pure a metà degli anni 70 si erano cominciate e manifestare nell’isola.
La scelta di un turismo che tenesse conto dell’ambiente naturale con una tendenza all’edilizia turistica “sparsa” e non “concentrata” in voluminosi impianti, si è evidenziata in particolare nell’iniziativa dell’agriturismo che in quegli anni si propose a Malfa con buoni risultati. A Salina si può dire che il turismo ha avuto un effetto meno stravolgente sull’agricoltura. Non è mancato anche qui un certo esodo agricolo, ma l’intreccio fra la crescente domanda turistica con il rilancio della malvasia ha sollecitato un miglioramento ed incremento della cultura della vite.
Ma se la vocazione turistica a Salina seppure tardiva si manifesta molto veloce dimostrando non solo una volontà di recupero ma anche una capacità di saper fare tesoro degli errori degli altri, in quegli anni Filicudi ed ancora più Alicudi rimangono ai margini del fatto turistico assorbendo rispettivamente l’1,3% e lo 0,2% del flusso nell’arcipelago. E questo malgrado il tentativo di farne luogo di soggiorno obbligato per i presunti mafiosi fosse fallito e l’evento della rivolta avesse destato una certa curiosità ed attenzione.
Avrà influito certamente la loro perifericità che ha scoraggiato l’intervento di investitori forestieri e così si è dovuto aspettare che maturassero nei locali la cultura e le risorse per fare degli investimento nelle attività ricettive e nella ristorazione.
Anche qui, come per Panarea, hanno svolto un certo ruolo turisti che hanno cercato di imporre le loro logiche elitarie calando le loro esigenze su quelle della popolazione locale ed in qualche modo condizionandola.
Le altre risorse: l'inustria della pomice

Di tutti i settori economici del territorio comunale di Lipari, sul finire degli anni 70, quello che è in forte crescita insieme al turismo ed all’industria della pomice, è il settore dell’edilizia coerentemente con una prospettiva di turismo basata sulle costruzioni e le speculazioni. Le imprese locali del settore erano a metà degli anni settanta 23 con 150 dipendenti contro le 10 imprese edilizie non locali con 120 dipendenti; se ci riferiamo a Vulcano la maggior parte degli imprenditori che operavano nell’isola importavano mano d’opera dalla Sicilia,[2] Per l’edilizia a cominciare da quella abusiva il turismo ha fatto da volano, come anche per il commercio ed i servizi[3]. Nessuna influenza invece il turismo ha avuto sull’industria della pomice, a meno di fare riferimento al prodotto adoperato nell’edilizia locale soprattutto con la fabbricazione di blocchi per le costruzioni, che comunque rappresentava una percentuale minima rispetto alle centinaia di migliaia di tonnellate esportate.
A metà degli anni 70 alla lavorazione della pomice si dedicavano la Pumex spa di Canneto, la Italpomice di Acquacalda e la Cooperativa San Cristoforo di Canneto. Le prime due lavoravano per il 75% circa per l’esportazione, mentre la cooperativa si occupava solo di produzione. La Pumex era sorta nel 1958 dalla graduale fusione di diversi gruppi imprenditoriali che nel passato avevano concessioni per lo sfruttamento del giacimento. La Italpomice, che sfruttava le cave di Acquacalda, era stata costituita nel 1956 dal tedesco H. Leonholdt, dopo che la famiglia Saltalamacchia cedette cave e impianti di lavorazione.

In alto la Bergman in una delle scene drammatiche e conclusive del film "Sreomboli, terra di Dio". Qui sopra la locandina del film.
Dopo la crisi della prima guerra mondiale il commercio ebbe una ripresa nel 1922 con 27.221 tonnellate di materiale esportato e un andamento favorevole, per il crescente impiego nell’edilizia. Questo fino al 1940 quando la produzione fu di 41.801 tonnellate.
Nel secondo conflitto mondiale l’industria della pomice subì la stessa sorte delle altre industrie.
Agli inizi degli anni 50 l’esportazione si intensificò e nel 1953 si raggiunsero le 114.840 tonnellate pur essendo allora caratterizzata la produzione da modeste aziende individuali che operavano con mezzi tecnologici e impianti rudimentali. Cominciò allora un lento processo di aggregazione nella Pumex delle aziende Th. Ferlazzo, F. La Cava, Eolpomice e Angelo D’Ambra.
Nel 1969 si esportarono 496.999 t di pomice di varie qualità. Cioè la produzione in sedici anni si era pressoché quadruplicata sia per miglioramenti produttivi sia per la ricerca di nuove strade commerciali. Fra il 1969 ed il 1976 la produzione avrà degli alti e bassi oscillando fra le circa 600 mila tonnellate del 1972 e le poco più di 200 mila del 1975. In questi anni cambiano anche i mercati di esportazione e nel 1976 l’area del mercato comune europeo soppianta gli Usa come principali importatori della pomice di Lipari mentre al terzo posto si attestano sempre i paesi africani. Sulla riduzione delle importazioni dagli Usa ha influito la crisi internazionale di quel periodo ma anche la concorrenza della pomice greca che era favorita sia sul piano fiscale che su quello del costo della manodopera.
Nel 1977 lavoravano nell’industria della pomice 226 persone la grande maggioranza nella Pumex: 186 contro i 29 dell’Italpomice e gli 11 della Cooperativa S. Cristoforo. Altre 250 persone erano addetti ad attività complementari.


Ma c’era un problema che immediatamente non venne avvertito. Era cambiato il procedimento di estrazione per lo sfruttamento dei giacimenti. In passato l’estrazione avveniva a cava, a taglia e in galleria. L’estrazione a cava consisteva nel praticare ampie buche nel terreno, entro un’area più convenientemente sfruttabile. L′estrazione “a taglia” veniva praticata in superficie, a cielo aperto, per la produzione dei materiali pomicei più comuni e di minor valore commerciale quali, ad esempio, i “lapilli”, pomice ricca di impurità. I cosiddetti “tagliaroli”, coordinati dal capo-taglia, scalfivano la montagna sino a realizzare tre o quattro buche profonde un paio di metri , poste l′una accanto all′altra. Si formava così un grande “ritaglio” di roccia che, sfruttando la naturale pendenza del terreno, veniva fatto “precipitare” verso il basso. Il colpo d′asta decisivo veniva inflitto dal capo-taglia, il più esperto nel riconoscere i punti deboli della roccia e l′esatto momento del crollo definitivo. L’estrazione “in galleria” infine veniva praticata da cavaioli specializzati che, attraverso gallerie, si spingevano all’interno dei giacimenti.
Ora invece il sistema di scavo veniva effettuato attaccando il giacimento per piani orizzontali, dall’alto verso il basso, con ruspe, che spingono il materiale in tramogge ricavate nel corpo della montagna stessa e dal cui fondo, attraverso apposite bocchette di scarico, l’escavato precipitava su un nastro trasportatore che lo convogliava ai canali di produzione.
Certamente questo metodo di lavoro riduceva i rischi di infortuni rispetto a quando si lavorava con picconi e zappe di ferro operando in cunicoli o gallerie o provocando degli smottamenti, ma l’impatto ambientale era di molto più rilevante. I bulldozers operando dall’alto verso il basso affettavano la montagna come un cosciotto di prosciutto cambiandole completamente fisionomia e, a lungo andare, questa attività non poteva non entrare in conflitto con un territorio che voleva sviluppare la sua vocazione turistica, soprattutto se questo turismo doveva essere di tipo naturalistico e legato, per buona parte alla vicenda dei vulcani[4].
E il termalismo?
Un rapporto virtuoso fra turismo e termalismo è sempre stato nelle aspirazioni degli eoliani ma questo processo non si è mai potuto attuare pienamente.

Per quanto riguarda le Terme di San Calogero[5], dopo la gestione Mancuso lo stabilimento è passato nelle disponibilità del Comune che lo gestiva attraverso l’ufficio Ragioneria. Funzionava per stagioni termali di 92 giorni che andavano dall’1 luglio al 30 settembre e vi lavoravano 4-5 persone. Lo stabilimento continuava ad essere carente di luce elettrica e telefono che verranno istallati solo nel 1968. La strada di collegamento con la frazione di Pianoconte verrà completata nel corso del 1964.
Mancava un adeguato impianto di smaltimento reflui e l’acqua corrente per usi umani.
Nel corso degli anni ’60 i pazienti curati durante la stagione estiva si aggiravano intorno ai 150 che era il massimo che lo stabilimento poteva ospitare nelle camere a disposizione. Malgrado i rilievi avanzati dal medico-sanitario il Comune non operava alcun intervento di riqualificazione mentre l’assistenza si rilevava insufficiente, il telefono non funzionava e il trattamento di cucina risultava pessimo. E sarà proprio il peggiorare delle condizioni igienico sanitario che a metà degli anni ’70 porterà alla chiusura delle terme.
Giustamente Pino La Greca osserva che più che una chiusura si tratta di un abbandono infatti l’impianto viene utilizzato per alcuni anni come bivacco da parte dei turisti e dopo il 1978 l’Amministrazione ci collocherà i terremotati.
 Nel 1983 l’Assessore al Turismo della Regione Siciliana firma il decreto di finanziamento per l’importo di un miliardo. Si decide di dare il via ai lavori malgrado la somma sia insufficiente e la portata dell’acqua della fonte è di 25 litri/minuto mentre era preventivata una portata di 104 litri/minuto. La nuova costruzione stravolge completamente l’antico edificio. Quando nel 1994 i lavori verranno consegnati l’Amministrazione comunale scopre che per potere diventare operativo l’impianto ha bisogno di tutta una serie di importanti supporti ma soprattutto ha bisogno di conoscere su quale volume di acqua termale si può far conto.
Nel 1983 l’Assessore al Turismo della Regione Siciliana firma il decreto di finanziamento per l’importo di un miliardo. Si decide di dare il via ai lavori malgrado la somma sia insufficiente e la portata dell’acqua della fonte è di 25 litri/minuto mentre era preventivata una portata di 104 litri/minuto. La nuova costruzione stravolge completamente l’antico edificio. Quando nel 1994 i lavori verranno consegnati l’Amministrazione comunale scopre che per potere diventare operativo l’impianto ha bisogno di tutta una serie di importanti supporti ma soprattutto ha bisogno di conoscere su quale volume di acqua termale si può far conto.
L’altro termalismo operante nelle Eolie e molto utilizzato, a partire dagli anni 50 - anche se privo di ogni assistenza e controllo non solo medico ma anche di natura igienica - è quello dei fanghi di Vulcano a cui si accompagnano le fumarole ed il mare che bolle. Fin dall’agosto del 1957 furono richieste concessioni per lo sfruttamento delle acque termali. Ma gli interventi operati dalla ditta Castrogiovanni fra il 1957 ed il 1965 produssero solo una devastazione del territorio nella zona di Porto Levante senza arrivare a nessun risultato utile. Nel 1970 voleva provarci la società Hephaistos ma scatenò una tale reazione che non se ne fece niente. Qualche tentativo di organizzarne in qualche modo l’utilizzo è stato avviato a partire dal 1998, anche qui con forti resistenze da parte di chi voleva che la fruizione rimanesse libera.
L'agricoltura e la pesca
 Più volte abbiamo detto che l’agricoltura, che aveva rappresentato in passato l’attività forte dell’arcipelago, già nel 1950 era ridotta ad una attività praticamente marginale salvo forse per l’isola di Salina. La coltura della vite, importante per la produzione del vino “malvasia” e dell’”uva passa” aveva subìto il tracollo maggiore con la conseguente scomparsa di oltre il 50% delle aziende prevalentemente viticole ed una riduzione della coltura che nel 1970 arriverà a 210 ha.[6]
Più volte abbiamo detto che l’agricoltura, che aveva rappresentato in passato l’attività forte dell’arcipelago, già nel 1950 era ridotta ad una attività praticamente marginale salvo forse per l’isola di Salina. La coltura della vite, importante per la produzione del vino “malvasia” e dell’”uva passa” aveva subìto il tracollo maggiore con la conseguente scomparsa di oltre il 50% delle aziende prevalentemente viticole ed una riduzione della coltura che nel 1970 arriverà a 210 ha.[6]
“L’agricoltura eoliana – scriveva nel 1979 Carmelo Cavallaro – si trova in grave dissesto; pur se il carico umano gravante sulle campagne è diminuito notevolmente in questi ultimi anni, esso deve però essere considerato la causa dell’attuale crisi, determinata, salvo rare eccezioni, dal frazionamento eccessivo della proprietà fondiaria; dall’indirizzo economico delle aziende agricole basate sull’autarchia familiare e quindi su culture non adatte ai terreni; dalla limitata possibilità di lavorazioni meccaniche a causa della morfologia dei terreni; della mancanza di organizzazione commerciale per la trasformazione dei prodotti e dall’eccessivo carico fiscale. A queste cause si aggiunga il miraggio dell’attività turistica e di sicuri guadagni che ha indirizzato ulteriore manodopera verso lavori meno faticosi”[7].
Così il turismo che poteva essere il volano per il rilancio di produzioni di pregio come la malvasia, la passolina ed il cappero, nella versione speculativa che le Eolie hanno conosciuto a partire dagli anni 60, ha finito col dare il colpo di grazia fatale ad un settore in crisi. Dovranno passare diversi anni perché si comincia a ragionare in termini di sinergia fra il turismo e l’agricoltura. Comunque nel 1974 la “Malvasia delle Lipari” diventa doc.
Il turismo certamente ha stimolato la pesca tanto che il naviglio complessivamente è aumentato di 99 unità passando dalle 359 del 1963 alle 458 del 1979. Di queste 458 unità da pesca – barche remo veliche, moto barche e moto pesca – 281 erano concentrate a Lipari, 100 a Salina, 45 a Stromboli, 23 a Panarea e solo 9 a Filicudi. A Lipari erano concentrati anche la gran parte di pescatori: 975 su 1.033 iscritti nelle apposite liste.
Visto che nel 1954 gli iscritti dell’arcipelago erano solo 235 si potrebbe parlare di un incremento notevole di attività. Probabilmente questa crescita però non è dovuta solo al turismo ma anche, osserva Cavallaro, alla facilità di potere usufruire di vantaggi assistenziali e previdenziali. Comunque rimane il fatto che il “consumo locale è aumentato, in particolar modo nel periodo estivo, per la richiesta dei gestori di alberghi, locali pubblici della ristorazione e dai forestieri soggiornanti in case private[8]”.

Questo incremento di consumo e di produzione aveva portato, nel corso degli anni 70, ad un tentativo di autogestione fra i pescatori promuovendo una cooperativa che gestiva il centro ittico di raccolta e smistamento. L’impianto ricettivo accoglieva il pescato dei cooperatori in alcuni locali di proprietà comunale a Marina corta. Il centro ittico contrattava il pescato con i commercianti al dettaglio e con gli incettatori che provvedevano a collocare il prodotto sui mercati di Milazzo, Messina e Palermo. I locali erano inadeguati ad moderno centro di raccolta e fra i pescatori non era matura la cultura della cooperazione. C’era sempre qualcuno che cercava di socializzare le perdite e di privatizzare i profitti. E così alla lunga la cooperativa dovette chiudere.
Proprio fra il 1967 e il 1970 un allarme veniva lanciato dall’Istituto di Zoologia dell’Università di Messina che costatava il progressivo e preoccupante depauperamento dei fondali di gran parte delle isole. La responsabilità veniva attribuita alla pesca di frodo , esercitata in alcune zone su larga scala per inefficienza degli organi di vigilanza e alla pesca sportiva subacquea accusata di causare il progressivo allontanamento delle specie verso zone di maggiore profondità.
Che questa fosse una preoccupazione molto presente lo dimostra la polemica che accompagnò l’organizzazione del IX Campionato di pesca subacquea organizzato nelle Eolie dal 5 al 10 agosto 1969 e che interessò anche giornali nazionali come il Corriere della sera e regionali come il Giornale di Sicilia. La candidatura delle Eolie era stata promossa dalla Azienda turismo delle Isole Eolie che pensava al grande ritorno pubblicitario che l’arcipelago avrebbe avuto visto inoltre che al campionato si era abbinato anche un rally nautico. A questa iniziativa si contrappose un “Comitato per la difesa dell’ambiente delle isole Eolie” costituitosi per l’occasione per iniziativa soprattutto di forestieri che avevano scelto le Eolie come luogo di residenza o di villeggiatura. Il Comitato attraverso lettere a firme di una “cernia bruna” che viveva nei fondali di Panarea, chiedeva che fosse impedita la manifestazione che avrebbe provocato una catacombe di pesci ma anche una distruzione delle loro tane. La manifestazione si svolse lo stesso anche se per la carenza di strutture – porti, banchine, strade, energia elettrica nelle isole minori, mancanza di comunicazioni, punti di rifornimento carburanti,… - essa attirò numerose critiche ed il Notiziario delle isole Eolie la definì questa candidatura “un atto garibaldino”[9].

Una bella cernia bruna
Si cominciò a parlare allora di un parco marino con particolare riferimento a Panarea ed al XIII Convegno nazionale di Italia nostra tenutosi a Roma nel dicembre del 1971 anche di un Parco nazionale delle Isole Eolie per la protezione dell’agricoltura, del mare e dell’ambiente in genere.
[1] A. Raffa, Le trasformazioni ecc., op. cit., pag. 189.
[2] C.Cavallaro, Evoluzione e prospettive della regione turistica…, op. cit., pag. 59.
[3] Tra il 1951 ed il 1971 l’edilizia è passata dal 5,2% al 14,3%, il commercio dal 5,8% al 12,5%, i servizi hanno raggiunto il 10,1%. Pressocché stazionaria l’industria e la pubblica amministrazione, in forte calo l’agricoltura dal 48,3% al 18,5%. In A. Raffa, La trasformazione dell’ambiente naturale…, op. cit., pag. 185.
[4] Nel dicembre del 2000 le isole Eolie sono Patrimonio dell’Umanità, inserite dall’Unesco nell’Heritage List con la seguente motivazione: “I peculiari aspetti vulcanici delle Isole rappresentano in maniera esemplare l’oggetto degli studi della vulcanologia mondiale. Grazie alle ricerche avviate nel XVIII secolo, le isole hanno consentito l’approfondimento dei due tipi di eruzione – vulcaniana e stromboliana – e la trattazione dei temi più importanti della vulcanologia e geologia moderne contribuendo alla formazione di una classe di scienziati in oltre 200 anni di ricerche. Le isole continuano ancora oggi ad essere un ricco terreno di studi e continui processi che ancora stanno mutando l’aspetto del paesaggio e la composizione geologica dell’arcipelago”-
[5] Anche per questa parte continuiamo a fare riferimento al G. La Greca, Le Terme di San Calogero, op. cit. , pp.89 e ss.
[6] C. Cavallaro, Le recenti modificazioni dell’attività agricola e della pesca nelle isole Eolie., in “Annali della Facoltà di Economia e Commercio” dell’Università di Messina, n.2 del 1979.
[7] Idem, pag. 15.
[8] Idem, pag. 25.
[9] Il Notiziario delle isole Eolie, agosto settembre 1969.(Archivio Storico Eoliano.it)

Salvare laLa rivolta di Filicudi
Filicudi, un’isola “trascurata”

Abbiamo visto che Filicudi, insieme naturalmente ad Alicudi, è l’isola che quando ha cominciato a svilupparsi il turismo nell’arcipelago è parsa la più trascurata. Non presentavano l’attrazione dei fenomeni vulcanici e non erano su una rotta così battuta come quella che dalla Sicilia tirrenica porta a Napoli.
Spallanzani scrive che nel 1788 l’isola aveva 680 abitanti mentre nel 1861 ne contava 2025 e nel 1901 1530. Al censimento del 1931 gli abitanti erano 1094 ed il 50% viveva in case sparse ed i rimanenti in agglomerati nei centri di Filicudi Pecorini, Rocca di Ciauli e Valle Chiesa. Nel 1971 a questi nuclei bisognava aggiunger quelli di Filicudi Porto e Canale mentre l’emigrazione crescente aveva determinato lungo il terrazzamento di Seccagni e Zucco Grande uno stato pressoché totale di abbandono. Quasi analoghe situazioni si riscontravano nelle località di Valle Chiesa, Rocca di Ciauli e Pecorini.
Il numero di emigranti tra il 1890 e il 1961 è stato di 920 unità. In un primo tempo l’emigrazione era diretta verso l’America ma a partire dal 1912 e soprattutto dopo il secondo dopoguerra si volse verso l’Australia. Ed è proprio a causa dell’emigrazione che vi è stato l’abbandono delle culture, dove una volta vi erano vigneti che fornivano uve eccellenti. Così se nel passato si producevano 3-4 mila ettolitri di vino, ora, a fine anni 60 non si superavano i 250-300 ettolitri. Così è anche per l’olio per il quale si è passarti dai 1900 quintali del 1930 ai 42,5 di fine anni 60. In regresso anche la produzione del cappero dai 900-1000 quintali l’anno del 193 ai 100.120 q. di fine anni 60. Trascurabile la produzione di cereali.
Sul finire degli anni 60 ovunque si notavano abitazioni abbandonate e lasciate incustodite. La maggior parte della popolazione viveva delle rimesse dai congiunti emigrati e per il resto si adattava a qualunque mestiere.
Qualche risorsa veniva dalla pesca giacchè la fauna ittica era abbondante e ricca di qualità. Di particolare pregio le aragoste anche se sul finire degli anni 60 la loro pesca manifestava una certa flessione. La maggior parte del pescato veniva esportato.
L’isola all’inizio degli anni 70
Prima guida alle Eolie
Alla fine degli anni 60 Filicudi contava solo strade mulattiere che collegavano i vari abitati. Le comunicazioni con le altre isole dell’arcipelago e la Sicilia venivano effettuate con corse trisettimanali da piroscafi della Navisarma e, nel periodo estivo, più frequentemente con motovelieri e barche a motore. Sul finire degli anni 60 fu avviato un servizio di aliscafi che in estate era trisettimanale ma nel resto dell’anno risultava spesso aleatorio.
Quanto al turismo l’organizzazione di Connaisance du Monde avviò all’inizio degli anni 50 molti soci interessati alle pesca subacquea verso Filicudi. Col tempo sorsero due alberghi, uno a Filicudi Porto ed uno a Filicudi Pecorini, e furono attrezzati circa 50 posti letto in case private. Questa nuova attività influì positivamente sull’economia dell’isola anche se il movimento turistico rimase complessivamente modesto. Anzi nel corso degli anni 60 si era registrata una sensibile flessione rispetto ai livelli raggiunti nella seconda metà del decennio precedente[1].
Questa era la condizione di Filicudi quando il 26 maggio del 1971 si verificò quella che fu chiamata “la rivolta di Filicudi”[2] contro la decisione di confinare nell’isola dei presunti mafiosi.
Quel 26 maggio 1971

La mattina del 26 maggio è convocato a Filicudi il Consiglio comunale proprio per discutere di questo problema. All’alba sbarcano a Pecorini con una speciale corsa di aliscafo il Sindaco e diciotto dei trenta Consiglieri. La riunione si tiene nella stanzetta a pino terra dell’albergo Sirena.
Il Sindaco spiega come è nata la vicenda e come l’amministrazione è impegnata a far rientrare il provvedimento. Il Consiglio non dura molto perché non c’è molto da dire e così alle 9,30 il Sindaco ed una parte dei consiglieri riprendono l’aliscafo e tornano a Lipari.
Rimangono sull’isola alcuni consiglieri che temono che la situazione precipiti da un momento all’altro. Intanto alle 10 con un altro aliscafo arrivano da Lipari tanti altri cittadini venuti a dare una mano a chi era già sul posto. Altra gente arriva da Salina e dalle isole più lontane con barche da pesca.
Vitale arriva a Filicudiper discutere con la popolazione.
Che quello sia il giorno fatidico lo si vede subito dopo quando sbarcano a Filicudi porto cinquanta poliziotti in assetto antisommossa con caschi, fucili, manganelli, lacrimogeni. Nessuno si oppone, ma tutta l’isola si mette in allarme ed infatti poco dopo sbarcano anche una quindicina di “presunti mafiosi”. Le campane della chiesa di Santo Stefano suonano a distesa. I filicudesi e la gente venuta da Lipari si avviano correndo lungo i pendii rocciosi verso il Porto. La truppa e i “mafiosi” si sono radunati sotto il tetto incompleto dell’albergo in costruzione mentre la gente si raccoglie vicino alla stradella che conduce a Canale e comincia a rumoreggiare scandendo con le parole il proprio dissenso.
“Ironia strana – commenta l’articolista anonimo del Notiziario – ; questo grosso complesso turistico che dovrebbe avviare Filicudi ad un migliore avvenire viene costruito con il contributo dello Stato – mutuo agevolato della Cassa per il Mezzogiorno – e i primi gratuiti ospiti sono dei ‘presunti mafiosi’. Gentile pensiero e significativa premessa per le fortune turistiche dell’albergo dell’isola[3].”

L’ordine di “caricare”
E’ a questo punto che dalla parte della truppa arriva l’ordine ai militari di assestarsi pronti alla carica contro la folla. Caricare chi e perchè? La gente inerme che protesta solo con la propria voce? Per evitare il possibile scontro fisico la gente comincia a creare con tavole, sedie, masserizie e quant’altro una barricata quasi simbolica. Improvvisamente gli animi si placano e si perviene ad una tacita tregua. I funzionari invitano il proprietario di un piccolo ristorante vicino al porto ad aprire il locale e lì si asserragliano le truppe e i mafiosi.

La manifestazione di Lipari in appoggio ai filicudari.
Così gli uni nella piccola sala del ristorante gli altri al di là della barricata passano due giorni e due notti con la protesta tenuta sotto controllo ed anche con alcuni momenti in cui si fraternizza offrendo ai militari i viveri che erano giunti da Lipari in grande abbondanza. Le notti erano lunghe da far passare con i fuochi accesi, le ombre vaganti come fantasmi, la gente addormentata ai margini della strada.
I contatti col Sindaco erano tenuti attraverso l’unico telefono che si trovava a Canale. In alto sopra il Porto.
Arriva così l’alba del 28 maggio. Verso le 8 e mezza si ferma in rada una nave bianca zeppa di militari e poco dopo arriva un traghetto con altra truppa e tanti mezzi da sbarco, idranti, camions. I camions? Ma dove devono andare se a Filicudi non ci sono strade? E poi contro chi devono combatte?
Abbandonare Filicudi!

Gli abitanti di Filicudi decidono di abbandonare l'isola come forma di protesta.
Era chiaro. Chi aveva ordinato quella operazione non conosceva Filicudi, mancava di buonsenso e non aveva il senso del ridicolo. Se si voleva usare la forza non bastavano i carabinieri di Filicudi?
Di fronte a tanta stupida arroganza non rimaneva che una cosa da fare: abbandonare tutti Filicudi. E fu la decisione che venne presa con dignità, orgoglio e coraggio. I filicudesi raccolgono pochi indumenti, sprangano le porte delle loro case e si imbarcano sui mezzi che erano in porto alla volta di Lipari e tutto questo sotto gli sguardi attoniti e stupefatti dei funzionari, dei militari e dei “presunti mafiosi”.
E quando i filicudesi giungono a Lipari si scatena una gara di solidarietà ad accoglierli, rifocillarli, assisterli.

Lo stesso giorno la notizia della protesta pacifica e coraggiosa di tutti gli abitanti di un’isola si diffuse in tutto il mondo ed il Governo non poté fare altro che revocare il provvedimento. Lo confermò in una riunione a Palermo il Presidente del Consiglio Emilio Colombo ricevendo il Sindaco Vitale e una delegazione del comitato Pro Filicudi.
Il libro di Giuseppe La Greca
Nel 2011 Giuseppe La Greca ha pubblicato per le edizioni del Centro Studi Eoliano il libro “Le giornate di Filicudi. 26 maggio 1971, la prima rivolta contro la mafia in Sicilia” con una prefazione di Pietro Grasso allora Procuratore Nazionale Antimafia. La ricerca si caratterizza per un inquadramento generale nel fenomeno mafioso ricollegandosi all’omicidio Scaglione ed all’uccisione nel 1971 di Walter Tobagi e considerando il confino – non solo alle Eolie ma anche in altre isole come Linosa, Pantelleria, le Egadi – e la sua validità di strumento per combattere questo fenomeno. Gli eventi vengono raccontati attraverso i servizi dei quotidiani che allora si occuparono della vicenda e soprattutto il Corriere della sera, il Messaggero, il Giorno, la Stampa, l’Unità. la Gazzetta del sud ed anche stranieri come lo spagnolo ABC, la rivista Life il settimanale Panorama, vari servizi radiofonici e televisivi (in particolare quello di TV7 diretta all’epoca da Emilio Fede). Oltre naturalmente alle testimonianze dell’epoca – in particolare Renato de Pasquale e il Notiziario delle Isole Eolie – e quelli di testimoni che hanno rievocato l’evento.
La ricerca di La Greca si conclude con un capitolo dedicato ai mafiosi inviati a Filicudi. Con la consapevolezza della storia che abbiamo vissuto possiamo dire, che diversi di loro, sono stati fra i protagonisti dell’azione mafiosa degli anni che sono seguiti come, ad esempio, Gaetano Badalamenti.
[1] Per questa parte storico-geografica ho fatto riferimento a C.Cavallaro, L’isola di Filicudi, in “Universo”, anno XLVII, n. 6 novembre-dicembre 1967.
[2] Sulla rivolta di Filicudi: La rivolta di Filicudi, in “Il Notiziario delle Isole Eolie”, maggio 1971.; R. De Pasquale, Il mio tempo, op. cit., pp. 106-114.
[3]La rivolta di Filicudi, in “Il Notiziario delle Isole Eolie”, maggio 1971.(Archivio Storico Eoliano.it)
Il successo della rivoltaII sacco di Vulcano
Il piano di fabbricazione

La storia degli anni sessanta e settanta ed in parte, forse, degli stessi anni ottanta, è la storia di come una grande intuizione, quella del turismo naturalistico e culturale, venga drammaticamente travolta e tutto si tramuta in speculazione e distruzione di molte delle peculiarità del paesaggio e della cultura eoliana. La lunga testimonianza di De Pasquale che abbiamo voluto raccogliere mette l’accento su un grande peccato dell’amministrazione di quel periodo: la mancanza di programmazione.
“Alle isole Eolie – ha scritto Cavallaro – non si è potuta realizzare una pianificazione urbanistica malgrado che da tempo se ne avvertisse la inderogabile necessità: vani furono i tentativi negli anni 1959, 1969 e 1973. Soltanto il 3 novembre 1975 [l’era Vitale era già conclusa ], in seguito alle costanti pressioni di taluni ambienti culturali è stato adottato per il Comune di Lipari il programma di fabbricazione con relativo regolamento edilizio per porre fine alla speculazione immobiliare che durante questi ultimi anni aveva compromesso parte dell’isola di Vulcano.
La mancanza di strumenti urbanistici ha dato luogo, in particolare modo dal 1964 in poi, ad una consistente richiesta di aree che di conseguenza ha determinato insediamenti senza una logica urbanistica ed ambientale.[1]”

Vulcano prima della speculazione.
Più volte abbiamo fatto cenno ad un convegno sulla tutela e lo sviluppo del territorio tenuto a Lipari nel dicembre del 1974. Bisogna dire che il tema dello sviluppo e della tutela ambientale delle isole minori era stato aperto dalla Associazione “Italia Nostra” con un seminario dal titolo “Strumenti per la tutela delle Isole Eolie” tenuto il 9 giugno del 1973 a Taormina. A Taormina fu forte la denuncia delle speculazioni edilizia che deturpavano il territorio, e soprattutto quello dell’isola di Vulcano. Anzi in alcuni momenti si rischiò la rissa personale come nello scambio di epiteti fra il prof. Meli, incaricato della relazione di apertura, e il Sindaco di S. Marina Salina Liberatore Giuffré, ma anche – forse in toni più contenuti – fra Meli e il Sindaco Vitali[2].
Per questo gli amministratori liparesi tentarono una risposta col convegno di Lipari dal tema “Tutela e sviluppo socio-economico delle Eolie” con la partecipazione di numerosi parlamentari nazionali e regionali, tra cui il Presidente della Regione e l’Assessore on. Piersanti Mattarella al convegno prese parte anche “Italia Nostra” che ribadì le accuse al modello di sviluppo che si era affermato nelle isole.
Il quaderno di Italia nostra sulle isole minori
Alcuni anni dopo, nel 1981, Italia Nostra curò un quaderno sulle “Isole minori: cultura e ambiente”, nel quale Angelo Raffa torna sul tema della speculazione e vuole verificare se negli ultimi anni fosse cambiato qualcosa.

“Non è necessario – afferma avviando l’indagine – soffermarsi a lungo sulle ragioni che hanno reso tanto lenta l’approvazione di uno strumento urbanistico essenziale per la difesa delle peculiarità ambientali, ma che sarebbe stato di ostacolo alle iniziative speculative di proprietari terrieri e di imprenditori dell’edilizia e del turismo. Sta di fatto che fra il gennaio 1970 ed il novembre 1974 ottennero la dichiarazione di abitabilità ben 2.227 vani, di cui solo 841 nell’isola di Lipari, la più estesa e popolata, e 1.117 in quella di Vulcano, la cui superficie è inferiore di 1.700 ettari a quella di Lipari e la cui popolazione era un ventesimo di quella dell’isola maggiore… Nello stesso periodo il comune rilasciava 418 licenze edilizie, un terzo delle quali per la sola isola di Vulcano”[3].
E’ a questo punto che l’analisi di Raffa si ricollega al fenomeno dell’emigrazione e delle case abbandonate o cedute per pochi spiccioli ed a quello del turismo.
“Verso la metà degli anni ’50 l’interesse di ricchi turisti alla ricerca del paradiso perduto, venne favorito dalla larga disponibilità di case abbandonate, spesso ruderi, e di terreni incolti in posti panoramici, lasciati disponibili dalla popolazione emigrata. L’indice di abbandono delle abitazioni, infatti, nel comune di Lipari era nel 1951 del 25,5%, nel 61 del 30, 6%. Tali immobili furono facilmente acquistati da parte dei turisti non solo per la deruralizzazione che li aveva liberati degli abitanti, ma anche perché erano concentrati nelle mani di pochi benestanti e notabili indigeni che spesso li avevano acquistati a bassissimo prezzo ( il presso del biglietto di viaggio per l’Australia o l’America), o addirittura gratuitamente per usucapione o ne disponevano in base a procure loro rilasciate dagli emigrati”[4].
A questa fase caratterizzata dall’acquirente diretto che si compra e si fa ristrutturare la casa ne segue un’altra, quella della intermediazione e speculazione immobiliare sempre più organizzata. Sono nati così complessi residenziali specialmente a Vulcano, nelle località di Porto e Vulcanello, dove esistevano proprietà fondiarie meno frammentate delle isole Eolie, in possesso di poche famiglie.
“Fra queste, - incalza Raffa – la famiglia di un cittadino che ha ricoperto la carica di Sindaco per 23 anni ha venduto lotti di decine ed anche centinaia di migliaia di metri quadri a imprenditori che hanno ottenuto prontamente le licenze, hanno lottizzato, costruito e venduto centinaia di appartamenti, in luoghi dove quindici anni fa non esisteva neanche una casa[5]”.

Da sinistra, il prof. Tommaso Carnevale, il Sindaco Vitale, Filippo Bernardi, il Vescovo Nicolosi ed, in piedi, il farmacista Silvestro.
E così oltre alla mancanza di programmazione, intrecciata e connessa con questa, vi è un altro grosso peccato contro il proprio territorio di cui si è ammantata l’amministrazione liparese nel corso di quegli anni e cioè l’aver praticato una politica di mediazione fondata sul consenso e, potremmo aggiungere, sull'alimentazione di un tessuto di piccole clientele e favori.
Che si commettevano degli abusi edilizi come anche che si compissero usurpazioni al demanio comunale necessariamente gli amministratori hanno dovuto accorgersene ma, sostiene Raffa, “non hanno voluto fermarle, perché timorosi di scontrarsi con gli interessi di gruppi di potere, o anche di una crescente massa di cittadini amministrati dei cui consensi avevano bisogno”[6].
E come non le hanno volute vedere gli amministratori dell’arcipelago, non hanno voluto vederle anche gli entri preposti al controllo, dalla Sovrintendenza all’Assessorato regionale.
Non solo Lipari, anche Salina
“La commissione edilizia ha dato pareri positivi, la Sovraintendenza ha rilasciato nulla-osta, il sindaco ha firmato licenze edilizie, l’assessorato regionale, sollecitato ad intervenire anche da Italia Nostra, in qualche caso ha fatto orecchio[7] da mercante, in altri ha ingiunto al sindaco di ritirare licenze illegittime in tempi brevissimi, ma è poi rimasto passivo di fronte alle inadempienze del sindaco”.

E non si creda che questi processi fossero tipici solo del Comune di Lipari, in qualche modo essi hanno investito, anche se in misura minore, anche i comuni di Salina. Infatti nel dicembre del 1978 nel piccolo comune di S. Marina Salina, la commissione edilizia ha esaminato ed approvato un centinaio di progetti e il sindaco ha iniziato a rilasciare licenze edilizia senza neanche attendere il parere della Sovrintendenza. Nel comune di Malfa con abitanti pressoché dello stesso numero e cioè intorno ai 700, alla vigilia dell’adozione dello strumento urbanistico, e cioè nel maggio del 1977, sono stati presentati alla commissione edilizia più di cento progetti, che solo un intervento, sollecitato alla Presidenza della regione ed alla giunta regionale, è riuscito a bloccare[8].
Un processo che si è arrestato dopo le denuncie del 1974? Niente affatto. “Nel 1975 – continua Raffa – in una sola seduta, nell’imminenza della votazione del programma di fabbricazione, la Commissione edilizia emise il fantastico numero di 140 pareri favorevoli”[9]. Questo al Comune di Lipari.
Fra il 1974 ed il 1978 la massa di interventi privati di trasformazione del territorio messi in moto, calcola Raffa, ammontava almeno a 2.400 iniziative nelle Eolie di cui ben 1.242 solo a Lipari e 50 a Salina, in attuazione della legge regionale 38/78 che contemplava provvidenze per la popolazione colpita dal terremoto dell’aprile 1978. Un’altra grande occasione per incrementare licenze e concessioni è stata la legge regionale n. 7 /1980 che proponeva una sanatoria per l’abusivismo edilizio in nome del “riordino urbanistico ed edilizio”.(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] C. Cavallaro, Evoluzioni e prospettive…, op. cit., pag. 61.
[2] Si vedano le cronache ed i commenti pubblicati da il Notiziario delle Isole Eolie, giugno 1973. In particolare l’articolo dell’ing. Augusto Merlino.
[3] A. Raffa, Le Trasformazioni dell’ambiente naturale e sociale nelle isole Eolie, in “Quaderni di Italia nostra”n. 18, 1981. pag. 184.
[4] Idem, pag. 185.
[5] Idem, pag. 188. Il cittadino a cui si riferisce Raffa è naturalmente il Sindaco Francesco Vitale.
[6] Idem, pag. 190.
[7] Idem, pag. 191.
[8] A. Raffa, Le trasformazioni…, op.cit., pp. 193-194.
[9] Idem, pag. 184.
Angelo RaffaL'era di Checchino Vitale
Il Sindaco Vitale
Una manifestazione al campo sportivo. A destra il Sindaco Checchino Vitale, al centro il segretario comunale Profilio, a sinistra Renato De Pasquale.
Lo sviluppo delle Eolie si intreccia, nel bene e nel male, con il protagonismo di un personaggio, passato nell’immaginario popolare come l’amministratore capace per antonomasia: il Sindaco di Lipari Francesco Vitale detto Checchino. Egli amministrò il Comune ininterrottamente dal giugno 1952 al 3 luglio 1976 anche se nella vita politica locale aveva fatto la sua comparsa nel periodo fascista essendo stato segretario del partito prima dal 1929 al 1933 e poi, quando ormai gli alleati erano alle porte, nel 1943. Nel parlare di lui ci lasceremo guidare da un altro eoliano, Renato De Pasquale, che con lui ebbe modo di collaborare ma anche di confrontarsi e di affrontarlo nelle competizioni politiche.[1]
“Il Vitale entra decisamente – scrive De Pasquale – nella scena politica locale con i primi movimenti democratici del dopoguerra, ma egli comincia a tessere il suo impero nel 1952, con le elezioni amministrative di quell’anno e l’investitura alla carica di primo cittadino.
La sua indiscussa personalità – e forse anche precedenti esperienze gerarchiche durante l’era fascista – lo pongono nella condizione ideale per dare alla sua sindacatura un’impronta di prestigio e di comando. Le elezioni del 1952 mi videro schierato in una posizione politica contrapposta a quella di Vitale. C’era in noi giovani, usciti da una lunga dittatura e da una sciagurata guerra, la grande voglia di rinnovamento e di partecipazione alla vita democratica. Di qui la mia scelta e la nostra contestazione ad uno schieramento che consideravamo di stampo conservatore. Non sto a raccontare le tante vicende legate alla strenua battaglia tra le due liste, la nostra “La bilancia” e l’altra “Il Vascelluzzo”. Per una manciata di voti vinse “Il Vascelluzzo”, e fù l’inizio dell’era Vitale.
Passano gli anni, seguono altre elezioni ed altri tentativi di contrapposizione democratica al consolidato potere dello schieramento di maggioranza, con il Vitale rieletto puntualmente, di volta in volta, alla carica di Sindaco. Solo agli inizi degli anni Sessanta, dopo le varie vicende politiche di cui non servirebbe fare la cronaca, ebbi modo di entrare in Amministrazione e quindi di meglio conoscere ( da quell’ideale e ravvicinato osservatorio) il personaggio in tutti i suoi aspetti umani e politici.
Con Vitale Lipari diventa democristiana

Una cerimonia pubblica. Si individuano al centro il Vescovo Mons. Re con la lunga barba bianca, alla sua destra il Sindaco Vitale, sua moglie, don Alfredo Adornato, il guardiano dei cappuccini p. Agostino Lo Cascio da Giardini, Leonida Bongiorno, il maestro Cangemi.
Intanto egli esercitò sempre il mandato col pieno sostegno del Partito che lo aveva espresso, la DC. Seppe inoltre curare e conservare per tant’anni la sua grande popolarità, affidando ai fedelissimi del suo seguito il compito di alimentare l’entusiasmo e la fiducia della gente, che arrivò a considerarlo come il Capo indiscusso e insostituibile.
Vivendo alla luce della sua popolare investitura egli poco si curò, va detto, di dare il giusto risalto alle qualità e all’impegno dei suoi collaboratori, che agli occhi dei più finivano coll’apparire come personaggi secondari, quasi di contorno, ovviamente perdenti al confronto con il primo cittadino. Questo suo atteggiamento non era indubbiamente quello di chi avrebbe potuto e dovuto pensare anche al dopo, che in ogni vicenda umana è cosa naturale e ineluttabile…
Detto ciò, come non riconoscere al Vitale indiscusse doti di amministratore capace e attento, di abile politico e di grande protagonista nell’opera di ricostruzione e di sviluppo civile e sociale realizzata durante gli anni del suo governo? Rassegnati a esercitare un ruolo non sempre appagante e poco appariscente, tanti di noi ebbero ugualmente a dare la propria collaborazione, nel rispetto della funzione e della condivisione del comune indirizzo volto a risolvere i tanti grossi problemi del territorio e della gente.
Fare l’elenco delle realizzazioni legate all’era Vitale sarebbe valido pretesto per suffragare la concretezza operativa di quella lunga gestione. Dalla costruzione di nuove strade, alla elettrificazione delle borgate e delle isole minori; dalle tante strutture portuali ( anche se ancor oggi insufficienti e incomplete), ai serbatoi idrici e relative reti di distribuzione; dai plessi scolatici ai nuovi impianti sportivi di Lipari. Senza dimenticare la conquista della doppia corsa della nave per Milazzo e l’istituzione del servizio aliscafi nel 1957. E l’elenco potrebbe continuare. Certo per una comunità territorialmente così vasta e decentrata come la nostra i problemi sono tanti e sono di anno in anno crescenti.
Ma tornando al nostro personaggio, va detto che il Vitale era dotato di tenace perseveranza e si serviva, occorrendo, del suo prestigio politico per ottenere il finanziamento delle opere che via via venivano programmate.
Nei rapporti personali era sicuramente corretto e neppure ai suoi avversari dava a mostrare risentimento o rancore. Almeno all’apparenza. Difficilmente perdeva la calma. Per far valere sempre e comunque le sue scelte, di fronte a posizioni avverse egli preferiva incassare e attendere.
Nell’esercizio della sua funzione di Sindaco era certamente un protagonista indiscusso ma anche un grande accentratore. Durante le sedute del Consiglio Comunale egli si poneva come il solo interlocutore dei Consiglieri presenti, raramente consentendo agli Assessori di fornire dirette risposte su problemi di loro pertinenza.
Era il suo temperamento, e non era facile indurlo ad atteggiamenti diversi e più rispettosi, come legittimamente auspicato dagli stessi suoi collaboratori. Ricordo tuttavia che in occasione dell’insediamento di una nuova Giunta, naturalmente sempre da lui presieduta, riuscimmo a far valere una impostazione nuova della funzione di ciascuno e del rapporto Assessori-Consiglieri.
Un grande accentratore

Costruzione del cosiddetto teatro greco.
Infatti, alla prima seduta del Consiglio ogni componente della Giunta illustrò in aula il programma del proprio assessorato. Fu quella una novità ( e tante altre nel proseguo riuscimmo a portare avanti) che egli ebbe a subire con malcelata irritazione.
Le riunioni del Consiglio erano allora assai proficue, e il confronto, a volte anche acceso, avveniva – come sempre dovrebbe essere – nella esclusiva contrapposizione di proposte e di idee. Nella sua conduzione politica egli riusciva ad intrattenere corretti rapporti con le minoranze dalle quali ambiva – e sovente otteneva – condivisioni e consensi. Il che gli serviva a volte per scoraggiare e frenare qualche timida rivolta all’interno del suo stesso schieramento politico.
Ritengo debba essere comunque imputabile a quel periodo, per altri versi ricco di tante realizzazioni, una mancata visione programmatica del territorio e delle sue risorse.

Il Municipio
Capire del perché non si vollero portare avanti gli strumenti urbanistici, più volte elaborati, non è cosa facile, e preferisco non azzardare valutazioni personali o qualsivoglia ipotesi. Certamente, oggi paghiamo le conseguenze di un tale errore, anche perché gli amministratori che si sono succeduti, sempre provvisori e precari nei brevi intervalli fra una crisi e l’altra, non sono riusciti, nonostante i tanti anni trascorsi, a colmare una così grave lacuna…..
In occasione della rivolta di Filicudi - maggio 1971 - egli preferì svolgere un’azione direi istituzionale e burocratica, a differenza di alcuni di noi, suoi collaboratori di Giunta, che decisero di restare con la gente di Filicudi fino al momento dell’esodo dall’isola di tutti i suoi abitanti.
Non voglio dire che egli dal Palazzo non abbia fatto la sua parte, forse anche importante e certamente utile. Probabilmente come Sindaco egli non avrebbe potuto o dovuto fare diversamente. Dubito tuttavia che, senza la strenua rivolta popolare, alla quale ci unimmo sin dal primo momento, si sarebbe ottenuta la revoca del provvedimento governativo [che aveva inviato “mafiosi” a vivere nell’isola e la cancellazione delle Eolie dall'elenco dei luoghi da adibire a soggiorno obbligato]. Ed è anche vero che in quella occasione ( e lo notammo nei giorni che seguirono l'arrivo dei filicudesi a Lipari ) egli visse momenti di difficoltà politica e di manifesta impopolarità, come mai prima gli era capitato.
1974: Un'era si va chiudendo

Nel dicembre del 1974 si tenne a Lipari un importante convegno su “Tutela e sviluppo socio-economico delle Eolie”. Si ebbe in quell'occasione la netta sensazione che l'era Vitale stava per concludersi. Egli probabilmente per primo avvertì il mutare dei tempi e l'insorgere di critici atteggiamenti alla sua politica. Puntuale e commovente la sua difesa a sostegno di una gestione amministrativa mai prima di allora messa in discussione. In quell'occasione gli attacchi più spietati ( ma non furono i soli) gli vennero mossi dai rappresentanti di “Italia Nostra”, che ebbe a denunciare, in assenza di uno strumento urbanistico, i danni perpetrati sul territorio. Il riferimento era particolarmente a Vulcano e alla sua selvaggia cementificazione...
Come nelle previsioni, nel giugno del 1975, si conclude la carriera politica di Checchino Vitale, che malinconicamente rientra nel privato dopo circa cinque lustri di indiscusso protagonismo”.
Che cosa aggiungere a questo “ricordo”? La considerazione che Vitale governò in una fase irripetibile della storia del Paese, nel pieno del potere democristiano e della gestione della Cassa del Mezzogiorno che permisero di fare affluire a Lipari risorse notevoli non sempre sapientemente spese a cominciare, come è stato notato, dal problema dei porti che non solo non furono completati ma i lavori fatti si rivelarono in parte non adeguati con un forte impatto ambientale che incise indelebilmente sull'immagine delle Eolie. Si pensi a Sottomonastero e Marina Corta.
[1] R. De Pasquale, Momenti . Riflessioni e ricordi, Aldo Natoli Editore, Lipari, 1993(Archivio Storico Eoliano.it)
Italia NostraLa “scoperta” del turismo
Primi i francesi di Connaissance du monde

Il turismo arriva nelle Eolie negli anni 50 ed apre subito una prospettiva nuova di sviluppo per rilanciare una economia in crisi[1]. Nel 1949 il vulcanologo Hourun Tazieff aveva proiettato in Francia ed in Belgio alcune riprese filmate delle isole di Stromboli e Vulcano. Fu l’occasione perché l’Associazione parigina “Connaissance du monde”, che andava alla ricerca di località nuove da proporre ai propri soci, prendesse l’iniziativa di organizzare dei tours per i vulcani italiani. Nel programma “croisière des volcans” si era scelta come località di soggiorno Vulcano da dove sarebbero partite escursioni per Stromboli, Lipari e le altre isole. Prima di Vulcano il programma prevedeva la visita al Vesuvio e dopo, quella conclusiva, all’Etna.
Ma dove alloggiare i turisti? Allora l’intera attrezzatura ricettiva dell’arcipelago era formata da tre locande a Lipari, una a Stromboli ed una a Salina. In tutto 35 posti letto. A Vulcano non c’era niente. Era allora una landa attraente ma senza quasi segno di vita.
Si fece un accordo con un abitante dell’isola che aveva del terreno nella zona di Ponente e si costruì un villaggio modesto, con un minimo di attrezzature ma che fin dal primo anno fece registrare un tale successo da stimolarne l’ampliamento ed il miglioramento.
Stesso problema a Stromboli. Ma qui almeno un punto di riferimento c’era: il parroco di San Vincenzo che conosceva la disponibilità di molte case di chi negli anni e mesi precedenti era partito per l’Australia o per l’America. Non fu facile convincere la gente che a Stromboli c’era ancora possibilità di vita. Dopo l’effervescenza vulcanica degli anni trenta e quaranta la popolazione non pensava che ad emigrare. Molti erano andati già via, gli altri aspettavano la”chiamata” da amici o parenti. Come non fu facile convincere gli abitanti di Panarea, Filicudi, Alicudi e della stessa Salina.
Ogni isola però trovò il suo pioniere che credette nel turismo e si mise ad operare perché il sogno divenisse realtà.

Su Vulcano e Stromboli l'attenzione maggiore
Sicuramente un contributo importante lo dettero anche i film di Rossellini e della Magnani, Stromboli e Vulcano, è la contesa e la polemica professionale- amorosa che si scatenò fra i protagonisti delle due produzioni. Il messaggio che fu trasmesso al mondo era quello di una realtà ancora selvaggia ed incontaminata ricca di colori e di fascino, ma anche di mistero. Un soggiorno al tempo stesso interessante e riposante.
Nel corso degli anni cinquanta e parte degli anni sessanta furono soprattutto Vulcano e Stromboli ad attrarre l’attenzione. Di Vulcano colpivano le fumarole, il mare che bolliva, i faraglioni che sembravano ergersi da profondità notevoli, i cristalli di zolfo. Di Stromboli l’attività vulcanica con gli scoppi pirotecnici che illuminavano la notte, il sordo brontolio del cratere, la sciara del fuoco che si poteva ammirare, durante le eruzioni, dalla barca.
Erano motivi che interessavano ed affascinavano scienziati ed uomini di cultura ma anche il pubblico meno colto alla ricerca di emozioni forti o solo amante della natura. E il tutto immerso in una cornice storica, che una visita irrinunciabile al Museo di Lipari, permetteva di cadenzare.
Dal 1950 al 1958, osserva Carmelo Cavallaro, la corrente turistica – quasi esclusivamente per merito di Connaissance du Monde – era prevalentemente formata da stranieri provenienti dalla Francia, dall’Olanda e dal Belgio. A quel tempo una organizzazione universitaria messinese, la Corda frates, prese l’iniziativa di istituire due villaggi, prima a Vulcano e poi a Stromboli, facendovi affluire numerosi studenti di alcune Università centro- settentrionali e straniere. A Stromboli il Club Alpino istituì un rifugio per i propri soci e l’Istituto di Vulcanologia dell’Università di Catania vi attrezzò una sezione.
Grazie all’attività di queste organizzazioni arrivarono molti giovani. E fu allora che cominciò un’azione di propaganda e di incentivazione di organi provinciali e regionali perché si aprissero esercizi alberghieri.
E così dai tre esercizi esistenti in tutto l’arcipelago nel 1949, già nel 1954 se ne contavano 17, ancora di dimensioni modeste, per un complesso di 81 camere e di 150 posti. Le presenze furono di 11.424 turisti negli alberghi e 5 mila in alloggi privati. Privilegiate in questo flusso furono le isole di Vulcano e di Stromboli segno che questo tipo di turismo era non solo attratto dalla natura ma anche dai fenomeni, in qualche modo eccezionali, che questa proponeva. Lipari invece – essendo più attrezzata – ospitò le comitive in transito. Le altre isole parevano poco coinvolte da questo nuovo fenomeno, salvo Panarea la quale attirava, in particolar modo, gruppetti di lombardi.
La seconda metà degli anni 50 fa registrare, nelle isole, un pur modesto segnale di risveglio sociale trainato dai primi proventi dell’attività turistica, da modelli di vita introdotti dai nuovi frequentatori, dalle erogazioni finanziarie degli emigrati in Australia.
Turismo residenziale e cementificazione

Ma se fino a questo momento il flusso che riguarda le Eolie si delinea come un turismo naturalistico ed in certa misura anche culturale, a partire dal 1962 abbiamo una inversione di tendenza. E’ in quell’anno che prende l’avvio la costruzione di nuovi alberghi ma soprattutto comincia, da parte di forestieri, la domanda di terreni e di ruderi per realizzarvi costruzioni. Le richieste maggiori interessano Vulcano e a Vulcanello e sorgono appunto villette e costruzioni in spregio spesso del paesaggio e dell’ambiente. Si tratta di un processo lento ma inesorabile. Nel 1964 nelle isole si possono contare ben 42 esercizi alberghieri con 461 camere e 885 letti, oltre all’offerta in case private che certo supera il migliaio di posti letto. Si registrano, quell’anno, in alberghi 31.897 presenze di cui 12.216 stranieri, mentre si stimano fra le 7 e le 8 mila le presenze in esercizi extralberghieri.
L’epoca del boom economico e delle prime fortune ostentate da una borghesia rampante è anche quella dell’evidenziarsi dello stress delle metropoli e dei ritmi dell’economia e degli affari per cui diventa di moda la ricerca di un mondo lontano dai soliti circuiti turistici e quindi anche “rifugiarsi” alle Eolie. Così le isole richiamano sempre più un turismo italiano di tipo residenziale che crea il fenomeno delle residenze secondarie che si diffonde , pur in misura diversa, in tutte le isole.
E’ in questo momento che cessa anche l’attività, per mancanza di sostegno e di agevolazioni, delle organizzazioni che avevano promosso le isole e così il flusso degli stranieri va lentamente diminuendo anche se i vuoti vengono ricoperti, come abbiamo detto, da turisti italiani che risultano invece in crescita.
“Non esistendo alcuno strumento urbanistico – osserva Carmelo Cavallaro – durante il ‘miracolo economico nazionale’, le costruzioni crescono disordinatamente, le localizzazioni degli alberghi avvengono senza alcun criterio di analisi territoriale, e l’urbanizzazione dilagante a Vulcano tocca i limiti non soltanto di saturazione ma anche di pericolo. Ci riferiamo alle villette costruite alle pendici di Forgia Vecchia della Fossa di Vulcano. E così si va avanti nel tempo con una serie di problemi assillanti: dalla mancanza di acqua, alla carenza di trasporti, alla insufficienza ed inefficienza di centri di servizio. Aumentano l’urbanizzazione e il flusso turistico, aumenta vertiginosamente il movimento durante le festività, ma le strutture del territorio restano quelle di una volta”[2].
Nel 1974, lungo questa linea di tendenza, gli esercizi alberghieri erano divenuti 55, le camere 1.047, i posti letto 1.992. Diversi gli impianti sempre destinati alla recezione turistica: vi erano 4 campeggi, l’Ostello della gioventù e 168 affittacamere e appartamenti ammobiliati per complessivi 838 posti letto. In particolare gli alberghi erano così distribuiti: 14 a Lipari, 12 a Vulcano, 11 a Stromboli, 9 a Panarea, 6 a Salina, 2 a Filicudi, 1 ad Alicudi.
Il maggior incremento lo hanno avuto Lipari e Vulcano mentre Alicudi e Filicudi, sono state penalizzate dalle comunicazioni. Stromboli, come Panarea, invece sono state caratterizzate da una rilevante ristrutturazione delle abitazioni esistenti, in particolare quelle abbandonate dalla grande emigrazione, creando un mercato della seconda casa. A Stromboli già nel 1950 tre quarti delle abitazioni risultavano deserte; a Panarea era l’isola più frequentata da milanesi, torinesi, e veneti e si operava in tutte le case e i ruderi sparsi con adattamenti discutibili.
Vulcano sotto il tiro del cemento

L’isola più colpita dal fenomeno della cementificazione è stata però Vulcano dove il paesaggio, ed in particolar modo il tratto di territorio che va dal porto di Levante a Ponente, ha subito una profonda modificazione. Al vigneto e alla vegetazione tipica si sono sostituite costruzioni che non hanno tenuto conto dell’architettura tradizionale. E ancora peggiore si presentava la situazione di Vulcanello dove non era mai esistito alcun insediamento umano. Ciò che a Vulcano favoriva la speculazione era la concentrazione della proprietà.
L’isola di Salina è rimasta invece un po’ ai margini di questo processo passando dai 41 posti letto del 1956 ai 132 del 1974 con una conservazione quasi totale dei beni naturali e paesistici. Non è mancato però anche a Salina un certo flusso turistico che ha trovato accoglienza presso affittacamere ed appartamenti ammobiliati oltre che un Ostello della Gioventù, il tutto per complessivi 1500 posti letto circa.
Solo le isole di Alicudi e Filicudi, almeno in questa fase, rimanevano indenni da questa “mercificazione” del suolo.
Nel 1974 nelle isole si sono registrate circa 126 mila presenze in esercizi alberghieri e 181 mila circa in esercizi extralberghieri oltre alle miglia di presenze che sfuggono alla rilevazione statistica.
La presenza degli stranieri negli esercizi alberghieri nel 1974 sono state 24.253 e rappresentano il 20,4% delle presenze globali. Questi provengono dalla Germania ( 37,77%), dalla Svizzera (18,15%), dalla Francia (15,68 %), dagli Stati Uniti (4,48%), dall’Austria ( 3,21%) e la rimanenza (20,71%) da altri stati.
Ma, è bene sottolinearlo, dopo il 1970 è l’espansione delle residenze secondarie l’elemento caratterizzante dello sviluppo turistico del’arcipelago: nuove villette, case, appartamenti, ristrutturazioni e ampliamenti di case esistenti, ruderi che diventano villette.(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] Nella stesura di questo paragrafo abbiamo fatto riferimento costante a C. Cavallaro, Evoluzione e prospettive della regione turistica delle Isole Eolie, in “Rassegna di Studi Turistici” anno XI, n. 1-2, 1976, gennaio-giugno , pp. 51-64; v. anche C.Cavallaro, Sistema territoriale arcipelago Eolie, Genova 1987.
[2] C. Cavallaro, Evoluzione e prospettive della regione turistica delle Isole Eolie, in “Rassegna di Studi Turistici” anno XI, n. 1-2, 1976, gennaio-giugno , pag. 54
Ingrid BergmanIl contributo di Fabio Famularo alla storia delle Eolie della prima metà del 900
1. Due considerazioni preliminari: la storiografia eoliana del 900 ed i materiali di riferimento

Prima di entrare nel merito del libro di Fabio Famularo permettetemi alcune considerazioni preliminari per chi affronta la storia delle Eolie del 900.
Prima considerazione. Una storiografia delle Eolie del 900 si può dire che non esista. E’ il problema che mi sono trovato di fronte quando ho scritto “Navigando nella storia delle Eolie” rischiando di andare oltre le colonne d’ercole del 700 che erano quelle alle quali, di fatto, si era fermato Leopoldo Zagami. Così ho dovuto improvvisare cercando di mettere a fuoco i temi nodali ricorrendo ad una documentazione parziale e carente. I temi, visti a volo d’uccello, sono quelli della crisi dell’agricoltura, delle vicende della pomice e della ricerca di un nuovo modello di sviluppo fondato sul turismo; lo scontro sulla proprietà dei terreni pomici feri; il travaglio di Salina e la sua autonomia amministrativa; le opere pubbliche della modernità ( centrale elettrica, rotabili, collegamenti marittimi); le due guerre mondiali; il fascismo e il confino ma soprattutto, trasversale a questi temi, quello della vita quotidiana della gente di Lipari e delle isole minori. Sul novecento il libro “Navigando” non rappresenta un punto di arrivo storiografico ma soltanto un punto di partenza. Fa il punto sulla documentazione esistente e si augura che sproni giovani e meno giovani a raccogliere e pubblicare documenti e memorie. Fabio Famularo dà un contributo importante, per certi versi fin’ora unico, alla conoscenza della vita quotidiana soprattutto a Stromboli ed alla seconda guerra mondiale nel nostro arcipelago e questo sia col libretto di cui parliamo oggi “I giorni dwella guerra. Quando i tedeschi sbarcarono a Stromboli” e il primo” …e poi Stromboli”. Invece “Il richiamo silenzioso del vulcano” anche se qui è lì ci sono sprazzi di vita locale, appartiene più al genere romanzo (la storia di Giuliano) e “Raccontami di Stromboli” raccoglie una serie di racconti anche se l’ambientazione è sempre a Stromboli nella prima metà del secolo scorso.
Seconda considerazione. Sul novecento eoliano i materiali di riferimento sono scarsi e sicuramente insufficienti. E questo proprio a cominciare dalle memorie che offrono uno spaccato immediato della vita quotidiana. Oggi possiamo dire paradossalmente che grazie a Marilena Maffei si sa più dell’immaginario degli eoliani della prima metà del 900 che della loro vita reale. Su questo piano oltre a Fabio Famularo mi sembra di potere segnalare solo Renato De Pasquale e le pagine del Notiziario delle Isole Eolie di Salvatore Saltalamacchia prima e Augusto Merlino poi, Arcipelago di Bartolino Famularo, e gli allegati con cui Pino Paino ha arricchito gli otto volumi sulle Eolie dell’arciduca Luigi Salvatore d’Austria.
Ma con Pino Paino forse siamo più in là dell’ambito delle memorie ed entriamo nella casistica della ricerca/documentazione soprattutto con il libro la “Vera storia di Lipari”. In questo settore oltre ai saggi di Iacolino raccolti in “Gente delle Eolie” e il libro “Strade che vai, memorie che trovi” troviamo “Confinati politici e relegati comuni a Lipari” di Leopoldo Zagami, i volumi ed i saggi di Carmelo Cavallaro, il libro “Mercanti di mare” di Saija e Cervellera su Salina e il saggio di Marcello Saija su “La seconda controversia liparitana” nel secondo quaderno del Museo Archeologico, un saggio di Angelo Raffa su Quaderni di Italia Nostra sulla speculazione nelle Eolie nel secondo dopoguerra, i libri di p. Alfredo Adornato, il saggio di p.Agostino da Giardini su Mons. Re ed infine la preziosa produzione di Pino la Greca di questi anni sulle terme di S. Calogero, l’industria della pomice, il confino e infine le giornate di Filicudi.
Un materiale, in genere, di valore e spessore diverso, non sempre passato ad un severo vaglio critico e carente di un lavoro di inquadramento generale che sappia ricondursi ad una lettura della nostra storia.
2.Fabio Famularo e la vita quotidiana di Stromboli della prima metà del 900

Dopo queste due considerazioni di ordine generale vorrei farne altre due a partire dai libri di Fabio Famularo. Il primo relativo alla vita quotidiana di Stromboli nella prima metà del 900. Il secondo riguardante la seconda guerra mondiale a Stromboli e nelle Eolie.
Il libro di Fabio che contiene il maggior numero di notizie sulla Stromboli della prima metà del 900, è “… e poi Stromboli” pubblicato nel 2008 e che parla della vita avventurosa del nonno dell’autore. Diciamo “grosso modo”che il periodo esaminato prende il via dagli anni 25 quando Gaetano fugge da Lipari e dalla sua famiglia ancora ragazzino e si va a stabilire in quest’isola, fino alla seconda metà degli anni 50 quando, come la maggior parte degli Stromboliani, decide di emigrare a New York e di abbandonare Iddu che si è rivelato inaffidabile. Ma al contrario di tanti suoi compaesani Gaetano a New York rimane poco, solo due anni, poi, con la moglie Maria decide di fare ritorno al suo vulcano giusto per fare i conti con una realtà profondamente cambiata e con le prime avvisaglie del turismo. Quella che emerge in queste pagine è’ la Stromboli dove la gente lavora duramente la terra sfruttandone ogni più piccolo fazzoletto, ma anche la Stromboli dei pescatori : persone coraggiose che si avventurano in mare cercando di interpretare l’andamento del tempo, la Stromboli delle feste serali nelle case spesso in competizione fra loro.. E’ la Stromboli della realizzazione di alcune importanti opere come il nuovo cimitero ai lavori del quale partecipa Gaetano, la costruzione della chiesa di San Bartolomeo, ma anche dell’eruzione dell’11 settembre 1930 una delle più drammatiche che rompe il rapporto di fiducia fra il vulcano ed gli abitanti. Tutti gli anni 30 sono anni di forte instabilità del vulcano per cui inizia un lungo periodo di emigrazione che svuota l’isola per la gran parte. Infine la guerra. La seconda guerra mondiale che fa di Stromboli l’isola delle Eolie più militarizzata con militari italiani e tedeschi. Anzi i tedeschi fanno dell’isola un punto strategico per gli avvistamenti in mare.
3. I giorni della guerra a Stromboli

Della Stromboli in guerra Fabio ne parla in una decine di pagine del suo primo libro e poi riprende il tema sviluppandolo nel volumetto “I giorni della guerra. Quando i tedeschi sbarcarono a Stromboli”.
Dico subito che si tratta di un prezioso contributo. Prima di questi due libri ed in particolare dell’ultimo sembrava che la le Eolie avessero guardato la guerra da lontano se non fosse strato per l’affondamento del piroscafo Santamarina il 9 maggio del 1943 nel quale perirono 61 persone e non ci fu famiglia che non fosse toccata dalla tragedia ed il siluramento nel 1942 dell’incrociatore Bolzano della Marina nelle acque di Panarea. Anzi la guerra a Lipari e alle Eolie è stata soprattutto l’affondamento del Santamarina le cui ragioni e motivazioni sono ancora avvolte nel mistero. Nel maggio del 2002 Antonio Brundu , sul periodico “Stretto indispensabile”, ha sostenuto che l’affondamento potesse essere connesso con l’ammaraggio di fortuna di un idrovolante da guerra tedesco, proveniente dall’Africa, colpito da aerei alleati nel laghetto di Lingua (Salina) avvenuto proprio qualche giorno prima. I tedeschi che pare fossero in possesso di importanti documenti dovevano imbarcarsi sul Santamarina proprio il 9 maggio ma all’ultimo minuto ci fu un cambio di programma. Questa novità non venne colta dal controspionaggio inglese e così il sommergibile Unrivalled silurano ugualmente l’innocente piroscafo eoliano carico di inermi passeggeri.
Fabio Famularo ci fa vedere invece che a Stromboli – proprio per la particolare collocazione strategica dell’isola - la guerra fu palpabile e consistette nella presenza di numerosi militari italiani ma soprattutto una guarnigione di soldati tedeschi che si comportarono, non come alleati, ma come un vero e proprio esercito di occupazione.
“Essi giunsero, scrive Fabio, improvvisamente in una mattina di calma piatta, provenienti dalla Calabria a bordo di un grande zatterone nero a due scafi, simile ad un moderno catamarano… Il loro zatterone era attrezzato come un vero e proprio mezzo da sbarco e arrivò direttamente sulla spiaggia senza gettare le ancore. Sembrò un abbordaggio come quello dei racconti dei pirati… I tedeschi si annunciarono con una lunga raffica di mitra che c’impedì di scappare. Un giovane ufficiale ci richiamò sotto bordo e con modi prepotenti ci ordinò di aiutarli a sbarcare le loro cose…”.
Prepotenza ed arroganza sono il loro modo di presentarsi che vengono in qualche modo contrastati dal coraggio di un maresciallo dei carabinieri sopraggiunto di corsa richiamato dalle raffiche di mitra.

Ma al di là di questa presentazione i tedeschi fanno una vita piuttosto ritirata, chiusi praticamente tutto il giorno nelle loro postazioni e nei loro rifugi dove, a sera bevevano fino ad ubriacarsi. I rapporti con i locali erano scarsi e si limitavano alla ricerca di viveri e soprattutto di vino proponendo degli scambi. Scambi e relazioni che erano fortemente proibiti dal loro comando.
Ma oltre alla presenza dei militari la militarizzazione dell’isola riduce la libertà e le possibilità di lavoro degli abitanti. Obbligo dell’oscuramento, obbligo di rientrare in casa la sera perché vi era il coprifuoco, obbligo di non andare a pescare, mancanza di collegamenti con Lipari e la Sicilia, prima forte riduzione dei rifornimenti e poi la fame quella vera. Poi gli scontri navali nell’area di mare al largo dell’isola, le incursioni aeree sul mare, il mare pieno di rottami e di centinaia di cadaveri di soldati italiani, tedeschi, americani, inglesi, bianchi e di colore.
Ed inoltre le azioni di coraggio per procurarsi il cibo per sopravvivere, l’elusione dei controlli per andare a pescare malgrado i divieti, l’escursione a Palermo per raccogliere vettovaglie e quindi la grande solidarietà fra la gente che , pur nella miseria, si aiutava e sosteneva a vicenda, le partenze per la guerra e la gioia dei rientri a casa, la tracotanza dei fascisti che per gli isolani erano il vero nemico più dei tedeschi..

Infine la fuga dei tedeschi e l’arrivo degli americani.
“ Il primo segno che qualcosa stesse veramente cambiando – scrive Fabio ( pag. 80) -si ebbe un mattino, quando alle prime luci dell’alba fummo svegliati da un forte odore acre di bruciato proveniente da diversi punti dell’isola e vedemmo i tedeschi riunirsi velocemente sulla spiaggia di Ficogrande. In tutta fretta misero in mare i grossi zatteroni con cui erano arrivati e dopo essersi imbarcati, sparirono all’orizzonte verso la Calabria, abbandonando l’isola dopo mesi e mesi di occupazione. Prima della partenza si erano premurati di mettere a ferro e fuoco ciò che avevano realizzato in tutto quel tempo e delle loro strutture non era rimasto più nulla”.
Giudizio sull’occupazione tedesca: pag. 81.: “In tutti quei mesi avevamo imparto a conoscere i soldati tedeschi…”.
L’arrivo degli americani : “…Un mattino sulla linea dell’orizzonte si affacciarono due navi che piano piano facevano rotta verso di noi, fino a quando gettarono l’ancora davanti alla spiaggia di Ficogrande. Tutti gli abitanti, compreso me, non sapendo chi fossero scapparono velocemente su per la montagna cercando di sfuggire ai nuovi invasori. Le due navi battenti bandiera americana, si fermarono ad osservare i nostri movimenti da lontano senza accennare a un imminente sbarco. Questo ci tranquillizzò un po’ ma ben presto capimmo che qualunque fossero state le loro intenzioni, non gli saremmo mai potuti sfuggire: l’isola era troppo piccola e ci avrebbero comunque trovato. Cos’ mi feci coraggio e con due miei amici decidemmo di andargli incontro. Ci recammo sulla spiaggia del prete, dove prendemmo in prestito un gozzo… Una volta arrivati sottobordo, tutti i soldati si affacciarono dalle mura di dritta puntandoci addosso i fucili e subito una voce c’invitò ad avvicinarci lentamente, quindi ci lanciarono una cima senza però farci salire a bordo. Uno dei militari, che parlava con un forte accento palermitano, dall’alto cominciò ad interrogarmi. Mi disse di stare tranquillo, che loro erano soldati americani venuti in pace e che stavano perlustrando tutte le isole in cerca di soldati tedeschi e di fascisti. Rimasi sorpreso del fatto che l’ufficiale della nave parlasse in siciliano e lui, vedendomi perplesso, mi disse, che era figlio di emigranti di Palermo e che da sempre parlava il nostro dialetto”.
La guerra e i patimenti della guerra erano veramente finiti. Cominciano quelli del dopoguerra e riprende la strada dell’emigrazione. Ma questo è un altro racconto.
Un’ultima considerazione. Fabio è uno scrittore nato. Ha lo stile fluido di chi racconta la vita di tutti i giorni non aliena dall’uso di immagini colorite ed anche poetiche. Si capisce subito che la sua vocazione è il romanzo o il racconto con un’attenzione ai dialoghi che ravvivano e sveltiscono il testo. Queste sue doti li manifesta soprattutto ne “Il richiamo silenzioso del vulcano” che, come abbiamo detto, è un vero e proprio romanzo e in “Raccontami Stromboli” che è una raccolta di racconti che hanno come ambiente la sua isola. (Archivio Storico Eoliano.it)
L'arrivo degli americaniDue contributi di Caterina Conti su sua madre

Milazzo, veduta del lungomare prima dell'ultima guerra
La professoressa Isabella Vainicher Conti a Milazzo: una esperienza... umana
La preside Conti , che aveva insegnato a Barcellona alla fine di quell’anno scolastico riuscì a trasferirsi a Milazzo, con i figli Caterina e Giovanni, con le masserizie a piedi su un carretto.
Arrivò a Milazzo, la vigilia della requisizione della nave che faceva servizio Milazzo- Lipari. La nave avrebbe potuto raggiungere Lipari, ma fu dato ordine diverso al comandante, che fu costretto a lasciare il porto di Milazzo e a spostarsi in altra zona dove la nave fu poi affondata.
La Sig.ra Isabella trovò ospitalità nella casa del nostromo Bartolo Casamento, la cui famiglia l’aveva abbondata perché la zona era ritenuta troppo pericolosa, perché si pensava che la battaglia sarebbe potuta avvenire nella Piana di Milazzo.
Isabella rimase in una Milazzo deserta per un mese con Caterina e Giovanni, mangiando pomodori con il sale e spighe di granturco abbrustolite.
A Milazzo, dove tutti erano fuggiti, vi erano soltanto la famiglia Conti, il carcere e i carabinieri, che uno o due volte la settimana andavano a controllare se la famiglia Conti era ancora viva.

Si deve pensare che Milazzo era sottoposta ad una serie di bombardamenti ininterrotti , compresa poi una battaglia navale, perché oltre tutto nel porto vi era ancorata una magnifica nave tedesca.
Durante tutto il periodo precedente all’arrivo degli americani, la famiglia Conti finì con il raccogliere attorno a sé una parte dei 50 reduci che salirono sul motoveliero Rolando per rientrare a Lipari con il vescovo S.E. . Reduci, che via via arrivavano alla spicciolata con le loro sofferenze e le loro tragedie.
Va detto però a questo punto che il primo dei reduci che era arrivato a casa Conti , fu un certo signore di Lipari, al quale Isabella dette subito ospitalità, facendo cedere a Caterina il suo letto.
Il giorno dopo l’arrivo di questo liparoto, eravamo ancora all’inizio del mese, arrivò la notizia che un motoveliero sarebbe venuto da Lipari a prendere i fuggiaschi. Isabella con Caterina e Giovanni e il liparoto, andarono sul porto ad attendere il motoveliero.
Dopo un po’, mentre che aspettavano sotto il sole, era estate e l’asfalto bruciava, si sentirono ad un certo punto in lontananza dei bombardieri in arrivo.
Allora esisteva sul porto un albergo, “La stella d’Italia”, anch’esso abbandonato. Isabella con i bambini e l’amico si rifugiarono nell’ingresso la cui porta spalancata era proprio sulla banchina. Arrivarono i bombardieri e le bombe cadevano fischiando, fitte, dappertutto. Ad un tratto l’amico disse: “Aspettate un momento che adesso ritorno”, lasciando lì soli Isabella, Caterina e Giovanni. Dopo avere atteso un po’, vedendo che l’amico non ritornava e che le bombe continuavano a cadere, uscimmo da quel rifugio e facendo la piccola stradina, arrivammo sulla strada e cominciammo a correre verso la stazione, tentando di andare verso un posto più sicuro.
Va tenuto presente che faceva un caldo terribile, mamma che era claudicante e zoppicava, e Giovanni che aveva sempre le scarpe rotte, camminando sull’asfalto che bruciava, piangeva. A questo punto mentre correvamo arrivò un giovanissimo marinaio tedesco, che ghermisce Giovanni sotto le ascelle e comincia a correre lungo la strada verso la ferrovia.
Ogni tanto si girava per essere certo che riuscivamo a seguirlo. Quando ritenne, di averci portato abbastanza in salvo, poggiò Giovanni a terra e da lontano ci salutò. Tornammo a casa e vi rimanemmo per circa un mese. Il nostro amico lo ritrovammo sulla banchina di Lipari, quando finalmente ritornammo sulla nostra isola. Mamma che si era inginocchiata per baciare terra, incontrò il signore della storia che, essendo rientrato con il motoveliero un mese prima, aveva avuto pure il coraggio di stendere la mano a mia madre.
Tutto quanto raccontato per voi ragazzi è per dire che il bene - il male, il coraggio- la vigliaccheria , sono indipendenti dal colore della pelle, della razza, della nazionalità.
La Preside Conti e il Museo archeologico
Mia madre, Isabella Conti Eller Vainicher, subito dopo la guerra, ha sentito la necessità di impegnarsi nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico eoliano custodito sia nella Cura Vescovile, sia presso privati, per scongiurarne la sua dispersione E questo coinvolgendo sia la Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, allora diretta dal prof. Bernabò Brea, sia il Vescovo del tempo, mons. Bernardino Re, ed altre personalità Liparesi. Fondò, quindi, con la collezione vescovile e quelle di alcuni privati, presso i locali dell’Istituto Tecnico di Lipari un antiquarium, che successivamente rappresentò il primo nucleo espositivi del Museo Archeologico Eoliano presso la sua attuale sede nel Castello di Lipari.
Come documentato dalla copiosa corrispondenza intercorsa - oltre 100 lettere attualmente custodite presso l’archivio di famiglia - tra i il prof. Bernabò Brea e mia madre, è stata proprio lei ad occuparsi della ricerca di una sede per la realizzazione del Museo Eoliano, del quale fu poi Conservatrice Onoraria, ponendo la sua attenzione nei locali del complesso del Castello di Lipari, affinché questo luogo, per lungo tempo usato come campo di detenzione e di confino, diventasse un luogo di cultura e di riscatto sociale e culturale degli Eoliani.
Tale era la fiducia del prof. BernabòBrea nei confronti di mia madre, che lo stesso, nonostante mia madre non fosse un’archeologa, la incaricò di sorvegliare gli scavi eseguiti da Bottari, dipendente delle Soprintendenza di Siracusa, nella località Portinenti di Lipari.
Dopo anni di oblio sul ruolo avuto da mia madre nella fondazione del Museo di Lipari, soltanto nel 2006, in occasione del centenari della sua nascita, il Museo, allora diretto dal dott. Riccardo Gullo, organizzò una mostra, che è stata inaugurata il 25 marzo presso i locali dell’ex chiesa di S. Caterina e successivamente spostata presso i locali dell’ex Ostello – anch’esso fondato da mia madre -, sulla sua vita e le sue opere. Ma ebbe vita breve, poiché, dopo tre anni, a seguito del pensionamento del dott. Gullo, la nuova dirigenza del Museo ritenne di doverla smantellare, mettendo da parte la documentazione, riprodotta in copia secondo un criterio espositivo allora molto apprezzato dai fruitori della mostra, che testimoniava l’impegno ed il ruolo avuto da mia madre nella fondazione del Museo di Lipari.

Il manifesto della mostra organizzata dal Museo Archeologico
La mostra, per ciò che concerne l’attività svolta per la creazione del Museo. conteneva la corrispondenza del 1947, relativa all’antiquarium e la documentazione sull’istituzione di un apposito comitato locale, la corrispondenza del 1948, sulla attività archeologica e l’antiquarium, la nomina a Conservatrice onoraria e la corrispondenza del 1950 sull’antiquarium, la corrispondenza del mese di ottobre 1950 e dell’anno 1951, riguardante ancora l’antiquarium, una “nota archeologica” per la pubblicazione in un opuscolo sulle “Isole Eolie” e notizie del 1954, quando dall’antiquarium nasce il Museo Archeologico Eoliano, con il quale continua la collaborazione di mia madre. Spero che questa parte di storia del Museo non passi definitivamente nell’oblio perché sarebbe una testimonianza di verità che non toglie meriti a nessuno!(Archivio Storico Eoliano.it)
Riprende la politica eoliana
Casaceli, primo sindaco della Lipari liberata

La vita politica locale riprenderà nel maggio del 1944 quando il colonnello Jeo lascerà Lipari. Durante il periodo del Governatorato le funzioni di Sindaco le aveva svolte il segretario comunale Ugo Sclafani. Partito Jeo il Comitato di Liberazione Nazionale designa come primo sindaco della Lipari liberata l’avv. Francesco Casaceli che svolgerà questo ruolo per più di un anno fino all’ottobre 1945. Casaceli era un moderato ma anche un democratico e fu quello che in pieno fascismo, nel corso di un Consiglio comunale che esprimeva il suo cordoglio per l’on Armando Casalini, deputato fascista, ucciso a Roma con tre colpi di rivoltella, ebbe il coraggio di estendere il cordoglio all’on. Giacomo Matteotti caduto per mano di sicari fascisti.
A Lipari con la politica si andava risvegliando anche la società, soprattutto i giovani. Nascono così due associazioni studentesche: La “5 esse” a Lipari e la “Giovane Eolia” a Canneto che applicano al loro interno il metodo democratico facendo eleggere i dirigenti dall’assemblea dei soci. Elezioni con liste contrapposte in un clima acceso e vivace. La “5 esse” che era l’acronimo di “Siamo studenti sempre senza soldi”organizzava manifestazioni culturali, teatrali, ricreative e benefiche che coinvolgevano anche gli adulti. Per qualche tempo uscì anche un giornaletto, “Lipari Nova”, che portava sotto la testata, al posto della periodicità, la dicitura “Esce…quando può”.

1941- Ospedale di Lipari
L’associazione acquistò notorietà in paese per le numerose recite della sua filodrammatica al cinema Eolo. Fu il periodo quello in cui i talenti teatrali si moltiplicavano – Pino di Giovanni, Armando e Bianca Raffaele, le sorelle Tacchini, Peppuccio Paino, Claudio Natoli, Carmelino Salmieri, Jachino Cullotta - ed a fianco a quella della “5esse” sorse anche la “Sant’Agatone” promossa da ambienti dell’Azione Cattolica.
Il referendum istituzionale del 1946 che scelse fra monarchia e repubblica assegnò, nelle Eolie, un netto successo alla monarchia confermando che, la gente delle isole e delle campagne, era legata alle tradizioni e non amava i cambiamenti.
Riparte il flusso migratorio

Con l’arrivo della democrazia cadde anche il divieto all’espatrio che in qualche modo aveva bloccato il flusso migratorio nel periodo fascista. E siccome le prospettiva di lavoro erano sempre minori soprattutto nell’agricoltura che non dava prospettive di sviluppo e di progresso mentre la pesca rimaneva una attività limitata e il lavoro nelle cave di pomice era sempre più duro e comunque, anche perché la ripresa delle esportazioni stentava ad arrivare, non poteva soddisfare un consistente bisogno di lavoro.
Così riprende il flusso emigratorio verso le Americhe e verso l’Australia. La gente partiva con le poche cose che si potevano portare nella valigia, richiamati dai parenti che si erano stabiliti nei nuovi continenti . Fra il 1946 e il 1970 sono emigrati dalle Eolie più di 13 mila abitanti cioè una popolazione quasi pari a quella che vi è rimasta e di questi oltre sei mila sono andati all’estero e circa sette mila in Italia[1].Nei primi anni del dopoguerra la media dei partenti fu di almeno di cento al mese.

Queste partenze avevano un risvolto sociale che emergerà in tutta la sua evidenza nel corso degli anni cinquanta. La gente che emigrava svendeva la sua casa al prezzo del biglietto di viaggio o le lasciava con procure a parenti ed amici confidando in un ritorno che difficilmente si verificava. E così vi è stato un passaggio notevole di proprietà per fabbricati che nel corso degli anni 40 sembravano non avere nessun valore ed invece dieci o vent’anni dopo avranno un valore sempre crescente.
Ma mentre il Lloyd Triestino e la Flotta Lauro staccavano biglietti per le Americhe e l’Australia a Lipari facevano la prima comparsa le Vespe e le Lambrette, le cucine a gas e le lavatrici, i frigoriferi e le macchine da cucire.
Si ripropone l'autonomia di Canneto
Mentre si cerca di dimenticare la guerra e crescono le aspirazioni degli isolani si ripropone il tema dell’autonomia di Canneto sostenuta da un “Comitato per l’autonomia di Canneto” di cui era presidente il cav. Angelo Ferlazzo. E’ sindaco di Lipari l’avv. Francesco Palamara che è succeduto dopo Casaceli a due commissari prefettizi il dott. Salvatore Carnevale ed il dott. Girolamo l’Acquaniti. Palamara sarà sindaco dal dicembre 1946 al novembre 1948 ed è proprio la fine del 1946 quando viene ripresentato il problema. Il 2 gennaio 1947 i cittadini di Canneto e delle borgate di S.Vincenzo, Culia, Pirrera, Sciaratore, Pomiciazzo, Lami, Castagna, Truffa, Montepilato, Campobianco, Porticello e Acquacalda chiedono con una istanza indirizzata al Prefetto e per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’interno di divenire Comune autonomo: complessivamente 3.694 abitanti. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale il 22 dicembre e come era accaduto già nel 1922 il parere espresso è contrario. Ma la mobilitazione non si ferma lì. Il 5 settembre del 1950 l’on. Antonio Dante presenta un disegno di legge per il riconoscimento del nuovo Comune. All’Assemblea Regionale Siciliana questa volta perché nel frattempo la competenza è passata alla Regione. L’avv. Giovanni Raffale, nello stendere una memoria storico-giuridica il 18 novembre 1950, per incarico del Comune, su questa vertenza, afferma “si può, con piena tranquillità di coscienza, affermare che tale movimento non trova giustificazione in condizioni di fatto (territoriali od amministrative) di quella frazione, né in particolari interessi sociali ed economici distinti da quelli del capoluogo e dalle restanti frazioni, ma che, malgrado l'orpello del desiderio popolare, in realtà il movimento stesso è stato artificiosamente determinato, e si cerca con ogni mezzo sostenere, per interessi meramente privati, in stridente contrasto con quelli generali dei frazionisti di Canneto, da pochi individui esercenti l'industria della lavorazione ed esportazione della pietra pomice e conducenti la stessa giovandosi, a propri fini, dello sfruttamento esoso degli operai e, nel contempo, della tenace occupazione di zone del demanio comunale pomicifero di Lipari, di appartenenza all'intera collettività degli abitanti del comune di Lipari, donde la pomice viene estratta[2]”. E il Sindaco Domenico Cincotta che era succeduto a Palamara, commentando l’iniziativa del progetto di legge aggiunge che questa autonomia “sarebbe un grave danno per i contribuenti di tutto l’Arcipelago e principalmente per quelli di Canneto che verrebbero tartassati per dare ossigeno all’invocato Comune – che nascerebbe indubbiamente asfittico – e per servire interessi personali e non nell’interesse della cittadinanza”[3].
Emerse allora l’idea del tunnel fra Lipari e Canneto che avrebbe ridotto la distanza a poco più di un chilometro ed avrebbe reso le due cittadine, di fatto, uno il prosieguo dell’altra.
L’idea dell’autonomia la riprenderanno vent’anni dopo nel luglio del 1968 gli abitanti di Vulcano. Anche qui viene stilata una istanza, sottoscritta da 150 abitanti e inviata al Presidente della Regione. Se ne parla per qualche mese ed il 3 novembre si terrà a Lipari nei locali del circolo ACLI un dibattito pubblico. Ma poi, ancora una volta, tutto si sgonfia.
Ora parlare di nuove strade e di nuove opere era sempre più facile visto che il 15 maggio del 1946 veniva approvato lo Statuto della Sicilia come regione autonoma con valenza costituzionale ed il 10 agosto 1950 veniva creata la Cassa del Mezzogiorno, un organismo che si prefiggeva di eseguire un programma di lavori straordinari per superare il distacco del sud dal nord.
Comunque la modernizzazione bussa ormai alle porte e nel 1950 si dà inizio vallo sviluppo della rete telefonica, idrica ed elettrica in tutte le frazioni dell’isola di Lipari mentre i rifornimento idrico di Lipari e Salina viene posto a carico dello Stato. Nel 1951 prende il via il servizio di autobus della Ditta Urso con qualche corsa al giorno per Canneto e Pianoconte mentre il 9 agosto del 1956 si inaugura il servizio aliscafi sulla linea Messina- Reggio Calabria- Giardini.
Intanto anche Lipari cambia faccia. Nel 1954 si apre piazza Monfalcone, la futura Piazza Arciduca d’Austria, con la demolizione di diversi vecchie strutture che ormai rappresentavano solo un ingombro: Ancora qualche anno e verranno demolite le gibbie e l’austero cancello che introduceva nel viale Vescovile.
[1] A. Raffa, Le trasformazioni dell’ambiente naturale e sociale nelle isole Eolie, in “Isole minori. Cultura e ambiente. Quaderni di Italia Nostra, n. 18, 1981.
[2] Avv. G. Raffaele, Per l’integrità territoriale del Comune di Lipari. Memoria storico-giuridica, Lipari 1951.
[3] Comune di Lipari, Contro l’autonomia di Canneto, Lipari 1950, p.2; G. Iacolino, Strade che vai…pp,180-181.(Archivio Storico Eoliano.it)
cav. Angelo Ferlazzo. Il sindaco Cincotta
Il dopoguerra inizia nel segno della cultura
Le Eolie, una importante stazione archeologica

Il professor Luigi Bernabò Brea
Nel 1946 metterà piede nelle Eolie per la prima volta un personaggio di grande levatura scientifica e culturale che porterà le Eolie alla ribalta del mondo con il loro immenso tesoro archeologico. Ma prima di Luigi Bernabò Brea a Lipari vi erano stati anche altri archeologi e di reperti archeologici avevano parlato numerosi viaggiatori.
Nel 1928 infatti era venuto a compiere una campagna di scavi il prof. Paolo Orsi, direttore del Museo di Siracusa.
“Da molti anni - ci racconta lui stesso – io ero assillato dalle Autorità e dagli intellettuali, che non mancano a Lipari, perché facessi qualche cosa; e tutti erano soprattutto infatuati della terra esistente nel giardino vescovile, che per me, a dir vero, passava in seconda linea. Io pensavo alla possibilità di trovare la necropoli greca, ed in particola quella arcaica. E così decisi una campagna, che durò tutto il giugno 1928 (…). Tutta la buona cittadinanza di Lipari mi fu larga di accoglienze, di suggerimenti, e tutte le porte di chi deteneva qualche cosa mi vennero aperte con la massima cordialità; e ricordo con vero riconoscente affetto i pochi giorni passati nell’Isola. Voglio in particolare sia fatto il nome di S.E. Mons. Bernardino Salvatore Re, che mi diede il primo consenso allo scavo del vigneto vescovile, e quello del dott. Giuseppe Favaloro, R. Ispettore onorario degli scavi e monumenti dell’Isola, che mi accordò ospitalità nella sua casa e colla sua lunga esperienza mi fu largo di indicazioni e consigli”[1].
Questa campagna si svolse in contrada Diana, “nel vasto orto e vigneto a SO degli edifici vescovili, a pochi passi dalla città antica, rispondente alla moderna, adagiata al piede dell’Acropoli sotto dell’alto colle del castello, racchiudente anche la Cattedrale. In questo terreno pianeggiante si cela una necropoli ellenistica-tarda e romana alla profondità di mt 2,50 circa in un suolo che è un vero lenzuolo funebre, perché formato di una sottile cenere di eruzione, nera, soffice, quasi impalpabile. Quivi e nelle terre contigue mai si erano eseguiti metodici scavi, ma parecchi tumultuari e saltuari, dal barone Madralisca verso il 1864, da Giuseppe Scolarici verso il 1879, il cui prodotto dicesi venduto a Glasgow”[2].

Luigi Bernabò Brea e Maddlene Cavalier
Luigi Bernabò Brea[3] mette piede, abbiamo detto, per la prima volta nelle Isole Eolie nel 1946 che, dagli anni immediatamente successivi, divengono il centro dei suoi interessi scientifici; vi inizia con la collaborazione preziosissima di Madelene Cavalier, uno straordinario lavoro di scavi sistematici; ricostruisce la storia dell'antropizzazione dell'arcipelago dal neolitico fino all'età romana con una chiarezza, una puntualità che portano immediatamente i risultati delle sue scoperte ad essere paradigma imprescindibile per la conoscenza e lo studio delle civiltà preistoriche e protostoriche di tutto il Mediterraneo centrale.
Le ricerche condotte con le tecniche stratigrafiche e il bagaglio di conoscenze di cui Bernabò Brea aveva fatto tesoro, vengono seguite da pubblicazioni: i materiali vengono subito ordinati e classificati, si inizia un gigantesco lavoro di trasformazione del Castello di Lipari che, circondato dalle monumentali opere di fortificazione cinquecentesche, ospitava la Cattedrale, l'antico palazzo del Vescovi, altre chiese e gli edifici che, fra i due conflitti mondiali, costituiscono la sede della colonia di confino politico.
Bernabò Brea a questo proposito si trovò, in qualche modo la strada aperta, perché nel 1947 era stato creato, proprio al Castello, nel vecchio palazzo dei vescovi, un Antiquarium. Promotrice ne era stata Isabella Conti. La professoressa aveva frugato fra le case della città e della campagna in cerca di ogni tipo di reperti che si conservassero in privato e si era accordata con mons. Bernardino Re, anch'egli un collezionista di pezzi recuperati nei terreni della Mensa, e si era ingegnata a catalogare e inventariare ogni oggetto. Occorreva una sede per fare una sorta di mostra permanente di questi reperti. Bussò a tante porte: Prefettura, Ministero degli Interni, Ministero dell'Istruzione. Ma nessuno le dava risposte. Così un bel giorno decise di salire al castello di forzare una porta del plesso che era stato destinato al confino e lì organizzò la sua mostra.
Si mettono le basi del Museo archeologico

Il Castello, col palazzo vescovile che Bernabò Brea riesce a restaurare, diventa il nucleo principale di quella che sarà la più importante realizzazione museale siciliana in campo preistorico, ma soprattutto esempio impareggiabile di organizzazione espositiva, di perfetta tenuta dei depositi e dei laboratori. Questo Museo dal 1960 è in continuo processo di ampliamento e miglioramento. Infatti se si pensa alle opere realizzate per l'importantissimo padiglione dedicato alla vulcanologia, a quelle riguardanti il padiglione ristrutturato delle isole minori, e infine ai lavori per il completo rifacimento del padiglione n. 2, si ha l'idea di ciò che oggi rappresenta per l'archeologia non soltanto siciliana, questa istituzione museale, ma soprattutto dell'enorme insegnamento che è per tutti coloro che creano e gestiscono musei.
 Come attraverso le Eolie, si venne a stabilire il suo definitivo e indissolubile legame con l'archeologia della Sicilia, lo ha spiegato lo stesso professore : “Avevo affidato gli scavi di Tindari all'Istituto internazionale di Studi Liguri …. Particolarmente fortunati gli scavi condotti a Milazzo e nelle isole Eolie nelle quali avevo potuto eseguire qualche primo saggio esplorativo, soprattutto a Panarea fin dal 1947 e 1948....Affidai la direzione di queste ricerche a Madeleine Cavalier, già segretaria della Section Languedocienne dell'Istituto di Studi Liguri, venuta in Sicilia per gli scavi di Tindari, e che da allora è rimasta a Lipari, ed ha diretto il Museo Archeologico Eoliano che insieme abbiamo creato. Attraverso gli scavi degli Eolie e di Milazzo si veniva rivelando tutto un mondo nuovo fino ad allora ignoto e insospettato. Si raccoglievano le testimonianze di intensi e prolungati rapporti col mondo egeo. Lipari in particolare ci offriva una serie stratigrafica imponente, estesa attraverso parecchi millenni dagli inizi del neolitico medio alla fine dell'età del bronzo, che veniva a costituire un paradigma per definire su basi certe la fino allora incerta successione delle facies culturali preistoriche della regione tirrenica.
Come attraverso le Eolie, si venne a stabilire il suo definitivo e indissolubile legame con l'archeologia della Sicilia, lo ha spiegato lo stesso professore : “Avevo affidato gli scavi di Tindari all'Istituto internazionale di Studi Liguri …. Particolarmente fortunati gli scavi condotti a Milazzo e nelle isole Eolie nelle quali avevo potuto eseguire qualche primo saggio esplorativo, soprattutto a Panarea fin dal 1947 e 1948....Affidai la direzione di queste ricerche a Madeleine Cavalier, già segretaria della Section Languedocienne dell'Istituto di Studi Liguri, venuta in Sicilia per gli scavi di Tindari, e che da allora è rimasta a Lipari, ed ha diretto il Museo Archeologico Eoliano che insieme abbiamo creato. Attraverso gli scavi degli Eolie e di Milazzo si veniva rivelando tutto un mondo nuovo fino ad allora ignoto e insospettato. Si raccoglievano le testimonianze di intensi e prolungati rapporti col mondo egeo. Lipari in particolare ci offriva una serie stratigrafica imponente, estesa attraverso parecchi millenni dagli inizi del neolitico medio alla fine dell'età del bronzo, che veniva a costituire un paradigma per definire su basi certe la fino allora incerta successione delle facies culturali preistoriche della regione tirrenica.
Le nostre scoperete ebbero subito larga risonanza europea. I risultati degli scavi di Lipari e Milazzo venivano ad arricchire largamente il panorama tradizionale della preistoria siciliana fondato sulla lunga ed intensa attività dell'Orsi, integrato d'altronde per quanto riguarda la Sicilia occidentale dai fondamentali contributi portati da Iole Marconi Bovio. Sommando le esperienze siracusane con quelle eoliane ero quindi ora in grado di tracciare un quadro più ampio della preistoria siciliana, più aggiornato, più complesso... Gli scavi delle Isole Eolie e la creazione del Museo eoliano vennero a stabilire il mio definitivo e indissolubile legame con l'archeologia della Sicilia, facendomi escludere la possibilità di qualsiasi altra scelta[4]”.


In alto, un'altra immagine di Luigi Bernabò Brea e Maddlene Cavalier. Sopra: Il parco esterno del Museo dove sono state raccolte molte tombe preistoriche e, a destra, una stanza interna.
Hunziker, lo svizzero che amava le Eolie
A Lipari nel 1947 faceva ritorno dopo un’assenza di sette anni un altro eoliano di adozione che alle Eolie aveva dedicato la sua arte di pittore : Edwin Hunziker detto “lo svizzero”.
“Svizzero lo era Hunziker – ha scritto Iacolino – ma solo a metà. Lo era perchè nato nel Cantone di Zurigo, ad Affoltern sull'Albis, nella bella fattoria di papà Rodolfo, il 3 aprile del 1901. Lo era per quel temperamento di puritana e quasi teutonica coerenza con certi suoi principi di etica e di arte. Per il resto, la sua psicologia e gran parte delle sue scelte e dei suoi comportamenti furono italici: anzi siculi e schiettamente isolani. E fu questa la ragione di fondo per cui Hunziker si protese e si aprì al sole mediterraneo sino a rimanere stregato. Esattamente come era capitato ad altri spiriti nordici: a Goethe, per esempio, e a Byron”[5].
 Edwin Hunziker
Edwin Hunziker
.A Lipari giunge occasionalmente nel 1922. Tornò altre volte e nel 1924 volle mettervi radici invitando altri giovani colleghi a venire a scoprire questi luoghi d'incanto. Una colonia di tre quattro giovani che avevano a modello Henri Matisse e fra i quali primeggiava Max Gubler che eseguì la grande tela intitolata “Processione a Lipari”. Edwin dipinge Marina corta, le case di Lipari, la moglie e il figlioletto, Portinente, Mendolita ma anche le contrade lontane, partendosi di mattina con il cavalletto ed il seggiolino e raggiungendo Pianoconte, Capistello...
A quel tempo Lipari era una cittadina tranquilla ma questi giovani andarono ad abitare fuori dal paese a Diana.”Idillio quasi paradisiaco dei pittori nell'isola” ebbe a commentare Hunziker stesso. In un'isola non ancora devastata da un turismo troppo commercializzato arriva però il confino politico voluto dal regime fascista e i forestieri dovevano andare via. Così gli amici, a cominciare da Max Gubler, ebbero il foglio di via mentre Hunziker si salvò perchè il 21 novembre del 1925 aveva sposato una ragazza liparese, Clelia Gemmola Una compagna coraggiosa che avrà un ruolo importantissimo nella vita di Edwin sostenendo sempre la sua voglia d'arte e sollevandolo dai piccoli fastidi della quotidianeità.
Il confino procurò a Edwin prima occasioni di incontri con Ambrosini, Malaparte e Gualino e poi non pochi fastidi: sorveglianza attorno alla sua abitazione, mille difficoltà quando doveva viaggiare. Intanto , nel 1926, era nato il suo primogenito Sandro e nel 1931 andranno in Svizzera per organizzare una mostra alla galleria d'arte di Berna e poi l'anno dopo a Parigi, dove soggiornano alcuni mesi. Nel 1932 torna a Lipari ma non sopporta il clima poliziesco che vi si respira :”Ho spesso considerato la mia situazione un'amara ironia del destino. Non ero emigrato per imparare il timore, ma per conquistare una libertà più grande di quella che ci poteva essere nella mia patria”. Inoltre nell'agosto del 1936 era nato il suo secondogenito, Donato, purtroppo colpito da un handicap fin dalla nascita.
Così nel giugno del 1940, ai primi venti di guerra, decide di tornare con la famiglia in Svizzera e vi rimane fino al 1947. A Lipari aveva lasciato e ritrovato grazie all'attenzione di alcuni amici fidati, una casa di campagna a Diana; comprata poco tempo prima dell'inizio della guerra. La casa fu, nell'immediato dopo guerra, ampliata e attrezzata con finalità di farne una pensione, l'attuale albergo “Villa Diana” gestito dalla famiglia.

E. Hunziker, Il Castello
A Lipari Hunziker prese a frequentare Bernabò Brea, Mons. Re, Isabella Conti.. Per i contadini locali divenne una figura familiare da incontrare sotto gli ulivi di San Calogero o tra i fichi d'India del Salvatore. Ma la modernità che vedeva venire avanti non gli piaceva Non gli piaceva quel turismo.”La cittadina di Lipari è un unico grosso parcheggio. Edifici antichi e bellissimi devono fare spazio al traffico: l'edilizia soprattutto, è alimentata dall'incremento del turismo; ma anche molti italiani del continente si vogliono fare un'abitazione sicura nell'isola; e, in un certo senso, questi fatti si possono assomigliare ad eventi dei secoli passati quando all'interno dell'isola si cercava scampo dai pirati”.
C'è una ragione che spiega perchè, a cominciare dagli ultimi anni Cinquanta, abbandoni le colorazioni tenui e si dia a comporre con pennellate più decise, più cariche e più vigorose, e perchè al paesaggio diafano o al nudo impersonale preferisca i soggetti banali ma innocenti del suo pollaio. E' proprio perchè reagisce al degrado che avanza e ripiega sulla sua realtà domestica, sulla esperienza del suo cortile.
[1] In “Atti della Reale Accademica dei Lincei” Anno CCCXVI, 1929 (VII), serie sesta. Notizie degli scavi di antichità pubblicate d’accordo col R.Istituto di Archeologia e Storia dell’arte, Vol.V. Roma 1929, pag. 62.
[2] Idem.
[3] Per questo paragrafo ho fatto riferimento a G. Iacolino, Il premio “Selinon 1984” al Prof. Luigi Bernabò Brea, in Gente delle Eolie, op. cit. pp. 138- 143; M.Cavalier, Note Biografiche in www.luigibernabobrea.it
Si vedano gli articoli pubblicati dall'Accademia Selinuntina di Scienze, Lettere, Arti di Mazara del Vallo (Trapani, 1985) in occasione del conferimento del premio "Selinon", nel 1984: L. Bernabò Brea, La Sicilia nella mia vita, pp. 33-45; S.L. Agnello, LuigiBernabò Brea: abbozzo per un ritratto, pp. 47-57; G. Voza, Luigi Bernabò Brea: Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale, pp. 59-70.
[4] G. Iacolino, Il premio ecc., op. cit., pag. 140 e ss.
[5] G. Iacolino, Gente delle Eolie, op. cit., pag. 149. Per questo capitolo oltre a questo libro di Iacolino ho tratto informazioni da G. Lo Cascio, La “liparitudine” di Hunzicher, in “Questeolie, anno I n.9; Edwion Hunziker ( 1901-1986). Colore, Luce, Spazio, Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea”, 2004.
Edwin Hunziker frequentò la scuola elementare e secondaria nel suo paese natale e fin da piccolo dava una mano nella fattoria del padre perchè le condizioni di vita erano per la famiglia molto misere e difficoltose. Fin da allora il piccolo Edwin sognava di evadere da quell'ambiente ristretto e conoscere il mondo. Cominciò a fare notare il suo talento nel disegno e a parlare di fare il “pittore”. La Scuola Commerciale Cantonale di Zurigo non era per lui, la frequentava malvolentieri ma ubbidiente ai genitori prese il diploma (1920). Di intraprendere la carriera commerciale non vuole sentirne nemmeno parlare e così si iscrive all'università. Ma anche questa non va incontro alle sue esigenze e quindi convince il padre a fargli continuare i suoi studi a Roma. Qui partecipa alla scuola di pittura di Carlo Alberto Petrucci. Ma la sua famiglia non vede di buon occhio questo suo voler fare il “pittore” - “ un morto di fame non è gradito in famiglia”, gli dice il padre - e pretende almeno che si scriva ad una Accademia per diventare insegnante di disegno. Dopo Roma andrà a Monaco, poi a Firenze e quindi a Parigi. Conosce artisti, pittori, stringe amicizie. Nel 1975 Hunziker viene colpito da un ictus che per molti mesi lo costringe a cure sia in Lipari che in Svizzera. Si riprenderà molto bene, anche se da allora camminerà con l'aiuto di un bastone. Riprende a dipingere recandosi nei luoghi amati e lontani dell'isola non più a piedi ma con la macchina ed accompagnato dalla moglie. Dopo la malattia riscopre la vita e così i colori diventano più intensi e sembra mettere sulle tele un entusiasmo ancora maggiore, “Mi sembrava di riscoprire la natura dopo una lunga e involontaria assenza. Le cose più semplici ripresero una nuova parvenza”.
Nel dicembre del 1985 muore il figlio Sandro. Da questo dolore Edwin , già ottantaquattrenne non si riprenderà più. Morirà il 13 marzo del 1986, ad appena tre mesi dalla morte del figlio.(Archivio Storico Eoliano.it)
Max Gluber
Il Governatorato inglese

Il corso Vittorio Emanuele di Lipari nel primo dopoguerra
Lo sbarco degli inglesi
La guerra era ormai agli sgoccioli. La notte fra il 9 e il 10 luglio 1943 le truppe alleate sbarcano nei pressi di Gela e cominciano a dilagare per la Sicilia. Palermo fu occupata il 22 luglio ed il 3 agosto gli americani entrarono a Catania. Il 17 agosto, martedì, capitolò Messina e lo stesso giorno, alle 12 e 30, gli inglesi sbarcarono a Lipari con tre mass ed un cacciatorpediniere che operava nei dintorni. Scesero a terra ufficiali, marinai ma anche dei siciliani che si erano trasferiti in America da vari anni.
“Alla vigilia dello sbarco – racconta Renato De Pasquale - , ormai ritenuto imminente, ansia e paura si diffusero tra la gente, nella convinzione peraltro che il nemico avrebbe fatto razzìa di tutto. E così furono parecchi coloro che si preoccuparono di nascondere o addirittura sotterrare denaro, preziosi, argento e quant’altro si riteneva opportuno fare scomparire. Ma poi la paura si mostrò infondata. La truppa da sbarco era composta da un capitano e pochi soldati. La popolazione fu semplicemente invitata a denunciare e depositare presso i Carabinieri ogni tipo di arma posseduta. E così in caserma vennero ammassati vecchi fucili, revolver, sciabole. Più cimeli che vere armi”[1].
A dire il vero un’azione di saccheggio ci fu ma fu opera di liparesi che pensavano sia di approfittare della confusione sia di acquisire meriti verso gli occupanti. Non mancarono i fatti folkloristici. Così un maresciallo della polizia salì sulla gip degli inglesi e invitava i locali a festeggiare, mentre la guardia del semaforo mise la divisa americana e scese al porto di Lipari ad accogliere i vincitori. Fra la gente che assisteva ci fu anche chi gridò “Abbasso l’Italia viva l’America”.
Il governo del colonnello Jeo
Il colonnello Jeo giunse il 24 agosto e prese possesso del Municipio assumendo i pieni poteri e governando per circa nove mesi sino al 12 maggio del 1944 quando lasciò l’isola.
Ma ancora prima il 23 agosto egli ebbe a conoscere la determinazione degli eoliani quando un motoveliero ruppe il divieto di navigazione senza autorizzazione e si recò a Milazzo al comando alleato per chiedere i viveri per una popolazione ridotta allo stremo e sul bastimento c’erano tutte le autorità dell’arcipelago.
Era stato il signor Salvatore Bonica ad avere l’idea. La gente era affamata ed a Lipari non c’era più niente da mangiare. Andò da mons. Re e chiese il suo aiuto. Bisognava approntare un mezzo di trasporto ed andare direttamente al comando. Non occorsero molte parole per convincere il vescovo che chiamato un giovane seminarista, Alfredo Adornato, per farsi accompagnare, andarono prima dal dott. Ugo Sclafani che era il commissario prefettizio al Comune e poi dal comandante del Rolando, il capitano Francesco Piluso.

Mons.Salvatore Bernardino Re sul suo mezzo di locomozione abituale
“E se quella pattuglia di inglesi che sono arrivati pochi giorni fa, ci fermano?”, chiese il Piluso.
La missione del Rolando a Milazzo
“Isseremo sul pennone del Rolando la bandiera pontificia “ disse il vescovo e fece cenno al Bonica che l’aveva ripiegata in un pacchetto che portava gelosamente sotto il braccio. E così con la bandiera in testa portata dal Bonica e poi il Vescovo, il Commissario, don Adornato e il capitano Piluso il piccolo drappello andò al porto dove era ormeggiato il Rolando. Ed il veliero prese la rotta verso Milazzo con la bandiera sul pennone e sulla tolda disegnato il simbolo della Croce Rossa.
A Milazzo furono accolti con rispetto ma fu anche detto loro che un carico di viveri per le Eolie era già stato disposto e sarebbe arrivato il giorno dopo con le navi che accompagnavano il governatore Jeo. Un viaggio inutile? Assolutamente no. A Milazzo ci sono cinquanta soldati eoliani che da mesi cercano di tornare alle loro isole e non trovano un mezzo di trasporto. Loro interlocutrice si fa una professoressa napoletana che ha sposato un’eoliano e dopo mesi e mesi che non lo vedeva lo ha ritrovato fra questa schiera di reduci dispersi. Una parte di questi reduci aveva fatto come punto di raccolta la casa, dove la professoressa Conti da un oltre un mese, era stata ospitata dal nostromo Bartolo Casamento, con i figli Caterina e Giovanni. Tra l’altro tra questi reduci, vi era lo straordinario prof. Nicola Monteleone, che aveva con sé il primo antibiotico, la penicillina, che usò per persone che ne avevano bisogno.

La preside Isabella Vainicher Conti in due immagini

Due immagini della professoressa Vainicher Conti.
“Eccellenza, - dice la professoressa Conti[2] rivolgendosi a mons. Re – sono cinquanta giovani che non aspettano altro che tornare alle loro famiglie. Se ci fosse posto a bordo…”.
Il posto c’era ed il Vescovo fu ben felice di accoglierli sul Rolando. Saliti a bordo, questi giovani se ne stavano sul ponte, uno a fianco all'altro, muti, increduli che il calvario era veramente finito. Ed era proprio la professoressa Conti che faceva la spola da uno all'altro rincuorando, esortando.
Il giorno dopo, 24 agosto, poco prima che in Cattedrale si desse inizio alla messa pontificale si sentirono dei colpi di cannone e subito dopo arrivarono con la notizia che una nave inglese stava entrando nel porto. Mons. Re capì subito che si trattava della nave con i viveri e rimandando di un’ora la messa solenne, scese al porto con la gente per accogliere le tanto attese vettovaglie.
“Il periodo del governatorato – a parte alcune assurde carcerazioni di nostri concittadini[3], forse vittime di qualche delazione – pur potendo essere considerato – osserva Renato De Pasquale - [4]senza infamia e senza lode, fu sempre un periodo di umiliazione che la sconfitta ci costrinse a subire[5]”.
Un contributo del governatorato: la scuola
Comunque alcune cose positive vanno ascritte a questo Governatorato nei pochi mesi che governò. L’aver tracciata la strada Canneto – Acquacalda che era una antica aspirazione e aver pensato a rimettere ordine nel sistema scolastico eoliano.
Per la scuola, nell’ottobre 1943, il col. Jeo chiede la collaborazione della professoressa Isabella Eller Vainicher Conti . Napoletana di famiglia e di nascita, fin dal 1933, dopo che si era sposata con Riccardo Conti, la professoressa si era trasferita a Vulcano dove aveva creato la prima scuola elementare dell’isola, una scuola sussidiaria privata per i figli dei coloni, diretta e sostenuta solo da lei. “ Pensò essa stessa – scrive Giuseppe Iacolino– più tardi ad assicurare organicità a quella scuola e la necessaria continuità nel tempo affrontando la sua prima battaglia con i vertici della Provincia e coi ministeri[6]”.

Fu probabilmente perché si era reso conto delle grandi doti organizzative e soprattutto della sua forte volontà che il Governatore inglese le chiese di riorganizzare il sistema scolastico eoliano. Lo studio approfondito della situazione e delle esigenze della popolazione studentesca delle Isole, la portò a richiedere subito la soppressione dell’esistente Scuola di Avviamento Professionale e la creazione di una Scuola Media e di un Istituto Tecnico Commerciale, che lo stesso Governatore istituiva con Decreto A.M.G.O.T[7]. il 1 dicembre del 1943 e l’8 febbraio 1946 ne otteneva la Regificazione come Sezione staccata dell’Istituto “Jaci” di Messina. Nel 1948, poi questo Istituto otterrà la qualifica di Istituto Tecnico Commerciale statale ad indirizzo amministrativo e per Geometri.
“Inenarrabili le avventure di quegli anni per ottenere il riconoscimento legale da parte del Governo Italiano al nuovo Istituto. …Con zaino in spalla e mezzi di fortuna – la ricorda don Alfredo Adornato -, traversava il tratto di mare Lipari-Milazzo con barche a remi per 18 ore e per 13-14 volte. Utilizzando i permessi AMGOT faceva anche da corriere ai carabinieri e riusciva ad unirsi anche ai carabinieri per traversare lo stretto di Messina e raggiungere Salerno, sede del Governo provvisorio, quando ancora si combatteva a Cassino”. Viaggiava in terza classe, dormiva su una panchina di legno nelle stazioni, mangiava un panino nelle sale d'aspetto delle stazioni.
“Il Colonnello Jeo , meravigliato di tanto coraggio e di tanta forza d’animo, ebbe a chiederla un giorno :”Ma dove trova la forza e l'energia per superare tante fatiche?” Ed ella riecheggiando la pagina evangelica, rispondeva “..Come fanno gli uccelli del cielo?..” fu la sua risposta. “Se in Italia – concluse il Governatore – molti fossero come lei, ben presto questo paese diventerebbe una grande nazione”[8]
[1] R. De Pasquale, Il mio tempo, op. cit., pag. 59 e ss.
[2]Isabella Eller Vainicher Conti ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo socio-culturale delle Eolie. Nasce a Napoli il 15 gennaio 1906.. Isabella rimane orfana di madre in giovane età ed è colpita dalla poliomelite, passerà molto tempo ingessata, seduta su una poltrona. Da autodidatta consegue il diploma magistrale e in seguito anche la licenza liceale scientifica. Si iscrive alla facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Napoli conseguendo la laurea.
Durante una spedizione scientifica universitaria nel 1929 a Vulcano conosce Riccardo Conti che si occupa dell’estrazione dello zolfo e che insieme al fratello Attilio aveva realizzato una teleferica che serviva al trasporto dello zolfo dal cratere. Si sposeranno il 15 febbraio 1933 e Isabella dopo il matrimonio si trasferisce a Vulcano dove dà vita ad una scuola elementare sussidiaria per i figli dei coloni. Quando chiude la fabbrica di zolfo nel corso degli anni 30, Isabella inizia a insegnare lontano dalle isole mentre il marito è chiamato in guerra e deve partire. Rientra a Lipari alla fine dell’anno scolastico 1942/43 attraverso un viaggio avventuroso nell’agosto del 1943 e poco dopo avrà l’incarico dal Governatore inglese Jeo di riorganizzare le scuole delle Eolie. A partire da quegli anni è impegnata in tante iniziative sociali e culturali per le quali spende la propria esistenza insieme alle cure per la propria famiglia che va crescendo..
Diventa componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Provinciale per l’istruzione tecnica, Consigliere comunale di Lipari, creatrice della Sezione per le Isole Eolie del Centro Ecologico Italiano. Nel campo del turismo, nel 1947 fonda la prima “Pro-Eolie” premessa per la istituzione dell’Azienda di Soggiorno e Turismo. Si occupa anche di archeologia ed a questo proposito ”è stata dal 1947 – ha detto di lei Luigi Bernabò Brea - la più attiva e fattiva collaboratrice della Soprintendenza nel complesso di scavi e di ricerche…Per suo esclusivo merito sorse il primo nucleo di un Antiquarium eoliano, della cui conservazione onoraria essa ricevette incarico ufficiale dal Ministero”.
[3] Il 25 settembre furono tratti in arresto perché imputati di propaganda fascista Lino Carnevale, Checchino Vitale, Ninì Fiorentino, Attilio Maggio. In seguito furono arrestati anche l’ing. La Rosa e altri.
[4] Per questo paragrafo oltre a R. De Pasquale, Il mio tempo, op. cit., vedi anche A. Lo Cascio, Mons. Bernardino Salv. Re, vescovo cappuccino di Lipari, Messina 1977, pag.200-201; A. Adornato, Scritti e discorsi ecc., op. cit., pag 58-65.
[5] R. De Pasquale, Il mio tempo, op. cit., pag. 60.
[6]Giuseppe Iacolino, Gente delle Eolie, Lipari 1994, pag.53.
[7] L'Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT), in italiano Amministrazione militare alleata dei territori occupati, è stato un organo militare deputato all'amministrazione dei territori occupati dagli Alleati durante la seconda guerra mondiale.(Archivio Storico Eoliano.it)
capitano Francesco Piluso
Stromboli, comincia il grande esodo
L'eruzione del 1930

L’11 settembre del 1930 si ha forse l’eruzione più disastrosa che il vulcano abbia fatto registrare in epoca storica incrinando, fortemente, la fiducia che la gente che vi abita aveva nel gigante borbottone e capriccioso ma tutto sommato buono. Infatti quel giorno, dopo un'attività vulcanica che durava già da un po' di tempo, avvenne una forte esplosione dal cratere, posto a 750 metri di altitudine. Decine e decine di grossi massi furono scagliati nel cielo dalla possente bocca eruttiva. Molti di essi ricaddero sul terreno dell'isola, altri in mare, sollevando enormi colonne d'acqua. I massi più grossi vennero valutati del peso di centocinquanta chili, e, rotolando lungo i pendii della montagna, investirono qualche casa e fecero diversi feriti. Ma il fatto più clamoroso e drammatico avvenne sul lato est, verso l'abitato di San Vincenzo, il più popolato, nella zona di San Bartolomeo. Da una fenditura posta un po' più sotto del grande cratere fu espulsa con violenza una massa di gas e cenere rovente - ma non lava - che rotolò velocemente lungo il pendio, piuttosto ripido, forse inserendosi in uno dei tanti canaloni che circondano il cratere.
Una "nube ardente" che è estremamente pericolosa per le cose e per le persone perché è sempre molto veloce, e non dà il tempo di scappare e perché è improvvisa, e non si può, in genere, prevederne la direzione. Questa nube si avventò sulle poche, povere case di San Bartolomeo, le investì, le fece crollare, e sacrificò la vita di sei isolani, sorpresi da questo raro fenomeno della natura. Oltre a provocare diversi feriti e contusi. Alla fine si contarono in tutto ventidue feriti.
Si evacuarono molte abitazioni e molta gente abbandonò Stromboli. Quando la situazione si stabilizzò, e l'eruzione si calmò, molti degli abitanti dell'isola vulcanica tornarono, un po' scioccati e timorosi, ad abitare le loro semplici case sperando sempre nella buona sorte: l'attaccamento alle loro cose e ai loro terreni era più forte, in ultima analisi, di ogni preoccupazione. D'altra parte gli anziani sapevano che questi erano fenomeni eccezionali, che con tutta probabilità non si sarebbero ripetuti in breve tempo anche se c'era stato un precedente simile, il 22 maggio del 1919: maremoto, lancio di lapilli e cenere, caduta di molta lava in mare e, purtroppo, quattro persone decedute, e numerosi feriti.[1]
Fabio Famularo in un libro[2] in cui ricostruisce i ricordi del nonno, descrive quella esperienza sconvolgente, i boati, le eruzioni, la fuga sul mare con le barche, il mesto ritorno a sera inoltrata verso la spiaggia e le abitazioni accolti da “ un forte odore di bruciato e di zolfo”[3].
“Non appena albeggiò – racconta Famularo – ci destammo e una volta fuori ci ritrovammo di fronte ad un'isola completamente stravolta, ridotta in gran parte in una vasta e desolata terra bruciata. Era incredibile vedere il vulcano apparire calmo e sereno,come se la causa di quel disastro non fosse stata lui. Era lì come sempre fumante, quasi a chiederci scusa e ad invitarci ancora a credere in lui. La popolazione era impaurita e profondamente scossa. Gran parte della gente aveva già vissuto sulla propria pelle la forte eruzione del 1919 che si ricordava ancora più forte di quella avvenuta il giorno prima.... Le case danneggiate dalla violenza del vulcano erano tante, ma la gran parte aveva resistito alla sua furia,mentre nessuno dei campi e degli alberi si era salvato: l'agricoltura aveva subito un duro colpo e si prevedeva un periodo di grande carestia poiché l'autunno era alle porte e il cattivo tempo all'orizzonte. Eppure, nonostante la disperazione, tutti cominciarono a darsi da fare... Nel giro di poco l'isola ricominciò ad assumere quel senso di grande ordine che la caratterizzava ma un nuovo problema iniziava a farsi presente. Gran parte della popolazione stava maturando l'idea di abbandonare Stromboli. Molti di loro avevano parenti e amici sparsi nel mondo, dall'America all'Australia, dall'Argentina alla Nuova Zelanda: tante furono le richieste di un loro aiuto economico per acquistare il biglietto per raggiungerli...Qualcosa nel rapporto col vulcano si era interrotto: si sentivano traditi, come quando un amico ti volge le spalle... Era l'inizio di un lungo periodo di emigrazione che nel giro di qualche anno avrebbe ridotto la popolazione al minimo storico. In molti avrebbero venduto le loro proprietà per pochi soldi, giusto quelli per pagare i biglietti del viaggio; altri invece, avrebbero affidato per procura i propri beni ad amici fidati”[4].

Anni difficili e logoramento degli abitanti
Anche il 1938 - quello in cui le suore francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari aprono nell’isola una “Casa dei bambini” intitolata al Principe di Napoli e voluta dall’Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia -, fu quello in cui “il vulcano, scrive Famularo, non ci fece stare tranquilli un momento. Per lunghi periodi ci furono delle copiose colate laviche, che tenevano sempre con il fiato sospeso e con lo sguardo fisso verso la montagna, nel tentativo d'interpretare ogni suo segno. Le prime colate si verificarono a gennaio, poi a maggio, quindi a novembre”[5].
Allora l’abitato di San Vincenzo era un agglomerato di case sparse, la maggior parte delle quali si raggruppava in prossimità della chiesa su un pendio ai piedi del cono che degrada fino alla riva. Lontano della riva, su una piccola altura sorgeva la chiesa di San Vincenzo, intonacata e di un bianco abbagliante. Davanti alla chiesa si apriva una piazza triangolare dalla quale si godeva un'ampia vista sui declivi, sullo Strombolicchio che è proprio di fronte, sul mare e sulla costa calabra, che, nelle giornate limpide, si intravede sull'orizzonte. L'altra chiesa, del paesino , è quella di San Bartolomeo ricostruita sul finire dell'800, a nord est, nel punto abitato più vicino alla Sciara del Fuoco, e non a caso il più colpito dalle manifestazioni vulcaniche del 1930. Davanti alla chiesa si apriva una terrazza quadrata contornata di bisuoli dalla quale si accedeva ad un'altra terrazza più grande. Questa popolazione, che malgrado le fughe dopo le eruzioni del 1919 e del 1930, contava ancora almeno mille abitanti[6], era composta in maggioranza da uomini di mare imbarcati su navigli dell'isola, dediti alla pesca, o anche su navi italiane operanti nel campo del commercio, mentre la coltivazione dei campi era per lo più impegno delle donne.

Zunami a Stromboli
L’inaugurazione della “Casa dei bambini” fu sicuramente l’evento più importante negli anni a cavallo fra le due guerre mondiali. Avvenne in forma solenne con la partecipazione della Principessa di Piemonte e del suo seguito. La Principessa fu ricevuta dalle autorità provinciali e comunali oltre che dalla popolazione. Dalla spiaggia, dove sbarcarono, ci si avviò, in salita, all’Istituto che era collocato nella casa canonica a fianco alla chiesa di San Vincenzo, dove erano ad attendere il Vescovo di Lipari, le suore ed i bambini. La cerimonia prevedeva inni, canti, poesie, dialoghi e una simbolica offerta di fiori che le suore avevano preparato andando a Stromboli due mesi prima. Fu una impresa insegnare a quei bambini a recitare visto che non sapevano parlare nemmeno bene. Infatti nella lettera di incarico della Associazione promotrice si diceva che si sarebbe trattato” di una ‘Casa di bambini’ modesta, in un paese che non ha mai avuto Istituzioni di Assistenza, quindi una vera e propria opera missionaria”.
Gli anni 40 sono anni che logorano fino quasi ad annullare la resistenza degli isolani. Attività esplosive con effusione di lava e qualche volta anche di gas come nel 1930 – anche se in misura minore – si hanno il 22 agosto 1941, il 3 dicembre 1943, il 20 agosto 1944. Dal 1945 al 1948 si ha una attività esplosiva moderata ma il vulcano torna a farsi sentire fra aprile e maggio del 1949 e poi il 20 ottobre del 1950 alle 11,10. Il 20 ottobre si annunciò con un fortissimo boato che provocò apprensione. Poi pioggia di lapilli e cenere, una impetuosa corrente lavica nella Fossa craterica, e i lapilli provocarono alla Forgia Vecchia forti incendi alimentati anche dal vento. L’attività effusiva continuò per l’intero giorno con abbondanti colate laviche; durante la notte si intravidero vivi bagliori in direzione della Sciara, dando la certezza della persistenza dell’eruzione. Questa fase effusiva continuò fino al 23 ottobre con moderatezza, per cessare del tutto nei giorni seguenti[7].
Ed è soprattutto per questo che gli abitanti di Stromboli passarono dalle 2.487 anime che il censimento ne contava nel 1911 alle 659 del 1951 facendo registrare il più alto indice di abbandono di tutto l’arcipelago[8]
[1] Vito La Colla, L'eruzione dello Stromboli nel 1930, in Globalgeografia.com. Si veda anche D. Abbruzzese, Attività dello Stromboli dal 1930 al 1934, Boll. Soc. Sismol. Vol.XXIII, fasc. 3-4, Modena (1935).
[2] Fabio Famularo, “ ...e poi Stromboli”, Edizioni Strombolibri, Pomezia 2008.
[3] F. Famularo, idem, pag.127-132
[4] F. Famularo, idem, pag, 134.
[5] F. Famularo, idem, pag. 161 e ss.
[6] Stromboli arriva ad un picco di 2716 abitanti nel 1891 per poi decrescere, prima lentamente (nel 1911 gli abitanti sono circa 2.500) e poi, dopo gli eventi del 1919 e 1930 sempre più rapidamente. Nel 1931 sono infatti 1.100 e 659 nel 1951 dopo un forte esodo verso l' Australia del 1950, per raggiungere il picco più basso di 400 abitanti nel 1971e riprendere quindi lentamente a risalire.
[7] C. Cavallaro, L’attività dello Stromboli dal 1940 al 1953, in “Bollettino delle sedute dell’Accademia Gioenica di Scienze naturali di Catania”, serie IV, vol. III, fasc. 10, 1957.
[8] A Stromboli la popolazione che risulta al censimento del 1951 sarà solo il 26,50% di quella che c’era nel 1910; a Salina invece il 69,37%, a Filicudi il 41,24%; ad Alicudi il 40, 71%; a Lipari il 90, 37% ed a Vulcano addirittura in crescita il 151,28%. Questi dati dimostrano certamente che sull’esodo influirono anche fattori economici e non solo l’opera del vulcano ma ci dice anche che questo ebbe un grande rilievo e che più della metà se ne andò per questa ragione visto che soprattutto Stromboli dopo Lipari e Salina era l’isola che godeva di una maggiore vitalità economica.(Archivio Storico Eoliano.it)
Il terremoto del 1693 ( 2.a puntata)
La protezione dei liparesi fuori Lipari
Secondo il Campis la protezione di S.Bartolomeo ai liparesi dalle conseguenze di quel terribile terremoto, non si limitò a chi era nelle isole ma operò a favore di ogni liparese “che disperso si trovava…nel tempo di tanta ruina e stragge”[1].E ci dà qualche esempio.
Era partito da Malta con la sua feluca per tornare a Lipari, sua patria, il padron Giovanni Lambrosa con i suoi compagni e due cavalieri gerosolimitani. La notte del 9 gennaio, circa l’ore cinque, tutte si trovavano nel porto d’Augusta quando si sentono furiosamente sbattere da insoliti colpi di mare, mentre si sentono dalla città venire gridi, gemiti e rumori di rovine come se tutto stesse diroccando. Immediatamente, padrone ed equipaggio, invocano la protezione di S. Bartolomeo e confidando del suo aiuto mettono mano ai remi e, senza sapere come, in un momento si trovano al largo, fuori da ogni pericolo e senza alcun danno. Proseguirono così il loro viaggio e la domenica 11 gennaio giunsero a Catania. Padron Lambosa con i suoi compagni vollero andare a fare un giro in città pensando di trovare un buon posto dove pranzare. Ma non avendone trovati di loro gradimento decidono di tornare in barca. Ma avevano appena messo piede a bordo che sentono e vedono un disastro apocalittico. Catania in poco tempo si disfa in polvere, il mare freme ed urla e si ritira velocemente dal porto. I liparesi si appellano ancora una volta al loro Santo protettore e mentre vedono otto feluche affondare essi si abbandonano alla corrente. Una corrente tanto impetuosa che sembrava, ad ogni istante , doverli inghiottire. E invece miracolosamente si salvarono e, tornati a Lipari, poterono contare fra le lacrime, quanto era loro accaduto.
Sempre da Malta ritornava a Lipari, con la sua feluca, padron Giovanni Mangano. Giunto sotto il castello di Scicli, in località detta Mazzarelli, la sera stessa di venerdì 9 gennaio, con i suoi marinati, sbarcarono ed andarono in città per cenare. Ma improvvisamente , “toccati interiormente da tacito impulso” , lasciarono la casa in cui avevano deciso di cenare e si diressero al Convento del Carmine per cenare con i religiosi e pernottare. I dieci liparesi, si erano già ritirati nella cella che era stata loro assegnata quando sopraggiunse il terremoto. L’alloggio dove erano prima andati per cenare e dormire la notte viene raso completamente al suolo e tutti quelli che ci erano dentro trovarono la morte. Anche quattro celle del Monastero crollarono, ma quella in cui erano alloggiati i liparesi non subì il minimo danno. Di più, questi si erano appena alzati ed usciti che tutto il convento, compresa la loro cella, andò in rovina. Padron Mangano con i suoi marinai si ritirò sulla sua feluca a Mazzarelli e lavorarono per caricare la barca di mercanzie per partire. Domenica mattina il Mangano si accorse che per finire di portare il carico a bordo gli occorreva l’aiuto di un cavallo e mandò due marinai a cercarlo in città. Erano questi appena usciti dalla città e stavano tornando alla barca seguiti da un uomo col suo cavallo quando sentirono delle forti scosse ed il terreno si aprì dietro di loro inghiottendo l’uomo col cavallo. I due marinai illesi, videro Scicli andare in rovina dinnanzi ai loro occhi. Corsero verso la barca e videro che sulla spiaggia c’era il Mangano con gli altri marinai illesi. Il risucchio del mare e la successiva ondata danneggiarono la barca ma non la distrussero. S. Bartolomeo, raccontarono, a cui si erano affidati, li aveva protetti.
Altri due episodi riguardano liparesi che si trovarono a Messina la domenica 11 gennaio. Un padre osservante doveva partire da Messina per andare a predicare. Volle pertanto quella mattina, prima di lasciare la città, andare a salutare alcuni suoi devoti. Si prese per compagno il padre Serafino da Lipari ed entrarono in un palazzo. Ma padre Serafino non volle salire sopra, sebbene pregato disse che avrebbe aspettato nel cortile. Mentre il padre osservante è sopra a chiacchierare con l’amico giunge il terremoto che scuote tutto il palazzo. La parte di fabbrica dove si trovava il predicatore crollò e questi rimase coinvolto nelle rovine e morì. Si salvò invece padre Serafino.
La stessa cosa accadde ad una donna di Lipari che si trovava in una casa di Messina con altre due donne. Quando giunse il terremoto lei invocò la protezione di S. Bartolomeo e rimase illesa mentre le sue ospiti morirono nella rovina della casa.
Conclude il Campis questo escursus , affermando che “né si sa che in tante e sì grande rovine accadute nel Regno di Sicilia per causa di questi fieri tremoti vi sia rimasto morto o in qualche modo offeso alcun liparoto, onde pare che il Glorioso Bartolomeo potesse dire , in quelle sciagure, al Signore Dio: - Di quanti havete posto sotto la mia tutela ‘non perdidi ex eis quemquam’ (Giovanni XVIII,9) ”[2].
La riconoscenza dei liparesi al Santo patrono
I giorni che seguirono il terremoto, mentre arrivavano le notizie dei lutti e delle rovine dalla Sicilia e si moltiplicavano i racconti dei liparesi che tornavano a casa felici di essere scampati al disastro, certo uno degli argomenti più sentiti era come avrebbe potuto la città e l’isola esprimere la propria riconoscenza al Santo Patrono.
E la prima idea che venne in mente a tutti fu quella di dedicargli una nuova festa di precetto: la quarta dopo quella canonica del 24 agosto, il 13 febbraio quando ricorreva l’invenzione delle reliquie del corpo, il 17 giugno introdotta per aver preservato Lipari dalla peste quel giorno del 1541.
I giurati con la partecipazione del governatore convocarono il consiglio che all’unanimità deliberò che “a gloria di S. Bartolomeo si festeggiasse in perpetuo, e con tutta la divotione e pompa possibile, l’undicesimo del mese di Gennaro, giorno anniversario della grazia ricevuta”[3]. Inoltre l’atto pubblico sottoscritto dal notaio prevedeva anche che la vigilia fosse giorno di digiuno e lo stesso doveva avvenire per la vigilia delle altre tre feste del Santo. Il Tribunale del Real Patrimonio il 2 luglio, confermò questa delibera ed autorizzò la spesa per i festeggiamenti[4].
Un secondo provvedimento fu quello di costituire una confraternita dedicata al Santo che aggregasse solo nobili. Ancora il vescovo stabilì che il giorno 11 di ogni mese fosse esposto in Cattedrale alla pubblica venerazione la reliquia di S.Bartolomeo e che egli stesso avrebbe celebrato la Messa alla presenza della reliquia. Inoltre decise che tutti giorni, all’ora 21 che era quella del terremoto, ognuno smettesse la propria attività e recitasse un atto di dolore per i peccati commessi.
Al Santo fu anche promesso che si sarebbe fatto un altare nuovo in Cattedrale, che gli sarebbe stata dedicata una statua ad altezza naturale tutta in argento e che sarebbe stata riparata la chiesa madre che pure aveva accusato le scosse del terremoto.
Ma mentre le prime decisioni diventarono subito esecutive, questi altri tre proponimenti impiegarono del tempo a realizzarsi. In particolare la statua in argento e l’altare in legno forte intagliato ed ornato di fregi d'oro zecchino, richiedevano molti fondi e la ricerca di questi procedeva con estrema lentezza. Forse fu necessaria la forte scossa tellurica dell’1 settembre 1726 perché improvvisamente si ebbe una grande accelerazione e, nel giro di due anni, dal 1727 al 1728, tutto fu commissionato, improntato e posto in opera. Alla testa dell’operazione si misero i giurati Nicolò Antonino Rossi, Francesco Policastro e Girolamo Pisano facendo ricorso a fondi pubblici locali e contribuzioni di privati[5]. E fu da quel momento che le processioni del Santo, fino ad allora circoscritte nel Castello cominciano a snodarsi anche per la città bassa. Si trattava spesso di un lungo serpentone umano formato da oltre cento fra preti, frati e chierici, ben otto confraternite – San Bartolomeo, Immacolata Concezione, Maria S.S. Della Grazie, Addolorata, San Giuseppe, San Pietro, Sant'Antonio Abate, S. Francesco di Paola, e le Anime Sante del Purgatorio – e poi tutto il popolo.
Ma rimaniamo al 1693. Quell’anno, ci dicono i cronisti dell’epoca, il carnevale fu “consegrato alla modestia, alla computione ed alla integrità de’ costumi”[6].
Così il giovedì grasso, che cadeva il 29 gennaio, parve il giorno “più santo dell’anno”. La gente numerosissima si confessò e fece la comunione riempiendo la Cattedrale e disertando le piazze. In Cattedrale sopraggiunsero anche le confraternite ed i frati e si diede luogo ad una solennissima processione col vescovo che portava il santissimo e l’arcidiacono il braccio d’argento con la reliquia del dito pollice. Il baldacchino era sostenuto dai rappresentanti della città. L’interminabile sequela di gente uscì dalla città alta e si portò prima a San Giuseppe, poi alla cappella di S.Barolomeo a Portinenti, finalmente – compiendo un ampio giro – giunse alla chiesa di S. Pietro e da qui si fece ritorno alla Cattedrale dove il vescovo tenne un discorso annunziando, fra l’altro, che da venerdì a lunedì, la reliquia del santo sarebbe stata esposta alla venerazione dei fedeli, mentre martedì 3 febbraio, giornata del carnevale, sarebbe stata santificata con l’esposizione del Santissimo e l’adorazione dei fedeli. Così, senza intermezzo, si sarebbe entrati nella quaresima.
Intanto si approssimava il 13 febbraio, ricorrenza dell’arrivo a Lipari del corpo del Santo e si pensò quell’anno di celebrarla con particolare solennità. Si cominciò con l’esporre, tre giorni prima dell’evento, a sera, la reliquia e “si cantarono in musica le laudi”. Quando poi si era fatto buio in ogni parte della città, del borgo e della campagna si accesero dei grandi falò. La mattina del 13 ci fu il pontificale del vescovo con un panegirico rivolto al Santo. Alla fine della messa si portò, in processione - vescovo, canonici, clero, frati e confraternite, autorità e popolo - la reliquia alla chiesetta del Santo extra moenia . E per la prima volta da oltre un mese si vide la gente sorridere ed anche i canti non era più quelli della mestizia ma della gioia. La cerimonia si concluse in Cattedrale dove si intonò il Te Deum[7].
La morte del vescovo
Il personaggio che era emerso con forte spicco da questa vicenda del terremoto era sicuramente mons. Castillo che aveva interpretato, più di chiunque altro, il sentimento popolare ed intorno al quale si era stretto tutto il popolo ma anche le autorità ed i nobili cittadini. Tutti parlavano bene di lui nelle isole e si presagiva un futuro importante per la chiesa di Lipari vista anche la giovane età del prelato. Ma le cose dovevano andare diversamente.
Si era nella quaresima del 1694 ed era trascorso più di anno dal terremoto. Il papa Innocenzo XII aveva indetto un Giubileo e il vescovo volle che il popolo fosse preparato a questo evento religioso. Così affidò ad un predicatore, in Cattedrale, l’illustrazione del suo significato e l’importanza di prepararsi ad accogliere questo evento che era segno di riconciliazione e di remissione ei peccati. Lui stesso il venerdì 19 marzo , come usava fare tutti i venerdì di quaresima, volle prendere la parola ed, oltre a parlare della passione del Signore, affrontò il tema del Giubileo e degli effetti di santificazione che provocava nelle anime preparate a riceverlo. E poi preso dalla passione, nel fervore del discorso, ripeté più volte: “Beato quello a cui Dio concedesse di morire domenica prossima subito dopo aver ricevuto il Giubileo! Oh se fossi io questo fortunato!”.
La gente fu colpita dall’impeto del discorso e lo stesso presule finì, spossato, la celebrazione tanto che, contrariamente al suo solito, dovette mettersi a letto per riposare. Lui stesso ebbe a confidare nella stessa giornata che quello che gli era successo non gli era mai accaduto prima. La grande stanchezza dopo il discorso ma più ancora, un forte impulso interiore, mentre parlava, e l’impossibilità di trattenere le parole che uscivano da sole e le lacrime.
Il 21 marzo era il giorno in cui a Lipari si celebrava il Giubileo e alla funzione religiosa partecipò un gran numero di persone che si accostarono alla confessione ed alla comunione. Nel pomeriggio – dopo essere stato in chiesa a pregare – il vescovo salì con suo cognato, che era il governatore di Lipari, su un terrazzo per respirare l’aria del mare e passeggiare un po’. Passeggiando volle andare da un terrazzo ad un altro per mezzo di una scaletta di pietra senza appoggio. Probabilmente scendendo si impiglio nella veste, perse l’equilibrio e cadde nel terrazzo sottostante e batté con la testa nella parte destra. Subito perdette conoscenza e rimase in uno stato di letargo fino alla mattina di lunedì quando morì. Aveva 35 anni.
(www.archiviostoricoeoliano.it)
[1] Ibidem, pag. 362.
[2] P.Campis, pp. 362-365.
[3] P. Campis, op.cit., pag. 358.
[4] G.La Rosa, op.cit. vol I, pp.240-242.
[5] Per la verità le 750 onze che costarono i due manufatti, statua ed altare, furono raccolte fra la popolazione mentre il municipio offrì l’avantialtare d’argento e si fece carico della cappellina erogando, previa autorizzazione del viceré, prima 50 onze il 16 gennaio 1733 e poi altre 35 onse il 15 novembre dello stesso anno. Libro delle corrie,ff.171, 174, 174v.
[6] P. Campis, op.cit., pag. 359.
[7] Idem, pp. 359-262.
Il terremoto del 1693 (1.a puntata)
Come fu vissuto a Lipari il terremoto del 1693 che fece distruzioni e lutti nella Sicilia orientale fino a Messina ma risparmiò Lipari, è una importante pagina di cultura e di costume che è possibile ricostruire grazie ai contributi di Pietro Campis, Giuseppe la Rosa ed i recenti studi di vulcanologia (m.g.).
“All’unnici di Jinnaru a vintin’ura
a Jacu senza sonu s’abballava
cui sutta li petri e cui sutta li mura
e cui a misericordia chiamava”
“L’undici di gennaio alle ore ventuno
ad Acireale senza musica si ballava
chi sotto le pietre e chi sotto le mura
e chi invocava la misericordia divina”
(detto popolare siciliano)
l terremoto in Sicilia
La prima scossa avvenne nella notte - “nell’ora quinta[1]” - del 9 gennaio ma non furono in molti a sentirla perché i più dormivano e probabilmente a Lipari non dovette essere particolarmente forte. La seconda arrivò nel pomeriggio dell’11 gennaio, domenica, alle 13- 13,30 corrispondenti alle 21 siciliane dell’epoca, e questa volta la percepirono tutti, così riferiscono gli storici liparesi.[2]
Ma prima di parlare di quali furono le reazioni dei liparesi, cerchiamo di capire , anche alla luce delle ricerche moderne, la natura di questo evento sismico.
“Il terremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale – osserva uno studio del dipartimento di fisica dell’Università di Bologna[3] – è l’evento di più elevata magnitudo[4] della storia sismica italiana. Ad esso fu associato un maremoto catastrofico, osservato lungo tutta la costa orientale della Sicilia e più a sud fino all’arcipelago maltese”. Questo terremoto ha provocato distruzione completa in molte città delle attuali province di Catania, Siracusa e Ragusa e gravi danni fino a Palermo e Messina . Lo tsunami che ha colpito l’intera costa ionica aveva onde fino ad 8 metri.[5]. I morti furono da 60 mila a 93.000[6]. A Catania morirono 16 mila persone su 20 mila abitanti che contava allora la città; 5 mila su 9.950 a Ragusa; 4 mila su 10 mila a Lentini; 4 mila su 15.339 a Siracusa. La prima scossa arrivò la sera del venerdì 9 gennaio alle 21 circa[7], crollarono numerosi edifici e vi furono vittime, altri edifici furono seriamente lesionati. Il sabato passò senza forti scosse mentre la mattina di domenica alle ore 9 si ebbe una forte scossa e un’altra circa un’ora dopo. Ma l’evento principale, la scossa di 7,4° Richter, arrivò alle 13 e 30 provocando l’immane distruzione e l’innesco del successivo maremoto. Lo sciame sismico con le scosse di assestamento, anche forti, si protrasse ancora per circa due anni con un numero elevatissimo di repliche. Ne vengono stimate circa 1500 di varia intensità e a volte, come quella dell’1 aprile, provocarono altri danni[8]. L’area di avvertibilità è stata molto vasta e si è estesa dalla costa africana alla Calabria settentrionale. “Il terremoto ha raggiunto un’intensità del 6° grado nelle isole Eolie, ed ha provocato danni abbastanza gravi nell’isola di Malta (8°), ma la parte più colpita è stata la Sicilia meridionale con un’area di circa 5600 kmq in cui il terremoto ha raggiunto un’intensità di almeno 9°”. L’area mesosismica, cioè quella dei massimi effetti, la cui intensità è stata valutata dell’11°, copre una superficie di circa 550 kmq e mostra una direzione di allungamento verso nord-est e verso sud-ovest, cioè verso Messina e Malta dove, in entrambe, il sisma è stato dell’8° e che sono poste rispettivamente ad una distanza di circa 180 e 110km dall’area dell’epicentro. Mentre sulla direttrice perpendicolare, si ha una forte attenuazione e l’8° è raggiunto fra i 20 e 40 km dall’epicentro. Questo spiega perché alle Eolie che si trovano proprio sulla direttrice verticale il sisma è stato di 6° ben due in meno di Messina[9].
Ma dov’era l’epicentro? Oggi la tesi più accreditata sulla sorgente di quel sisma indica la scarpata ibleo-maltese che si trova sul mare proprio di fronte alla costa ionica della Sicilia e più precisamente al largo della costa fra Augusta e Catania. E spiegherebbe anche uno tzunami di quella portata[10]. La profondità risulterebbe circa di 20 km.
Messina subisce danni assai gravi. “I magnifici palazzi di Messina, dalle facciate imponenti e ornamentali, ma strutturalmente inadeguati a sostenere i movimenti tellurici dell’isola, furono scossi fin dalle fondamenta”.[11] Ma, visto come andò per Catania, Ragusa e altri centri della Sicilia orientale si può ben dire che essa sia stata risparmiata come, per la gran parte dei paesi della costa tirrenica e le stesse isole Eolie.
Il terremoto a Lipari
Il racconto di come avvenne il terremoto a Lipari lo si deve a Pietro Campis[12]che non si limita a dare informazioni sulle giornate del terremoto ma anche sulle manifestazioni di pietà religiosa che seguirono ai fatti e altre vicende che sono ad essi connessi. Siccome ci sembra che delineano un quadro suggestivo della Lipari del tempo e della sua cultura, anche noi attingeremo ampiamente a questa cronaca riportandola ad un linguaggio più accessibile al lettore di oggi. Va detto subito che il Campis, come d’altronde i liparesi suoi contemporanei, vede in questo evento che risparmiò non solo Lipari ma i liparesi ovunque si trovassero, la grandezza “del Patrocinio di S.Bartolomeo Apostolo sopra la Città di Lipari e i suoi Cittadini in occasione che la divina Giustizia provocata dalle colpe dei mortali usò la forza del suo giustissimo sdegno sopra la vicina Sicilia con spaventosi e replicati terremoti, i quali scotendola dai fondamenti, tolsero la stabilità alla terra, la fermezza alle fabbriche, la vita a più di cento quarantamila persone”[13]. Ed è proprio per fare comprendere “come per li meriti ed intercessione del Santo Apostolo sia stata preservata la Città di Lipari con i suoi abitanti da quello universale flagello[14]”ma anche per dimostrare il “grande amore del novello pastore verso le sue pecorelle” che lo storico che scrisse probabilmente un anno dopo gli eventi ci fornisce una narrazione dettagliata.
La cronaca del terremoto ha un antefatto. Tre mesi prima, l’8 ottobre del 1692 circa 21 ora, improvvisamente si annuvolò il cielo e si oscurò come se volesse piovere, e improvvisamente si scatenò sull’isola una furiosa tempesta come di grandine ma i chicchi erano grossi e pesanti fino a cinque libre[15], avevano una forma triangolare con tre punte lunghe ed al centro come la figura di un occhio che risaltava perché più chiaro. Questa burrasca sorvolò l’isola con un forte frastuono e si scaricò a mare, senza colpire nessuna persona ma solo alcuni animali che morirono.
Naturalmente questo evento, ripensato con quanto accadde dopo, nel successivo gennaio, apparve come un segnale divino a non peccare per non “sogiacere all’acuti strali dell’Irata Giustizia”.
La prima scossa del terremoto a Lipari si avverte il 9 gennaio alle “ore cinque di notte” che dovrebbero essere le 22 di oggi, ma siccome i più dormivano e non procurò alcun danno, passò per lo più inosservata. Ma, qualche giorno dopo, la domenica 11, circa l’ora 21, mentre in Cattedrale il vescovo stava amministrando la cresima, per cui la chiesa era affollata, si avvertono tre terribili scosse. Ogni cosa vacilla, gli edifici oscillano, le strade sembrano sfuggire sotto i piedi. Dove andare? Verso dove scappare per salvarsi la vita? Sono domande che ognuno si pone mentre si cerca di capire che cosa è successo, spaventati, instupiditi.
Quelli che sono in chiesa corrono verso l’altare dove si conserva la reliquia del pollice chiedendo misericordia, pietà perdono, invocando l’aiuto del Santo. Quelle scosse durarono a lungo, un tempo infinito. Ma come era venuto il tremore finì.
Durante quelle scosse vi erano a Vulcano dei liparesi che erano andati a lavorare nei campi. Anch’essi avvertirono le forti ed interminabili scosse ma ciò che li terrorizzava era vedere l’isola di Lipari, dove avevano casa e famiglia, come una piccola barca agitata da una furiosa tempesta e sballottata tanto da parere che da un momento all’altro dovesse inabissarsi. Ma poi improvvisamente anche questo fenomeno cessò e Lipari tornò ad essere ferma e stabile.
Il Campis, a questo punto, passa in rassegna le città e i paesi colpiti dal sisma cominciando con la Val di Noto e via enumerando fino a Catania.
Palermo, Messina e le altre città, terre villaggi della Sicilia “ se non caddero a quelle scosse, furono con tutto ciò sì maltrattate che non si reggono in piedi e, bisognose di sostengo per non cadere, hanno mendicato dalle selve l’appoggio affidando a’ legni le vacillanti e cadenti loro membra[16]”.
Solo Lipari, sostiene il Campis, nella sciagura e desolazione universale, non patì il minimo danno né nelle persone, né negli edifici. E non ha il minimo dubbio, il Campis, che il merito sia solo di S. Bartolomeo: “se l’invocato Santo Bartolomeo non si fusse subitamente interposto appresso la Divina Giustizia per il populo supplichevole, non haverebbe avuto Lipari miglior sorte di quella che incontrarono tante e tante famose Città della Sicilia”.
Una lunga penitenza
Comunque è questo il sentimento della grande maggioranza di liparesi in quel giorno tremendo. Finite le scosse, il vescovo che è mons. Castillo – che era andato a vivere nel Palazzo accanto alla Cattedrale, probabilmente in qualche modo riparato – va nella Cattedrale che è piena di popolo e fa esporre la reliquia del pollice, lascia quindi che la gente si sfoghi per qualche tempo con pianti e preghiere e quindi, chiesto di fare silenzio, prende la parola ed esorta tutti alla penitenza.
E subito, esposto il SS.Sacramento, annuncia che sarebbe rimasto all’adorazione dei fedeli per le prossime quarant’ore, notte e giorno comandando ai canonici che tutti facessero turni di due ore. E lui stesso diede l’esempio scegliendo per se il turno della mezzanotte.
Quella notte la maggior parte dei liparesi la passò in Cattedrale, alternando la paura alla speranza, e ritenendo che, se era destino che dovessero morire, meglio era morire in chiesa in ginocchio dinnanzi al Santissimo.
Ma la notte passò senza nessuna replica del terremoto per quanto leggera.
Il lunedì il vescovo preceduto dal clero e assistito dal governatore e dai giurati portò in processione il Santissimo dalla Cattedrale al Borgo e quindi per tutta la città invocando Dio che preservasse le persone e le isole dal ripetersi di eventuali dissesti. Alla processione il popolo partecipò numerosissimo e, tornata in Cattedrale la processione, il vescovo esortò tutti a prepararsi ad una comunione generale per il prossimo mercoledì mentre il martedì sarebbe stato dedicato alle confessioni.
E così passò il martedì col vescovo che partecipò direttamente alle confessioni mentre ognuno viveva nel raccoglimento e nella preghiera.
Arrivò il mercoledì 14 e per tempo la mattina arrivarono alla Cattedrale in processione le varie confraternite con i loro abiti penitenziali e intonando canti di penitenza. Dopo la comunione si formò una processione che dalla cattedrale, attraverso il borgo, si diresse alla chiesa di San Bartolomeo extra moenia sempre con il clero, il vescovo e le autorità in testa portando la reliquia del pollice. Lì giunti fu chiesto al Santo di confermare il proprio patrocinio e quindi tornarono alla Cattedrale.
Ma la giornata non poteva dirsi ancora conclusa. Nel pomeriggio, quando scadevano le quaranta ore di adorazione, di nuovo le confraternite si diressero alla chiesa madre e questa volta tutti i confrati avevano una corona di spine in testa e una grossa e rozza fune al collo.
Anche i frati Osservanti ed i Cappuccini intervennero con la corona di spine in testa e scalzi e ciascuno portava uno specifico strumento di penitenza: chi si era caricato una grande e pesantissima croce, chi si trascinava al piede una lunga e massiccia catena, chi aveva sulle spalle un pesante macigno, chi con strumenti a punta si colpiva il volto che aveva tutto coperto di sangue. Anche il clero sopraggiunse con il capo cinto di spine.
La processione, con alla testa il vescovo, che mostrava il Santissimo, e le autorità cittadine – anch’essi cinti di corone di spine -, dalla Cattedrale si diresse verso la chiesa di San Giuseppe nel Borgo seguita da un a folla numerosa, tutti con in capo una corona di spine. In questo lungo corteo non mancava chi con flagelli si sferzava le spalle, o si era fasciato le carni nude con l’ortica, o chi si piagava il petto mentre il clero con voce flebile intonava preghiere. Quindi la precessione fece ritorno alla cattedrale dove il vescovo, con un breve discorso, accomiatò tutti.
La congregazione dell’Immacolata chiese al vescovo che si prolungasse di altre quaranta ore e ad essa si unirono le altre congregazioni. Così fu deciso che l’indomani mattina, 15 gennaio, il Sacramento venisse esposto nella chiesa di San Giuseppe e poi a turno si sarebbe portato nelle altre chiese e conventi – e durante il giorno oltre alle preghiere ci sarebbero stati esortazioni spirituali di canonici, padri regolari e dello stesso vescovo nel pomeriggio – e questo fino alla Domenica.
La domenica 18 il vescovo era nuovamente in cattedrale in abito penitenziale e nel pomeriggio, arrivati anche i monaci e il clero con gli stessi segni penitenziali del giorno 14, con la reliquia del Santo la processione si diresse verso la chiesetta di San Bartolo extra moenia. Vi erano anche il governatore ed i giurati anch’essi cinti di spine e con al collo una corda di canapa e così tutto il popolo che seguiva silenzioso e penitente.
E’ fra la sera della domenica e la mattina del lunedì che finalmente giungono a Lipari notizie dalla Sicilia. E ciò che colpisce di più è il sapere che lì alle fortissime scosse dell’11 ne erano seguite diverse altre, “minacciandone un totale sterminio”.
La mattina del lunedì Lipari è tutto un pianto. Nella case, nelle chiese, nelle piazze, nelle strade sono solo suppliche e gemiti. E non si capisce se questi sono per la commiserazione della rovina che è toccata a tanta gente o per il riconoscimento di esserne stati preservati. “La verità si è che – commenta il Campis – dall’uno e l’altro motivo il tutto s’originava nel cuore dei Liparoti”[17].
A questo punto la sequela penitenziale riprende con maggior convinzione e vigore. “Affronte di tante calamità partorite dal tremoto in Sicilia più spicca la gratia fatta alla Città di Lipari, che, sbattuta gagliardamente, fu sostenuta, e, già cadente, fu fermata senza minomissimo detrimento”[18].
Il vescovo scende in Cattedrale con la corona di spine in testa e scalzo, si prostra in preghiera di ringraziamento dinnanzi alla reliquia dell’Apostolo e poi, sempre scalzo, si reca alla chiesa della Madonna delle Grazie , che si trova ad un centinaio di metri dalla Cattedrale, dove era esposto il Santissimo. Qui lo raggiungono i canonici del capitolo anch’essi incoronati di spine e scalzi. E quando si sparse la voce nella città che il vescovo è con i canonici in preghiera e scalzo, tutti corrono alla Madonna delle Grazie. Tutti scalzi, tutti col capo coperto di spine, anche il governatore ed i giurati, tutti senza eccezione alcuna incuranti del fatto che era inverno, che faceva freddo, che le strade erano pozzanghere fangose. Tutti anche le signore, le donne di ogni ceto, scarmigliate, con croci e flagelli, battendosi il petto, piangendo, invocando pietà. Tutti anche le ragazze, i giovani, i bambini graffiandosi la faccia. Percotendosi il petto con sassi, battendosi le spalle con corde impeciate, tutti implorando misericordia e perdono, “vedevasi una divotione confusa et una confusione devota[19]”.
“Chi non vidde Ninive penitente poteva quella mattina raffigurarla in Lipari[20]”!
E questa contrizione non si trattò di un fuoco fatuo. Il martedì, il mercoledì e il giovedì furono giorni totalmente consacrati al pianto, al pentimento, alla confessione ed alla comunione, ad atti di penitenza “che ognuno a suo talento esercitava” , di giorno per le strade e nelle chiese e di notte dinnanzi alle porte chiuse di queste giacchè si temevano ancora rovine e stragi.
Le notizie che erano arrivate dalla Sicilia sembravano avere tolto senno e sonno alle persone. Non si dormiva più di notte e di giorno si camminava per le strade “insensate e stolide”, meste e taciturne. Non si vedevano più per le strade e per le piazze il formarsi di circoli per chiacchierare, anzi appena si scambiavano saluti muti fra amici e parenti. Diversi pensavano di abbandonare la città e il borgo e di rifugiarsi in campagna come se anche qui non si fossero potuti aprire delle voragini.
Di questo sentimento popolare di depressione ne fu turbato il vescovo che pensò che fosse giunto il momento di porre fine a questa lunga penitenza ch era durata per più di dieci giorni.
Così giovedì 22 gennaio era l’ultimo giorno in cui il Santissimo stava esposto nella Chiesa delle Grazie. Il vescovo, alla 21 ora (ore 14?), preceduto dal capitolo e seguito dai rappresentanti la città, si soffermò in preghiera dinnanzi all’ostensorio poi presolo in mano si portò alla porta della chiesa perché potesse essere ascoltato da quelli che erano dentro la chiesa e dai moltissimi che non erano riusciti ad entrare e stavano in ginocchio nella piazzetta dinnanzi. Nel suo discorso partì dalla grazia che Lipari ed i liparesi avevano ricevuto per i meriti di S. Bartolomeo ma, parte nuova del suo discorso, si disse sicuro che l’isola e la città non sarebbero più stati soggetti a cataclismi e scosse di terremoto e questo proprio per la tutela del santo. E disse questo senza alcuna esitazione sereno in volto ma con voce ispirata. E lo ripeté più volte alzando l’ostensorio. Grazie a S. Bartolomeo il pericolo era cessato.
Un discorso breve ma di grande efficacia. E la gente gli credette ed immediatamente tutti si rasserenarono. Così accompagnarono vescovo e ostensorio in processione ancora una volta per la città e ritornati alla Chiesa delle Grazie il vescovo volle rassicurare ancora i cittadini: “Non bisognava avere più paura che tremi la terra. Dio per i meriti del suo Apostolo ci ha preservati da questo tragedia e così sarà per l’avvenire”. Quindi mons. Castillo impartì la benedizione e rimandò la gente alle proprie case.
Nei giorni seguenti si seppe che proprio nella giornata di giovedì, “alle 22 ore sonate”, mentre il vescovo parlava rassicurando tutti, a Messina ed in altre città la terra fu scossa da forti tremori. Ma a Lipari non ci fu più alcun sommovimento, ne allora nei mesi seguenti, dice il Campis, che finiva di scrivere il 10 agosto di quello stesso anno[21].
[1] Le ore si contavano a partire dall’Ave Maria che però cambiava da stagione a stagione perché corrispondeva all’imbrunire. Se a gennaio il sole tramonta alle 17 si può pensare che l’ora quinta siano le 22 e che le 21 della domenica erano le 13. Un calcolo diverso degli orari viene fatto da M.S. Barbaro e M. Cosentino (Il terremoto siciliano dell’11 gennaio 1693, Rend.Soc. Geol.It, 4 (1981), pp- 517-522): il 9 gennaio la scossa si sarebbe verificata alle ore 4,30 del tempo corrispondente alle 21,07 di oggi; il terremoto dell’11 gennaio sarebbe avvenuto alle ore 21 del tempo allora in uso corrispondente alle 14.09 del tempo odierno. Ma se il terremoto a Lipari giunse durante la cerimonia in Cattedrale è difficile che questa fosse ancora in corso alle 14.09. Più probabilmente la scossa che colse la gente in cattedrale fu quella delle 16 tempo di allora corrispondente alle ore 9. 23 di oggi e che vi sia stata confusione fra le due scosse.
[2] G. La Rosa, “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole di Lipari”, a cura di Alfredo Adornato,vol. I, pp232-241,
[3] S. Tinti, A.Armigliato e R.Tonini, Studio delle possibili sorgenti del maremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale mediante modellazione numerica, Convegno GNDT 2004.
[4] M=7,4 secondo Gruppo di Lavoro CPTI, 2004.
[5] Dal sito www.socgeol.it , vol.128(2009) f.1.
[6] M.S. Barbano, M. Cosentino, art. cit., pag. 521. I dati e le notizie riportati dalle cronache o da descrizioni del terremoto si rivelano spesso contraddittori. Risulta perciò importante confrontare più documenti, possibilmente atti ufficiali. Riguardo, ad esempio, alle vittime del terremoto le notizie sono estremamente discordanti; per la Relazione dei Senatori di Siracusa ... , cit., i morti sono 93.000, secondo il manoscritto anonimo Il gran terremoto del 1693 in Siracusa sarebbero 26.000: L. Trigilia, Siracusa ... , cit., pp. 116-117, cfr. a p. 82. F. Aprile, Della cronologia ... , cit., riportando gli «Estinti nelle rovine del terremoto», osserva: «rapporterò qui la strage delle persone quasi d'ogni popolazione per potersene conietturare ancora le rovine degli edifici; avvegnaché non sia in tutte argomento infallibile, poiché in alcune fu grande il danno delle fabbriche, minore, e non corrispondente la perdita degli uomini, che con maggiore accorgimento si sottrassero al pericolo dopo il terremoto del venerdì .. ».
[7] La prima scossa si fece sentire “per lo spazio di due pater noster”, quella dell’11 gennaio (alle 15 o alle 13.30), fu avvertita per il tempo di “una litania cantata”. ( Da una lettera del conte Domenico Lacorcia scritta da Mazzarino il 13 gennaio ad Antonio Bulifon in L.Trigilia, La ricostruzione necessaria, Centro Internazionale di Studi sul Barocco.)
[8] M.S.Barbano e M. Cosentino, art. cit., pag. 519.
[9] Idem, 519-521.
[10] M. Stucchi, F.Albini, A.Moroni, I. Leshiutta, C.Mirto e G.Morelli, Il terremoto del 9 gennaio 1693 in (a cura di) G.Giarrizzo, La Sicilia dei terremoti lunga durata e dinamiche sociali, Catania 1886.
[11] S.Greco, Messina medievale e moderna, op.cit., pag. 332.
[12] P.Campis, Disegno historico della Città di Lipari, a cura di G. Iacolino,t., pp.345-366. E la cronaca del Campis riprende ampiamente Giuseppe La Rosa, op.cit., vol I,pp.232-241. Noi seguiremo la narrazione del Campis integrandola, dove ci sembra più chiara e puntuale sotto l’aspetto narrativo, con quella del LaRosa, che in qualche punto se ne discosta.
[13] P. Campis, op.cit., pag. 345.
[14] Idem, pag. 345.
[15] La libra siciliana doveva essere di poco superiore ai 3 etti e quindi questi chicchi di grandine sarebbero arrivati pesare sino ad un chilo e mezzo.
[16] P.Campis, op, cit., pag.350.
[17] P. Campis, op. cit., pag. 354.
[18] Idem, pag. 354.
[19] P. Campis, op. cit., p.355.
[20] Ibidem, pag. 355.
[21] Ibidem pag. 358.
---Il terremoto del 1693
Il terremoto in Sicilia
“All’unnici di Jinnaru a vintin’ura
a Jacu senza sonu s’abballava
cui sutta li petri e cui sutta li mura
e cui a misericordia chiamava”
“L’undici di gennaio alle ore ventuno
ad Acireale senza musica si ballava
chi sotto le pietre e chi sotto le mura
e chi invocava la misericordia divina”
(detto popolare siciliano)
La prima scossa avvenne nella notte - “nell’ora quinta[1]” - del 9 gennaio ma non furono in molti a sentirla perché i più dormivano e probabilmente a Lipari non dovette essere particolarmente forte. La seconda arrivò nel pomeriggio dell’11 gennaio, domenica, alle 13- 13,30 corrispondenti alle 21 siciliane dell’epoca, e questa volta la percepirono tutti, così riferiscono gli storici liparesi.[2]
Ma prima di parlare di quali furono le reazioni dei liparesi, cerchiamo di capire , anche alla luce delle ricerche moderne, la natura di questo evento sismico.
“Il terremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale – osserva uno studio del dipartimento di fisica dell’Università di Bologna[3] – è l’evento di più elevata magnitudo[4] della storia sismica italiana. Ad esso fu associato un maremoto catastrofico, osservato lungo tutta la costa orientale della Sicilia e più a sud fino all’arcipelago maltese”. Questo terremoto ha provocato distruzione completa in molte città delle attuali province di Catania, Siracusa e Ragusa e gravi danni fino a Palermo e Messina . Lo tsunami che ha colpito l’intera costa ionica aveva onde fino ad 8 metri.[5]. I morti furono da 60 mila a 93.000[6]. A Catania morirono 16 mila persone su 20 mila abitanti che contava allora la città; 5 mila su 9.950 a Ragusa; 4 mila su 10 mila a Lentini; 4 mila su 15.339 a Siracusa. La prima scossa arrivò la sera del venerdì 9 gennaio alle 21 circa[7], crollarono numerosi edifici e vi furono vittime, altri edifici furono seriamente lesionati. Il sabato passò senza forti scosse mentre la mattina di domenica alle ore 9 si ebbe una forte scossa e un’altra circa un’ora dopo. Ma l’evento principale, la scossa di 7,4° Richter, arrivò alle 13 e 30 provocando l’immane distruzione e l’innesco del successivo maremoto. Lo sciame sismico con le scosse di assestamento, anche forti, si protrasse ancora per circa due anni con un numero elevatissimo di repliche. Ne vengono stimate circa 1500 di varia intensità e a volte, come quella dell’1 aprile, provocarono altri danni[8]. L’area di avvertibilità è stata molto vasta e si è estesa dalla costa africana alla Calabria settentrionale. “Il terremoto ha raggiunto un’intensità del 6° grado nelle isole Eolie, ed ha provocato danni abbastanza gravi nell’isola di Malta (8°), ma la parte più colpita è stata la Sicilia meridionale con un’area di circa 5600 kmq in cui il terremoto ha raggiunto un’intensità di almeno 9°”. L’area mesosismica, cioè quella dei massimi effetti, la cui intensità è stata valutata dell’11°, copre una superficie di circa 550 kmq e mostra una direzione di allungamento verso nord-est e verso sud-ovest, cioè verso Messina e Malta dove, in entrambe, il sisma è stato dell’8° e che sono poste rispettivamente ad una distanza di circa 180 e 110km dall’area dell’epicentro. Mentre sulla direttrice perpendicolare, si ha una forte attenuazione e l’8° è raggiunto fra i 20 e 40 km dall’epicentro. Questo spiega perché alle Eolie che si trovano proprio sulla direttrice verticale il sisma è stato di 6° ben due in meno di Messina[9].
Ma dov’era l’epicentro? Oggi la tesi più accreditata sulla sorgente di quel sisma indica la scarpata ibleo-maltese che si trova sul mare proprio di fronte alla costa ionica della Sicilia e più precisamente al largo della costa fra Augusta e Catania. E spiegherebbe anche uno tzunami di quella portata[10]. La profondità risulterebbe circa di 20 km.
Messina subisce danni assai gravi. “I magnifici palazzi di Messina, dalle facciate imponenti e ornamentali, ma strutturalmente inadeguati a sostenere i movimenti tellurici dell’isola, furono scossi fin dalle fondamenta”.[11] Ma, visto come andò per Catania, Ragusa e altri centri della Sicilia orientale si può ben dire che essa sia stata risparmiata come, per la gran parte dei paesi della costa tirrenica e le stesse isole Eolie.
Il terremoto a Lipari
Il racconto di come avvenne il terremoto a Lipari lo si deve a Pietro Campis[12]che non si limita a dare informazioni sulle giornate del terremoto ma anche sulle manifestazioni di pietà religiosa che seguirono ai fatti e altre vicende che sono ad essi connessi. Siccome ci sembra che delineano un quadro suggestivo della Lipari del tempo e della sua cultura, anche noi attingeremo ampiamente a questa cronaca riportandola ad un linguaggio più accessibile al lettore di oggi. Va detto subito che il Campis, come d’altronde i liparesi suoi contemporanei, vede in questo evento che risparmiò non solo Lipari ma i liparesi ovunque si trovassero, la grandezza “del Patrocinio di S.Bartolomeo Apostolo sopra la Città di Lipari e i suoi Cittadini in occasione che la divina Giustizia provocata dalle colpe dei mortali usò la forza del suo giustissimo sdegno sopra la vicina Sicilia con spaventosi e replicati terremoti, i quali scotendola dai fondamenti, tolsero la stabilità alla terra, la fermezza alle fabbriche, la vita a più di cento quarantamila persone”[13]. Ed è proprio per fare comprendere “come per li meriti ed intercessione del Santo Apostolo sia stata preservata la Città di Lipari con i suoi abitanti da quello universale flagello[14]”ma anche per dimostrare il “grande amore del novello pastore verso le sue pecorelle”che lo storico che scrisse probabilmente un anno dopo gli eventi ci fornisce una narrazione dettagliata.
La cronaca del terremoto ha un antefatto. Tre mesi prima, l’8 ottobre del 1692 circa 21 ora, improvvisamente si annuvolò il cielo e si oscurò come se volesse piovere, e improvvisamente si scatenò sull’isola una furiosa tempesta come di grandine ma i chicchi erano grossi e pesanti fino a cinque libre[15], avevano una forma triangolare con tre punte lunghe ed al centro come la figura di un occhio che risaltava perché più chiaro. Questa burrasca sorvolò l’isola con un forte frastuono e si scaricò a mare, senza colpire nessuna persona ma solo alcuni animali che morirono.
Naturalmente questo evento, ripensato con quanto accadde dopo, nel successivo gennaio, apparve come un segnale divino a non peccare per non “sogiacere all’acuti strali dell’Irata Giustizia”.
La prima scossa del terremoto a Lipari si avverte il 9 gennaio alle “ore cinque di notte” che dovrebbero essere le 22 di oggi, ma siccome i più dormivano e non procurò alcun danno, passò per lo più inosservata. Ma, qualche giorno dopo, la domenica 11, circa l’ora 21, mentre in Cattedrale il vescovo stava amministrando la cresima, per cui la chiesa era affollata, si avvertono tre terribili scosse. Ogni cosa vacilla, gli edifici oscillano, le strade sembrano sfuggire sotto i piedi. Dove andare? Verso dove scappare per salvarsi la vita? Sono domande che ognuno si pone mentre si cerca di capire che cosa è successo, spaventati, instupiditi.
Quelli che sono in chiesa corrono verso l’altare dove si conserva la reliquia del pollice chiedendo misericordia, pietà perdono, invocando l’aiuto del Santo. Quelle scosse durarono a lungo, un tempo infinito. Ma come era venuto il tremore finì.
Durante quelle scosse vi erano a Vulcano dei liparesi che erano andati a lavorare nei campi. Anch’essi avvertirono le forti ed interminabili scosse ma ciò che li terrorizzava era vedere l’isola di Lipari, dove avevano casa e famiglia, come una piccola barca agitata da una furiosa tempesta e sballottata tanto da parere che da un momento all’altro dovesse inabissarsi. Ma poi improvvisamente anche questo fenomeno cessò e Lipari tornò ad essere ferma e stabile.
Il Campis, a questo punto, passa in rassegna le città e i paesi colpiti dal sisma cominciando con la Val di Noto e via enumerando fino a Catania.
Palermo, Messina e le altre città, terre villaggi della Sicilia “ se non caddero a quelle scosse, furono con tutto ciò sì maltrattate che non si reggono in piedi e, bisognose di sostengo per non cadere, hanno mendicato dalle selve l’appoggio affidando a’ legni le vacillanti e cadenti loro membra[16]”.
Solo Lipari, sostiene il Campis, nella sciagura e desolazione universale, non patì il minimo danno né nelle persone,né negli edifici. E non ha il minimo dubbio, il Campis, che il merito sia solo di S. Bartolomeo: “se l’invocato Santo Bartolomeo non si fusse subitamente interposto appresso la Divina Giustizia per il populo supplichevole, non haverebbe avuto Lipari miglior sorte di quella che incontrarono tante e tante famose Città della Sicilia”.
Una lunga penitenza
Comunque è questo il sentimento della grande maggioranza di liparesi in quel giorno tremendo. Finite le scosse, il vescovo che è mons. Castillo – che era andato a vivere nel Palazzo accanto alla Cattedrale, probabilmente in qualche modo riparato – va nella Cattedrale che è piena di popolo e fa esporre la reliquia del pollice, lascia quindi che la gente si sfoghi per qualche tempo con pianti e preghiere e quindi, chiesto di fare silenzio, prende la parola ed esorta tutti alla penitenza.
E subito, esposto il SS.Sacramento, annuncia che sarebbe rimasto all’adorazione dei fedeli per le prossime quarant’ore, notte e giorno comandando ai canonici che tutti facessero turni di due ore. E lui stesso diede l’esempio scegliendo per se il turno della mezzanotte.
Quella notte la maggior parte dei liparesi la passò in Cattedrale, alternando la paura alla speranza, e ritenendo che, se era destino che dovessero morire, meglio era morire in chiesa in ginocchio dinnanzi al Santissimo.
Ma la notte passò senza nessuna replica del terremoto per quanto leggera.
Il lunedì il vescovo preceduto dal clero e assistito dal governatore e dai giurati portò in processione il Santissimo dalla Cattedrale al Borgo e quindi per tutta la città invocando Dio che preservasse le persone e le isole dal ripetersi di eventuali dissesti. Alla processione il popolo partecipò numerosissimo e, tornata in Cattedrale la processione, il vescovo esortò tutti a prepararsi ad una comunione generale per il prossimo mercoledì mentre il martedì sarebbe stato dedicato alle confessioni.
E così passò il martedì col vescovo che partecipò direttamente alle confessioni mentre ognuno viveva nel raccoglimento e nella preghiera.
Arrivò il mercoledì 14 e per tempo la mattina arrivarono alla Cattedrale in processione le varie confraternite con i loro abiti penitenziali e intonando canti di penitenza. Dopo la comunione si formò una processione che dalla cattedrale, attraverso il borgo, si diresse alla chiesa di San Bartolomeo extra moenia sempre con il clero, il vescovo e le autorità in testa portando la reliquia del pollice. Lì giunti fu chiesto al Santo di confermare il proprio patrocinio e quindi tornarono alla Cattedrale.
Ma la giornata non poteva dirsi ancora conclusa. Nel pomeriggio, quando scadevano le quaranta ore di adorazione, di nuovo le confraternite si diressero alla chiesa madre e questa volta tutti i confrati avevano una corona di spine in testa e una grossa e rozza fune al collo.
Anche i frati Osservanti ed i Cappuccini intervennero con la corona di spine in testa e scalzi e ciascuno portava uno specifico strumento di penitenza: chi si era caricato una grande e pesantissima croce, chi si trascinava al piede una lunga e massiccia catena, chi aveva sulle spalle un pesante macigno, chi con strumenti a punta si colpiva il volto che aveva tutto coperto di sangue. Anche il clero sopraggiunse con il capo cinto di spine.
La processione, con alla testa il vescovo, che mostrava il Santissimo, e le autorità cittadine – anch’essi cinti di corone di spine -, dalla Cattedrale si diresse verso la chiesa di San Giuseppe nel Borgo seguita da un a folla numerosa, tutti con in capo una corona di spine. In questo lungo corteo non mancava chi con flagelli si sferzava le spalle, o si era fasciato le carni nude con l’ortica, o chi si piagava il petto mentre il clero con voce flebile intonava preghiere. Quindi la precessione fece ritorno alla cattedrale dove il vescovo, con un breve discorso, accomiatò tutti.
La congregazione dell’Immacolata chiese al vescovo che si prolungasse di altre quaranta ore e ad essa si unirono le altre congregazioni. Così fu deciso che l’indomani mattina, 15 gennaio, il Sacramento venisse esposto nella chiesa di San Giuseppe e poi a turno si sarebbe portato nelle altre chiese e conventi – e durante il giorno oltre alle preghiere ci sarebbero stati esortazioni spirituali di canonici, padri regolari e dello stesso vescovo nel pomeriggio – e questo fino alla Domenica.
La domenica 18 il vescovo era nuovamente in cattedrale in abito penitenziale e nel pomeriggio, arrivati anche i monaci e il clero con gli stessi segni penitenziali del giorno 14, con la reliquia del Santo la processione si diresse verso la chiesetta di San Bartolo extra moenia. Vi erano anche il governatore ed i giurati anch’essi cinti di spine e con al collo una corda di canapa e così tutto il popolo che seguiva silenzioso e penitente.
E’ fra la sera della domenica e la mattina del lunedì che finalmente giungono a Lipari notizie dalla Sicilia. E ciò che colpisce di più è il sapere che lì alle fortissime scosse dell’11 ne erano seguite diverse altre, “minacciandone un totale sterminio”.
La mattina del lunedì Lipari è tutto un pianto. Nella case, nelle chiese, nelle piazze, nelle strade sono solo suppliche e gemiti. E non si capisce se questi sono per la commiserazione della rovina che è toccata a tanta gente o per il riconoscimento di esserne stati preservati. “La verità si è che – commenta il Campis – dall’uno e l’altro motivo il tutto s’originava nel cuore dei Liparoti”[17].
A questo punto la sequela penitenziale riprende con maggior convinzione e vigore. “Affronte di tante calamità partorite dal tremoto in Sicilia più spicca la gratia fatta alla Città di Lipari, che, sbattuta gagliardamente, fu sostenuta, e, già cadente, fu fermata senza minomissimo detrimento”[18].
Lipari come Ninive penitente
Il vescovo scende in Cattedrale con la corona di spine in testa e scalzo, si prostra in preghiera di ringraziamento dinnanzi alla reliquia dell’Apostolo e poi, sempre scalzo, si reca alla chiesa della Madonna delle Grazie , che si trova ad un centinaio di metri dalla Cattedrale, dove era esposto il Santissimo. Qui lo raggiungono i canonici del capitolo anch’essi incoronati di spine e scalzi. E quando si sparse la voce nella città che il vescovo è con i canonici in preghiera e scalzo, tutti corrono alla Madonna delle Grazie. Tutti scalzi, tutti col capo coperto di spine, anche il governatore ed i giurati, tutti senza eccezione alcuna incuranti del fatto che era inverno, che faceva freddo, che le strade erano pozzanghere fangose. Tutti anche le signore, le donne di ogni ceto, scarmigliate, con croci e flagelli, battendosi il petto, piangendo, invocando pietà. Tutti anche le ragazze, i giovani, i bambini graffiandosi la faccia. Percotendosi il petto con sassi, battendosi le spalle con corde impeciate, tutti implorando misericordia e perdono, “vedevasi una divotione confusa et una confusione devota[19]”.
“Chi non vidde Ninive penitente poteva quella mattina raffigurarla in Lipari[20]”!
E questa contrizione non si trattò di un fuoco fatuo. Il martedì, il mercoledì e il giovedì furono giorni totalmente consacrati al pianto, al pentimento, alla confessione ed alla comunione, ad atti di penitenza “che ognuno a suo talento esercitava” , di giorno per le strade e nelle chiese e di notte dinnanzi alle porte chiuse di queste giacchè si temevano ancora rovine e stragi.
Le notizie che erano arrivate dalla Sicilia sembravano avere tolto senno e sonno alle persone. Non si dormiva più di notte e di giorno si camminava per le strade “insensate e stolide”, meste e taciturne. Non si vedevano più per le strade e per le piazze il formarsi di circoli per chiacchierare, anzi appena si scambiavano saluti muti fra amici e parenti. Diversi pensavano di abbandonare la città e il borgo e di rifugiarsi in campagna come se anche qui non si fossero potuti aprire delle voragini.
Di questo sentimento popolare di depressione ne fu turbato il vescovo che pensò che fosse giunto il momento di porre fine a questa lunga penitenza ch era durata per più di dieci giorni.
Così giovedì 22 gennaio era l’ultimo giorno in cui il Santissimo stava esposto nella Chiesa delle Grazie. Il vescovo, alla 21 ora (ore 14?), preceduto dal capitolo e seguito dai rappresentanti la città, si soffermò in preghiera dinnanzi all’ostensorio poi presolo in mano si portò alla porta della chiesa perché potesse essere ascoltato da quelli che erano dentro la chiesa e dai moltissimi che non erano riusciti ad entrare e stavano in ginocchio nella piazzetta dinnanzi. Nel suo discorso partì dalla grazia che Lipari ed i liparesi avevano ricevuto per i meriti di S. Bartolomeo ma, parte nuova del suo discorso, si disse sicuro che l’isola e la città non sarebbero più stati soggetti a cataclismi e scosse di terremoto e questo proprio per la tutela del santo. E disse questo senza alcuna esitazione sereno in volto ma con voce ispirata. E lo ripeté più volte alzando l’ostensorio. Grazie a S. Bartolomeo il pericolo era cessato.
Un discorso breve ma di grande efficacia. E la gente gli credette ed immediatamente tutti si rasserenarono. Così accompagnarono vescovo e ostensorio in processione ancora una volta per la città e ritornati alla Chiesa delle Grazie il vescovo volle rassicurare ancora i cittadini: “Non bisognava avere più paura che tremi la terra. Dio per i meriti del suo Apostolo ci ha preservati da questo tragedia e così sarà per l’avvenire”. Quindi mons. Castillo impartì la benedizione e rimandò la gente alle proprie case.
Nei giorni seguenti si seppe che proprio nella giornata di giovedì, “alle 22 ore sonate”, mentre il vescovo parlava rassicurando tutti, a Messina ed in altre città la terra fu scossa da forti tremori. Ma a Lipari non ci fu più alcun sommovimento, ne allora nei mesi seguenti, dice il Campis, che finiva di scrivere il 10 agosto di quello stesso anno[21].
[1] Le ore si contavano a partire dall’Ave Maria che però cambiava da stagione a stagione perché corrispondeva all’imbrunire. Se a gennaio il sole tramonta alle 17 si può pensare che l’ora quinta siano le 22 e che le 21 della domenica erano le 13. Un calcolo diverso degli orari viene fatto da M.S. Barbaro e M. Cosentino (Il terremoto siciliano dell’11 gennaio 1693, Rend.Soc. Geol.It, 4 (1981), pp- 517-522): il 9 gennaio la scossa si sarebbe verificata alle ore 4,30 del tempo corrispondente alle 21,07 di oggi; il terremoto dell’11 gennaio sarebbe avvenuto alle ore 21 del tempo allora in uso corrispondente alle 14.09 del tempo odierno. Ma se il terremoto a Lipari giunse durante la cerimonia in Cattedrale è difficile che questa fosse ancora in corso alle 14.09. Più probabilmente la scossa che colse la gente in cattedrale fu quella delle 16 tempo di allora corrispondente alle ore 9. 23 di oggi e che vi sia stata confusione fra le due scosse.(Archivio storico eoliano.it)
[2] G.La Rosa, op.cit., voll. I, pp232-241,
[3] S. Tinti, A.Armigliato e R.Tonini, Studio delle possibili sorgenti del maremoto dell’11 gennaio 1693 in Sicilia orientale mediante modellazione numerica, Convegno GNDT 2004.
[4] M=7,4 secondo Gruppo di Lavoro CPTI, 2004.
[5] Dal sito www.socgeol.it , vol.128(2009) f.1.
[6] M.S. Barbano, M. Cosentino, art. cit., pag. 521. I dati e le notizie riportati dalle cronache o da descrizioni del terremoto si rivelano spesso contraddittori. Risulta perciò importante confrontare più documenti, possibilmente atti ufficiali. Riguardo, ad esempio, alle vittime del terremoto le notizie sono estremamente discordanti; per la Relazione dei Senatori di Siracusa ... , cit., i morti sono 93.000, secondo il manoscritto anonimo Il gran terremoto del 1693 in Siracusa sarebbero 26.000: L. Trigilia, Siracusa ... , cit., pp. 116-117, cfr. a p. 82. F. Aprile, Della cronologia ... , cit., riportando gli «Estinti nelle rovine del terremoto», osserva: «rapporterò qui la strage delle persone quasi d'ogni popolazione per potersene conietturare ancora le rovine degli edifici; avvegnaché non sia in tutte argomento infallibile, poiché in alcune fu grande il danno delle fabbriche, minore, e non corrispondente la perdita degli uomini, che con maggiore accorgimento si sottrassero al pericolo dopo il terremoto del venerdì .. ».
[7] La prima scossa si fece sentire “per lo spazio di due pater noster”, quella dell’11 gennaio (alle 15 o alle 13.30), fu avvertita per il tempo di “una litania cantata”. ( Da una lettera del conte Domenico Lacorcia scritta da Mazzarino il 13 gennaio ad Antonio Bulifon in L.Trigilia, La ricostruzione necessaria, Centro Internazionale di Studi sul Barocco.)
[8] M.S.Barbano e M. Cosentino, art. cit., pag. 519.
[9] Idem, 519-521.
[10] M. Stucchi, F.Albini, A.Moroni, I. Leshiutta, C.Mirto e G.Morelli, Il terremoto del 9 gennaio 1693 in (a cura di) G.Giarrizzo, La Sicilia dei terremoti lunga durata e dinamiche sociali, Catania 1886.
[11] S.Greco, Messina medievale e moderna, op.cit., pag. 332.
[12] P.Campis, op.cit., pp.345-366. E la cronaca del Campis riprende ampiamente Giuseppe La Rosa, op.cit., vol I,pp.232-241. Noi seguiremo la narrazione del Campis integrandola, dove ci sembra più chiara e puntuale sotto l’aspetto narrativo, con quella del LaRosa, che in qualche punto se ne discosta.
[13] P. Campis, op.cit., pag. 345.
[14] Idem, pag. 345.
[15] La libra siciliana doveva essere di poco superiore ai 3 etti e quindi questi chicchi di grandine sarebbero arrivati pesare sino ad un chilo e mezzo.
[16] P.Campis, op, cit., pag.350.
[17] P. Campis, op. cit., pag. 354.
[18] Idem, pag. 354.
[19] P. Campis, op. cit., p.355.
[20] Ibidem, pag. 355.
[21] Ibidem pag. 358.
---L'arrivo degli Eolie. La crisi economica.
La recessione economica e demografica dovette manifestarsi proprio con l'avvento dell'età dei metalli, nella seconda metà del terzo millennio, cioè durante l’età del rame che è metallo troppo fragile per potere scalzare subito e totalmente la pietra ed all’inizio della lavorazione del bronzo. Proprio questa convivenza della pietra con i metalli fa si che la crisi sia lenta anche se progressiva ed inesorabile visto che l'economia di Lipari è legata ad una monocultura - quella della produzione e del commercio dell'ossidiana – e fa fatica a diversificarsi e riconvertirsi. Più duttile è invece l’economia di Salina - allora circa 200 abitanti contro i mille di Lipari - che può contare su una terra più generosa, su coltivazioni più redditizie, su selvaggina abbondante e su ricche sorgenti d’acqua [1].
Quanto dura questa crisi? Probabilmente mezzo millennio a partire dal 2600. Infatti proprio negli anni a cavallo fra il III ed il II millennio incontriamo un nuovo periodo di forte fioritura. Questo risveglio sembra coincidere con una nuova trasmigrazione di gente che giunge dall'oriente: sono gli Eoli che daranno il loro nome alle Eolie. Probabilmente è proprio l'avvento dell'era dei metalli- e soprattutto la scoperta del bronzo che deriva dalla fusione del rame con lo stango - che mette le popolazioni in movimento alla ricerca di aree più ricche di risorse o collocate strategicamente. Inoltre dovettero contribuire non poco anche alcuni progressi avvenuti nel campo della navigazione grazie alla maggiore capacità di lavorare il legno, a metodi migliori per saldare le connessioni, a tessuti più grandi e più solidi da adoperare come vele [2]. Comunque è proprio in questo periodo che sta a cavallo dei due millenni che si sviluppa una fase di grandi trasmigrazioni che investono tutto il mondo e procedono, in genere, da est verso ovest..
Le grandi trasmigrazioni

Prima di noi, è la penisola greca ad accogliere ondate successive di popoli che incalzano e sospingono in avanti quelli che erano giunti prima. Proprio nel II millennio si stanzieranno sul suo territorio popolazioni indoeuropee provenienti da oriente, probabilmente dalle coste dell'Anatolia sul Mar Nero, ribattezzando la penisola col nome di Ellade. Così prima giungono gli ioni, quindi gli eoli e gli achei. Infine, ma siamo già nel 1150, giungeranno i dori.
Mentre gli ioni occupano l'Attica, gli achei (conosciuti anche col nome di micenei) il Peloponneso entrando in rapporti commerciali con la civiltà cretese, gli Eoli si stabiliscono nella Beozia e nella Tessaglia oltre che nella zona mediana della Grecia, su tratti della costa dell‘Asia Minore ed in diverse isole greche. E saranno essi che si spingeranno oltre che sulle coste ioniche dell'Italia anche fino alle Eolie per proseguire verso la Campania e la Toscana. Da noi giungono prima, probabilmente, con missioni esplorative, poi per realizzare - come sarà anche per Malta - presidi che favoriscano le rotte commerciali ed infine, proprio in relazione a questi presidi si creano insediamenti più stabili. Anzi proprio le Eolie e Malta rappresenteranno per gli Eoli le principali stazioni di transito e di commercio della loro imponente rete marinara.
Insediamenti degli Eoli
La prima scelta sarà naturalmente la rocca di Lipari, poi le altre isole - a Stromboli nel 1980 viene alla luce, nei presi della chiesa di S. Vincenzo, un villaggio preistorico di capanne risalenti alla prima metà del II millennio a.C. - ed in particolare Capo Graziano a Filicudi. E proprio da Capo Graziano questa nuova cultura delle Eolie prende il nome.


Sopra, Capo Graziano a Filicudi. Sotto, gli scavi
Il nome Eoli secondo la tradizione deriverebbe da Eolo Eponimo, figlio di Elleno e patriarca degli Elleni cioè dei popoli che emigrarono dall'Anatolia verso la Grecia dando vita all'ondata degli Ioni, degli Achei e quindi degli Eoli. Da noi la loro presenza, in un modo o nell'altro si estende lungo circa mille anni: dal XXI secolo all'XI a.C.
La tazza di Filicudi


La tazza di Filicudi e la riproduzione dei disegni
Uno dei manufatti più antichi e interessanti rinvenuti alle Eolie e precisamente a Filicudi nella zona detto Filo Braccio è la tazza emisferica che potrebbe risalire al XX-XIX secolo a,C. la cui forma, nell’insieme, “non trova confronto nell’ambito eoliano”. I disegni sulla tazza potrebbero raccontare – come ipotizza M.C. Martinelli [3] - “un evento di particolare importanza tale da essere tramandato”, possibilmente un momento di migrazione da o verso le isole. Al centro del racconto vi sarebbe una figura umana a braccia e mani aperte, disposto nella postura orante, circondato da barche fra cui una rappresentata al momento dell’attracco con i remi sollevati. (Archivio storico eoliano.it).
[1] G. Iacolino, op.cit., pag. 24-25.
[2] G. Iacolino, op.cit., pag. 33. H.W.Van Loon, Soria ella navigazione, op.cit. pa. 43,
[3] C.Martinelli e altri, Nuove ricerche nell’insediamento dell’istmo di Filo Braccio a Filicudi. Nota preliminare sugli scavi del 2009, ORIGINI XXXII, Nuova Serie IV, 2010, 285-314.
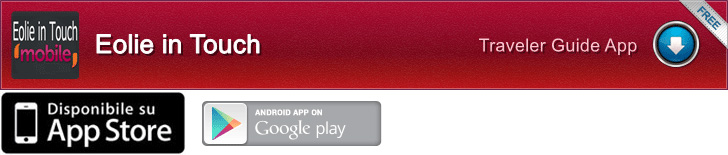

 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431